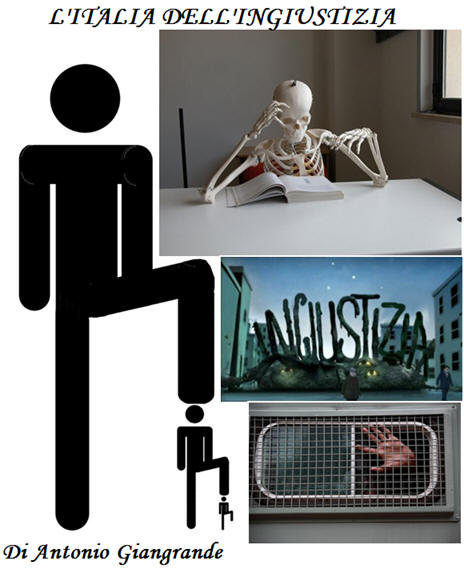Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI

 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
GIUSTIZIOPOLI
TERZA PARTE
DI ANTONIO GIANGRANDE

L’ITALIA DELL’INGIUSTIZIA
OSSIA, LA LEGGE DEL PIU’
FORTE,
NON LA FORZA DELLA LEGGE
DISFUNZIONI DEL SISTEMA
CHE COLPISCONO IL SINGOLO
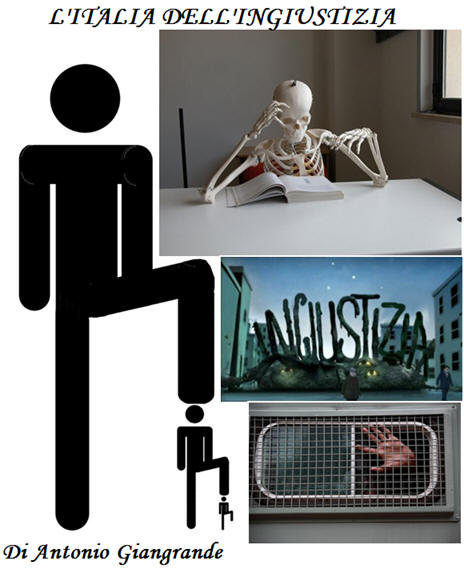
TIRANNIDE indistintamente appellare si
debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi,
può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od
anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo
infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o
tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a
ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che
lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Art. 101
della Costituzione: La Giustizia è amministrata in nome del popolo. I
costituenti hanno omesso di indicare che la Giustizia va amministrata non solo
in nome, ma anche per conto ed interesse del popolo. Un paradosso: le
illegalità, vere o artefatte, sono la fonte indispensabile per il sostentamento
del sistema sanzionatorio - repressivo dello Stato. I crimini se non ci sono
bisogna inventarli.
Una società
civile onesta farebbe a meno di Magistrati ed Avvocati, Forze dell'Ordine e
Secondini, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari.....oltre che dei partiti dei
giudici che della legalità fanno una bandiera e dei giornalisti che degli
scandali fanno la loro missione. Sarebbe una iattura per coloro che si fregiano
del titolo di Pubblici Ufficiali, con privilegi annessi e connessi. Tutti a casa
sarebbe il fallimento erariale. Per questo di illegalità si sparla.
Le pene siano
mirate al risarcimento ed alla rieducazione, da scontare con la confisca dei
beni e con lavori socialmente utili. Ai cittadini sia garantita la libera nomina
del difensore o l'autodifesa personale, se capace, ovvero il gratuito patrocinio
per i poveri. Sia garantita un'indennità e una protezione alla testimonianza.
Sia garantita
la scusa solenne e il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, al
cittadino vittima di offesa o violenza di funzionari pubblici, di ingiusta
imputazione, di ingiusta detenzione, di ingiusta condanna, di lungo o ingiusto
processo.
Il difensore
civico difenda i cittadini da abusi od omissioni amministrative, giudiziarie,
sanitarie o di altre materie di interesse pubblico."
di Antonio
Giangrande
*****
INGIUSTIZIA E
MALAGIUSTIZIA, OSSIA GIUSTIZIA NON UGUALE PER TUTTI.
Difficilmente si
troverà nel mondo editoriale un’opera come questa: senza peli sulla lingua (anzi
sulla tastiera). Nell’affrontare il tema della Giustizia non si può non parlare
dei tarli che la divorano e che generano Ingiustizia e Malagiustizia.
La
MALAGIUSTIZIA,
oggetto della presente opera, è la disfunzione ed i disservizi
dell’amministrazione della Giustizia che colpiscono la comunità: sprechi,
disservizi, insofferenza che provocano sfiducia verso le istituzioni ed il
sistema. Quindi si può dire che la Malagiustizia è la causa dell’Ingiustizia.
L’INGIUSTIZIA
è l’effetto che la malagiustizia opera sui cittadini: ossia le pene, i sacrifici
e le sofferenze patite dai singoli per colpa dell’inefficienza del Sistema
sorretto e corrotto da massonerie, lobbies e caste autoreferenziali attinti da
spirito di protagonismo e con delirio di onnipotenza: giudicanti, ingiudicati,
insomma, CHE NON PAGHERANNO MAI PER I LORO ERRORI e per questo, sostenuti dalla
loro claque in Parlamento, a loro si permette di non essere uguali, come tutti,
di fronte alla legge!!!
Della
malagiustizia si parla in un’inchiesta ed in un libro a parte. Dei legulei,
ossia degli operatori della giustizia, si parla dettagliatamente anche di loro
in altra inchiesta ed in altro libro.
LA LEGGE E' UGUALE PER
TUTTI ?!?!
LA GIUSTIZIA E' DI QUESTO
MONDO ?!?!
"Art. 101 della
Costituzione: La Giustizia è amministrata in nome del popolo. I costituenti
hanno omesso di indicare che la Giustizia va amministrata non solo in nome, ma
anche per conto ed interesse del popolo. Un paradosso: le illegalità, vere o
artefatte, sono la fonte indispensabile per il sostentamento del sistema
sanzionatorio - repressivo dello Stato. I crimini se non ci sono bisogna
inventarli. Una società civile onesta farebbe a meno di Magistrati ed Avvocati,
Forze dell'Ordine e Secondini, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari.....oltre che
dei partiti dei giudici che della legalità fanno una bandiera e dei giornalisti
che degli scandali fanno la loro missione. Sarebbe una iattura per coloro che si
fregiano del titolo di Pubblici Ufficiali, con privilegi annessi e connessi.
Tutti a casa sarebbe il fallimento erariale. Per questo di illegalità si
sparla."
di Antonio Giangrande
GIUSTIZIOPOLI
L'INGIUSTIZIA CHE COLPISCE
IL SINGOLO
SOMMARIO PRIMA PARTE
INTRODUZIONE.
"PADRI DELLA PATRIA"
VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA
ROVINA.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
ONESTA’ E DISONESTA’.
OTTENERE IL RISARCIMENTO PER INGIUSTA
DETENZIONE È UN’ODISSEA.
RISARCIMENTO PER I PROCESSI
LUNGHI. LEGGE PINTO? NO! LEGGE TRUFFA!
COME SI DICE…“CANE NON
MANGIA CANE!”
PARLIAMO DI INGIUSTIZIA E MALAGIUSTIZIA.
IL GIUSTIZIALISMO GIACOBINO
E LA PRESCRIZIONE.
GIUSTIZIALISTI: COME LA
METTIAMO CON GLI ERRORI GIUDIZIARI?
PARLIAMO DI INTERCETTAZIONI: LECITE, AMBIGUE,
SELVAGGE.
PARLIAMO DELLE OFFESE DEL PUBBLICO MINISTERO
ALL’IMPUTATO.
PARLIAMO DI TORTURA E VIOLENZA DI STATO.
SCIENZA E GIUSTIZIA.
LA RETORICA COLPEVOLISTA DELLA GIUSTIZIA
MEDIATICA.
ASSOLTI. PERO’…
COLPA DEI PROCESSI
INDIZIARI...
TOTO' CUFFARO: "LE MIE PRIGIONI".
L'INGIUSTIZIA NON E' UNA UTOPIA: E' REALTA'.
ANTONIO GIANGRANDE,
GABRIELLA NUZZI, SILVIO BERLUSCONI: LE RITORSIONI DEI MAGISTRATI.
INGIUSTIZIA E
MALAGIUSTIZIA, OSSIA GIUSTIZIA NON UGUALE PER TUTTI.
INGIUSTIZIA. PARLIAMO DI
DANTE BRANCATISANO. DETENUTO SENZA COLPA.
E’ TUTTA QUESTIONE DI
COSCIENZA.
I MEDIA ED I LORO PECCATI:
DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
PER UNA LETTURA UTILE E
CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
POLITICA,
GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE
VERGINELLE.
LA REPUBBLICA DELLE MANETTE.
“TUTTI DENTRO, CAZZO!!”
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI.
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’
E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
STATO DI DIRITTO?
CHI E’ IL POLITICO?
CHI E’ L’AVVOCATO?
DELINQUENTE A CHI? CHI E’
IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE SULLA MAFIA.
QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA
MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
2 OTTOBRE 2013. LE
GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
ITALIA DA VERGOGNA.
ITALIA BARONALE.
CASA ITALIA.
ITALIA. SOLIDARIETA’
TRUCCATA E DI SINISTRA.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI
ANTIRACKET.
ITALIA: PAESE ZOPPO.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
DUE COSE SU AMNISTIA,
INDULTO ED IPOCRISIA.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE
A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
ANCHE GESU' E' STATO
CARCERATO.
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA
CASTA.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE
COMMISSIONI D’ESAME?
LO STATO CON LICENZA DI
TORTURARE ED UCCIDERE.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA.
CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
27 NOVEMBRE 2013. LA
DECADENZA DI BERLUSCONI.
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI
DI NESSUNO.
LA TERRA DEI CACHI, DEI
PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
LO SPRECO DI DENARO
PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
SONO BRAVI I COMUNISTI.
NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
MENTRE PER LE LOBBIES LE
PORTE SONO SEMPRE APERTE.
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA
MAFIA ODONTOIATRICA.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60
MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
FATTI DI CRONACA, DISFATTI
DI GIUSTIZIA.
LOTTA
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO
STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO.
LA SINDROME DI NIMBY.
L’ITALIA DEI COLPI DI
STATO.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
NON VI REGGO PIU’.
BELLA ITALIA, SI’. MA
ITALIANI DEL CAZZO!!!
FENOMENOLOGIA RANCOROSA
DELL’INGRATITUDINE.
SE NASCI IN ITALIA……
DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO
E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
INNOCENTE PER LEGGE, MA ‘NDRANGHETISTA PER
SEMPRE.
LA TORTURA DI STATO, L'INTERVENTO DEL PAPA E
L'INFERNO DEI RISARCIMENTI.
L’ERRORE GIUDIZIARIO: INNOCENTI IN CELLA,
ASSOLTI ED ARCHIVIATI.
MAGISTRATI: FACCIAMO QUEL CHE VOGLIAMO!
GUERRA DI TOGHE. ANCHE I MAGISTRATI PIANGONO.
ANCHE BORSELLINO ERA INTERCETTATO.
IL SUD TARTASSATO.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
DETENUTO SUICIDA IN CARCERE? UNO DI MENO!!!
BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: FACCIAMO CHIAREZZA!
NON E’ COSA LORO!
IL BUSINESS DEI BEI SEQUESTRATI E CONFISCATI.
USURA ED ESTORSIONE: CONVIENE DENUNCIARE?
RISPONDONO LORO. ANTONIO GIANGRANDE. PINO MANIACI E MATTEO VIVIANI DE LE IENE
PER I FRATELLI CAVALLOTTI E L'ITALGAS. FRANCESCO DIPALO. LUIGI ORSINO. PINO
MASCIARI. COSIMO MAGGIORE. LUIGI COPPOLA. LUIGI LEONARDI. TIBERIO BENTIVOGLIO.
IGNAZIO CUTRO'.
MAI DIRE MAFIA. FRANCESCO CAVALLARI E LA
SFIDUCIA NEI MAGISTRATI.
E POI PARLIAMO DELL'ILVA.
EQUITALIA. STROZZINI DI STATO.
CONCORSI ED ESAMI. LE PROVE. TRUCCO CON I TEST;
TRUCCO CON GLI ELABORATI.
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO.
USURA BANCARIA: I MAGISTRATI STANNO CON LE
BANCHE.
SPECULAZIONE E BANCHE:
ECONOMIA CHE UCCIDE.
SINISTRA ED IDEOLOGIA:
L'ECONOMIA CHE UCCIDE.
SINISTRA ED ISLAM:
L'IDEOLOGIA CHE UCCIDE.
SINISTRA E MAGISTRATI. LA
GIUSTIZIA CHE UCCIDE L'ECONOMIA.
PROCESSATE BOSSI ED I
LEGHISTI.
I GRANDI PROCESSI DEL 2014 ED I GRANDI DUBBI: A
PERUGIA, KERCHER; A TARANTO, SCAZZI; A TORINO, ETERNIT; A MILANO, STASI; SENZA
DIMENTICARE CUCCHI A ROMA.
SLIDING DOORS A
MILANO: CRISAFULLI E BARILLA'. LA VITA CAMBIATA
SENZA SAPERE UN CAZZO.
CASO MARO’. ITALIANI POPOLO DI MALEDUCATI,
BUGIARDI ED INCOERENTI. DICONO UNA COSA, NE FANNO UN’ALTRA.
L’AQUILA NERA E L’ARMATA BRANCALEONE.
LA BANDA DEGLI ONESTI E MAFIA CAPITALE.
IN TEMA DI GIUSTIZIA E DI INFORMAZIONE CHI
SBAGLIA PAGA? IL DELITTO DI PERUGIA. AMANDA E RAFFAELE
COLPEVOLI DI INNOCENZA.
CARCERE. INFERNO SENZA ACQUA.
DONNE IN CARCERE. LA DISCRIMINAZIONE DIETRO LE
SBARRE.
QUANDO IN PRIGIONE CI VANNO I BAMBINI.
QUANDO IN ESILIO CI VANNO I BAMBINI.
BREGA MASSONE: CONDANNATO IN TV.
IMPRENDITORIA CRIMINOGENA. SEQUESTRI ED
AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE. A CHI CONVIENE?
LA CHIAMANO GIUSTIZIA, PARE
UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI TESTIMONI.
CONDANNA DEFINITIVA
REVOCATA? NON E' PIU' UN TABU'.
L’ASINARA, PIANOSA ED IL
FATTORE “M”.
CARCERI A SORPRESA. LE
CELLE LISCE E LE ISPEZIONI SENZA PREAVVISO.
INCHIESTA. IL CARCERE, I CARCERATI, I PARENTI
DEI CARCERATI ED I RADICALI…….
L’ITALIA COME LA CONCORDIA. LA RESPONSABILITA’
DELLA POLITICA.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO
PARLARE CLAUDIO BISIO.
L’ITALIA DEGLI IPOCRITI. GLI INCHINI E LA FEDE
CRIMINALE.
SOMMARIO SECONDA PARTE
LA PRESCRIZIONE. LA GARANZIA PER GLI INNOCENTI
CHE I GIUSTIZIALISTI NON VOGLIONO.
PRESCRIZIONE. MANLIO CERRONI ED I 14 ANNI DI
SOFFERENZA DA INNOCENTE.
MAGISTRATURA SENZA VERGOGNA.
L’ITALIA DEI MORALISTI CON LA MORALE DEGLI ALTRI.
STORIE DI MAFIOSI E PARA MAFIOSI.
POTENTE UGUALE IMPUNITO.
FIDARSI DELLE ISTITUZIONI. I CITTADINI: NO
GRAZIE!! CHI CONTROLLA I CONTROLLORI?
INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI? UNA BALLA. LO
STRAPOTERE DEI MAGISTRATI E LA VICINANZA DEI GIUDICI AI PM, OLTRE LA CORRUTTELA.
EDITORIA E CENSURA. SARAH SCAZZI ED I CASI DI
CRONACA NERA. QUELLO CHE NON SI DEVE DIRE.
FINANZA E GIUSTIZIA.
RESPONSABILITA' DELLE TOGHE? LA SINISTRA: NO
GRAZIE!!!
LA SINISTRA E LE TOGHE D’ASSALTO
LA VERA STORIA DI CORRADO CARNEVALE ED I
MAGISTRATI POLITICIZZATI E PIGRI.
SENTIAMO KARIMA EL MAHROUG, DETTA RUBY.
SENTIAMO CESARE BATTISTI.
YARA E' SEMPRE. SBATTERE IL MOSTRO IN PRIMA
PAGINA.
L'ULTIMO AFFRONTO AD ENZO TORTORA.
LA REPUBBLICA DEI MAGISTRATI.
GIUSTIZIA E POLITICA MADE IN SUD.
COLPEVOLE DI ESSERE
INNOCENTE.
CHE INGIUSTIZIA PERO'!!!
DAI CARABINIERI ENTRI VIVO E NE ESCI MORTO O SCONTI LA PENA NELLA CELLA ZERO.
IL CARCERE E LA GUERRA DELLE BOTTE.
DELITTO DI STATO. FEDERICO
PERNA.
POLIZIA, POLIZIA PENITENZIARIA E CARABINIERI:
ABBIAMO UN PROBLEMA?
LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA?
INGIUSTIZIA: IMMENSA BIBLIOGRAFIA.
LA METASTASI DELLA GIUSTIZIA. IL PROCESSO
INDIZIARIO. IL PROCESSO DEL NULLA. UOMO INDIZIATO: UOMO CONDANNATO.
PARLIAMO DEL REATO DI MAFIA.
DIRITTO CERTO E UNIVERSALE. CONTRADDIZIONI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE: CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA, UN REATO
CHE ESISTE; ANZI NO!!.
G8 E GLI ALTRI. TORTURATI IMPUNEMENTE DALLO
STATO.
AMANDA KNOX, RAFFAELE SOLLECITO E GLI ALTRI.
TORTURATI IMPUNEMENTE DALLA GIUSTIZIA.
BERLUSCONI E LA GUERRA PERSECUTORIA DEI
MAGISTRATI.
DOPO BERLUSCONI, I RIVA. ILVA E GLI ESPROPRI
PROLETARI.
CHI E’ L’AVVOCATO?
DELINQUENTE A CHI? CARMINE SCHIAVONE.
MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
CHI E’ IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI
REGIME NON DICE.
IN ITALIA UN ERRORE GIUDIZIARIO GRAVE OGNI DUE
MAGISTRATI.
QUANDO IL PM SBATTE IL VIP IN CARCERE PER
ANDARE IN PRIMA PAGINA.
IL PROFESSORE DI SALUZZO, LE ALLIEVE E LA
GIUSTIZIA ITALIOTA.
L'INGIUSTIZIA E LA FICTION.
LA DRAMMATICA LETTERA DI GAIA TORTORA A “IL
TEMPO” SULLA GIUSTIZIA ITALIANA.
QUANDO IL PM SBATTE IL VIP IN CARCERE PER
ANDARE IN PRIMA PAGINA.
GLI INNOCENTI? PARLIAMONE....
DELINQUENTE A CHI?
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
IL CSM ASSOLVE IL GIUDICE ROSSO CHE ANDAVA A
CACCIA CON I BOSS.
INNOCENTI IN CARCERE: ECCONE UN ALTRO. GIOVANNI
DE LUISE.
INNOCENTI IN CARCERE: ECCONE UN ALTRO. MAURIZIO
BOVA.
LA SCIENZA LO DICE: I MAGISTRATI FANNO
POLITICA. I ROSSI ATTACCANO. GLI AZZURRI INSABBIANO.
TRAMONTO ROSSO. I COMUNISTI E LA GIUSTIZIA.
BERLUSCONI E GLI ALTRI. I MAGISTRATI FANNO QUEL
CHE “CAZZO” VOGLIONO.
DUE PAROLE SULLA
MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
LE DINASTIE DEI MAGISTRATI.
TRIBUNALI SPECIALI. QUELLO CHE SUCCEDE A SILVIO
BERLUSCONI, CAPITA A TUTTI GLI ITALIOTI, CHE SUBISCONO E TACCIONO........ED I
GIORNALISTI OMERTOSI: "MUTI SONO".
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I
POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
PARLIAMO DEI CRITERI
DI VALUTAZIONE DELLE PROVE E DI CHI LI METTE IN PRATICA PER STABILIRE CHI MERITA
E CHI NON MERITA DI DIVENTARE MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO, ECC.
LE TOGHE IGNORANTI.
PARLIAMO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, MADRE DI
TUTTE LE CORTI. UN CASO PER TUTTI. DISCUTIAMO DELLA CONDANNA DI SILVIO
BERLUSCONI.
C’E’ UN GIUDICE A BERLINO!
IL PAESE DEL GARANTISMO IMMAGINARIO.
I GIOVANI VERGINELLI ATTRATTI DAL
GIUSTIZIALISMO.
MANETTE FACILI ED OMICIDI DI STAMPA E DI STATO:
I PROCESSI TRAGICOMICI.
MARIO MORI E LA MAGISTRATURA.
ED IL CITTADINO COME SI DIFENDE? CON I
REFERENDUM INUTILI ED INAPPLICATI.
LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E
LA DINASTIA DEGLI ESPOSITO.
CHI SONO I MAGISTRATI CHE HANNO CONDANNATO
SILVIO BERLUSCONI.
IL CASO DI MARCELLO LONZI.
L'ITALIA VISTA DALL'ESTERO.
COSTITUZIONE ITALIANA: COSTITUZIONE MASSONICA.
ED I LIBERALI? SOLO A PAROLE.
POPULISTA A CHI?!?
APOLOGIA DELLA RACCOMANDAZIONE. LA
RACCOMANDAZIONE SEMPLIFICA TUTTO.
LA LEGA MASSONICA.
LA STRATEGIA DELLA TENSIONE: TERRORISTICA E
GIUDIZIARIA.
GIUSTIZIA. LA RIFORMA IMPOSSIBILE.
MAGISTRATI: IL RISPETTO SI MERITA, NON SI
PRETENDE!!
GLI ITALIANI NON HANNO FIDUCIA IN QUESTA
GIUSTIZIA.
UN PAESE IN ATTESA DI GIUDIZIO.
RIFORMA DELLA (IN)GIUSTIZIA?
DA QUANTO TEMPO STIAMO ASPETTANDO GIUSTIZIA?
GIUDICI, NON DIVENTATE UNA CASTA.
DA UN SISTEMA DI GIUSTIZIA INGIUSTA AD UN
ALTRO.
IN ITALIA, VINCENZO MACCARONE E' INNOCENTE.
TOGHE SCATENATE.
CORTE DI CASSAZIONE: CHI SONO I MAGISTRATI CHE
HANNO CONDANNATO SILVIO BERLUSCONI.
CHI E' ANTONIO ESPOSITO.
ANTONIO ESPOSITO COME MARIANO MAFFEI.
PARLIAMO DI FERDINANDO ESPOSITO.
GIUDICE ANTONIO ESPOSITO: IMPARZIALE?
IL PDL LICENZIO' SUO FRATELLO.
PROCESSO MEDIASET. LA CONDANNA DI SILVIO
BERLUSCONI.
BERLUSCONI: CONFLITTO INTERESSI;
INELEGGIBILITA’; ABITUALITA’ A DELINQUERE. MA IN CHE ITALIA VIVIAMO?
BERLUSCONI E CRAXI: DUE CONDANNATI SENZA
PASSAPORTO.
DA ALMIRANTE A CRAXI CHI TOCCA LA SINISTRA
MUORE.
BERLUSCONIANI CONTRO ANTIBERLUSCONIANI.
I ROSSI BRINDANO ALLA CONDANNA.
QUANDO IL PCI RICATTO' IL COLLE: GRAZIA
ALL'ERGASTOLANO.
PASQUALE CASILLO E BERLUSCONI.
CORRUZIONE: MANETTE A GIUDICI ED AVVOCATI. SI
SALTA DA MAFIA IN MAFIA.
SE SCRIVI DI LORO TE LA FANNO PAGARE.
GLI ABUSI DEI GENERALI. SI SALTA DA MAFIA IN
MAFIA.
MAGISTRATI. CON LA DESIRE' DIGERONIMO I
PANNI SPORCHI SI LAVANO IN FAMIGLIA?!?
ITALIA, CULLA DEL DIRITTO NEGATO. STORIE DI
FALLIMENTI.
MEZZO SECOLO DI GIUSTIZIA ITALIANA A
STRASBURGO: UN’ECATOMBE.
LO STATO DELLA GIUSTIZIA VISTO DA UN
MAGISTRATO.
LA MALAGIUSTIZIA E L’ODIO POLITICO. LA VICENDA
DI GIULIO ANDREOTTI.
LA RIMESSIONE DEI PROCESSI PER LEGITTIMO
SOSPETTO (SUSPICIONE): UNA NORMA MAI APPLICATA.
CITTADINI ROVINATI DALLA GIUSTIZIA.
ITALIA, TARANTO, AVETRANA: IL CORTOCIRCUITO
GIUSTIZIA-INFORMAZIONE. TUTTO QUELLO CHE NON SI OSA DIRE.
LETTERA AL DEPUTATO
MAI ELETTO.
DENUNCIA CONTRO UN MAGISTRATO.
SE QUESTA E’ GIUSTIZIA.
GIUSTIZIA. QUELLO CHE NON SI DICE.
SEI IN CARCERE? CREPA!
SPECULATORI DELLA SOFFERENZA. CHI CI GUADAGNA
SUI DETENUTI?
ASPETTATIVA DI GIUSTIZIA.
DALLA PARTE DELLE VITTIME.
E IL GIUDICE SI TOLSE LA
TOGA PERCHE' NON SOPPORTAVA L'IDIOZIA DEI COLLEGHI.
PERCHE' CI FELICITIAMO
DELLE DISGRAZIE ALTRUI?
SARAH SCAZZI. MEDIA ED
APPROSSIMAZIONE, SE NON DISINFORMAZIONE.
ANNA MARIA FRANZONI:
COLPEVOLE PERCHE' LO HA DETTO LA STAMPA.
IL DELITTO DI GIUSI
POTENZA. SABRINA SANTORO E FILOMENA RITA (FLORIANA) MAGNINI. ACCUSATE
INGIUSTAMENTE MA PER LA STAMPA RESTERANNO "COLPEVOLI E PUTTANE" PER SEMPRE.
MELANIA REA. OMICIDI E
SETTE SATANICHE? NON SE NE DEVE PARLARE!!
IL FALLIMENTO DEL SISTEMA
INVESTIGATIVO. BREMBATE SOPRA:
QUANDO GLI ALTRI SIAMO NOI. IL DELITTO DI YARA GAMBIRASIO.
IL FALLIMENTO DEL SISTEMA
INVESTIGATIVO. AVETRANA IL DELITTO DI SARAH SCAZZI.
IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA. LA STRAGE DI ERBA. OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI.
IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA. FABRIZIO CORONA COLPEVOLE DI SFRONTATEZZA ED
ARROGANZA.
IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA. DELITTO DI MELANIA REA. SALVATORE PAROLISI CON IL
MOVENTE INTERSCAMBIABILE.
GRAVINA DI PUGLIA: CICCIO E
TORE PAPPALARDI. STORIA DI ORDINARIA ITALIANITA'.
PER NON DIMENTICARE. STORIE
DI ORDINARIA FOLLIA. L'ESEMPLARE STORIA DI ANTONIO GIANGRANDE. PERSEGUITATO
PERCHE' RACCONTA LA VERITA'.
RIMESSIONE DEI PROCESSI PER
LEGITTIMO SOSPETTO. UNA NORMA DISATTESA.
PER NON DIMENTICARE.
OTTAVIA DE LUISE.
PER NON DIMENTICARE.
MAURIZIO BOLOGNETTI E GIUSEPPE DI BELLO. COLPEVOLI DI ESSERE INNOCENTI.
ELISA CLAPS ED IL NIDO DI
SERPI.
INSABBIAMENTI E CENSURA A
POTENZA.
INSABBIAMENTI: A POTENZA UN MURO DI GOMMA.
TOGHE LUCANE. INCHIESTA CHE
NON SA DA FARE.
IL MISTERO DELLA MORTE DEI
FIDANZATI DI POLICORO. LUCA ORIOLI E MARIROSA ANDREOTTA.
INSABBIAMENTI: SE SUCCEDE A LORO, FIGURIAMOCI AI POVERI CRISTI !!!!!
DELITTO DI MEREDITH
KERCHER. AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO. MA CHE GIUSTIZIA E’ QUESTA?
OMICIDI DI STATO. IL CASO
BIANZINO.
OMICIDI DI STATO. GIUSEPPE
UVA.
OMICIDI DI STATO. FEDERICO
ALDROVANDI.
IL CASO DEL DELITTO DI
SIMONETTA CESARONI. RANIERO BUSCO E PIETRINO VANACORE.
MANOLO ZIONI IN CARCERE DA
INNOCENTE.
OMICIDI DI STATO. LUIGI
MARINELLI.
OMICIDI DI STATO. STEFANO
CUCCHI.
OMICIDI DI
STATO. MICHELE FERRULLI.
CONDANNATI PREVENTIVI. LA CONDIZIONE DEGLI
INNOCENTI IN CARCERE.
TARANTO FORO DELL’INGIUSTIZIA.
SOLO A TARANTO. ILVA, SARAH SCAZZI, BEN
EZZEDINE SEBAI. AVVOCATI SUCCUBI DEI MAGISTRATI.
L'INGIUSTIZIA RACCONTATA
DAGLI ADDETTI AI LAVORI.
INGIUSTIZIA, OSSIA
GIUSTIZIA NON UGUALE PER TUTTI.
A
PROPOSITO DI GIUSTIZIA. QUELLO CHE LA
STAMPA NON DICE.
CARCERE E STORIE DI
ORDINARIA INGIUSTIZIA.
CARA INGIUSTIZIA.
GLI INNOCENTI IN GALERA.
IL COSTO DEGLI ERRORI GIUDIZIARI.
PARLIAMO DI GIUSTIZIA E
GIUSTIZIERI. L'ITALIA IN MANO AI MAGISTRATI.
LETTERE DAL CARCERE.
INTERVISTA AL PROCURATORE CAPO.
CENTO VOLTE INGIUSTIZIA.
TROPPI ERRORI GIUDIZIARI:
CHI PROTEGGE GLI INNOCENTI?
EURISPES: RAPPORTO SUL
PROCESSO PENALE.
DATI MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PENITENZIARIO. CARCERE: ICONA DELL'INGIUSTIZIA.
ABUSI E VIOLENZE SUI
DETENUTI: UN DOSSIER INFINITO....
NIENTE RISARCIMENTO PER
L'INGIUSTA IMPUTAZIONE.
(IN)GIUSTIZIA: 5 MILIONI
GLI ITALIANI VITTIME DI ERRORI GIUDIZIARI.
IL DIRITTO DI DIFESA:
UGUALE PER TUTTI ???
IMPUNITOPOLI PER I
MAGISTRATI. LA IRRESPONSABILITA’ DEI MAGISTRATI.
MPUNITOPOLI PER I
FUNZIONARI PUBBLICI. FUNZIONARI PUBBLICI: IMPUNITA' ED IMMUNITA'.
MAGISTRATURA: FORTE CON I
DEBOLI E DEBOLE CON I FORTI ???
IL MISTERO USTICA.
IL MISTERO MATTEI.
IL MISTERO MORO.
IL MISTERO SULLA
MASSONERIA.
IL MISTERO PEDOFILIA.
IL MISTERO DEL MOSTRO DI
FIRENZE.
IL MISTERO MOBY PRINCE.
DA MOSTRO A INNOCENTE,
STORIE DI CALVARI.
OMICIDI DI STATO E DI
STAMPA.
MILANO: IL CASO RIZZOLI.
MILANO: IL CASO BERLUSCONI.
MILANO: IL CASO BARILLA’.
MILANO: I CASI MARIANI E
CROSIGNANI
MILANO: IL CASO PALAU
GIOVANNETTI.
CAGLIARI: IL CASO MANUELLA.
NUORO: IL CASO CONTENA.
ROMA: IL CASO ANDREOTTI.
ROMA: IL CASO LUTTAZZI.
ROMA: IL CASO SABANI.
ROMA: IL CASO DELITTO
SIMONETTA CESARONI.
CASERTA: IL CASO OGARISTI.
NAPOLI: IL CASO TORTORA.
BARI: IL CASO LASTELLA.
TARANTO: IL CASO FAIUOLO,
ORLANDI, NARDELLI, TINELLI, MONTEMURRO, DONVITO.
TARANTO: IL CASO PEDONE,
CAFORIO, AIELLO, BELLO.
LECCE: IL CASO DI NAPOLI.
COSENZA: IL CASO MASALA.
CALTANISSETTA: IL CASO
TURCO.
PEDOFILIA. LA FABBRICA DEI MOSTRI.
RIGNANO FLAMINIO E LE SUGGESTIONI. IL CASO
DELLA PEDOFILIA SATANICA.
MODENA E LE SUGGESTIONI. IL
CASO DELLA PEDOFILIA SATANICA.
SOMMARIO TERZA PARTE
GIUSTIZIA CAROGNA.
IL DIRITTO DI CRITICA GIUDIZIARIA.
ENZO MANNINA. IN CONFRONTO ALLA GIUSTIZIA
ITALIANA KAFKA ERA UN DILETTANTE.
ONESTA’ E DISONESTA’.
CULTURA. EMIL ZOLA: L’AFFAIRE DREYFUS ED I
GIORNALI CHE VIVONO DI SCANDALI.
IN NOME DELLO SCANDALO I GIORNALI SBEFFEGGIANO
LA VERITA’.
MARCELLO DELL’UTRI. VITTIMA SACRIFICALE.
NICOLA MANCINO. VITTIMA SACRIFICALE.
CLEMENTE MASTELLA. VITTIMA SACRIFICALE.
CULTURA E CIVILTA’ GIURIDICA. CESARE BECCARIA.
DEI DELITTI E DELLE PENE.
L’INCIVILTA’ GIURIDICA. IL RITO INQUISITORIO.
L’INCIVILTA’ GIURIDICA. LA CRUDELTA’.
DENUNCE A PERDERE.
L'IMPRESA IMPOSSIBILE DELLA RIPARAZIONE DEL
NOCUMENTO GIUDIZIARIO.
LE COMPATIBILITA’ ELETTIVE.
IO SON IO E TU NON SEI UN CAZZO.
COME SI DICE…“CANE NON
MANGIA CANE!”
PARLIAMO DI INGIUSTIZIA E MALAGIUSTIZIA.
COLPA DEI PROCESSI
INDIZIARI...
ASSOLTI. PERO’…
L'INGIUSTIZIA NON E' UNA UTOPIA: E' REALTA'.
MORIRE DI CARCERE.
LA STORIA DELL’AMNISTIA.
ESEMPI SCOLASTICI. SONO ASSOLUTAMENTE
INNOCENTI. NICOLA SACCO E BARTOLOMEO VANZETTI.
PRESUNTO COLPEVOLE.
PRESUNTA COLPEVOLE. ANNA PAGLIALONGA.
PRESUNTO COLPEVOLE. OSCAR SANCHEZ.
PRESUNTO COLPEVOLE. FABRIZIO BOTTARO.
PRESUNTO COLPEVOLE. ANGELO CIRRI.
PRESUNTA COLPEVOLE. ANASTASIA MONTANARIELLO.
PRESUNTO COLPEVOLE. ANTONIO FRANCESCO DI
NICOLA.
PRESUNTO COLPEVOLE. CARMINE FORCELLA.
PRESUNTO COLPEVOLE. DINO TRAPPETTI.
PRESUNTO COLPEVOLE. SANDRO VECCHIARELLI.
PRESUNTO COLPEVOLE. TITO RODRIGUEZ.
PRESUNTO COLPEVOLE. EMANUELE NASSISI.
PRESUNTO COLPEVOLE. FILIPPO DI BENEDETTO.
PRESUNTO COLPEVOLE. FRANCESCO SPANO'.
PRESUNTO COLPEVOLE. JOSE' VINCENT PIERA RIPOLL.
PRESUNTO COLPEVOLE. BRUNO DEL MORO.
PRESUNTO COLPEVOLE. EMMANUEL ZEBAZE SOKENG.
PRESUNTA COLPEVOLE. JOY IDUGBOE.
PRESUNTO COLPEVOLE. MASSIMO MALLEGNI.
PRESUNTO COLPEVOLE. PIO RAGNI.
PRESUNTO COLPEVOLE. MAURIZIO COMINO.
PRESUNTA COLPEVOLE. MONICA BUSETTO.
PRESUNTO COLPEVOLE. GIUSEPPE LA MASTRA.
PRESUNTO COLPEVOLE. GIOVANNI CAMASSA.
PRESUNTO COLPEVOLE. VITTORIO EMANUELE DI
SAVOIA.
PRESUNTO COLPEVOLE. CLAUDIO BURLANDO.
PRESUNTO COLPEVOLE. GIGI SABANI.
PRESUNTA COLPEVOLE. LAURA ANTONELLI.
PRESUNTO COLPEVOLE. ROBERTO RUGGIERO.
PRESUNTO COLPEVOLE. CARLO PALERMO.
PRESUNTO COLPEVOLE. SANDRO FRISULLO.
PRESUNTO COLPEVOLE. CLELIO DARIDA.
PRESUNTO COLPEVOLE. FERDINANDO PINTO
PRESUNTO COLPEVOLE. MARIO SPEZI.
PRESUNTO COLPEVOLE. GIOVANNI TERZI.
PRESUNTO COLPEVOLE. ANTONIO GAVA.
PRESUNTA COLPEVOLE. DANIELA POGGIALI.
PRESUNTO COLPEVOLE. PIER PAOLO BREGA MASSONE.
PRESUNTI COLPEVOLI. GIOVANNI SCATTONE E
SALVATORE FERRARO.
PRESUNTO COLPEVOLE. RAFFAELE SOLLECITO.
PRESUNTA COLPEVOLE. AMANDA KNOX.
PRESUNTO COLPEVOLE. LUCIANO CONTE.
PRESUNTO COLPEVOLE. MARIO CONTE.
PRESUNTO COLPEVOLE. BENIAMINO ZAPPIA.
PRESUNTO COLPEVOLE. MARCO SAVINI.
PRESUNTO COLPEVOLE. OSCAR MILANETTO.
PRESUNTO COLPEVOLE. DIALLO A..
PRESUNTO COLPEVOLE. MARCO SANTESE.
PRESUNTO COLPEVOLE. FRANCESCO FUSCO.
PRESUNTO COLPEVOLE. ANDREA MARCON.
PRESUNTA COLPEVOLE. CHIARA BARATTERI.
PRESUNTO COLPEVOLE. FRANCO MOCERI.
PRESUNTO COLPEVOLE. SALVATORE RAMELLA.
PRESUNTO COLPEVOLE. SALVATORE GRASSO.
PRESUNTI COLPEVOLI. VINCENZO E GIUSEPPE
IAQUINTA.
PRESUNTA COLPEVOLE. BEATRICE CENCI.
PRESUNTO COLPEVOLE. ARMANDO CHIARO.
PRESUNTA COLPEVOLE. EMILIA SALOMONE.
PRESUNTO COLPEVOLE. ALFONSO SABELLA.
PRESUNTO COLPEVOLE. DOMENICO ZAMBETTI.
PRESUNTO COLPEVOLE. AMBROGIO CRESPI.
PRESUNTO COLPEVOLE. ILVO CALZIA.
PRESUNTO COLPEVOLE.
OTTAVIANO DEL TURCO.
PRESUNTA COLPEVOLE. MARTA VINCENZI.
PRESUNTI COLPEVOLI. GIULIO E MARIA FRANCESCA
OCCHIONERO.
PRESUNTO COLPEVOLE. FILIPPO MAGNINI.
PRESUNTO COLPEVOLE. ALEX SCHWAZER.
PRESUNTO COLPEVOLE. MARCO PANTANI.
PRESUNTE COLPEVOLI. SABRINA MISSERI E COSIMA
SERRANO.
PRESUNTI COLPEVOLI. OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI.
PRESUNTO COLPEVOLE. MASSIMO BOSSETTI.
PRESUNTO COLPEVOLE. CATENO DE LUCA.
SONO INNOCENTE.
SONO INNOCENTE. ELAINE ARAUCO DA SILVA.
SONO INNOCENTE. ENZO TORTORA.
SONO INNOCENTE. LORENA MORSELLI.
SONO INNOCENTE. DOMENICO MORRONE.
SONO INNOCENTE. STEFANO MESSORE.
SONO INNOCENTE. ALDO SCARDELLA.
SONO INNOCENTE. MARIA VITTORIA PICHI.
SONO INNOCENTE. PATRIK LUMUNBA.
SONO INNOCENTE. ALBERTO OGARISTI.
SONO INNOCENTE. SAVERIO DE SARIO.
SONO INNOCENTE. FILIPPO LA MANTIA.
SONO INNOCENTE. FULVIO PASSANANTI.
SONO INNOCENTE. VITO GAMBERALE.
SONO INNOCENTE. CARMINE BELLI.
SONO INNOCENTE. PIETRO MELIS.
SONO INNOCENTE. GIUSEPPE GULOTTA.
SONO INNOCENTE. MARIA ANDO’.
SONO INNOCENTE. DIEGO OLIVIERI.
SONO INNOCENTE. CORRADO DI GIOVANNI.
SONO INNOCENTE. LUCIA FIUMBERTI.
SONO INNOCENTE. FRANCESCO RAIOLA.
SONO INNOCENTE. GUIDO BERTOLASO.
SONO INNOCENTE. ANTONIO CARIDI.
SONO INNOCENTE. HASHI OMAR HASSAN.
SONO INNOCENTE. MARIA GRAZIA MODENA.
SONO INNOCENTE. GIUSEPPE MELZI.
SONO INNOCENTI. GIUSEPPE ORSI E BRUNO
SPAGNOLINI.
SONO INNOCENTE. ANGELO
MASSARO.
SONO INNOCENTE. ANNA MARIA
MANNA.
SONO INNOCENTE. CLAUDIO RIBELLI.
SONO INNOCENTE. ANTONIO LATTANZI.
SONO INNOCENTE. JOAN HARDUGACI.
SONO INNOCENTE. VITTORIO LUIGI COLITTI.
SONO INNOCENTE. VITTORIO RAFFAELE GALLO.
SONO INNOCENTE. MICHELE TEDESCO.
SONO INNOCENTE. ROBERTO GIANNONI.
SONO INNOCENTE. SANDRA MALTINTI.
SONO INNOCENTE. GAETANO MURANA.
SONO INNOCENTE. GIUSEPPE SILLITTI.
SONO INNOCENTE. PIO DEL GAUDIO.
SONO INNOCENTE. ANTONIO COLAMONICO.
ALTRI CENTO, MILLE, MILIONI DI INNOCENTI.
TERZA PARTE
GIUSTIZIA CAROGNA.
Io che mi occupo della prassi, ben conoscendo
anche la legge e la sua personalistica applicazione corporativa (dei magistrati)
e lobbistica (degli avvocati), posso dire che ci sono verità indicibili. Mai si
dirà in convegni giudiziari o forensi che da un lato ci sono le misure di
prevenzione (inefficienti ed inique perché mai al passo con i tempi ragionevoli
del processo e spesso incongruenti con le risultanze processuali di assoluzione,
vedi i Cavallotti) e dall’altra le confische (conseguenti a processi dubbi, vedi
Francesco Cavallari, mafioso per associazione, ma senza sodali) ed i
procedimenti fallimentari con le aste truccate. L’arbitrio dei magistrati sia in
fase di misure cautelari e di prevenzione, sia in fase di confisca o di gestione
e vendita dei beni confiscati o sequestrati (anche in sede civilistica con i
fallimenti), non sono altro che strumenti di espropriazione illegale di aziende,
spesso sane, per mantenere in modo vampiresco un sistema di potere, di cui i
magistrati sono solo strumento, ma non beneficiari come lo sono il monopolio
associativo di una certa antimafia o il sistema di gestione che è
prevalentemente forense. Questo sistema è coperto dalla disinformazione dei
media genuflessi a chi, dando vita alle liturgie antimafia, usufruisce dei
vantaggi politici per generare ulteriore potere di restaurazione. Se a qualcuno
interessa ho scritto un libro, “la mafia dell’antimafia”, sui benefici che si
producono per fare antimafia. In più ho scritto “Usuropoli e Fallimentopoli.
Usura e fallimenti truccati”, che parla di usurpazione di beni privati a
vantaggio di un sistema di potere insito nei palazzi di giustizia. Insomma: si
toglie ai poveri per dare ai ricchi. E se qualcuno parla (come Pino Maniaci che
“Muto deve stare”), scatta la ritorsione. Si badi bene: nessuno mi chiamerà per
parlare di questo fenomeno, che è nazionale, in convegni organizzati nei fori
giudiziari, né nessuna vittima pavida di questo fenomeno si prenderà la briga di
divulgare queste verità, attraverso i miei saggi. Ecco perché si parlerà sempre
di aria fritta e non ci sarà mai una rivoluzione che miri a ribaltare la prassi,
più che a cambiare le norme.
Milano, scarcerato grazie a una lettera
aperta dopo 13 anni. Era una condanna definitiva in un
caso di violenza su minore. I giudici e le parole del compagno suicida, scrive
Luigi Ferrarella l'1 novembre 2018 su "Il Corriere della Sera". C’è un uomo che
urla dalla tomba. E il suo grido postumo di innocenza, affidato prima di
suicidarsi nel 2005 a una lettera in busta sigillata conservata a lungo in una
stazione dei carabinieri e mai aperta per 13 anni, ora convince i giudici a
precipitarsi a tirar fuori dal carcere un altro uomo, il suo compagno, benché
questi stia scontando una condanna definitiva per concorso in violenze sessuali
nel 2002 sulla nipotina di 4 anni. E così la Procura generale di Milano,
competente sull’esecuzione della pena del detenuto nel carcere di Pavia, riceve
dalla II Corte d’Appello di Brescia l’ordine di appunto sospendere
immediatamente l’espiazione e liberare il condannato, da subito e fino a quando
la Corte non avrà deciso nel merito l’istanza straordinaria presentata dal
difensore Guglielmo Gulotta per un giudizio di revisione della condanna
definitiva: il presidente Deantoni, la giudice relatrice Milesi e il consigliere
Vacchiano, infatti, reputano «che il prudente apprezzamento» della lettera, e
della proposta difensiva di nuovi test di neuroscienze oggi ancora controversi
ma che 15 anni fa comunque non esistevano, «faccia apparire non infondato il
rischio che il condannato protragga l’espiazione di una pena che potrebbe
rivelarsi ingiusta». Andrà dunque ai (molto rari) tempi supplementari questo
processo dagli esiti altalenanti, che aveva visto l’imputato assolto in primo
grado con rito abbreviato a Busto Arsizio nel 2007 dall’ccusa di aver concorso
(fotografandole) nelle violenze sessuali, asseritamente commesse nell’autunno
2002 dal suo compagno (poi suicida il 15 luglio 2005) sulla figlia di 4 anni
della sorella. In Appello, però, nel 2009 i giudici ribaltarono l’assoluzione in
condanna, a sua volta tuttavia annullata nel 2010 dalla Corte di Cassazione con
rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado. Ma nel 2014 questa Corte d’Appello
bis ricondannò l’imputato, e al secondo passaggio in Cassazione nel 2016 anche
gli ermellini confermarono la sentenza di colpevolezza, rendendo definitivi 4
anni di condanna (fine pena il Ferragosto 2020). Un’altalena di verdetti tutti
ruotanti attorno alle differenti valutazioni dei consulenti tecnici
sull’affidabilità scientifica o meno dei ricordi (sotto forma di «brutto sogno»)
della bimbetta, visto che per il resto la perquisizione a casa non aveva trovato
alcun materiale pedopornografico, e negativo era stato anche l’esito della
perizia sulla pellicola inserita nella macchina fotografica sequestrata. Ma il 6
settembre 2017 in una stazione dei carabinieri, quella dove nel 2005 erano
finiti gli effetti personali del suicida, uno dei succedutisi avvocati recupera
la busta chiusa che fino ad allora nessuno — né i familiari, né i legali, né gli
inquirenti — aveva evidentemente voluto acquisire e aprire. Nella lettera datata
3 e 11 luglio 2005 lo zio materno della bimba, prima di uccidersi il 15 luglio,
appare prostrato per «l’infamia» che da un lato scrive gli stia rovinando la
vita, ma contro la quale dall’altro lato confessa di non avere più la forza di
combattere: «Quello che posso dire è che non ho fatto niente di così schifoso.
Sono innocente, che mi crediate o no». E prima di chiedere che «l’avvocato vada
fino in fondo», l’uomo che sta per uccidersi chiede perdono al suo compagno (e
coimputato) per un gesto «aberrante» che lo lascerà da solo: «Mi sento in colpa
solo verso di lui, che ho tradito, solo per questo».
La malagiustizia esiste e bisogna fare i
nomi, scrive Aldo Grasso il 30 marzo 2012 su "Il
Corriere della Sera". La malagiustizia esiste, non c'è dubbio. Ci sono persone
che, da un giorno all'altro, sono precipitate in un abisso di angoscia per
qualche errore giudiziario e hanno faticato una vita per risalire; altri non ce
l'hanno fatta. «Presunto colpevole», scritto da Sergio Bertolini, Paola
Bulbarelli, Giuseppe Ciulla, Andrea Ruggieri, diretto da Daniele Vismara si
propone di raccontare i drammi di persone che hanno ricevuto accuse infamanti
loro malgrado (Raidue, mercoledì, ore 23.13). Non avevano colpa, ma qualcuno li
ha incriminati. Ora si tenta di dare loro una sorta di risarcimento televisivo.
Per esempio, nella terza puntata, si è parlato di un camionista, Antonio
Francesco Di Nicola, coinvolto in un traffico di stupefacenti per una sbagliata
interpretazione delle intercettazioni. Finito in galera per la superficialità
delle indagini. O di Francesco Spanò accusato ingiustamente di associazione a
delinquere di stampo mafioso e arrestato per uno scambio di persona. O di Marco
Matteucci accusato dall'ex moglie d'aver abusato della sua bambina. Ha penato
sette anni per essere assolto in appello. Le storie sono commentate in studio
dall'attore Fabio Massimo Bonini che finge di parlare a un microfono radiofonico
nello stile di Jack Folla, il prigioniero di «Alcatraz» inventato da Diego
Cugia. E questa è la parte più debole del programma, quasi si volesse affidare a
una Superiore Voce Etica l'anticipazione del giudizio universale. Ovviamente è
giusto denunciare i casi di malagiustizia, ma forse era il caso di fare nomi e
cognomi. Chi è il magistrato che ha fatto arrestare Antonio Francesco? Chi è il
responsabile dell'ingiusta detenzione di Francesco? E chi ha assecondato le
vendette dell'ex moglie? Nomi e cognomi, altrimenti si spara nel mucchio, si
alimenta un generico malcontento contro una magistratura composta in prevalenza
di «manettari» e «mozzaorecchi». Nomi e cognomi, please.
Quei 24 mila ingiustamente detenuti,
scrive il 5 luglio 2016 "L'Inkiesta". Basta una intercettazione mal trascritta,
uno scambio di persona, una superficialità investigativa o una disattenzione del
magistrato. 24 mila i casi dal 1992, ma quando non si tratta di politici o vip
il tema perde interesse. L’Italia è quel Paese in cui dal 1992 a oggi lo Stato
ha pagato 630 milioni di risarcimenti per ingiusta detenzione per un totale di
24 mila casi. In maggioranza signori nessuno, eppure il più classico garantismo
«a targhe alterne», a parte qualche lodevole eccezione, si solleva solo quando i
nomi sono noti, per di più politici o capitani d’industria. Dedicato a quei nomi
che subito si dimenticano è il progetto di due giornalisti e un avvocato che è
stato prima un libro, poi un sito e infine è diventato un docufilm. I tre sono
Benedetto Lattanzi, Valentino Maimone e l’avvocato Stefano Oliva che hanno
lavorato a “Non voltarti indietro”, primo docufilm sugli errori giudiziari in
Italia con la regia di Francesco Del Grosso. «La genesi del docufilm - spiega
a Linkiesta Benedetto Lattanzi - ha origini lontane. All’inizio degli anni ’90
dopo i casi Tortora e soprattutto quello di Lanfranco Schillaci (accusato di
violenza sessuale nei confronti della figlia, salvo poi scoprire che si trattava
di un tumore) ci siamo avvicinato al fenomeno iniziando a raccogliere storie e
materiale sugli errori giudiziari». Quel materiale diventa il libro “100 volte
giustizia” e sono raccolte cento storie dal 1948 al 1996. Da lì Lattanzi e il
collega Maimone continuano a raccogliere storie, perché gli errori continuano a
esserci. Ce ne sono tanti che i due si trovano a decidere se fare una seconda
edizione di “100 volte giustizia” oppure virare su un progetto più ampio. Le
storie sono diventate 675, così i due giornalisti decidono di aprire il
sito errorigiudiziari.com e inserire un database. A loro si affianca l’avvocato
Stefano Oliva, che tra quei 675 ha avuto diversi clienti e soprattutto si
dimostra sensibile al tema. In quella “enciclopedia” dell’errore giudiziario c’è
di tutto. Dal noto caso di Giuseppe Gulotta, in carcere da innocente per 22 anni
e risarcito con 6,5 milioni di euro, alla vicenda di Giancarlo Noto che per uno
scambio di persona di un testimone oculare passa tre giorni dietro le sbarre,
salvato poi da un test del DNA, passando per Patrick Lumumba coinvolto nel caso
di Meredith Kercher. Nell’archivio fa capolino anche Giuseppe Santangelo
condannato ingiustamente insieme a Gulotta per la strage di Alcamo nel 1977 in
cui persero la vita due Carabinieri. Gaetano Santangelo, si legge sul sito, era
stato individuato come uno degli autori del duplice omicidio, insieme con
Giuseppe Gulotta e Vincenzo Ferrantelli. Nella sentenza di primo grado, Gulotta,
Santangelo e Ferrantelli vennero ritenuti colpevoli: il primo fu condannato
all’ergastolo, gli altri due a 20 anni di reclusione. Poco prima dell’esecuzione
della pena Santangelo fuggì in Brasile con Ferrantelli, dove entrambi ottennero
lo status di rifugiato politico. Da lì presentarono, attraverso i propri legali,
un’istanza di revisione del processo che fu accolta: la condanna fu cancellata e
la Corte d’Appello di Catania stabilì un risarcimento per errore giudiziario di
1 milione e 100 mila euro a ciascuno di loro. Ma non è finita, perché i legali
dei due hanno presentato un’ulteriore richiesta di 12 milioni di euro per danno
patrimoniale, biologico e morale. Una richiesta analoga a quella presentata da
Gulotta. In Italia dal 1992 sono stati pagati 630 milioni di risarcimenti per
ingiusta detenzione su un totale di 24 mila casi. Poi c’è Fabrizio Bottaro,
designer di moda romani, 40 anni, che nel 2011 attraversa un calvario lungo 10
mesi. Accusato di rapina dopo il racconto di un testimone si scoprirà poi che
Bottaro sul luogo semplicemente non poteva esserci: si trovava a Marbella in
vacanza. Sarebbe bastato un controllo sulle liste dell’albergo oppure alle
videocamere a circuito chiuso dello stesso. Un virus quello dell’errore che si
insinua soprattutto in fase di indagine, magari con la trascrizione di una
intercettazione telefonica sbagliata che poi origina una interpretazione da
parte della magistratura inquirente che va verso una direzione che non è quella
giusta. In questo giocano dunque un ruolo fondamentale non solo i magistrati, ma
anche periti e Forze dell’Ordine. Insomma, c’è materiale sufficiente perché dal
sito si passi al docufilm. A fare la proposta ai due giornalisti e all’avvocato
Oliva è il regista Francesco del Grosso che ha curato la realizzazione del
prodotto che ha iniziato il suo giro d’Italia, da Catania a Pesaro, passando per
Ischia, mentre è atteso il 9 luglio all’Ortigia Film Festival e al Salento
Finibus Terrae il 25 luglio. Gli errori continuano, e spesso i magistrati
italiani vengono accusati di un eccessivo ricorso alla custodia cautelare, cioè
dell’arresto e detenzione prima del termine del processo. Errori che mai nessuno
vorrebbe attraversare, ma che in Europa non sono una eccezione, e anzi da notare
come in alcuni Paesi non esistano risarcimenti per ingiusta detenzione. «La Gran
Bretagna - ha detto di recente a La Stampa Mauro Palma, garante nazionale dei
diritti delle persone private della libertà e già presidente del Comitato
Europeo per la Prevenzione delle Torture - non prevede alcun indennizzo per
ingiusta detenzione, la Bulgaria paga con grandi ritardi, mentre l’Olanda, per
esempio, ha un meccanismo molto simile al nostro» e i numeri, conferma Palma,
non sono granché differenti: «Penso che gli errori italiani rientrino nella
fisiologia del sistema e non nella sua patologia. Mi pare anche che la riforma
della responsabilità civile sia un buon compromesso, perché un giudice non può
vivere sotto la spada di Damocle della causa, soprattutto in un Paese dove ci
sono la mafia, la ‘ndrangheta e la camorra, che in genere hanno avvocati molto
in gamba e molto ben pagati. Certo, bisognerebbe cercare di arrestare il meno
possibile e anche lavorare di più sugli automatismi che portano all’applicazione
della custodia cautelare».
IL DIRITTO DI CRITICA GIUDIZIARIA.
L’assoluzione di Giuliano Ferrara,
denunciato da Nino Di Matteo. Giusto criticare i magistrati. Parola di giudice,
scrive Errico Novi il 13 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Non esiste un’immunità
rispetto alle critiche, per i magistrati. È questa la motivazione con cui il
giudice di Milano Maria Teresa Guadagnino ha assolto Giuliano Ferrara
dall’accusa di aver diffamato il pm Nino Di Matteo. Sembra niente. Sembra una
normale sentenza. E in effetti all’atto di pronunciarla, lo scorso 12 dicembre,
il giudice monocratico del Tribunale di Milano Maria Teresa Guadagnino non aveva
fatto scalpore. Ma a leggere le motivazioni cambia tutto. La sentenza introduce,
o meglio ripristina, un principio tacitamente soppresso negli ultimi anni: il
«diritto di critica giudiziaria», come lo definisce la magistrata. Si tratta del
processo per “diffamazione aggravata” innescato da una denuncia del pm di
Palermo Nino Di Matteo nei confronti del fondatore del Foglio Giuliano Ferrara.
Il quale, in un editoriale pubblicato il 22 gennaio 2014, aveva espresso
valutazioni molto severe nei confronti del sostituto di Palermo. Nel suo mirino,
è ovvio, la madre di tutti i processi infiniti, ovvero l’inchiesta sulla
cosiddetta trattativa Stato- mafia. Secondo Ferrara «traballante» e poco seria.
Critiche certo inasprite da altri aspetti segnalati nell’articolo, come la
«spaventosa messa in scena» dei colloqui tra Totò Riina e il suo compagno d’ora
d’aria nel carcere di Opera, Alberto Lorusso. Di Matteo ritenne che l’invettiva
scagliata da Ferrara sull’indagine fosse intollerabile. A maggior ragione in
quanto connessa alle “clamorose rivelazioni” del capo dei capi, secondo il
giornalista architettate da «qualche settore d’apparato dello Stato italiano»
per «mostrificare il presidente della Repubblica, calunniare Berlusconi e
monumentalizzare Di Matteo e il suo traballante processo». Ma per la giudice il
fatto addebitato al fondatore del Foglio «non costituisce reato» perché, come si
legge nelle motivazioni, «è assolutamente lecito che un giornalista esprima la
propria opinione in merito a un processo così rilevante, anche sotto il profilo
politico, criticando metodi utilizzati e/ o risultati ottenuti dai magistrati».
In tal senso, secondo la magistrata milanese, «non appare censurabile il
riferimento, nell’ultima parte dell’articolo, al “rito palermitano” e alla
ritenuta mancanza di serietà delle inchieste giudiziarie». È il concetto di
magistrato criticabile al pari del politico, che fa breccia. Anche perché negli
ultimi mesi, di attacchi anche violenti, nei confronti di altri giudici, si
erano pure visti: ma solo nei casi in cui avevano adottato provvedimenti
garantisti. Un esempio su tutti: il gip di Reggio Emilia Giovanni Ghini, contro
il quale erano state organizzate persino manifestazioni di piazza, per
un’ordinanza meno restrittiva rispetto alla custodia in carcere invocata dalla
Procura. Adesso, grazie alla dottoressa Guadagnino, scopriamo che si possono
criticare pure i magistrati che teorizzano ignobili accordi e vergognose
compromissioni. L’editoriale al centro del processo era intitolato “Riina, lo
Stato come agente provocatore. Subito un’inchiesta”. Ebbene, secondo la giudice,
«è evidente che la libertà, riconosciuta dall’articolo 21 della Costituzione e
dall’articolo 10 della Cedu, di manifestazione del pensiero e di formulazione di
critica nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche comprenda il diritto di
critica giudiziaria ossia l’espressione di dissenso, anche aspro e veemente, nei
confronti dell’operato dei magistrati i quali, in quanto tali, non godono di
alcuna immunità, nonché degli atti da costoro compiuti». Diritto di critica.
Giudiziaria. Una categoria declassata al rango di sacrilegio. E invece, si legge
nelle motivazioni depositate dalla giudice della IV sezione penale di Milano,
«il giornalismo scomodo e polemico di Ferrara, certamente non privo di
espressioni allusive e iperboliche e di espedienti retorici, non persegue
l’obiettivo di ledere l’onore e la reputazione della persona offesa ma solo
quello di disapprovare alcuni fatti e comportamenti connessi al processo che
ancora si sta svolgendo davanti alla Corte d’assise di Palermo». Legittimo.
Sembra niente. E invece è una mezza rivoluzione.
IN CONFRONTO ALLA GIUSTIZIA ITALIANA KAFKA ERA
UN DILETTANTE.
Situazione kafkiana.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K.,
perché senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato.» (Franz
Kafka, Il processo, incipit). Il termine "kafkiano" è un neologismo della lingua
italiana che indica una situazione paradossale, e in genere angosciante, che
viene accettata come status quo, implicando l'impossibilità di qualunque
reazione tanto sul piano pratico quanto su quello psicologico. Il termine deriva
da Franz Kafka, la cui opera è ricca di situazioni di questo tipo; si pensi per
esempio a Il processo, Il castello, o America. Un termine equivalente potrebbe
essere perturbante nell'accezione freudiana: qualcosa che è estraneo e familiare
ad un tempo, e risuona inquietante proprio per questa sua ineliminabile e
spiazzante ambiguità. Uno degli esempi più paradigmatici di situazione
"kafkiana" è forse proprio quella del Processo di Kafka, in cui l'impotenza
(l'impossibilità della reazione) viene messa in relazione, tra l'altro, col tema
della burocrazia giudiziaria. In quest'opera, il protagonista "Josef K." riceve
inaspettatamente la notizia di essere in arresto. Un giorno, trovandosi negli
uffici della banca dove lavora, apre una porta di un ripostiglio e vi trova i
custodi che si erano presentati in casa sua, puniti da un aguzzino, perché Josef
K. si era lamentato del loro comportamento. L'effetto kafkiano del lettore si
scatena però non in questa sorpresa irreale, ma nel constatare il comportamento
del protagonista: egli non reagisce al fatto di trovare dei poliziotti là dove
mai avrebbe pensato ma si preoccupa che i poliziotti non facciano troppo rumore
quando sono frustati. La paura di Josef K. è che i colleghi o i suoi sottoposti
si presentino a vedere cosa succede e scoprano così che egli è sotto processo.
La vergogna per l'indagine, a cui non ci si può opporre (Josef K. non sa neppure
di preciso quale sia l'imputazione) viene così amplificata dal predominare
paradossale del senso del pudore del protagonista. La scena mette bene in
risalto il funzionamento dell'assurdo kafkiano. Cioè creare un contrasto che
sembra irragionevole ma che in realtà rivela un aspetto profondo, sconvolgendo e
spiazzando il lettore.
Situazioni kafkiane nella letteratura e nel
cinema. Nel film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970),
di Elio Petri, il finale è riservato ad una citazione dell'opera
kafkiana: "Qualunque impressione faccia su di noi, egli è servo della Legge e
come tale sfugge al giudizio umano".
Enzo Mannina. Kafka era un dilettante!
Scrive Piero Sansonetti il 27 Settembre 2017 su "Il Dubbio". Storie come
queste, purtroppo, non sono infrequenti. Però se ne parla poco, perché l’idea è
che se uno finisce sotto processo, almeno un po’, è colpevole. E quindi è bene
che paghi. La riassumo in pochissime righe: c’è un tale – un imprenditore – che
viene arrestato e sbattuto in prigione. Siccome ha una azienda e dei beni, gli
sequestrano l’azienda e gli confiscano i beni. Trapani insegna: Kafka era solo
un dilettante… Resta in prigione per anni. Affronta svariati processi. Poi lo
assolvono. Gli dicono: «Oh, scusi, ci siamo sbagliati». Lui dice: allora posso
avere indietro i beni che mi avete confiscato? «Eh, no – gli rispondono –
purtroppo quelli ormai sono dell’erario». Ah. E mentre ancora è stordito per
questa risposta, gli arriva un conto da 3 milioni che gli viene spedito da
“Riscossione Sicilia” per via di alcuni debiti con l’erario che l’azienda – che
ora è tornata sua – ha accumulato durante il periodo di amministrazione
giudiziaria. Deve restituirli, e in fretta. Voi dite: vabbé non è possibile,
manco Kafka si sarebbe immaginato una cosa del genere. Invece è proprio così
Nomi e cognomi. Lui si chiama Enzo Mannina, è di Trapani, oggi ha 56 anni. La
sua azienda si chiama “Mannina Vito Srl”, l’ha fondata suo padre una cinquantina
d’anni fa. Ha 35 dipendenti. Che ora rischiano di restare per strada.
L’ingiunzione della “Riscossione Sicilia” lascia pochi margini: pagare subito,
entro 30 giorni. I 30 giorni scadono l’otto ottobre. Enzo Mannina i tre milioni
non li ha, perché negli ultimi anni ha vissuto molto tempo in cella e ha
guadagnato poco. E i soldi che aveva guadagnato prima, come dicevamo, glieli
hanno confiscati e non glieli ridanno più. E allora che si fa? Figuratevi un
po’, il poveretto – invece che dare di matto, come credo avrebbe fatto chiunque
di noi – ha preso carta e penna per chiedere una rateizzazione. Perché avrebbe
intenzione di riprendere in mano l’azienda, farla fruttare, e piano piano pagare
i debiti e i danni apocalittici combinati dallo Stato e dalla giustizia, i quali
Stato e giustizia non intendono in nessun modo assumersi le loro responsabilità.
Dicono: in fondo alla fine lo abbiamo assolto, dunque ha avuto giustizia. Che
vuole di più? Mannina era stato arrestato nel 2007 nell’ambito di una operazione
che si chiamava “Mafia e Appalti”. Lo accusavano di far parte di Cosa Nostra e
precisamente di essere il vice del capomandamento di Trapani, Francesco Pace. A
quel punto erano scattati anche i sequestri preventivi, diventati poi confische,
e la sua azienda era finita in amministrazione giudiziaria. Ed erano anche
partite tutte le interdittive che avevano bloccato i lavori che gli erano stati
commissionati da enti pubblici. Da quel momento è iniziata una serie infinita di
processi, conclusi con alcune condanne e molte assoluzioni, e accompagnati da
una lunga prigionia: quasi cinque anni. Poi, nel dicembre scorso, dopo un paio
di rimpalli tra Appello e Cassazione, la Corte d’Appello di Palermo lo ha
assolto definitivamente perché il fatto non sussiste. Finita l’odissea penale e
carceraria è iniziata quella economica. Mannina, a 56 anni, si è trovato a dover
ripartire da zero. L’avvocato del signor Mannina (Michele Guitta) ha spiegato il
motivo per il quale non può riavere indietro i soldi che gli erano stati
ingiustamente confiscati. Ha detto che questa situazione è il frutto della
normativa vigente che prevede in caso di confisca definitiva dei beni (che nel
caso di Mannina era scattata dopo la prima condanna) “l’estinzione per
confusione dei crediti erariali”. Avete capito qualcosa? No, neanch’io. Però mi
sono informato. Vuol dire che una volta che ti hanno confiscato i beni, e quei
beni sono finito all’erario, è successo che si sono “confusi” con gli altri beni
dell’erario e non è più possibile “separarli” e dunque renderteli. Restano
dell’erario. Ci dispiace: stavolta è andata male…È chiaro che in questa storia
di mischiano un numero incredibile di errori e di incongruenze della giustizia.
Ho l’impressione però che siano tutti dovuti alla stessa idea: l’idea che la
lotta alla mafia giustifica qualunque sopruso, perché comunque si tratta di
soprusi a fin di bene. E questo sia al momento di immaginare e redigere le
leggi, e le norme, e il meccanismo delle interdittive, sia nello svolgere le
indagini e nel considerare un sospetto qualcosa di molto molto simile a una
prova. E’ la cosiddetta pesca a strascico: la preoccupazione è quello di
colpire, comunque e con durezza. Arrestare, confiscare, bloccare i lavori.
Naturalmente è una preoccupazione ragionevole, nel senso che sarebbe una follia
sottovalutare l’importanza della lotta alla mafia. Solo che è impossibile
combattere la mafia facendo strame del diritto. E purtroppo è molto difficile
far passare questa idea. La conseguenza di questa pesca a strascico è il caso
Mannina. Il quale, vedrete, non appassionerà molto i giornali, i quali, di
solito, a tutto sono interessati fuorché al diritto.
Frankestein ci insegna che i mostri siamo
noi. Compie 200 anni il primo libro di fantascienza
della storia. Fu scritto da una ragazza prodigiosa di soli 19 anni: Mary
Shelley, scrive Daniele Zaccaria il 22 Settembre 2018 su "Il Dubbio". Un’estate
fredda e piovosa, quella del 1816, un gruppo di amici in vacanza sul lago di
Ginevra. La sera bevono vino rosso, flirtano, scherzano e discutono; di poesia,
di scienza, di letteratura, del futuro, il loro gioco preferito è un concorso
letterario in cui ti devi inventare storie di fantasmi, racconti estemporanei
costruiti sulla falsariga del romanzo gotico, genere snobbato dalla critica
letteraria dell’epoca. Ci vuole immaginazione e rapidità di pensiero, la più
brava di tutti è Mary, che è anche la più giovane, 19 anni e un talento
mostruoso. È figlia della filosofa femminista Mary Wollstonecraft e del
romanziere e giornalista William Godwin, il gusto letterario, l’amore per le
scienze, un clima di sferzante anticonformismo accompagnano tutta la sua
infanzia. Con lei a Ginevra ci sono i poeti George Byron e Percy Shelley che
presto diventerà suo marito, il medico e aspirante scrittore John Polidori che
nel 1819 pubblicherà Il Vampiro, primo romanzo della letteratura moderna
dedicato al celebre succhiasangue. Ogni tanto viene a trovarli il fisico e
chimico Humphry Davy, pioniere nello studio dei fenomeni elettrici, scopritore e
mentore del grande Michael Faraday, a sua volta pioniere dell’elettromagnetismo.
È in quelle eccentriche notti a Villa Diodati tra fumi dell’alcol e i lampi di
genio che Mary Shelley concepisce il suo Frankestein, che non è solo un libro
fantasy ma il primo grande romanzo di fantascienza. Il mostro, anzi la Creatura
non è il frutto di un sortilegio, non è il prodotto di oscure forze del male o
di astruse stregonerie, al contrario è figlio della ricerca scientifica, nasce
in laboratorio, il suo fattore è un essere umano, la scintilla della vita è un
“fluido galvanico” che rianima le fibre morte di carni ricucite, come il medico
italiano Galvani faceva contrarre i muscoli dei cadaveri di rana, Viktor
Frankestein, professore di filosofia naturale, crea un essere umano dotato di
coscienza, capace di provare sentimenti estremi come la paura e l’odio e di
consumare una tremenda vendetta nei confronti del “padre”. Nella sua prefazione
Mary Shelley rende omaggio alle esperienze di Galvani, ai lavori di Benjamin
Franklin, alle ricerche poco note di un anatomista chiamato George von Frakenau
che sosteneva la tesi della rigenerazione spontanea della materia inerte.
Aderisce al meccanicismo filosofico che utilizza la metafora della macchina come
schema di spiegazione dei fenomeni naturali. Studi di sapienti e accademici che
legge con passione, per accrescere la sua cultura personale ma soprattutto per
trarre ispirazione letteraria. Viktor Frankestein non è ancora un uomo di
scienza a tutto tondo, vive in bilico tra esoterismo e ragione, cerca
suggestioni anche nel mondo della magia e dell’alchimia, ha letto i libri di
Cornelius Agrippa, un occultista del Rinascimento, si entusiasma per gli scritti
di Paracelso e rimprovera ai suoi colleghi di condurre studi banali e privi di
coraggio. Ma è anche il miglior studente di anatomia e fisiologia alla
prestigiosa Università di Ingolstadt e il più innovativo ricercatore dell’epoca;
ammira la magìa per la sua sfrontatezza, per le biografie “storte” dei suoi
fautori, ma realizzerà il sogno di penetrare il segreto della vita seguendo il
metodo scientifico. Il flusso elettrico che attraversa e anima le carni morte ha
la stessa intensità dei Lumi della ragione che brillavano in Europa. Il tragico
corso di eventi che nasce dal rifiuto della Creatura le cui sembianze abnormi
provocano estremo ribrezzo in Viktor, non è un monito moralista rivolto alla
superbia degli scienziati che osano “sostituirsi a Dio” come hanno scritto in
molti. La malvagità della Creatura è la reazione a una società che non ha la
forza e la maturità di accettare il diverso, il difforme, e che lo emargina
rendendolo un mostro incattivito. La vendetta feroce della Creatura che uccide
il fratello e la moglie del suo creatore è in fondo una reazione umanissima di
un uomo odiato da tutti a causa del suo aspetto esteriore. In questo Viktor
Frankestein ha avuto un successo perfetto, ha creato un essere umano con tutte
le sue debolezze e imperfezioni, con il suo bisogno di amore e la sua sete di
rivalsa. Eppure nel corso dei secoli l’immagine della Creatura, confusa con il
nome del suo creatore, ha subito una progressiva “mostrificazione” rappresentata
poi nel cinema dal colosso con la testa quadrata cosparso di cicatrici, tutto
grugniti e movenze robotiche, un figuro bestiale e repellente privo di
intelligenza e senso morale. Andando nei dettagli Mary Shelley non descrive la
sagoma espressionista di Boris Karlov che tanta fortuna ha avuto
nell’immaginario collettivo, ma un uomo affetto da gigantismo e dall’aspetto
molto sgradevole, nulla di più. Una creatura intelligente, che impara a leggere
e a scrivere, che capisce i sentimenti degli umani e si allontana da loro per
sopravvivere fino al tragico suicidio quando si dà fuoco tra i ghiacci
dell’Artico. Ma noi continuiamo a immaginarlo e a rappresentarlo come
“Frankestein il mostro”, una specie di zombie formato gigante. Perche questo
slittamento? I mostri in fondo ci rassicurano perché sono corpi estranei.
Eccezioni alla regola, anomalie selvagge che non appartengono all’umano.
Presenze minacciose, certo, ma soprattutto entità aliene e reiette dalla
comunità. Le sembianze ibride e deformi fungono da segni visibili delle sventure
di cui il mostro è portatore, mentre le sue mille metamorfosi seguono il corso
dell’immaginario popolare in modo che ogni epoca sia in grado di partorire e di
specchiarsi nei suoi peculiari mostri.
Le società hanno un bisogno disperato di
fabbricarli proprio perché, strappano l’orrore dalla sua dimensione anodina e
quotidiana per assegnarlo al cliché dello straordinario, le loro incursioni nel
mondo reale sono tanto spaventose quanto effimere. Nominato, isolato, eliminato
il mostro, tutto sembra tornare nella norma. Nell’antichità il terrore e il
ribrezzo suscitati dai mostri sono spesso associati allo stupore, alla
contemplazione dei portenti e delle mirabilia di cui queste creature sono
capaci, dei fantasmagorici poteri che sovvertono le leggi della fisica e della
natura come l’invisibilità, l’invulnerabilità o addirittura l’immortalità. Se
non proprio epifanie diaboliche i mostri sono la faccia oscura del divino, una
punizione inviata dal cielo per castigare le nefandezze commesse dagli uomini
come scriveva lo storico romano del IV secolo Giulio Ossequiente nel
celebre Libro dei prodigi, il più accurato elenco di testimonianze di fatti
insoliti, miracolosi e terrificanti avvenuti nel mondo classico. I protagonisti
di cataloghi infernali, di racconti immaginifici popolati da chimere,
basilischi, fenici, arpie, centauri, cerberi, ciclopi e centinaia di altri
esseri dalle indecifrabili fattezze, accompagnano la nostra tradizione religiosa
e letteraria, dalla notte dei tempi. Danno forma e corpo a inquietudini
ancestrali e a timori atavici, ma sono anche squarci meravigliosi
dell’immaginazione umana, straordinarie metafore della nostra capacità di
creazione. Nel suo Manuale di zoologia fantastica Borges ci offre una
incredibile parata di creature soprannaturali, come il Burak, cavalcatura
celeste di Maometto capace di viaggiare nel tempo, o l’Anfesibena, serpente
immaginario che sgretola la linearità dello spazio perché «si muove in due
direzioni allo stesso tempo, possedendo due estremità anteriori». Frankestein
appartiene anch’egli al catalogo multiforme delle creature fantastiche, ma non è
un mostro, non è un’allegoria, la sua esistenza appartiene al campo del
possibile, almeno per quel che immaginavano gli scienziati del 19esimo secolo.
Il vero mostro moderno non fa più parte dell’antico bestiario. Se il freak, lo
storpio, il menomato (dalla donna- scimmia, all’uomo elefante), nella loro
innocua diversità provocano un disgusto misto a sincera compassione, colui che
si macchia di atti e comportamenti mostruosi (ovvero antisociali) non merita
alcuna comprensione o pietà. La sua nemesi si svolge all’ombra di patiboli,
torce e forconi e linciaggi: che si tratti un ammasso di cadaveri ricuciti o di
un realissimo serial killer di una grande metropoli, il mostro viene sempre
catturato e giustiziato. Ecco un’altra trama consolatoria che abbiamo costruito
attorno all’errare dei mostri: farli diventare il capro espiatorio del nostro
malessere. Ma questi individui- mostro costituiscono ancora una volta
un’eccezione alla regola, le loro azioni efferate non rispecchiano la morale
pubblica ma la infrangono, non esprimono un sentimento collettivo, ma rimangono
a loro modo “straordinarie”. Nei suo film a episodi I Mostri (1963) il regista
Dino Risi compie invece l’operazione opposta: il mostruoso viene infatti
ricollocato nel cerchio della normalità, il campionario di bassezze sfoggiato
dai protagonisti, il familismo amorale, la loro incapacità patologica nel
diventare cittadini, membri consapevoli di una comunità, è lo specchio
rovesciato del boom economico e dei suoi sentimenti puliti. Dietro l’ottimismo
di una società che corre spensierata verso un avvenire virtuoso si muove un
popolo cialtrone, dall’indole meschina, ipocrita e, all’occasione, anche
spietata. Sono i nostri genitori, i nostri cugini, i nostri amici più stretti, i
nostri vicini di casa: non più fenomeni da baraccone e terrificanti anomalie, ma
viziosi quanto banali compagni di vita. Così la commedia di costume umanizza il
mostro e mostrifica la società in cui esso vive. E nessuno può più dichiararsi
innocente e irresponsabile rispetto alle piccole, grandi nefandezze che
commettiamo ogni giorno. Proprio come ci insegna il Frankestein di Mary Shelley,
perché i veri mostri siamo noi.
ONESTA’ E DISONESTA’.
1. Era una donna virtuosa, ma
il caso volle che sposasse un cornuto. (Sacha Guitry)
2. L'amore ha diritto di
essere disonesto e bugiardo. Se è' sincero. (Marcello Marchesi)
3. Proposta: "Facciamo il
governo degli onesti!". "Già, e il pluralismo?". (Manetta)
4. Il
socialista più elegante? Martelli. Il più grasso? Craxi. Il più onesto? Manca!
5. Due manager discutono di
come scegliere la segretaria e uno dei due dice di avere un metodo speciale
tutto suo: "Io la ricevo in ufficio e le faccio trovare per terra un biglietto
da 100.000 lire; poi con una scusa mi allontano e osservo quello che succede. La
loro reazione è molto istruttiva". Dopo qualche tempo si reincontrano e il primo
chiede: "Allora, amico mio, come è andata la scelta della segretaria?". "Ho
fatto come mi hai detto: la prima ha raccolto il biglietto e l'ha messo
velocemente nella sua borsetta. La seconda l'ha raccolto e me lo ha
consegnato. La terza ha fatto come se niente fosse". "E quale hai scelto?".
"Quella con le tette più grosse!".
6. La disumanità del computer
sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in
maniera perfettamente onesta (Isaac Asimov).
7. Convinto dalla tangente, il
cerchio accettò di trasformarsi in quadrato. L'angolo invece rifiutò: era sempre
stato retto e tale voleva restare.
8. Come ci sono oratori
balbuzienti, umoristi tristi, parrucchieri calvi, potrebbero esistere benissimo
anche politici onesti. (Dario Fo)
9. A volte è difficile fare la
scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della
fame. (Totò in "La banda degli onesti")
10. C'è un modo per scoprire
se un uomo è onesto: chiedeteglielo. Se risponde di sì, è marcio. (Groucho Marx)
11. Se la canaglia impera, la
patria degli onesti è la galera (proverbio italiano)
12. L'onestà paga.
La disonestà è pagata. (Silvia Ziche)
13. Definizione di corrotto:
vezzeggiativo politico. (S. M. Tafani)
14. Il segreto della
vita è l'onestà e il comportarsi giustamente. Se potete simulare ciò lo avete
raggiunto. (Groucho Marx)
15. Niente assomiglia tanto a
una donna onesta quanto una donna disonesta di cui ignori le colpe.
16. Se l'esperienza insegna
qualcosa, ci insegna questo: che un buon politico, in democrazia, è tanto
impensabile quanto un ladro onesto. (H.L Mencken)
17. Nel dolore un orbo è
avvantaggiato, piange con un occhio solo. (Antonio (Totò) in "La banda degli
onesti")
18. L'onestà è la chiave di
una relazione sentimentale. Se riuscite a far credere di essere onesti, siete a
cavallo. (Richard Jeni)
19. L'onestà è lodata da
tutti, ma muore di freddo. (Giovenale)
20. "Jim, dove posso trovare
dieci uomini onesti?". "Cosa? Diogene si sarebbe contentato di trovarne uno".
(Robert A. Heinlein, Cittadino della galassia)
21. A molti non mancano che i
denari per essere onesti. (Carlo Dossi)
22. Le donne oneste non
riescono a consolarsi degli errori che non hanno commesso. (SachaGuitry)
23. Un politico onesto è
quello che una volta "comprato" resta comprato. (Legge di Simon Cameron)
24. Le persone oneste e
intelligenti difficilmente fanno una rivoluzione, perché sono sempre in
minoranza. (Aristotele)
25. "Signora - dice la nuova
cameriera - in camera sua, sotto il letto, ho trovato questo anello!". "Grazie
Rosi. L'avevo messo apposta per controllare la sua onestà". "E' proprio quello
che ho pensato anch'io, signora!".
26. Ero veramente un uomo
troppo onesto per vivere ed essere un politico. (Socrate)
27. Un governo d'onesti è come
un bordello di vergini. (Roberto Gervaso)
28. Si dice: "La disonestà dei
politici non paga mai!". E' vero. Generalmente riscuote.
29. Sei onesta come le mosche
d'estate, al mattatoio, che rinascono dalla loro stessa merda. (dall'Otello)
(William Shakespeare)
30. A volte mi viene il
sospetto che avere la fama di essere scrupolosamente onesto equivalga a un
marchio di idiozia. (Isaac Asimov)
31. In tutta onestà, non credo
nell'onestà.
32. Un uomo onesto può essere
innamorato come un pazzo, ma non come uno sciocco. (François de
La Rochefoucauld) 33. Ammetto di essere onesto. Ma se si sparge la voce, sono
rovinato: nessuno si fiderà più di me. (Pino Caruso)
34. Donne oneste ce ne
sono più di quelle che non si crede, ma meno di quelle che si dice.
(Alessandro Dumas figlio) (in "L'amico delle donne")
35. La
principale difficoltà con le donne oneste non è sedurle, è portarle in un luogo
chiuso. La loro virtù è fatta di porte semiaperte. (Jean Giraudoux)
36. Una volta l'onestà, in un
individuo, era il minimo che gli si richiedesse. Oggi è un
optional. (Maurizio Costanzo)
37. Le anime belle, le
figurine del presepe, le persone oneste... Ne ho conosciute tante, erano tutte
come te. Facevano le tue domande, e con voi il mondo diventa più fantasioso, più
colorato... Ma non cambia mai !! (Il ministro Nanni Moretti a Silvio Orlando in
"Il portaborse")
38. Non è grave il clamore
chiassoso dei violenti, bensì il silenzio spaventoso delle persone oneste.
(Martin Luther King)
39. Era così onesto che
quando trovò un lavoro, lo restituì.
40. Mi piace un soprabito
scoperto dagli americani, il koccomero, quello che si aggancia con i
calamari. (Totò in "La banda degli onesti")
41. Il tipografo Lo Turco
ammira tutto l'armamentario per fabbricare banconote false: "Ma questa
è filagrana!". Toto': "Sfido io! Viene dal policlinico dello Stato!". (In "La
banda degli onesti")
42. L'onestà nella
compilazione della dichiarazione dei redditi viene considerata in Italia una
forma blanda di demenza. (Dino Barluzzi)
43. Non abbiamo bisogno di
chissà quali grandi cose o chissà quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno di
più gente onesta. (Benedetto Croce)
44. Ci sono fortune che
gridano "imbecille" all'uomo onesto. (Edmond e
Jules de Goncourt)
45. L'onestà dovrebbe essere
la via migliore, ma è importante ricordare che, a rigor di logica, per
eliminazione la disonestà è la seconda scelta. (George Carlin)
46. In Italia si ruba
con onestà, rispettando le percentuali. (Antonio Amurri)
47. I nordici prendono il
caffè lungo, noi sudici lo prendiamo corto. (Totò in "La banda degli onesti")
48. Ben poche sono le donne
oneste che non siano stanche di questo ruolo. (FriedrichNietzsche)
49. L'onestà è un lusso che i
ricchi non possono permettersi. (Pierre de Coubertin)
50. Neanche la disonestà può
offuscare la brillantezza dell’oro.
51. Ti ho insegnato ad essere
onesto, perché intelligente non sei. (Bertold Brecht)
52. L'onestà paga, ma pare non
abbastanza per certe persone. (F. M. Hubbard)
53. Nessuna persona onesta si
è mai arricchita in breve tempo. (Menandro)
54. Nessuno può guadagnare un
milione di dollari onestamente. (No one can earn a million
dollars honestly).
(William Jennings Bryan)
55. Sicuramente ci sono
persone disoneste nei governi locali. Ma è anche vero che ci sono persone
disoneste anche nel governo nazionale. (Richard Nixon)
56. Le persone oneste si
riconoscono dal fatto che compiono le cattive azioni con più
goffaggine. (Charles Péguy)
57. L'onestà, come tante altre
virtù, dipende dalle circostanze. (Roberto Gervaso)
58. Nessun uomo può guadagnare
un milione di dollari onestamente, così come è disonesto ed invidioso chi
dichiara il contrario. (Antonio Giangrande)
59. Colmo per un uomo retto:
innamorarsi di una donna tutta curve.
60. Una politica onesta
proietta una nazione sana nel futuro. Per questo si chiama
Fantascienza. (Mauroemme)
61. Per il mercante anche
l'onestà è una speculazione. (Charles Baudelaire)
62. In politica l'onestà è
forse la cosa più importante. Chi ce l'ha deve partire con un grosso handicap!
(Bilbo Baggins)
63. Dimettersi per una multa è
soprattutto un ennesimo esempio della severità del rapporto tra etica e politica
in Gran Bretagna. Tranquilli, ci pensiamo noi qua a ristabilire l'equilibrio
europeo. (Annalisa Vecchiarelli)
64. La massima ambizione
dell'uomo? Diventare ricco. Come? In modo disonesto, se è possibile; se non
è possibile, in modo onesto. (Mark Twain)
65. Era un uomo così onesto e
probo, da non essere neanche capace d'ingannare il tempo... (Fabio Carapezza)
66. Se l'esperienza ci insegna
qualcosa, ci insegna questo: che un buon politico, in democrazia, è tanto
impensabile quanto un ladro onesto.
67. La disperazione più grave
che possa colpire una società e' il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
(Corrado Alvaro)
68. In un'epistola Orazio
fustiga un doppiogiochista della morale che, ammirato da tutto il popolo, offre
un bue e un porco agli dei, pregando Giove e Apollo ad alta voce. Ma subito dopo
si rivolge a LAVERNA, dea protettrice dei ladri e a fior di labbra, in modo che
nessun lo intenda, prega: "Laverna bella, fammi la grazia ch'io possa imbrogliar
il prossimo, concedi ch'io passi per un galantuomo, un santo, e sopra i miei
peccati distendi la notte, sopra gli imbrogli una nube". (Orazio)
69. Ingiuriare i mascalzoni
con la Satira è cosa nobile, a ben vedere significa onorare gli
onesti. (Aristofane)
70. L'onestà andrà di
moda. (Beppe Grillo)
71. L'onestà è sempre la
migliore scelta... ma spesso bisogna seguire la seconda scelta.
72. Odiare i mascalzoni è cosa
nobile. (Quintiliano)
73. Uomini onesti si lasciano
corrompere in un solo caso: ogniqualvolta si presenti l'occasione. (Gian Carlo
Moglia)
74. Maresciallo: "...hanno
arrestato anche il tipografo". Totò: "Lo Turco!!". Maresciallo: "No, lo
svizzero". Totò: "Allora mi ha dato un nome falso!!" (Totò in "La banda degli
onesti")
75. Portieri si nasce, non si
diventa. (Totò in "La banda degli onesti")
76. Perchè anch'io,
modestamente, nella media borghesia italiana occupo una società... condomini
che vanno e che vengono, che quando è natale, pasqua mi danno la mancia, per il
mio nome mi regalano lumini..." (Totò ne "La banda degli onesti")
77. Ho mandato mia moglie e i
miei figli a un funerale, così si divagano un po'. (Totò' ne "La banda degli
onesti")
78. Tanto Gentile il
segretario pare se si dimette
e la poltrona sua saluta
e ogni lingua de li colleghi
trema muta
che
altrimenti vorrebber commentare.
Egli si va,
sentendosi laudare,
per la rinuncia
d’umiltà vestuta,
e par quasi fosse cosa non
dovuta
ma invece scelta per obbligo
morale.
Che il popolino l’onestà
l’ammira,
e dà agli illusi una dolcezza
al core,
chi se ne va senza aspettar
altre prove.
Ma i peggiori non v’è modo li
si muova,
né per decenza oppur spinti
dall’onore,
che sol per la poltrona
l’anima lor sospira. (Bilbo Baggins)
79. L'onestà non paga. Se vuoi
fare l'onesto lo devi fare gratis. (Pino Caruso)
80. Ricòrdati che l'onestà
paga sempre! Specialmente le tasse! (Renato R.)
81. La madre dei cretini è
sempre incinta. Quella degli onesti ormai è in menopausa.
82. L'onestà è un lusso che i
ricchi non possono permettersi. (Pierre de Coubertin)
83. Sto cercando di fare di
mio figlio un italiano onesto, leale, corretto, solidale, amante della
giustizia... "Un disadattato, insomma". (Stefano Mazzurana)
84. Io sono onesto. Contro
chi devo scagliare la prima pietra? (Renato R.)
85. Nigeriano disoccupato
trova 4.350 euro e li restituisce. Bisogna dire basta a questi gesti
inappropriati, se vengono nel nostro paese devono rispettare le nostre regole.
Che sono venuti qua ad insegnarci l'onestà? (Barbara Zappacosta)
86. Viviamo tempi in cui se
dici "onesto!" a qualcuno, rischi d'offenderlo... (Alessandro Maso)
87. Sono una persona molto
onesta e corretta. Mi sento un verme anche quando, ad un incontro, inganno
l'attesa. (DrZap)
88. Secondo un emendamento del
decreto milleproroghe, il M5S verrà multato per aver rifiutato i rimborsi
elettorali. Sancendo la nascita di un nuovo reato: ONESTARE. (Kotiomkin)
(Giovy Novaro)
Il "no" di Benedetto Croce al moralismo
in politica. L'edizione nazionale dell'opera del
pensatore ci restituisce i testi completi sul rapporto tra l'etica e la cosa
pubblica, scrive Giancristiano Desiderio, Giovedì 26/05/2016, su "Il Giornale".
È curioso, ma gli italiani quando si tratta di curare malanni e malattie non
chiedono un onest'uomo, sì piuttosto un buon medico, onesto o disonesto che sia,
purché sappia il fatto suo e non li mandi anzitempo all'altro mondo mentre
quando ci sono in ballo le cose della politica gli italiani richiedono non
uomini pratici e d'azione ma onest'uomini o, almeno, così dicono. Cos'è, dunque,
l'onestà politica? Se lo chiedeva in modo diretto Benedetto Croce e rispondeva
in modo altrettanto diretto: «L'onestà politica non è altro che la capacità
politica: come l'onestà del medico e del chirurgo è la sua capacità di medico e
di chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza
condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze». Lo scritto
intitolato proprio così - L'onestà politica - è il frammento XXXVII dei
Frammenti di etica che uscì in volume nel 1922 e che nel 1931 andò a comporre,
insieme con altri scritti, l'importante volume Etica e Politica. Ora la casa
editrice Bibliopolis, che cura l'Edizione Nazionale delle Opere di Benedetto
Croce, sta per mandare in libreria a cura di A. Musci proprio Etica e Politica
nella edizione completa del 1931 riproducendo il testo nell'edizione ne varietur
del 1945. In questo modo il lettore che segue le uscite delle opere crociane
avrà modo di avere in un unico testo i quattro libri che compongono il volume:
appunto, i Frammenti di etica del 1922, gli Elementi di politica del 1925, gli
Aspetti morali della vita politica del 1928 e il Contributo alla critica di me
stesso che uscì per la prima volta nel 1918 in cento copie stampate da Riccardo
Ricciardi, l'amico editore di Croce che il filosofo chiamava con affetto
Belacqua. Gli scritti raccoglievano nella maggior parte dei casi testi già
pubblicati sin dal 1915 su riviste e periodici: anzitutto La Critica, e poi La
Diana di Fiorina Centi, il Giornale Critico della Filosofia Italiana di Gentile,
Politica di Alfredo Rocco e Francesco Coppola, gli Atti dell'Accademia di
Scienze morali e politiche della Società reale di Napoli, i Quaderni critici di
Domenico Petrini e La Parola di Zino Zini. In qualche caso anticipazioni e
estratti erano già comparsi su quotidiani d'ispirazione liberale e conservatrice
come Il Resto del Carlino di Tomaso Monicelli o Il Giornale d'Italia di Alberto
Bergamini e Vittorio Vettori. L'origine pubblicistica dei testi ci fa aprire gli
occhi sulla qualità del giornalismo italiano del secolo scorso. Ma oggi questi
scritti cos'hanno da dire al lettore, son vivi o son morti? Faccia così il
signor lettore, non si fidi di niente e di nessuno, neanche di questa noterella,
prenda in mano il testo e si faccia un'idea sua. Qui, se è possibile, do solo un
consiglio, di guardar le date e notare che gli scritti di politica - gli
elementi - uscirono nel 1925 quando Croce, ormai, era passato all'opposizione di
Mussolini e del fascismo, quando era finita male l'amicizia con Giovanni Gentile
e in quegli scritti il filosofo della libertà marcava tutta la sua differenza
rispetto alle commistioni di pensiero e azione fatte da Gentile e da Mussolini e
rifiutava apertamente ogni morale governativa respingendo la sbagliata e
pericolosa idea hegeliana dello Stato etico: «Nonostante codeste esaltazioni e
codesto dionisiaco delirio statale e governa mentale -diceva- bisogna tener
fermo a considerare lo Stato per quel che esso veramente è: forma elementare e
angusta della vita pratica, dalla quale la vita morale esce fuori da ogni banda
e trabocca, spargendosi in rivoli copiosi e fecondi, così fecondi da disfare e
rifare in perpetuo la vita politica stessa e gli Stati, ossia costringerli a
rinnovarsi conforme alle esigenze che essa pone». Il pregio della posizione
liberale di Croce è proprio qua: nella distinzione tra filosofia e politica,
pensiero e azione; una distinzione che non solo si basava sulla qualità del
giudizio storico che ha la sua virtù proprio nella distinzione ma anche sulla
grande e imperitura lezione di Machiavelli che rendendo autonoma la politica
rese possibile il governo liberale e il controllo dei governanti. Il liberalismo
di Croce ha in sé il realismo politico e questo gli consente di non degenerare
né nell'utopia né nel giusnaturalismo e di essere oggi come allora un pensatore
antitotalitario che si oppose non solo al fascismo ma anche al comunismo.
Tuttavia, qui giunto, vorrei dare al lettore, se mi è concesso e se non lo
infastidisco, un altro consiglio non richiesto: inizi la lettura dal Contributo
alla critica di me stesso, un gioiello di pensiero, umanità e letteratura.
Forse, è il modo migliore non solo di avvicinarsi a quest'opera ma anche di
avvicinarsi a Croce e di entrare nel suo mondo che è tutto ispirato dalla
libertà umana e improntato alla sua promozione e custodia. La lezione viva che
si può ricavare da Etica e Politica è quella di non cadere nelle illusioni e nei
miti della politica e della vita pratica e di conservare quella necessità che
insita nella vita umana: pensare la propria esistenza per non farsi
eccessivamente governare dagli altri.
La “presunta” onestà degli
italiani,
scrive il 2 agosto 2015 don Giorgio De Capitani. In questi ultimi tempi, anche a
causa delle polemiche inerenti ai profughi che, dietro ordini delle
Prefetture, vengono smistati e messi in alcuni locali dismessi dei Comuni, è
uscita di colpo la “presunta” onestà dei cittadini italiani. Anche sul mio sito,
ho letto frasi simili: da 50 anni pago le tasse, ho lavorato e sudato
onestamente, ed ecco che arriva questa gente, per non dire “gentaglia”, che mi
fa sentire cittadino di serie B o Z, quasi umiliato nei miei diritti, eccetera,
eccetera. C’è un giornale online locale, Merateonline, dove, ogni giorno, magari
con la soddisfazione del suo Direttore, appaiono lettere e lettere di cittadini
frustrati dalla presenza di questi “loschi” individui, che non pagano le tasse,
non lavorano, anzi li disturbano, non li fanno più vivere in santa pace. Se
volete toccare di persona il polso della solidarietà o umanità della gente
brianzola, ecco, ne potete avere una certa idea. Sì, una certa idea, perché in
realtà i brianzoli sono ancor più egoisti, al di là della loro “innocenza”
battesimale o del loro utile pragmatismo pastorale, con la benedizione dei
parroci consenzienti. Ma… chi è onesto al cento per cento? Credo nessuno,
nemmeno il papa. Chi non ha fatto fare qualche lavoretto in nero? Chi ha
fatturato ogni lavoro eseguito? Chi ha sempre pagato l’iva? Chi ha dichiarato
l’esatta metratura dei propri locali, per evitare di pagare più tasse sulla
spazzatura? Chi lavora per raccomandazione o ha vinto un concorso truccato, chi
è un falso invalido o un baby pensionato, ecc. Chi è senza peccato scagli la
prima pietra! Naturalmente, quando non paghiamo qualche tassa, ci giustifichiamo
in nome della nostra “onestà” presunta, oppure del fatto che gli altri non
pagano: “Io non sono un coglione”! E così via…E poi, soprattutto nel campo
ecclesiastico, c’è sempre una ragione “valida” per non pagare tutte le tasse:
faccio il bene, mi do da fare per gli altri, sono qui tutto il giorno al
servizio della comunità anche civile, e poi dovrei pagare anche le tasse? Il
bene mi fa sentire in diritto di esserne esente! Ma questo è un altro discorso,
anche complesso. Ma ciò che non sopporto è la “presunta” onestà degli italiani,
a giustificazione del proprio egoismo di cittadini che, per il fatto di vantare
la propria onestà in base a criteri del tutto personali (ognuno si è fatto il
proprio Codice e la propria Costituzione), rifiutano coloro che essi ritengono
“diversi”, “estranei”, “illegali”, addirittura “pericolosi”, che mettono a
rischio la “presunta” onestà di cittadini italiani.
Chi scaglia la prima
pietra?
L’editoriale di Sebastiano Cultrera del 06.02.2016. Le incalzanti notizie di
cronaca giudiziaria provocano reazioni variegate tra i cittadini della nostra
isola. Sgomento, sorpresa, sdegno, compassione o incredulità si alternano nei
discorsi tra i cittadini. Ma emerge, troppo spesso, una ipocrisia di fondo che è
la stessa che attraversa, troppo spesso, la nostra società procidana. “La devono
pagare cara!” ho sentito dire da qualche anima bella “Anche per rispetto ai
procidani onesti”. E questa storia dell’ONESTA’ è una specie di ritornello al
quale, anche in politica, qualcuno si appella, e di solito lo fa chi è a corto
di argomenti: naturalmente declinando il concetto di “onestà” a propria
convenienza e piacimento. Io sono convinto, e ho cercato di sostenerlo anche
recentemente, che il popolo procidano è un popolo profondamente onesto. Forse il
nostro peggior difetto è il menefreghismo, unito ad un individualismo esasperato
(i procidani sono “sciuontere”, usa dirsi). Ma rispetto ad altre realtà, anche
contigue alla nostra, non possiamo certo lamentarci: non prosperano qui bande
criminali, né (per fortuna) si registrano un numero di crimini particolarmente
allarmante. Sostanzialmente il popolo procidano (che ha una grande storia
imprenditoriale, densa di integrazione culturale e di commerci internazionali) è
un popolo sano, produttivo e lavoratore, con un bagaglio etico del lavoro e
della famiglia di tipo tradizionale. Tuttavia l’Onestà Aà Aà (quella degli
slogan) è un’altra cosa, e proprio quegli esacerbati che la proclamano ai
quattro venti (o semplicemente nelle chiacchiere da bar o da aliscafo)
dovrebbero, prima, almeno, farsi delle domande. Il quadro che, in effetti,
emerge dalle notizie che i media ci restituiscono, rispetto alle inchieste in
corso, è un quadro complesso, che lascia intendere una vastissima rete di
complicità, con l’abitudine a piccoli e grandi privilegi individuali o di
“categoria” che erano diventati, nel tempo, dei veri e propri abusi; magari
questi episodi non rivestono sempre rilevanza penale, ma, ciò non di meno, sono
egualmente molti distanti da qualunque ideale corretto di ONESTA’. E’, poi,
meritevole di approfondimento (e a breve mi piacerebbe farlo) la differenza tra
i concetti di ONESTA’, di ETICA e di MORALE, recentemente abusati e usati
talvolta a sproposito. Faccio solo notare che essi necessitano, per concretarsi,
di un quadro di VALORI condiviso, che invece non esiste più o non è
sufficientemente condiviso. Giacché ciascuno si fa una morale a proprio uso e
consumo e si finisce per riferirsi, volentieri, alla sola dis-ONESTA’ degli
ALTRI, in un eterno gioco di specchi asimmetrico: che, come Lui ha insegnato, ci
fa concentrare, colpevolmente, esclusivamente sulle pagliuzze altrui. I sepolcri
imbiancati di oggi è facile riconoscerli: sono quelli che, in certi frangenti,
si sbattono più di tutti, quelli che vagano stracciandosi le vesti predicando
ONESTA’ a sproposito, come se fosse una confezione di dentifricio atta a pulire
bocca e denti. E nulla dicono su di loro stessi e sui loro amici, sui costumi
diffusi di una comunità che non si riscatta additando le colpe di altri, neanche
di uno o più capri espiatori. Invece il largo stuolo di professionisti,
impiegati, commercianti e cittadini che beneficiavano (o beneficiano?) di quel
“sistema” o comunque si integravano in quel quadro è imponente (e non risparmia
neanche molti soggetti dispensatori di slogan o in vario modo in contiguità col
moralismo di maniera); essi non sono esattamente dei criminali, almeno fino a
prova contraria (e nessuno lo è, quindi, fino a sentenza definitiva). Ma certo
dobbiamo dire con ONESTA’ INTELLETTUALE (ahia, l’ho detto anche io!) che tra
multe cancellate, impunità varie, spiate e dossier, professionalità tecniche
asservite a “papocchi” amministrativi, emerge un quadro sconfortante. Se poi
apriamo il focus e vediamo anche il popolo delle casse marittime facili, dei
piccoli e grandi abusi e delle piccole e grandi evasioni, possiamo allora essere
certi di avere toccato quasi ogni famiglia isolana. Poiché l’averla “fatta
franca” non significa essere moralmente meno colpevoli, ciò NON AUTORIZZA a
scagliare la PRIMA PIETRA per ferire (a colpi di ONESTA’) chi sciaguratamente è
stato scoperto. Spesso, infatti, è proprio la cattiva coscienza che porta a
voler concentrarsi su uno o più responsabili (presunti) del decadimento morale,
anche al fine di mondare catarticamente le proprie responsabilità e quindi la
coscienza stessa. Invece la strada per la “salvezza” (cioè verso una nuova
consapevolezza) passa attraverso una presa di coscienza collettiva delle VIRTU’,
ma anche dei VIZI di una comunità: al fine di migliorarla.
Una banda di ballisti.
Quello che sembrava un partito granitico oggi appare come un castello di carte a
cui una manina, forse interessata, ne ha sfilata una. Da banda degli onesti a
banda dei bugiardi è stato un attimo, scrive Alessandro Sallusti, Mercoledì
07/09/2016 su “Il Giornale”. Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti, cadde
su una bugia. Un suo successore, Bill Clinton, rischiò la stessa fine e si salvò
in extremis solo perché si pentì e chiese scusa in tempo. Margaret Thatcher
sull'argomento aveva un'idea più femminile: «Non si raccontano - ebbe a dire -
bugie deliberatamente, diciamo che a volte bisogna essere evasivi». Virginia
Raggi, neosindaco di Roma, Luigi Di Maio e tutta la banda dei Cinquestelle,
travolti dallo scandalo della bugia sul fatto che nessuno sapeva che una loro
assessora era indagata, sono quindi in buona compagnia. Del resto perché
sorprendersi di un politico bugiardo? Machiavelli, già cinquecento anni fa,
inseriva la menzogna tra le arti di cui un principe deve essere dotato se vuole
ben governare. Il problema nasce quando sul malcapitato si accende il faro del
sospetto, perché secondo gli esperti, per provare a coprire una bugia -
esattamente come accade tra marito e moglie fedifraghi - è necessario
raccontarne almeno altre sette. Che è esattamente quello che sta succedendo in
queste ore nei piani alti del partito di Grillo, tra accuse e difese, sospetti e
veleni incrociati. Quello che sembrava un partito granitico oggi appare come un
castello di carte a cui una manina, forse interessata, ne ha sfilata una. Da
banda degli onesti a banda dei bugiardi è stato un attimo. E adesso si fa dura,
perché, come dice un antico proverbio russo, con le bugie si può andare avanti
ma mai tornare indietro. E quindi addio per sempre verginità, addio purezza,
addio diversità, addio a tutte le fregnacce che ci siamo dovuti sorbire in
questi anni. Il Cinquestelle non è il partito Bengodi, non lo è mai stato e mai
lo sarà, è semplicemente una casta che sta tentando di scalzarne un'altra. Con
l'aggravante dell'inesperienza e dell'incapacità che si sono dimostrate maggiori
del previsto, non solo a Roma ma in tutte le città in cui sono stati messi alla
prova. C'è da gioire di tutto questo? No, per niente. Milioni di italiani sono
stati ingannati dal moralismo di un comico e da un gruppo di ragazzini; Virginia
Raggi, se come probabile resterà in sella grazie a qualche espediente mediatico,
sarà un sindaco dimezzato, bugiardo e inaffidabile. E parliamo del sindaco di
Roma capitale, non so se mi spiego.
Sul web scatta la gara di sfottò: "È
tutta colpa delle cavallette". Raffica di parodie su
Di Maio, scrive Paolo Bracalini, Giovedì 08/09/2016, su "Il Giornale". Dopo le
case pagate ad insaputa e lauree conseguite senza saperlo, la mail letta ma non
capita da Di Maio entra di diritto nella classifica delle scuse più incredibili
della politica nazionale, anche perché nel breve curriculum di Di Maio figura un
periodo da webmaster, difficile da svolgere se si ha difficoltà con le mail.
L'ironia del web, quindi, si abbatte senza pietà sul pupillo avellinese della
Casaleggio Associati, che già aveva pronti nel guardaroba i completi da
presidente del Consiglio. Anche se molte tweetstar che in altri casi avrebbero
fatto a pezzi il protagonista della gaffe politica, con Di Maio si astengono
dall'infierire, meglio non mettersi contro i follower grillini che fanno numero.
Ma se una parte dei commenti in Rete è rappresentato dai fan che seguono
fedelmente la linea indicata dal direttorio (cioè: è tutta una montatura dei
partiti e dei media per screditare il M5S, gli scandali sono altri), la
stragrande maggioranza sono sfottó e parodie per la goffa giustificazione
addotta dal vicepresidente della Camera. Che rievoca a molti lettori, ricordi e
memorie dai banchi di scuola: «Ma oggi c'era interrogazione? Pensavo si facesse
ripasso», «Il cane mi ha mangiato i compiti!», «La difesa del ripetente: non
avevo capito, non c'ero, e se c'ero dormivo» suggeriscono tre lettori di
Repubblica.it, mentre un altro propone un'interpretazione linguistica: «Lui è
napoletano e la Taverna parla in romanesco stretto, dovete pur capire il
poverino!». Molti twittaroli suggeriscono una integrazione alla scusa di Di Maio
pubblicando il celebre monologo di John Belushi in Blues Brothers, quando deve
giustificarsi di fronte all'ex ragazza che lo punta con un fucile d'assalto M16
per averla abbandonata davanti all'altare («Ero rimasto senza benzina. C'era il
funerale di mia madre! Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una
tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!»),
mentre sui social network viene rimbalza una parodia evangelica: «Tutti contro
Di Maio per una mail e nessuno parla dei Corinzi che non hanno mai risposto alle
lettere di San Paolo. Questa è l'Italia dei poteri forti». Su Twitter esiste un
account @Iddio, con 454mila follower, e anche da lì arriva l'ironia sul
vicepresidente della Camera: «Nel progetto originale era previsto di fare le
donne senza peli e senza cellulite, ma ho letto male l'email». Filippo Casini ha
capito l'origine del complotto denunciato dai Cinque stelle: «Di Maio: Abbiamo
tutti i media contro. Soprattutto Hotmail e Outlook», i provider di posta
elettronica. «Ho sbagliato a leggere la mail» is the new «Mi hanno rubato
l'account», twitta la Lucarelli del Fatto. Sfotte anche Pig Floyd su Twitter:
«Mi è arrivata la bolletta della luce da 230. Credo che pagherò 2.30 dicendo
Scusate, ho letto male». Ma poi il popolo M5S si dà la carica con Grillo a
Nettuno. E anche questo ispira la presa per i fondelli sui malintesi di Di Maio:
«Nettuno? Cavolo. Ma un pianeta più vicino non c'era?».
La follia di fare
dell'onestà un manifesto politico.
Io non so se Casaleggio, parlandone da vivo, fosse o no il re degli onesti. So
che il suo partito, dove governa, non riesce a risolvere neppure mezzo problema
in più di qualsiasi altro, scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 15/04/2016, su
"Il Giornale". «Onestà, onestà», hanno intonato dirigenti e simpatizzanti
grillini sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie all'uscita della
bara di Gianroberto Casaleggio. Come ultimo saluto, una preghiera laica in linea
con il dogma pentastellato che al di fuori del loro club tutto è marcio e
indegno. Gli unici onesti del Paese sarebbero loro, come vent'anni fa si
spacciavano per tali i magistrati del pool di Mani pulite, come tre anni fa
sosteneva di esserlo il candidato del Pd Marino contrapposto a Roma ai presunti
ladri di destra. Come tanti altri. Io non faccio esami di onestà a nessuno, me
ne guardo bene, ma per lavoro seguo la cronaca e ho preso atto di un principio
ineluttabile: chi di onestà colpisce, prima o poi i conti deve farli con la sua,
di onestà. Lo sa bene Di Pietro, naufragato sui pasticci immobiliari del suo
partito; ne ha pagato le conseguenze Marino con i suoi scontrini taroccati; lo
stesso Grillo, a distanza di anni, non ha ancora smentito le notizie sui tanti
soldi in nero che incassava quando faceva il comico di professione. Cari Di Maio
e compagnia, smettetela con questa scemenza del partito degli onesti che fa la
morale a tutti, cosa che fra l'altro porta pure male. L'onestà non è un
programma politico, è una precondizione personale per affrontare la vita in un
certo modo. Io voglio comportarmi onestamente, e mi piacerebbe facessero
altrettanto il mio fruttivendolo, chi mi vende l'automobile, chi si occupa della
mia salute, il politico che voto. Ma da loro pretendo solo una cosa: che la
frutta sia buona e sana, che l'auto funzioni come mi aspettavo, che se
necessario il mio medico mi salvi la vita, che la politica sia efficiente nel
risolvere i miei problemi. L'onestà che viene a mancare è un problema della loro
coscienza, e giudiziario se comporta la violazione delle leggi e se danneggia la
comunità. Io non so se Casaleggio, parlandone da vivo, fosse o no il re degli
onesti. So che il suo partito, dove governa, non riesce a risolvere neppure
mezzo problema in più di qualsiasi altro. Anzi, a volte, vedi casi Livorno e
Quarto, fanno disastri ben peggiori. Cosi come in Parlamento la strategia
grillina ha prodotto tanto fumo e zero arrosto. Sarò all'antica, ma in chiesa,
ai cori sull'esclusiva dell'onestà («chi è senza peccato scagli la prima
pietra», diceva il Padrone di casa) preferisco ancora una preghiera.
"Noi siamo garantisti e lo siamo anche con il
sindaco di Livorno raggiunto da avviso di garanzia non come gli esponenti del
Movimento che sono garantisti con i loro e giustizialisti con gli altri": lo ha
detto il ministro Boschi parlando nel bresciano a Desenzano del Garda il 7
maggio 2016. Boschi ha quindi aggiunto "Di Maio era a Lodi questa mattina, mi
auguro che domani vada a Livorno a chiedere le dimissioni del suo sindaco". "Il
21% dei comuni amministrati dal Movimento 5 stelle - ha concluso - ha problemi
con la giustizia, ma il loro grido onestà, onestà diventa omertà, omertà quando
riguarda loro".
Caso Pizzarotti: il doppiopesismo che
spaventa. L'ipocrisia dentro e fuori il M5S li mostra
giustizialisti in pubblico, esoterici nelle “stanze delle tastiere”. Un pericolo
per la democrazia, scrive Marco Ventura il 15 maggio 2016 su "Panorama". Lo
aveva detto con chiarezza Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, prima della
sospensione dal Movimento 5 Stelle tramite la mail anonima dello “staff” (che
rimanda al direttorio M5S e, in definitiva, al clan Casaleggio): “Non è che
tutti gli altri sono cattivi e noi tutti buoni. Per sistemare i problemi a volte
è necessario sporcarsi le mani”. Ammissione importante. Quindi, non erano tutti
cattivi i craxiani o i berlusconiani, così come non sono tutti buoni i
magistrati o i 5 Stelle. Se c’è di mezzo l’amministrazione di una città, ci si
può dover sporcare le mani. Ne consegue che se questo vale per Livorno, a
maggior ragione deve valere per Roma o Milano. Ci si può sporcare le mani “a fin
di bene”, forse. Per dare un’aggiustatina. Eppure, per degli integralisti come i
5 Stelle dovrebbe valere il principio che il fine non giustifica mai i mezzi,
insomma le mani bisognerebbe non sporcarsele in nessun caso. Tanto meno
bisognerebbe accusare gli altri di sporcarsele, per poi autoassolversi se si
viene beccati con le mani dentro lo stesso barattolo di marmellata con
l’etichetta “concorrenza in bancarotta fraudolenta” o “abuso d’ufficio”. Sembra
invece che i grillini siano una razza a parte anche sotto questo aspetto. Se
sono loro a finire nel mirino delle Procure (è successo nella maggioranza delle
amministrazioni locali che controllano), si tratta di giustizia a orologeria,
manganellate giustizialiste, “reati minori”. Vito Crimi, ex presidente dei
senatori pentastellati, sembra considerare una medaglia al petto l’avviso di
garanzia al compagno di partito nonché Sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, per
33 assunzioni in un’azienda sull’orlo del baratro. Si può mai esser colpevoli,
chiede Crimi, di “aver evitato a 33 famiglie di finire in mezzo a una strada?”.
Eppure, in altri tempi e riferita ad avversari, l’assunzione di 33 persone in
un’azienda municipalizzata che sta per fallire sarebbe stata definita proprio
dai 5 Stelle “clientelismo”. I due pesi e due misure riguardano non soltanto i
nemici, ma i compagni di cordata. Pizzarotti è sempre stato un mezzo dissidente
rispetto ai vertici del partito, Nogarin no. Quindi Pizzarotti viene sospeso e
Nogarin salvato (e difeso). Ma il problema non riguarda solo i pentastellati.
Riguarda tutti noi. I 5 Stelle un giorno potrebbero avere i numeri per
governare. Si tratta di un movimento rivoluzionario, guidato senza trasparenza,
molto simile a una setta (spesso i rivoluzionari sono strutturalmente settari).
Ma quando la setta incrocia il potere, diventa un pericolo per la democrazia. La
verità è che i rivoluzionari, a qualsiasi latitudine e in qualsiasi momento
storico, hanno dimostrato di essere poi bravissimi a adattarsi alle poltrone e
nicchie di potere, e di essere mediamente peggiori dei predecessori che si sono
trovati a gestire un consenso che calava. I due pesi e due misure di direttorio
e clan Casaleggio contraddicono in modo eclatante la supposta trasparenza delle
origini (che in realtà non c’è mai stata). I terribili scontri intestini
appartengono alla peggiore tradizione del variegato socialismo e comunismo
sovietico. Specchio capovolto del populismo sbandierato dai parlamentari 5
Stelle. Populisti e giustizialisti in pubblico, esoterici e incontrollabili nel
chiuso di “stanze delle tastiere” che hanno sostituito le “stanze dei bottoni”.
Come il giustizialista
imputato diventa garantista.
L'ex comunista Cioni a Firenze. I grillini Nogarin a Livorno e Pizzarotti a
Parma. Prima giacobini, poi indagati: e oggi chiedono il rispetto delle regole
dello Stato di diritto, scrive il 13 maggio 2016 Maurizio Tortorella su
"Panorama". "A mia figlia Giulia, la più piccola, i compagni di classe
domandavano: perché tuo padre non è in prigione? Nel tritacarne mediatico i
giornali ti bollano come corrotto e gli amici scompaiono". È bellissima e
illuminante l'intervista di Graziano Cioni al Foglio di oggi. Cioni, 70 anni, è
stato un esponente del Pci-Pds-Ds-Pd toscano, assessore alla Sicurezza e alla
vivibilità di Firenze: nel novembre 2008, da candidato a sindaco della città,
venne travolto politicamente e umanamente da un'inchiesta e poi da un processo
per corruzione per un progetto urbanistico sull'area fiorentina di
Castello. Quell'inchiesta è appena terminata in nulla, in Cassazione. Ma Cioni
ha vissuto quasi otto anni d'inferno. Oggi dice ad Annalisa Chirico, che lo
intervista: "Io ero un giustizialista convinto. Che puttanata. Per me la
legalità era un vessillo assoluto, una bandiera. Le garanzie? la presunzione
d'innocenza? Non mi ponevo il problema. Quel che un magistrato fa è giusto per
definizione". Cioni ricorda il famoso discorso di Bettino Craxi: quello del
luglio 1992, in piena Tangentopoli, quando in Parlamento il segretario del Psi
chiamò in correità tutti i segretari di partito, dichiarando "spergiuro" chi
avesse negato un finanziamento illecito. "Io ero un anticraxiano di ferro" dice
oggi Cioni. "Votai per l'autorizzazione a procedere. Oggi non lo
rifarei. Pensavo che Craxi avesse torto. Ho capito che avevamo torto noi". Oggi
che cosa dice Cioni della giustizia? "Le carriere dei pm e dei giudici vanno
separate. L'assoluzione deve essere inappellabile: io sono stato scagionato da
ogni accusa in primo grado, ma il pm è ricorso in appello così mi sono ritrovato
nel fuoco incrociato di una contrapposizione tra giudici. La responsabilità
civile dei magistrati resta una chimera: perché chi sbaglia non paga? Si dice:
questo potrebbe frenarli. Ma allora un chirurgo che dovrebbe fare?". È un uomo
folgorato sulla via di un processo. Induce sincera compassione umana, Graziano
Cioni. La vita con lui è stata durissima e crudele, non soltanto dal punto di
vista giudiziario. Ma il suo percorso mentale da giustizialista a garantista,
per quanto straordinario e paradossale, e intimamente giusto, scuote
l'animo. Anche perché ormai incarna in sé gli echi di una sconcertante
regolarità. Perché, esattamente come lui, proprio in questo periodo approdano
alla sponda garantista tanti ex giustizialisti. Sono sempre più numerosi i
giacobini che, colpiti da un avviso di garanzia ed entrati loro malgrado nel
circo mediatico-giudiziario, scoprono la violenza che hanno alimentato fino al
giorno prima. E a quel punto saltano loro i nervi, diventano fragili, soffrono.
Capiscono i disastri del populismo giudiziario. Filippo Nogarin, sindaco
grillino di Livorno, e Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, indagati a diverso
titolo, oggi rivendicano la correttezza del loro operato e si
ribellano: rifiutano di seguire le regole del Movimento 5 stelle cui
appartengono. Non si dimettono, dopo che il mantra grillino per anni è
stato: "Fuori dallo Stato ogni indagato". Attenzione: qui nessuno s'indigna.
Ed è in buona misura scorretto fare quel che fanno certi esponenti del Pd, che
gridano strumentalmente allo scandalo per il cambio di fronte degli avversari
grillini. Non pare corretta nemmeno la rivalsa di chi, nel centrodestra, osserva
tacendo: come se fosse una consolazione, perché "ora tocca a loro". No, qui non
si tratta nemmeno di contestare una doppia morale, o il doppiopesismo. Chi crede
di avere davvero nel sangue il rispetto delle regole dello Stato di diritto, in
realtà, si stupisce soltanto che tutti costoro non lo abbiano capito prima. Che
non abbiano compreso che l'errore è umano, e che anche l'errore giudiziario lo
è. E pertanto che non c'è alcuna certezza, né una Verità assoluta e
insindacabile. Né in una chiesa, né in un partito, né (tantomeno) in un
tribunale. Il problema è che non si può attendere di subire un'esperienza
giudiziaria per comprendere che la presunzione d'innocenza va davvero utilizzata
come una regola superiore, stellare. Che l'arresto in carcere deve essere
l'ultima istanza, davvero. Che i giornali non possono devastare l'immagine di
una persona. Possono porre problemi, ma non dare certezze. Quelle le ha soltanto
Dio, se esiste. Il problema è che il circuito mediatico-giudiziario, un unicum
vergognoso, da Paese sottosviluppato, è un mostro che va affrontato
collettivamente e contenuto, possibilmente annullato. Non lo si è fatto per
troppi anni, per miope calcolo politico (con la sua intervista anche Cioni lo
conferma, esplicitamente). Ma di calcoli politici si può anche soccombere.
CULTURA. EMIL ZOLA: L’AFFAIRE DREYFUS ED I
GIORNALI CHE VIVONO DI SCANDALI.
Cos’è la cultura? Solo un “libretto di
istruzioni”…, scrive Corrado Ocone il 26 Agosto 2018
su "Il Dubbio". Antonio Genovesi, allievo di Vico, teologo, maestro
dell’illuminismo napoletano, filosofo eclettico. Usò la scienza anche per
studiare il commercio. Sabato a Vatolla, in provincia di Salerno, nel castello
De Vargas ove soggiornò per più anni Giambattista Vico, alle ore 19, si è svolto
il convegno Opportunità, pace e ricchezza. Il libero commercio dalle lezioni di
economia di Antonio Genovesi ad oggi. Sono intervenuti Corrado Ocone e Lorenzo
Infantino (moderati da Antonluca Cuoco). È stata l’occasione per ricordare
Genovesi, allievo di Vico e padre dell’illuminismo napoletano, pensatore di
calibro europeo del tutto dimenticato. Qui un suo profilo. Una decina di anni fa
la casa editrice dell’Università di Cambridge pubblicò un documentato volume
(mai tradotto in italiano) di un noto storico inglese, John Robertson, in cui si
stabiliva un legame, intellettuale ma anche concreto e pratico (le idee e i
libri circolavano con molta rapidità nella settecentesca “repubblica delle
lettere”), fra l’illuminismo scozzese e quello napoletano. Gli esponenti di
entrambi, al contrario degli illuministi francesi, temperavano infatti il culto
della Ragione con un istintivo senso storico e (almeno negli scozzesi) con una
profonda venatura scettica. Credo che, pur con i dovuti limiti, questa
tipizzazione valga anche per Antonio Genovesi, il padre dell’illuminismo
napoletano. Se non proprio scettico, egli, che aveva una formazione filosofica e
teologica (era lui stesso un sacerdote), anzi propriamente metafisica, era
sicuramente un eclettico: possedeva una solida cultura classica, e insieme una
vasta conoscenza degli autori moderni e a lui contemporanei, ma riteneva che
elementi di verità fossero nel pensiero di ogni filosofo e che era saggio
prendere il meglio da più parti. Quanto al senso storico, Genovesi lo aveva
sicuramente appreso anche alla scuola di Giambattista Vico, che, essendosi
trasferito a Napoli venticinquenne nel 1738 (era nato a Castiglione, in
provincia di Salerno, il primo novembre 1713), fece in tempo a frequentare
(l’autore della “Scienza nuova” sarebbe poi morto nello stesso anno in cui fu
pubblicata l’edizione definitiva del suo capolavoro: il 1744). È ai primi anni
Cinquanta del secolo che è databile quella “svolta” negli interessi di Genovesi
(nell’Autobiografia egli parlerà di “sbalzo”) che lo porterà rapidamente a
tralasciare gli studi di metafisica e teologia e ad occuparsi quasi
esclusivamente di economia. Certo, si trattava della scienza del momento, legata
all’intensificarsi dei commerci e allo sviluppo economico degli Stati europei,
ma l’affermarsi dell’economia era il portato anche, più radicalmente, dello
spirito immanentistico connesso all’età moderna (Benedetto Croce avrebbe parlato
della “scoperta” settecentesca delle due “scienza mondane”, cioè l’estetica e
appunto l’economia). Napoli, città di porto e cosmopolita per quanto con un
retroterra arretrato e semifeudale (la vasta provincia del Regno borbonico),
partecipava in pieno al moto di idee che da Parigi alla Gran Bretagna percorreva
l’Europa: l’abate Ferdinando Galiani, altro esponente di spicco dell’illuminismo
partenopeo, nel 1751 aveva pubblicato il trattato Della moneta che gli avrebbe
presto dato fama europea. Genovesi, da parte sua, da un lato, concludeva nel
1752, con la pubblicazione dell’ultimo tomo, il suo trattato di Metafisica, che
non pochi problemi gli aveva dato con la censura regia e soprattutto
ecclesiastica; dall’altro, maturava delle idee del tutto nuove sullo scopo della
sua attività di studioso che ne avrebbero fatto in poco tempo, come lui stesso
ebbe a dire, da filosofo e metafisico un “mercatante”. In questo processo lo
agevolò certamente l’essere entrato a far parte del circolo, e anzi nelle
grazie, di un illuminato mercante e mecenate toscano trapiantato a Napoli,
Bartolomeo Intieri. Il quale, consapevole, nello spirito dei lumi, della
necessità di formare una classe dirigente su idee nuove e praticamente utili,
finanziò e affidò al nostro una cattedra di “meccanica e economia”
all’Università di Napoli (probabilmente la prima cattedra di economia al mondo).
Il 5 novembre 1754, con grande successo, parlando a braccio, Genovesi tenne la
memorabile prolusione con cui inaugurava il suo corso, le cui idee sistemò poi
nel Ragionamento sul commercio in generale (1757), Le sue Lezioni di commercio o
sia d’economia civile, pubblicate per la prima volta nel 1765, diventeranno un
classico e saranno tradotte e discusse in mezza Europa. E’ difficile, almeno per
me, giudicare la validità e forza delle idee economiche di Genovesi, né
tantomeno la loro possibile “attualità”: un tema, quest’ultimo, che il senso
storico mi porterebbe a consigliare di affrontare con molta cautela. Non manca
però chi (ad esempio Stefano Zamagni), mutuando da Genovesi e dagli altri
illuministi napoletani l’espressione “economia civile”, vede oggi nelle sue idee
un’alternativa al pensiero economico puro o classico, basato sull’idea di
un homo aeconomicus inteso a perseguire razionalmente il proprio interesse. In
effetti, è sicuramente vero che i temi etici nel pensiero di Genovesi si
intrecciano a quelli più propriamente economici e finiscono per dare ad essi il
tono e la sostanza. È pur vero, tuttavia, che, stando almeno a certi passi delle
sue opere, la natura non meramente altruistica dell’uomo gli era, senza
moralismi di sorta, molto chiara. Tanto che lo stesso concetto di “reciprocità”
che, secondo lui, è alla base dello scambio mercantile, conserva a mio avviso un
che di utilitaristico che non lo discosta troppo dall’impostazione che sarà data
qualche decennio dopo di lui da Adam Smith. Anche l’autore della Ricchezza delle
nazioni (1776) aveva, fra l’altro, parlato della “fiducia” (“pubblica”) che è
alla base del rapporto economico, occupandosene nell’opera filosofica che è da
considerarsi come la premessa teorica del suo capolavoro: la Teoria dei
sentimenti morali (1759). Mi sembra che ci troviamo di fronte a motivi propri
dell’epoca, di un periodo in cui l’economia non aveva del tutto sviluppato
quell’autonomia dalle altre scienze che è stata poi, nei secoli a seguire, il
motivo del suo successo ma anche della sua crisi attuale. Tipicamente
illuministico è anche il tema della “felicità”, che, sulla scia di Genovesi, gli
illuministi napoletani hanno sviluppato e diffuso nel mondo (di esso se ne
trovano echi evidenti, per il tramite di Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin,
nella stessa Costituzione americana). Anche in questo caso, il pensiero di
Genovesi, legato in senso stretto alle virtù morali e civili, non presenta
quegli aspetti utilitaristici che ritroveremo in seguito fra gli economisti. Ad
ogni modo, a me sembra particolarmente interessante considerare anche la
concezione della cultura e dei fini o dello scopo del lavoro intellettuale che
aveva il nostro e che, anche per questa parte, lo trova completamente aderente
allo spirito del suo tempo, cioè all’illuminismo. Il riferimento in questo caso
è soprattutto il Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, che
egli compose nell’autunno del 1753 nella casa di villeggiatura di Intieri dalle
parti di Vico Equense e pubblicò l’anno dopo poco prima che iniziassero i suoi
corsi di economia. In esso egli prese di mira i filosofi, e i “cento e cento
altri dialettici e metafisici” che, “per sette e più secoli… fecero a gara a chi
potesse essere più ferace in inutili immaginazioni ed astrazioni”. Il loro
compito sarebbe stato invece quello di dare “rischiaramento e aiuto” ai popoli e
soprattutto ai governanti che avrebbero dovuto guidare gli Stati secondo i
dettami della pura ragione. Come si vede, qui c’è una netta presa di distanza da
quegli interessi metafisici che lo avevano impegnato, quasi come per liberarsene
con cognizione, nella prima fase della sua attività. Il rapporto fra scienza e
prassi è stabilito in maniera netta: le scienze da preferire e studiare saranno
quelle utili a migliorare e a “incivilire” il popolo umano. In effetti, la
scienza scopre, da una parte, certe “verità” nella realtà e, dall’altro, le
propone ai saggi legislatori del “dispotismo illuminato” che le “applicano”,
anche con l’ausilio della tecnica, all’azione. Questa concezione del mondo come
un libro che noi dobbiamo solo leggere e interpretare (secondo l’espressione di
Galileo Galilei), della verità come “rispecchiamento” e della prassi come
“applicazione” è quella che successivamente il pensiero occidentale post-
illuministico metterà per lo più in discussione. Essa, infatti, tendenzialmente,
lascia poco spazio alla libertà, cioè all’inventiva e imprevedibile creatività
umana. Da un lato, Marx tenderà a risolvere le contraddizioni teoriche
immediatamente nell’agire pratico (“non si tratta di capire il mondo ma da
trasformarlo”); dall’altra, i liberali tenderanno a scindere l’attività
culturale, per sua natura disinteressata, da quella pratica volta a raggiungere
un fine di utilità. L’enorme fiducia nella cultura, istillata nei napoletani da
Genovesi e a seguire dagli altri esponenti della cultura illuministica cittadina
(lo stesso Filangieri, Francesco Maria Pagano o il suo allievo prediletto
Giuseppe Maria Galanti) avrà, anche simbolicamente, il suo esito finale nel
fallimento della rivoluzione napoletana del 1799. Una classe politico-
intellettuale che si affida alla cultura e alla morale senza fare i conti con la
maturità del popolo e con la situazione in cui deve operare, constaterà
amaramente Vincenzo Cuoco (allievo di Galanti) è destinata a fallire e a
rimanere nella storia come mera per quanto nobile testimonianza. Ovviamente,
Genovesi non fece in tempo a vedere i fumi della Rivoluzione (era morto a Napoli
il 22 settembre 1769) ma nella sua personalità si rispecchiano in maniera così
tipica i pregi e le virtù del suo tempo, molto più che in altri pensatori
stranieri, che, per noi italiani, è veramente assurdo non conoscerne e aver
dimenticato la sua lezione.
Emile Zola: Quei giornali che vivono di
scandali! Scrive Émile Zola il su “Le Figaro” il 25
novembre 1897 ripubblicato il 9 Agosto 2018 su "Il Dubbio". Che dramma
straziante, e quali splendidi personaggi! Di fronte a documenti di una bellezza
così tragica che la vita ci mette davanti, il mio cuore di romanziere freme di
appassionata ammirazione. Non so intravedere una psicologia più nobile. Non è
mia intenzione parlare del caso. Se talune circostanze mi hanno permesso di
studiarlo e di farmene un’opinione formale, non dimentico che un’inchiesta è in
corso, che la giustizia se ne sta occupando e che per onestà è giusto attendere,
senza contribuire all’ammasso di pettegolezzi volti a ostruire un caso così
chiaro e così semplice. Ma i personaggi, da questo momento, appartengono a me,
che sono soltanto un passante con gli occhi aperti sulla vita. E se il
condannato di tre anni or sono e l’accusato d’oggi per me rimangono sacri fino a
che la giustizia non avrà completato la sua opera, il terzo grande personaggio
del dramma, l’accusatore, non avrà certo a soffrire se parlerò di lui con onestà
e con coraggio. Ecco che cosa ho visto di Scheurer-Kestner, ecco che cosa penso
e che cosa affermo. Forse un giorno, se le circostanze lo permetteranno, parlerò
degli altri due. Una vita cristallina, la più nitida, la più diritta. Non una
tara, mai la più piccola debolezza. Una medesima opinione, costantemente
seguita, senza ambizione militante, sfociata in un’altra posizione politica
dovuta unicamente alla simpatia rispettosa dei suoi pari. E non un sognatore, né
un utopista. Un industriale, che ha vissuto chiuso nel suo laboratorio, dedito a
ricerche particolari, senza conta- re la preoccupazione quotidiana di una grande
ditta commerciale da mandare avanti. Ed anche una situazione patrimoniale
invidiabile. Tutte le ricchezze, tutti gli onori, tutte le gioie, il coronamento
di una bella vita interamente dedicata al lavoro e alla lealtà. Più un solo
desiderio da esprimere, ossia quello di finire in modo degno, in questa felicità
e nella stima generale. Eccolo, l’uomo. Lo conoscono tutti, non vedo chi mi
potrebbe smentire. Ed è proprio l’uomo attorno al quale si sta per svolgere uno
dei drammi più tragici e più appassionati. Un giorno, un dubbio si affaccia nel
suo spirito, poiché è un dubbio che è nell’aria e che ha già rubato varie
coscienze. Un tribunale militare ha condannato, per alto tradimento, un capitano
che, chissà, forse è innocente. Il castigo è stato tremendo, la degradazione
pubblica, l’internamento in un luogo lontano, l’esecrazione di tutto un popolo
che si accanisce, infierendo sull’infelice già a terra. E, qualora fosse
innocente, gran Dio! Che brivido di pietà, che orrore agghiacciante! Al pensiero
che non ci sarebbe riparazione possibile. Nello spirito del signor
Scheurer-Kestner, è nato il dubbio. Da quel momento, come ha spiegato lui
stesso, inizia il tormento, rinasce l’ossessione man mano che le cose gli
giungono all’orecchio. È un’intelligenza solida e logica quella che, a poco a
poco, finisce per essere conquistata dal bisogno insaziabile della verità. Non
c’è nulla di più alto, di più nobile e il travaglio che quest’uomo ha vissuto è
uno spettacolo straordinario ed entusiasmante, per me, portato come sono dal mio
mestiere a scrutare nelle coscienze. Il dibattito sulla verità e in nome della
giustizia, non esiste lotta più eroica. In breve, alla fine Scheurer-Kestner
giunge alla certezza. La verità la conosce, ora deve fare giustizia. È un
momento pauroso e posso immaginare cosa debba essere stato per lui quel momento
d’angoscia. Non gli erano certo ignote le tempeste che stava per sollevare, ma
la verità e la giustizia sono sovrane, poiché esse soltanto assicurano la
grandezza delle nazioni. Può accadere che interessi politici le oscurino per
qualche istante, ma un popolo che non basi su di esse la sua unica ragione
d’essere sarebbe, oggi, un popolo condannato. Fare luce sulla verità, certo; ma
potremmo avere l’ambizione di farcene un vanto. Alcuni la vendono, altri
vogliono almeno trarre vantaggio dall’averla detta. Il progetto di
Scheurer-Kestner era di restare nell’ombra, pur compiendo la sua opera. Aveva
deciso di dire al governo: «Le cose stanno così. Intervenite, abbiate voi stessi
il merito d’essere giusti, riparando a un errore. Chi fa giustizia, trionfa
sempre». Circostanze delle quali non voglio parlare fecero sì che non venisse
ascoltato. Da quel momento in poi, ebbe inizio la sua ascesa al calvario,
un’ascesa che dura da settimane. Si era sparsa la voce che egli fosse in
possesso della verità, e chi detiene la verità, senza gridarla ai quattro venti,
che altro può essere se non un nemico pubblico? Stoicamente, per quindici giorni
interminabili, rimase fedele alla parola data di tacere, sempre nella speranza
di non doversi ridurre a prendere il posto di quelli che avrebbero dovuto agire.
E sappiamo bene quale marea d’invettive e di minacce si sia abbattuta su di lui
durante questi quindici giorni; un vero torrente di accuse immonde, di fronte al
quale è rimasto impassibile, a testa alta. Perché taceva? Perché non mostrava il
suo incartamento a chiunque lo volesse vedere? Perché non faceva come gli altri
che riempivano i giornali delle loro confidenze? Quanto, ah, quanto è stato
grande e saggio! Taceva, perfino al di là della promessa fatta, proprio perché
si sentiva responsabile nei confronti della verità. Una povera verità, nuda e
tremebonda, schernita da tutti e che tutti sembravano avere interesse a
soffocare, lui pensava soltanto a proteggerla contro l’ira e le passioni altrui.
Aveva giurato a se stesso che non l’avrebbero fatta sparire e intendeva
scegliere il momento e i mezzi adatti per assicurarle il trionfo. Che può mai
esserci di più naturale, di più lodevole? Per me non esiste niente di più
sovranamente bello del silenzio di Scheurer- Kestner, dopo tre settimane di
ingiurie e di sospetti da parte di un intero popolo fuori di sé. Ispiratevi a
lui, romanzieri! In lui sì avreste un eroe! I più benevoli hanno avanzato dubbi
sul suo stato di salute mentale. Non era per caso un vegliardo indebolito,
caduto nell’infantilismo senile, uno di quegli spiriti che il rimbambimento
incipiente rende inclini alla credulità? Gli altri, i pazzi e i delinquenti,
l’hanno accusato senza tante cerimonie d’essersi lasciato “comprare”.
Semplicissimo: gli ebrei hanno sborsato un milione per acquistare tanta
incoscienza. E non si è levata una risata immensa, come risposta a tanta
stupidità! Scheurer- Kestner, è là, con la sua vita cristallina. Fate un
confronto tra lui e gli altri, quelli che lo accusano e lo insultano, e
giudicate. Bisogna scegliere tra questo e quelli. Trovatela, la ragione che lo
farebbe agire, al di fuori del suo bisogno così nobile di verità e di giustizia.
Coperto d’ingiurie, l’animo lacerato, sentendo vacillare il suo prestigio sotto
di sé, ma pronto a sacrificare tutto pur di portare a buon esito il suo eroico
compito, egli tace, aspetta. Fino a che punto si può essere grandi! L’ho detto,
del caso in sé non mi voglio occupare. Tuttavia, è bene che io lo ripeta: è il
più semplice, il più trasparente del mondo, per chi voglia prenderlo per quello
che è. Un errore giudiziario, eventualità deplorevole, sì, ma sempre possibile.
Sbagliano i magistrati, possono sbagliare i militari. Cos’ha a che fare, questo,
con l’onore dell’esercito? L’unico bel gesto, qualora sia stato commesso un
errore, è di porvi riparo: e la colpa nascerebbe nel momento in cui qualcuno
s’intestardisse a non voler ammettere di essersi sbagliato, nemmeno di fronte a
prove decisive. Non ci sono altre difficoltà, in fondo. Andrà tutto bene, purché
si sia decisi a riconoscere di aver potuto commettere un errore e di avere
esitato, in seguito, a convenirne, perché era imbarazzante. Quelli che sanno, mi
capiranno. Quanto al temere complicazioni diplomatiche, è uno spauracchio per
gli allocchi. Nessuna delle potenze vicine ha niente a che spartire con il caso
e converrà dirlo forte. Ci troviamo soltanto di fronte a un’opinione pubblica
esasperata, sovraffaticata da una campagna che è tra le più odiose. La stampa è
una forza necessaria; sono convinto che nel complesso faccia più bene che male.
Ma certi giornali, quelli che gettano lo scompiglio, quelli che seminano il
panico, che vivono di scandali per triplicare le vendite, non sono certo meno
colpevoli. L’antisemitismo idiota ha gettato il seme di questa demenza. La
delazione è dappertutto, nemmeno i più puri e più coraggiosi osano fare il loro
dovere per il timore di venire infangati. E così, eccoci in questo orribile
caos, nel quale tutti i sentimenti sono falsati, in cui non è possibile volere
la giustizia senza venire trattati da rimbambiti o da venduti. Le menzogne
mettono radici, le storie più assurde vengono riportate con sussiego dai
giornali seri, l’intera nazione sembra in preda alla follia, quando un po’ di
buon senso rimetterebbe subito a posto le cose. Oh, come sarà semplice, torno a
dirlo, il giorno in cui quelli che sono alla guida oseranno, nonostante la folla
aizzata, comportarsi da galantuomini! Immagino che nel silenzio altero di
Scheurer- Kestner, ci sia anche il desiderio di aspettare che ciascuno faccia il
suo esame di coscienza prima di agire. Quando ha parlato del suo dovere che,
perfino sulle rovine del suo prestigio, della sua felicità e dei suoi beni, gli
ordinava, dopo averla conosciuta, di servire la verità, quest’uomo ha detto una
frase ammirevole: «Non avrei più potuto vivere». Ebbene, ecco che cosa devono
dirsi tutte le persone oneste immischiate in questa storia: che non potranno più
vivere, se non faranno giustizia. E, qualora ragioni politiche volessero che la
giustizia venisse ritardata, si tratterebbe di una notizia falsa che servirebbe
soltanto a rinviare l’epilogo inevitabile, aggravandolo ulteriormente. La verità
è in cammino e niente la potrà fermare. Pubblicato su “Le Figaro” il 25 novembre
1897
«Dreyfus è innocente!» Così Zola inventò
l’intellettuale moderno. Scrive Vincenzo Vitale il 7
Agosto 2018 su "Il Dubbio". Si dice affaire Dreyfus e dovrebbe
dirsi affaire Zola. Infatti, se non ci fosse stato l’intervento determinante –
nei modi che vedremo – del celebre scrittore francese Emile Zola, all’epoca già
molto noto e apprezzato in tutta Europa, molto probabilmente il Capitano di
artiglieria Albert Dreyfus sarebbe silenziosamente deceduto alla Caienna
francese, seppellito dalla infamante accusa di spionaggio a favore dei tedeschi
e ignoto ai più: archiviato lui stesso come un doloroso fatto di cronaca e
null’altro. Invece, come è noto, fu Zola a fare, di Dreyfus, Dreyfus; vale a
dire probabilmente il più clamoroso e discusso caso giudiziario della storia
europea non solo della fine dell’ottocento francese, ma anche dei secoli
precedenti e successivi. Tuttavia, non si tratta, come vedremo, soltanto di un
caso giudiziario, per quanto importante e significativo; si tratta di qualcosa
di più e di diverso: il caso Dreyfus si fa infatti cogliere come un autentico
prisma di rifrazione che permette di scorgere ed interpretare le dinamiche
profonde e perfino le scansioni antropologiche del tessuto sociale europeo della
fine dell’ottocento, ma anche – ed è questo un aspetto di supremo interesse, in
quanto non esclusivamente storiografico – di quello contemporaneo, in tutte le
sue implicazioni politiche, giuridiche, umane e sociali. Insomma: conoscere e
comprendere il passato per interpretare il presente. Nulla sollecita e propizia
questa ben nota operazione culturale come il caso Dreyfus che qui si presenta.
Innanzitutto, i fatti. Dopo la cocente sconfitta di Sedan del 2 settembre del
1870, ove lo stesso Napoleone III era stato fatto prigioniero, dopo che, a pochi
giorni dalla caduta di Parigi del 18 gennaio 1871, era stato proclamato nella
sala degli specchi di Versailles l’impero tedesco, la Francia, riedificata in
Terza Repubblica, si era data nel 1875 una Costituzione. Ma il quadro politico e
sociale, all’inizio dell’ultimo decennio del secolo, è quanto mai instabile e
insicuro. L’eco del boulangismo ancora vivo ( movimento politico guidato dal
generale Boulanger, che si prefiggeva di abbattere la Terza Repubblica con un
colpo di stato militare), l’incapacità rivelata durante la guerra franco-
prussiana, gli orrori della Comune di Parigi, la rapida successione di Ministeri
deboli, la spiccata e violenta faziosità dei partiti, i ricorrenti e gravi
scandali finanziari ( non ultimo quello di Panama) contribuiscono a fornire
anche agli osservatori stranieri un’immagine della Francia come paese
agonizzante. Forse la sola istituzione che sembri ancora salvarsi dallo sfacelo
è l’esercito, da poco efficacemente riorganizzato ex novo da Charles de
Freycinet, ministro della guerra fra il 1889 e il 1990. È ovvio perciò come in
questa Francia le tensioni sociali, lievitando ormai in modo non controllabile,
né potendosi più risolvere e conciliare in un conflitto verso l’esterno,
esigano, per essere placate e per consentire il ritorno ai binari della
normalità, delle vittime: la prima di queste ha nome Dreyfus. Lo esige la Ragion
di Stato: per questo, la sorte di Alfred Dreyfus, capitano del 14° Reggimento di
artiglieria, addetto allo Stato Maggiore generale del Ministero della Guerra,
comandato al primo ufficio di artiglieria, quarantotto anni, coniugato, due
figli, israelita, di origine alsaziana, era segnata. Fin dall’inizio. In questo
quadro generale, non è difficile individuare i profili determinanti della
vicenda di Dreyfus. Accusare Dreyfus di tradimento; condurlo sul banco degli
imputati sulla sola base di un bordereau, contenente rivelazioni di segreti
militari a favore dei tedeschi, ma in realtà di mano altrui; condannarlo alla
degradazione e alla deportazione perpetua nell’Ile du Diable, sulla scorta di un
documento che ne avrebbe provato la certa colpevolezza, ma che, essendo
segretissimo, non viene mostrato neppure al difensore; assolvere, dopo soli tre
minuti di camera di consiglio, il comandante Walsin- Esterhazy – il vero
responsabile – solo allo scopo di non sconfessare l’operato del precedente
collegio giudicante, che aveva già condannato Dreyfus; imprigionare il tenente
colonnello Picquart, che aveva scoperto l’imbroglio, accusandolo di falso;
indurre al suicidio il Maggiore Henry, l’autore sciagurato del documento falso
adoperato per condannare Dreyfus… sono questi in tratti tipici di ogni
persecuzione sociale – come bene individuati da René Girard – e Dreyfus ne è il
capro espiatorio. E si tratta, come spesso accade, di una persecuzione
giudiziaria, vale a dire messa in opera attraverso le forme del diritto e
l’operato dei giudici: quanto di meglio per dissimulare sotto le specie della
legalità formale, la più perfida e sconcertante delle iniquità. Allo scopo di
perfezionare lo schema della persecuzione, occorrono alcuni elementi che sono
qui presenti in modo paradigmatico. Il primo è che deve trattarsi di un’accusa
che abbia un contenuto universalmente repellente, non suscettibile,
tendenzialmente, di suscitare eccezioni o ripensamenti: infatti, Dreyfus viene
accusato di spionaggio, reato spregevole di per sé, e che, nella Francia di fine
ottocento, mette a repentaglio la sola istituzione ancora meritevole di
credibilità, vale a dire l’esercito. Nessuno potrebbe permettersi di revocare in
dubbio la necessità di condannare in modo esemplare il colpevole di un illecito
così pericoloso e antinazionalista. Il secondo elemento consiste nella
circostanza che l’accusato non può mai essere uno qualunque, uno di cui sia
indifferente la qualità sociale, ma, al contrario, deve essere portatore di uno
stigma che lo consegni ad una classe minoritaria ma identificabile di individui:
il negro, il deforme, lo straniero. Infatti, Dreyfus è ebreo e, per giunta, di
origine alsaziana. Quanto di meglio per sollecitare lo spregio
dell’antisemitismo e del nazionalismo militarista di coloro che vedono negli
ebrei la causa di ogni male e negli alsaziani – sempre a metà fra Germania e
Francia – il germe di ogni tradimento. Infine, la persecuzione va dissimulata,
preferibilmente nascosta dietro le forme rassicuranti del diritto e del
processo, allo scopo di non svelare il meccanismo vittimario e persecutorio.
Infatti, Dreyfus viene processato ben due volte, così come Zola imputato di
diffamazione, ed essi vengono sempre condannati. Ed Esterhazy, il vero
colpevole, viene addirittura assolto, dopo appena tre minuti di camera di
consiglio. Tanto per non smentirsi. Orbene, il solo modo di contrastare i
nefandi effetti della persecuzione sta nello svelamento dei meccanismi che la
fanno funzionare: una persecuzione messa a nudo come strumento di violenza,
svelata come persecuzione, si sgonfia come un palloncino senza più ossigeno,
depotenziandosi in modo irreversibile. Occorre tuttavia qualcuno che si
incarichi di questo svelamento: Emile Zola si assume questo compito difficile,
scomodo, impopolare. Egli è il rivelatore. Anche del rivelatore della
persecuzione si richiedono comunque precise caratteristiche, tutte ampiamente
possedute da Zola: coraggio per opporsi alla massa della opinione pubblica e dei
mezzi di comunicazione; sufficiente notorietà per trovare una platea di ascolto
quanto più diffusa possibile; capacità soggettive di comunicazione universale. E
infine, quella più importante: la passione per la verità del diritto, vale a
dire per la giustizia. Così, Zola, scrivendo infuocati editoriali sulla stampa
parigina in difesa dell’innocente Dreyfus e accusando i suoi carnefici, inaugura
la figura dell’intellettuale in senso moderno. Si badi. Il termine
“intellettuale” fino al settecento era stato sempre usato in senso aggettivale,
non quale sostantivo, come oggi viene normalmente adoperato. Furono gli
illuministi francesi a propiziare questo nuovo uso del termine, a partire da
Diderot, il quale, nella sua celebre Lettre sur la liberté de la presse, segna
probabilmente il transito dal clericus tardo medievale all’intellettuale in
senso moderno.
Si badi ancora a non confondere l’intellettuale
con il filosofo o con il pensatore: costoro certamente pensano in modo
originale, ma non sempre rivestono il ruolo del vero intellettuale. Questi è
invece caratterizzato dal collocarsi sempre all’opposizione di ogni potere che,
mettendo fra parentesi le ragioni del diritto – e perciò della giustizia –
voglia manifestarsi quale pura sopraffazione: il potere economico, quello
politico, quello ideologico, quello comunicativo, quello giudiziario, quello
della mafia e anche (come insegna Sciascia) quello dell’antimafia.
L’intellettuale, identificandosi non con uno status personale, ma con un ruolo
sociale, si presenta perciò come il “demistificatore delle accuse”, colui che
svela pubblicamente il meccanismo persecutorio, opponendosi al potere violento
che di volta in volta sia capace di attivarne i percorsi. Ecco perché Zola si
colloca agli antipodi sia dall’intellettuale organico caro a Gramsci o a Lenin
(l’intellettuale al servizio del potere); sia da quello che – secondo la
lezione, di matrice platonica, di Fichte – indichi al potere il traguardo da
raggiungere (il potere al servizio dell’intellettuale); sia da quello
sdegnosamente rinchiuso, secondo la lezione di Max Weber, nella turris eburnea
del suo sapere (l’intellettuale al servizio di se stesso). Zola, infatti, è al
servizio esclusivamente della verità e della giustizia. In tal modo, egli si
colloca all’opposizione sia dell’esercito, minacciato dalle sue rivelazioni; sia
dei Consigli dei giudici militari che avevano condannato l’innocente Dreyfus e
assolto il colpevole Esterhazy; sia dei ministri che tali nefandezze avevano
propiziato e coperto; sia dei nazionalisti e conservatori, che lo consideravano
un pericolo pubblico; sia perfino dei socialisti, perché di origine borghese;
nonché della borghesia, perché egli non esita a criticarla. Insomma, dicendo la
verità sul caso Dreyfus, Zola attira su di sé le veementi reazioni di tutti, al
punto da essere condannato per diffamazione e dover riparare a Londra. Si attua
così il tipico “spostamento mimetico” – messo in luce dall’antropologia di
Girard – in forza del quale, la violenza indirizzata verso il perseguitato viene
spostata verso chi, demistificando l’accusa come persecutoria, diviene a sua
volta un nuovo capro espiatorio. Impegnandosi in questo compito socialmente
soteriologico, teso a demistificare l’accusa, Zola si colloca così in singolare
continuità con il compito che dovrebbe essere proprio del giudice in uno Stato
di diritto, anch’egli impegnato a demistificare le accuse non provate,
cerebrine, fumose, non previste dal codice penale (si pensi al concorso esterno
in associazione mafiosa): ma oggi purtroppo, in Italia, compito di rado condotto
a buon fine. In ogni caso, Zola è stato ed ancora è il paradigma
dell’intellettuale moderno, oggi forse in via di estinzione. Lo fu certamente
Pasolini, del quale rimane indimenticabile la posizione assunta, dopo i fatti di
Valle Giulia, attraverso i celebri versi dettati a difesa delle forze
dell’ordine (i figli dei braccianti del Sud), aggrediti dai sessantottini
rivoluzionari (i figli della opulenta borghesia del Nord); o, ancora, quella
assunta contro l’aborto come pratica legalizzata: «Se tutti gli uomini sono
stati embrioni, perché non tutti gli embrioni possono diventare uomini?», si
chiedeva Pasolini. Lo fu certamente Sciascia che denunciò il potere, sottratto
ad ogni critica, del quale certa antimafia può impunemente usare. Grandinarono
su entrambi ovviamente reprimende, accuse, censure, da stolidi e saccenti
alfieri del nulla, sedicenti custodi dell’etica pubblica. Altri in Italia,
nell’Italia di oggi, potrebbero e dovrebbero assumere quel ruolo. Ma, come sopra
rilevato, ci vorrebbe coraggio. E, come tutti sappiamo, il coraggio chi non l’ha
non se lo può dare.
Scheurer-Kestner interviene e da quel
momento si accese una fiammella di verità. Sul finire
del 1897, Zola non può fare a meno di constatare che il vicepresidente del
Senato Auguste Scheurer- Kestner, è roso dal dubbio che Dreyfus possa essere
innocente, scrive Vincenzo Vitale il 9 Agosto 2018 su "Il Dubbio". Nel 1894,
quando ha inizio il caso Dreyfus, attraverso il casuale ritrovamento in un
cestino dei rifiuti da parte di una addetta alle pulizie – che poi alcuni
dissero essere membro del controspionaggio – di un bordereau contenente
rivelazioni militari destinate agli odiati tedeschi, Emile Zola, scrittore già
molto conosciuto e molto apprezzato in tutta Europa, si trova a Roma. Fa ritorno
in Francia solo alla fine dell’anno ed è perciò naturale che non abbia avuto
notizia sufficiente di quanto accaduto durante il suo soggiorno italiano. Ecco
perché il primo intervento giornalistico di Zola, qui pubblicato, si colloca
soltanto nel novembre del 1897, quando già le prime parti del dramma sono state
abbondantemente consumate. Sulla scorta di quel documento strumentalmente
attribuito a Dreyfus, questi viene arrestato nell’ottobre del 1894 e
sommariamente giudicato, subendo una condanna che da tutti si esigeva esemplare:
degradazione e deportazione perpetua all’Isola del diavolo, nella Caienna
francese. Prove a carico: nessuna. Tuttavia, la durezza della condanna era
equivalente ad una condanna a morte che lentamente avrebbe consumato l’innocente
Dreyfus, con lo stesso scorrere delle ore e dei giorni e, per giunta, sostenuta
dalla esecrazione generale per il colpevole di un crimine così nefando. Un vero
orrore. Ecco dunque che sul finire del 1897, Zola non può fare a meno di
constatare che il vicepresidente del Senato Auguste Scheurer- Kestner, uomo
probo e di cui tesse le lodi, è roso dal dubbio che Dreyfus possa essere
innocente e che, poi, avendo egli conosciuto meglio i profili giudiziari del
caso, di questa innocenza abbia raggiunto la certezza. Ragion per cui, scrive
Zola: «Conosce la verità e ora deve fare giustizia». Scheurer- Kestner è un
chimico, un industriale di successo, fiero oppositore di Napoleone III, di
origine alsaziana, politico di razza. Ciò basta a mettere in chiaro due aspetti
rilevanti. Innanzitutto, che non occorre essere giuristi professionisti per
capire quando si metta in opera una persecuzione giudiziaria, destinata a
sacrificare una vittima – allo scopo di garantire la minacciata coesione sociale
– invece che a realizzare la giustizia. Scheurer- Kestner lo capisce
semplicemente ascoltando senza pregiudizi il racconto a lui fatto dal fratello
di Dreyfus, Mathieu, e dalla moglie, Lucie Hadamard: basta un po’ di normale
buon senso. Inoltre, va notato che è proprio lui, in prima battuta, a subire lo
spostamento mimetico proprio di ogni persecuzione. Infatti, su di lui –
alsaziano come Dreyfus – cadono, in questo momento, gli strali dei benpensanti,
di quelli che sono certi, certissimi della colpevolezza di Dreyfus, ma che
ovviamente si rifiutano ostinatamente di pensare, ritenendo il pensiero e il suo
esercizio compiti che possono bene essere affidati ad altri, incaricati di
pensare per tutti. Qualche anno dopo, un altro vero intellettuale, Karl Kraus,
scrivendo dal cuore profondo dell’Europa, la regale Vienna, l’avrebbe
icasticamente chiarito nei suoi Detti e contraddetti: «Tutta la vita dello Stato
e della società è fondata sul tacito presupposto che l’uomo non pensi. Una testa
che non si offra in qualsiasi situazione come un capace spazio vuoto non avrà
vita facile nel mondo». E dunque, nel bel mezzo di milioni di individui dalla
testa vuota che intendono custodire la facilità della propria vita, Scheurer-
Kestner preferisce avere una vita difficile, pur di pensare; e, pensando, non
può evitare di dire la verità e cioè che Dreyfus è stato condannato da perfetto
innocente. Zola viene attratto proprio da questo aspetto e perciò, senza ancora
voler trattare esplicitamente dell’affaire, assume le difese dell’uomo politico,
in vario modo sospettato, accusato dagli anti- dreyfusard di demenza senile e
perfino di essersi fatto comprare dagli ebrei che avrebbero sborsato una bella
somma allo scopo. Follie, assurdità, veleni contro la ragione dettati da un
becero antisemitismo e da un nazionalismo cieco, grida Zola. Questi, dal canto
suo, non è certo nuovo ad assumere posizioni oppositive. Basti pensare a quando,
nel 1866, appena ventiseienne, ancora squattrinato, ma incaricato da parte del
quotidiano L’Evénement – di proprietà del celebre Le Figaro – di seguire le
mostre pittoriche del Salon parigino, stronca letteralmente la paludata giuria
dell’esposizione, prigioniera di vetusti schemi accademici. Egli assume le
difese criticamente fondate di coloro che saranno chiamati poi “impressionisti”:
Edouard Manet – la cui Colazione sull’erba giudica un capolavoro – Claude Monet,
Pisarro e Cèzanne, di cui diviene grande amico. Si attira così le ire dei
benpensanti, di coloro che preferivano la pittura manieristica e odiavano le
opalescenze impressionistiche come traviamenti dell’anima e della mente. Ma Zola
non cede. Risultato: l’editore, travolto dalle polemiche, è costretto a
sospendere la rubrica tenuta da Zola e questi resta disoccupato e senza un
soldo. È appena il caso di ricordare che la storia si assumerà il compito di
consacrare definitivamente gli impressionisti, difesi da Zola, seppellendo
nell’oblio i suoi critici. Ecco perchè lo scrittore sa bene – quando prende le
difese di Scheurer- Kestner – che dire la verità esige sempre un prezzo, a volte
molto alto. Ma sa anche che – come recita la chiusa di questo articolo – «la
verità è in cammino e niente la potrà fermare».
«La caccia all’ebreo traditore».
Scrive Émile Zola su “Le Figaro” il primo dicembre 1897 ripubblicato il 12
Agosto 2018 su "Il Dubbio". Contavo di scrivere per Le Figaro tutta una serie di
articoli sul caso Dreyfus, un’intera campagna, via via che gli avvenimenti si
fossero svolti. Per caso, durante una passeggiata, ne avevo incontrato il
direttore, Fernand de Rodays. Ci eravamo messi a discorrere, accalorandoci,
proprio in mezzo ai passanti, e da lì era nata bruscamente la mia decisione di
offrirgli degli articoli, avendolo sentito d’accordo con me. Mi trovavo così
impegnato, quasi senza volerlo. Aggiungo, tuttavia, che prima o poi ne avrei
parlato, poiché tacere mi era impossibile. Non dimentichiamo con quale vigore Le
Figaro cominciò e soprattutto finì per sposare la causa. Il concetto è noto. Ed
è di una bassezza e di una stupidità semplicistica, degne di quelli che l’hanno
immaginato. Il capitano Dreyfus viene condannato da un tribunale militare per
alto tradimento. Da quel momento, diventa il traditore, non più un uomo ma
un’astrazione, colui che incarna l’idea della patria sgozzata, venduta al nemico
vincitore. Non si tratta solo di tradimento presente e futuro, rappresenta pure
il tradimento passato, poiché a lui si ascrive l’antica sconfitta, nell’ostinata
convinzione che solo il tradimento abbia potuto far sì che fossimo battuti. Ecco
quindi l’anima nera, il personaggio abominevole, la vergogna dell’esercito, il
bandito che vende i fratelli, proprio come Giuda ha venduto il suo Dio. E,
trattandosi di un ebreo, è semplicissimo: gli ebrei che sono ricchi e potenti e
senza patria, del resto, lavoreranno sott’acqua, con i loro milioni, per
toglierlo dai guai; compreranno le coscienze e tesseranno attorno alla Francia
un complotto esecrabile pur di ottenere la riabilitazione del colpevole, pronti
a sostituirgli un innocente. La famiglia del condannato, anch’essa ebrea,
naturalmente, entra nell’affare. Affare sì, poiché è a peso d’oro che si tenterà
di disonorare la giustizia, d’imporre la menzogna, di sporcare un popolo con la
più impudente delle campagne. Il tutto per salvare un ebreo dall’infamia e
sostituirlo con un cristiano. Insomma, si crea quasi un consorzio finanziario.
Vale a dire che alcuni banchieri si riuniscono, mettono dei fondi in comune,
sfruttano la credulità pubblica. Da qualche parte, c’è una cassa che paga per
tutto il fango smosso. C’è una vasta impresa tenebrosa, uomini mascherati, forti
somme consegnate di notte, sotto i ponti, a degli sconosciuti, ci sono grandi
personaggi da corrompere, pagandone a prezzi folli l’antica onestà. E a poco a
poco questo sindacato si allarga, finisce per essere un’organizzazione potente,
nell’ombra, tutta una spudorata cospirazione per glorificare il traditore e per
annegare la Francia sotto una marea d’ignominia. Esaminiamolo, questo sindacato.
Gli ebrei si sono arricchiti, e sono loro a pagare l’onore dei complici,
profumatamente. Mio Dio, chissà quanto avranno già speso! Ma, se sono arrivati
appena a una decina di milioni, capisco benissimo che li abbiamo sacrificati.
Siamo di fronte a cittadini francesi, nostri uguali e nostri fratelli, che
l’antisemitismo imbecille trascina quotidianamente nel fango. Si è tentato di
schiacciarli per mezzo del capitano Dreyfus; del crimine di uno di loro, si è
cercato di fare il crimine di un’intera razza. Tutti traditori, tutti venduti,
tutti da condannare. E volete che gli stessi non protestino furiosamente, non
cerchino di discolparsi, di restituire colpo su colpo in questa guerra di
sterminio della quale sono oggetto? Va da sé, naturalmente, che si augurino con
tutto il cuore di vedere risplendere l’innocenza del loro correligionario; e se
la riabilitazione appare loro possibile, chissà con quanto ardore si staranno
impegnando per ottenerla. Ciò che mi lascia perplesso è che, se esiste uno
sportello dove si va a riscuotere, non ci sia nel sindacato qualche autentico
briccone. Vediamo un po, voi li conoscete bene: come si spiega che il tale, o il
tal altro, o il tal altro ancora, non lo siano? E’ incredibile, ma tutta la
gente che si dice gli ebrei abbiano comprato gode di una solida reputazione di
probità. C’è forse un fondo di civetteria? Forse, gli ebrei vogliono soltanto
merce rara, essendo disposti a pagarla? Io, però, dubito molto di questo
sportello, anche se sarei prontissimo a giustificare gli ebrei qualora, portati
all’esasperazione, si difendessero con i loro milioni. In un massacro, ognuno si
serve di quello che ha. E parlo di loro con la massima tranquillità perché non
li amo e non li odio. Non ho amici ebrei particolarmente vicini al mio cuore.
Per me sono uomini, e tanto basta. Ma per la famiglia del capitano Dreyfus è ben
diverso, e qui se qualcuno non comprendesse, non s’inchinasse, sarebbe un cuore
davvero arido. Sia ben chiaro! tutto il suo oro, tutto il suo sangue, la
famiglia ha il diritto e il dovere di offrirlo, se crede innocente il suo
rampollo. Quella è una soglia sacra che nessuno ha il diritto di insozzare. In
quella casa che piange, dove c’è una moglie, dei fratelli, dei genitori in
lutto, è d’obbligo entrare con il cappello in mano; e soltanto gli zotici si
permettono di parlare ad alta voce e mostrarsi insolenti. Il fratello del
traditore! è l’insulto che si getta in faccia a quel fratello. Sotto quale
morale, sotto quale Dio viviamo, mi chiedo, perché ciò sia possibile, perché la
colpa di uno dei componenti venga rimproverata a tutta la famiglia? Non c’è
niente di più vile, di più indegno della nostra cultura e della nostra
generosità. I giornali che ingiuriano il fratello del capitano Dreyfus, solo
perché ha fatto il suo dovere, sono un’onta per la stampa francese. E chi mai
doveva parlare, se non lui? E’ compito suo. Quando la sua voce si è levata a
chiedere giustizia, nessuno più aveva il diritto d’intervenire, si sono fatti
tutti da parte. Lui solo aveva la veste per sollevare la spinosa questione di un
possibile errore giudiziario, della verità su cui far luce, una verità lampante.
Hanno un bell’accumulare ingiurie, nessuno potrà oscurare il concetto che la
difesa dell’assente l’hanno in mano quelli del suo sangue, che hanno conservato
la speranza e la fede. E la prova morale più forte in favore dell’innocenza del
condannato è proprio la convinzione incrollabile di un’intera e onorata
famiglia, di una probità e di un patriottismo senza macchia. Poi, dopo gli ebrei
fondatori, dopo la famiglia che ne è a capo, vengono i semplici membri del
sindacato, quelli che si sono fatti comprare. Due tra i più anziani sono Bernard
Lazare e il comandante Forzinetti. In seguito, sono venuti Scheurer- Kestner e
Monod. Ultimamente, si è scoperto il colonnello Picquart, senza contare Leblois.
E spero bene, dopo il mio primo articolo, di far parte pure io della banda. Del
resto, appartiene al sindacato, viene tacciato d’essere un malfattore e d’essere
stato pagato, chiunque, ossessionato dall’agghiacciante brivido di un possibile
errore giudiziario, si permetta di volere che sia fatta la verità, in nome della
giustizia. Siete stati voi a volerlo, a crearlo, questo sindacato. Voi tutti che
contribuite a questo spaventoso caos, voi falsi patrioti, antisemiti sbraitanti,
semplici sfruttatori della pubblica sconfitta. La prova non è forse completa, di
una luminosità solare? Se ci fosse stato un sindacato, ci sarebbe stata
un’intesa; e dov’è l’intesa? E’ semplicemente nato in alcune coscienze,
all’indomani della condanna, un senso di malessere, un dubbio, di fronte
all’infelice che grida a tutti la sua innocenza. La crisi terribile, la pubblica
follia alla quale assistiamo, è sicuramente partita da lì, dal lieve brivido
rimasto negli animi. Ed è il comandante Forzinetti l’uomo di quel brivido che
tanti altri hanno provato, quello che ce ne ha fatto un racconto così cocente.
Poi, c’è Bernard Lazare. Preso dal dubbio, lavora a far luce. La sua inchiesta
solitaria si svolge però in mezzo a tenebre che gli è impossibile diradare.
Pubblica un opuscolo, ne fa uscire un secondo alla vigilia delle sue rivelazioni
di oggi; e la prova che lavorava da solo, che non era in relazione con nessun
altro membro del sindacato, è che non ha saputo, non ha potuto dire niente della
verità vera. Un sindacato proprio strano, i cui membri si ignorano! C’è poi
Scheurer- Kestner, a sua volta torturato dal bisogno di verità e di giustizia, e
che cerca, tenta di arrivare a una certezza, senza sapere niente dell’inchiesta
ufficiale ufficiale, dico – che contemporaneamente veniva svolta dal colonnello
Picquart, messo sulla buona strada dalle sue stesse funzioni presso il ministero
della Guerra. C’è voluto un caso, un incontro, come si saprà in seguito, perché
i due uomini che non si conoscevano, che lavoravano ognuno per conto proprio
alla stessa opera, finissero all’ultimo momento per raggiungersi e procedere
fianco a fianco. La storia del sindacato è tutta qui: uomini di buona volontà,
di verità e di equità, partiti dai quattro punti cardinali, senza conoscersi e
lavorando a leghe di distanza, ma incamminati tutti verso uno stesso fine,
procedendo in silenzio, esplorando il terreno e convergendo tutti un bel mattino
verso lo stesso punto d’arrivo. Com’era inevitabile, si sono trovati tutti e
presi per mano a quel crocevia della verità, a quel fatale appuntamento della
giustizia. Come vedete siete voi che, ora, li riunite, li costringete a serrare
i ranghi per dedicarsi a un medesimo sforzo sano e onesto, questi uomini che voi
coprite d’insulti, che accusate del più nero complotto, quando miravano
unicamente a un’opera di suprema riparazione. Dieci, venti giornali, ai quali si
mescolano le passioni e gli interessi più diversi, una stampa ignobile che non
posso leggere senza che mi si spezzi il cuore per lo sdegno, non ha cessato,
come dicevo, di convincere il pubblico che un sindacato di ebrei fosse impegnato
nel più esecrabile dei complotti, acquistando le coscienze a peso d’oro. Lo
scopo era in un primo momento quello di salvare il traditore e sostituirlo con
un innocente; poi, quello di disonorare l’esercito, di vendere la Francia come
nel 1870. Sorvolo sui romanzeschi par- ticolari della tenebrosa macchinazione. E
questa opinione, lo riconosco, è diventata quella della grande maggioranza del
pubblico. Quante persone ingenue mi hanno avvicinato in questi otto giorni, per
dirmi con aria stupefatta: «Come! Dite che Scheurer- Kestner non è un bandito? e
anche voi vi mettete con quella gentaglia? Ma non lo sapete che hanno venduto la
Francia?». Il cuore mi si stringe per l’angoscia, perché so bene che una simile
perversione dell’opinione pubblica rende molto facile imbrogliare le carte. E il
peggio è che i coraggiosi sono rari, quando c’è da andare controcorrente. Quanti
ti mormorano all’orecchio di essere convinti dell’innocenza del capitano
Dreyfus, ma che non se la sentono di assumere un atteggiamento pericoloso, nella
mischia! Dietro l’opinione pubblica, sulla quale contano naturalmente di potersi
appoggiare, ci sono gli uffici del ministero della Guerra. Non voglio parlarne,
oggi, perché ancora spero che giustizia sarà fatta. Ma chi non si rende conto
che siamo di fronte alla cattiva volontà più cocciuta? Non si vuole riconoscere
di aver commesso degli errori e, vorrei dire, delle colpe. Ci si ostina a
coprire i personaggi compromessi e si è pronti a tutto, pur di evitare il
tremendo repulisti. E la cosa è talmente grave, che gli stessi che hanno in mano
la verità, dai quali si esige furiosamente che la dicano, esitano, aspettano a
gridarla pubblicamente, nella speranza che la stessa si imponga da sé e che
venga loro risparmiato il dolore di doverla dire. Ma è pur sempre una verità
quella che, da oggi, io vorrei diffondere in tutta la Francia. Ossia che si è
sul punto di farle commettere, a lei che è la giusta, la generosa, un autentico
crimine. Non è più la Francia, dunque, perché si possa ingannarla a tal punto,
aizzarla contro un infelice che, da tre anni, espia, in condizioni atroci, un
crimine che non ha commesso? Sì, esiste laggiù, in un’isola sperduta, sotto un
sole spietato, un essere che è stato separato dai suoi simili. E non solo il
mare lo isola, ma undici guardiani lo circondano notte e giorno come una
muraglia vivente. Undici uomini sono stati immobilizzati per sorvegliarne uno
solo. Mai assassino, mai pazzo furioso è stato murato in modo così totale. E
l’eterno silenzio e la lenta agonia sotto l’esecrazione di una nazione intera!
Osereste dire, ora, che quest’uomo non è colpevole? Ebbene, è proprio quello che
affermiamo, noi, gli appartenenti al sindacato. E lo diciamo alla Francia e ci
auguriamo che prima o poi ci ascolti poiché sempre essa si infervora per le
cause giuste e belle. Le diciamo che noi vogliamo l’onore dell’esercito, la
grandezza della nazione. E’ stato commesso un errore giudiziario e, finché non
sarà riparato, la Francia soffrirà, malaticcia, come per un cancro segreto che
corrode a poco a poco le armi. E se, per farla ritornare sana, è necessario
ricorrere al bisturi, si faccia! Un sindacato per agire sull’opinione pubblica,
per guarirla dalla demenza in cui l’ha gettata certa ignobile stampa, per
riportarla alla sua fierezza, alla sua secolare generosità. Un sindacato per
ripetere ogni mattina che le nostre relazioni diplomatiche non sono in gioco,
che l’onore dell’esercito non è affatto in causa, che solo alcune individualità
possono essere compromesse. Un sindacato per dimostrare che qualsiasi errore
giudiziario è riparabile, e che perseverare in un errore del genere, con il
pretesto che un consiglio di guerra non può sbagliarsi, è la più mostruosa delle
ostinazioni, la più spaventosa delle infallibilità. Un sindacato per condurre
una campagna fino a che verità sia detta, fino a che giustizia sia resa, al di
là di tutti gli ostacoli, quand’anche occorressero ancora anni di lotta. Sì, di
questo sindacato faccio parte anch’io e spero tanto che voglia farne parte tutta
la brava gente di Francia! Articolo Pubblicato su “Le Figaro” il primo dicembre
1897
Io accuso quel colonnello diabolico.
Il celeberrimo articolo intitolato J’Accuse nel quale Emile Zola elenca i nomi
dei responsabili della macchinazione giudiziaria contro Alfred Dreyfus. Scrive
Émile Zola sul quotidiano «L’Aurore» il 13 gennaio 1898 e ripubblicato il 15
Agosto 2018 su "Il Dubbio". «Monsieur le Président, permettetemi, grato, per la
benevola accoglienza che un giorno mi avete fatto, di preoccuparmi per la Vostra
giusta gloria e dirvi che la Vostra stella, se felice fino ad ora, è minacciata
dalla più offensiva ed inqualificabile delle macchie. Avete conquistato i cuori,
Voi siete uscito sano e salvo da grosse calunnie. Apparite raggiante
nell’apoteosi di questa festa patriottica che l’alleanza russa ha rappresentato
per la Francia e Vi preparate a presiedere al trionfo solenne della nostra
esposizione universale, che coronerà il nostro grande secolo di lavoro, di
libertà e di verità. Ma quale macchia di fango sul Vostro nome, stavo per dire
sul Vostro regno – soltanto quell’abominevole affare Dreyfus! Per ordine di un
consiglio di guerra è stato scagionato Esterhazy, ignorando la verità e
qualsiasi giustizia. È finita, la Francia ha sulla guancia questa macchia, la
storia scriverà che sotto la Vostra presidenza è stato possibile commettere
questo crimine sociale. E poiché è stato osato, oserò anche io. La verità, la
dirò io, poiché ho promesso di dirla, se la giustizia, regolarmente osservata
non la proclamasse interamente. Il mio dovere è di parlare, non voglio essere
complice. Le mie notti sarebbero abitate dallo spirito dell’uomo innocente che
espia laggiù nella più spaventosa delle torture un crimine che non ha commesso.
Ed è a Voi signor presidente, che io griderò questa verità, con tutta la forza
della mia rivolta di uomo onesto. In nome del Vostro onore, sono convinto che la
ignoriate. E a chi dunque denuncerò se non a Voi, primo magistrato del paese?
Per prima cosa, la verità sul processo e sulla condanna di Dreyfus. Un uomo
cattivo, ha condotto e fatto tutto: è il luogotenente colonnello del Paty di
Clam, allora semplice comandante. La verità sull’affare Dreyfus la saprà
soltanto quando un’inchiesta legale avrà chiarito i suoi atti e le sue
responsabilità. Appare come lo spirito più fumoso, più complicato, ricco di
intrighi romantici compiacendosi al modo dei romanzi feuilletons, carte sparite,
lettere anonime, appuntamenti in luoghi deserti, donne misteriose che
accaparrano prove durante gli appuntamenti. È lui che immaginò di dettare
l’elenco a Dreyfus, è lui che sognò di studiarlo in una parte rivestita di
ghiaccio, è lui che il comandante Forzinetti ci rappresenta armato di una
lanterna, volendo farsi introdurre vicino l’accusato addormentato, per
proiettare sul suo viso un brusco raggio di luce e sorprendere così il suo
crimine nel momento del risveglio. Ed io non ho da dire altro che se si cerca si
troverà. Dichiaro semplicemente che il comandante del Paty di Clam incaricato di
istruire la causa Dreyfus, come ufficiale giudiziario nel seguire l’ordine delle
date e delle responsabilità, è il primo colpevole del terribile errore
giudiziario che è stato commesso. L’elenco era già da tempo nelle mani del
colonnello Sandherr direttore dell’ufficio delle informazioni, morto dopo di
paralisi generale. Ebbero luogo delle fughe, carte sparivano come ne spariscono
oggi e l’autore dell’elenco era ricercato quando a priori si decise poco a poco
che l’autore non poteva essere che un ufficiale di stato maggiore e un ufficiale
dell’artiglieria: doppio errore evidente che mostra con quale spirito
superficiale si era studiato questo elenco, perché un esame ragionato dimostra
che non poteva agire soltanto un ufficiale di truppa. Si cercava dunque nella
casa, si esaminavano gli scritti come un affare di famiglia, un traditore da
sorprendere dagli uffici stessi per espellerlo. E senza che voglia rifare qui
una storia conosciuta solo in parte, entra in scena il comandante del Paty di
Clam da quando il primo sospetto cade su Dreyfus. A partire da questo momento, è
lui che ha inventato il caso Dreyfus, l’affare è diventato il suo affare, si fa
forte nel confondere le tracce, di condurlo all’inevitabile completamento. C’è
il ministro della guerra, il generale Mercier, la cui intelligenza sembra
mediocre; c’è il capo dello stato maggiore, il generale de Boisdeffre che sembra
aver ceduto alla sua passione clericale ed il sottocapo dello stato maggiore, il
generale Gonse la cui coscienza si è adattata a molti. Ma in fondo non c’è che
il comandante di Paty di Clam che li conduce tutti perché si occupa anche di
spiritismo, di occultismo, conversa con gli spiriti. Non si potrebbero concepire
le esperienze alle quali egli ha sottomesso l’infelice Dreyfus, le trappole
nelle quali ha voluto farlo cadere, le indagini pazze, le enormi immaginazioni,
tutta una torturante demenza. Ah! Questo primo affare è un incubo per chi lo
conosce nei suoi veri dettagli! Il comandante del Paty di Clam, arresta Dreyfus
e lo mette nella segreta. Corre dalla signora Dreyfus, la terrorizza dicendole
che se parla il marito è perduto. Durante questo tempo, l’infelice si strappava
la carne, gridava la sua innocenza. E la vicenda è stata progettata così come in
una cronaca del XV secolo, in mezzo al mistero, con la complicazione di selvaggi
espedienti, tutto ciò basato su una sola prova superficiale, questo elenco
sciocco, che era soltanto una tresca volgare, che era anche più impudente delle
frodi poiché i “famosi segreti” consegnati erano tutti senza valore. Se insisto
è perché il nodo è qui da dove usciva più tardi il vero crimine, il rifiuto
spaventoso di giustizia di cui la Francia è malata. […] Ma questa lettera è
lunga signor presidente, ed è tempo di concludere. Accuso il luogotenente
colonnello de Paty di Clam di essere stato l’operaio diabolico dell’errore
giudiziario, in incoscienza, io lo voglio credere, e di aver in seguito difeso
la sua opera nociva, da tre anni, con le macchinazioni più irragionevoli e più
colpevoli. Accuso il generale Marcire di essersi reso complice, almeno per
debolezza di spirito, di una delle più grandi iniquità del secolo. Accuso il
generale Billot di aver avuto tra le mani le prove certe dell’inno- cenza di
Dreyfus e di averle soffocate, di essersi reso colpevole di questo crimine di
lesa umanità e di lesa giustizia, per uno scopo politico e per salvare lo stato
maggiore compromesso. Accuso il generale de Boisdeffre ed il generale Gonse di
essersi resi complici dello stesso crimine, uno certamente per passione
clericale, l’altro forse con questo spirito di corpo che fa degli uffici della
guerra l’arcata santa, inattaccabile. Accuso il generale De Pellieux ed il
comandante Ravary di avere fatto un’indagine scellerata, intendendo con ciò
un’indagine della parzialità più enorme, di cui abbiamo nella relazione del
secondo un imperituro monumento di ingenua audacia…accuso i tre esperti in
scrittura i signori Belhomme, Varinard e Couard, di avere presentato relazioni
menzognere e fraudolente, a meno che un esame medico non li dichiari affetti da
una malattia della vista e del giudizio. Accuso gli uffici della guerra di avere
condotto nella stampa, particolarmente nell’Eclair e nell’Eco di Parigi, una
campagna abominevole, per smarrire l’opinione pubblica e coprire il loro
difetto. Accuso infine il primo consiglio di guerra di aver violato il diritto,
condannando un accusato su una parte rimasta segreta, ed io accuso il secondo
consiglio di guerra di aver coperto quest’illegalità per ordine, commettendo a
sua volta il crimine giuridico di liberare consapevolmente un colpevole.
Formulando queste accuse, non ignoro che mi metto sotto il tiro degli articoli
30 e 31 della legge sulla stampa del 29 luglio 1881, che punisce le offese di
diffamazione. Ed è volontariamente che mi espongo. Quanto alla gente che accuso,
non li conosco, non li ho mai visti, non ho contro di loro né rancore né odio.
Sono per me solo entità, spiriti di malcostume sociale. E l’atto che io compio
non è che un mezzo rivoluzionario per accelerare l’esplosione della verità e
della giustizia. Ho soltanto una passione, quella della luce, in nome
dell’umanità che ha tanto sofferto e che ha diritto alla felicità. La mia
protesta infiammata non è che il grido della mia anima. Che si osi dunque
portarmi in assise e che l’indagine abbia luogo al più presto. Aspetto. Vogliate
gradire, signor presidente, l’assicurazione del mio profondo rispetto». Articolo
pubblicato sul quotidiano «L’Aurore» il 13 gennaio 1898.
Quel giorno Zola schiaffeggiò il potere.
Il coraggio dello scrittore che diventa giurista per fare il suo dovere da
intellettuale: denunciare, scrive Vincenzo Vitale il 15 Agosto 2018 su "Il
Dubbio". Siamo così giunti all’apice della vicenda, al punto culminante dopo il
quale nulla sarà più come prima. In data 11 gennaio 1898, il Consiglio di
Guerra, appositamente convocato per giudicare la condotta di Esterhazy, dopo la
denuncia presentata a suo carico da Mathieu Dreyfus, clamorosamente, lo assolve,
con ciò implicitamente ma definitivamente confermando la colpevolezza di Alfred
Dreyfus.La cosa inaccettabile e che fa subito intendere come questo verdetto sia
stato dolosamente preordinato, sta nella circostanza che la camera di consiglio
è durata soltanto tre minuti – dico tre minuti di orologio – e che la prova
documentale della colpevolezza di Esterhazy non è stata neppure presa in
considerazione. Ciò significa che questo secondo Consiglio di guerra sapeva già
come decidere – cioè come non decidere – ancor prima della udienza e della
camera di consiglio: era etero- diretto da coloro che avevano ordinato di
assolvere Esterhazy, allo scopo di mettere una pietra tombale su Dreyfus. Zola
non può allora che alzare la voce per denunciare questo scandalo, confezionando
quello che è stato definito l’atto forse più rivoluzionario del secolo: il
J’accuse.Ovviamente, occorre prima denunciare con forza le gravissime nefandezze
commesse durante il processo a Dreyfus, anche per cercare di sollevare le
coscienze di una opinione pubblica spesso distratta o, peggio, condizionata
dalle voci di corridoio e da quelle della stampa popolare che, come abbiamo
visto, era tutta schierata contro Dreyfus.Si può condannare un essere umano alla
deportazione perpetua sulla scorta di un biglietto di origine molto incerta,
tanto che, per esser considerato prova a carico, va corredato da altro
documento, il quale, però, essendo segretissimo per ragioni di sicurezza
nazionale, non viene mostrato a nessuno, neppure al difensore?Non solo. Ogni
cosa viene imputata a Dreyfus: se conosce le lingue; se non le conosce; si
turba, allora è prova del delitto; non si turba, allora è prova del suo
professionismo delinquenziale… Siamo alla pura follia! Eppure è quello che
accaduto.Malgrado ciò – osserva stupito Zola – i protagonisti di queste
nefandezze riescono a dormire… Ma non basta. Il colonnello Picquart aveva
raggiunto la prova certa della colpevolezza di Esterhazy, attraverso il
reperimento di un telegramma a lui indirizzato da un agente straniero, mentre a
casa dello stesso era stato reperito materiale propagandistico contro la
Francia.Ma Esterhazy “doveva” essere assolto: e lo fu. Non si vuole qui
sottrarre la necessaria attenzione con cui si invita illettore a meditare sul
celebre scritto di Zola.La seconda parte non è che una sorta di crescendo
rossiniano, col quale Zola inchioda ogni soggetto che ebbe parte in questa
terribile vicenda alle proprie responsabilità.Zola opera qui, come si
accennava prima, una vera e propria demistificazione dell’accusa, smascherando –
e per questo è il rivelatore – la persecuzione giudiziaria alla quale era stato
sottoposto l’innocente Dreyfus.Egli mostra in tal modo come ogni intellettuale –
parola che va usata con parsimonia ed oculatezza– altro non sia che un vero
“eretico”, in quanto capace di operare scelte personali e spesso scomode, di
contro ad una opinione dominante e tendenzialmente totalizzante.Singolare e
degna di nota la consonanza di significato individuabile fra questa vocazione
dell’intellettuale a svolgere una funzione oppositiva del potere e la
definizione – assai pregnante – che del giurista forniva qualche decennio or
sono Salvatore Satta nei suoi indimenticabili Quaderni del diritto e della
procedura civile.Per Satta, il giurista è colui che dice di no, colui che sa e
ha il coraggio di dire di no a tutti coloro – e sono tanti – vorrebbero che
invece dicesse si, collaborando o prestando acquiescenza alle persecuzioni
sociali contro inermi innocenti, mistificate dall’involucro giuridico e
processuale.Come dire insomma che ogni giurista, per restare fedele al suo
ruolo, non può che svolgere una funzione oppositiva del potere, dedicandosi alla
demistificazione delle accuse false e persecutorie, così acquisendo la veste di
intellettuale; mentre, di converso, ogni intellettuale, destinato ad opporsi
ereticamente al potere persecutorio, allo scopo di smascherarlo, non può non
prestare attenzione alle vicende giuridiche e processuali della propria epoca,
alla loro valenza profondamente umana, morale, politica.E per far questo non
occorre la laurea in giurisprudenza. Basta non tenere gli occhi chiusi e farsi
guidare dal normale buon senso: Dostoevski, pur studiando da ingegnere, mostrava
più sensibilità giuridica e comprensione dei connessi problemi di tanti altri
che avessero seguito studi di giurisprudenza, Zola non era che uno scrittore.
Non era perciò un esperto di diritto, ma, per non far la fine miseranda di molti
esperti di qualcosa – i quali mostrano di saper tutto, ma non capiscono nulla –
si rifiutava di chiudere gli occhi.E, peccato ancor più grave, intendeva farsi
guidare dal buon senso. In quella società – ma anche nella nostra – come dire di
volersi suicidare.
L’odio antiebraico è il vero colpevole,
scrive Vincenzo Vitale il 16 Agosto 2018 su "Il Dubbio". Questo articolo,
pubblicato pochi giorni dopo che il fratello di Deyfus, Mathieu, ha formalmente
denunciato Esterhazy per il delitto di spionaggio, per il quale era stato
ingiustamente condannato Alfred, segna una sorta di messa a punto operata da
Zola. Infatti, lo scrittore, nutrendo una qualche riposta fiducia che il nuovo
processo a carico di Esterhazy possa condurre al riconoscimento della innocenza
di Dreyfus, sente il bisogno qui di chiarire la situazione come si era delineata
fino a quel punto. Per il resto, scrive Zola, «Un nuovo Consiglio di Guerra è al
lavoro… non resta che tacere e aspettare». Questo prudente atteggiamento di
attesa non esenta tuttavia dal cercare di capire cosa sia accaduto nei periodi
precedenti e come possa essere che un innocente sia finito alla deportazione
perpetua. Zola individua così alcuni elementi determinanti della situazione.
Innanzitutto, la stampa. Da un lato lo scrittore denuncia il comportamento della
maggioranza dei giornali, da subito ostili a Dreyfus, ma in modo pregiudiziale.
Sono soprattutto i giornali popolari a stimolare «passioni nefaste», conducendo
campagne settarie e spingendo il pubblico dei lettori non a farsi una idea
propria e indipendente, ma a schierarsi necessariamente contro il capitano
ebreo. Un vero inquinamento sociale organizzato a tutti i livelli e, quel che è
peggio, in perfetta buona fede. Ma è noto che di buona fede son lastricate le
vie dell’inferno. Invece, la grande stampa nazionale – quella delle classi colti
e della grande borghesia – ha fatto forse di peggio, registrando in modo anonimo
tutto e il contrario di tutto, la verità come l’errore, indifferentemente. E
tutto ciò spacciato per imparzialità, men- tre si tratta in modo evidente di una
condotta pericolosamente pilatesca di evitare di dire la verità, che invece
andrebbe gridata forte dai tetti. In secondo luogo, un elemento determinante è
senza alcun dubbio l’antisemitismo, come dice Zola, “il vero colpevole”. E qui
bisogna intendersi. Tutti siamo un po’ abituati a considerare patria
dell’antisemitismo la Germania e, in particolare, quella nazista, dove in
effetti si toccarono vertici di efferatezza difficilmente eguagliabili. Invece,
l’origine dell’antisemitismo risa a periodi precedenti e comunque trova in
Francia una delle sue espressioni più compiute e strabilianti. Non per nulla
Isacco Pinto, un ebreo portoghese, in un suo commento alle opere di Voltaire, ne
muove a questi un cauto ma fermo rimprovero. E Voltaire, in una lettera di
risposta, datata 21 luglio 1762, pur riconoscendo il torto di avere attribuito
«a tutto un popolo i vizi di molti individui», fa carico agli ebrei di essere
irrimediabilmente superstiziosi, «e la superstizione è il più abominevole
flagello della terra». Si può discutere a lungo sulla natura dell’antisemitismo
voltaireano nel considerarlo dovuto solo a una radicata avversione al misticismo
ebraico, sepolcro della ragione, o piuttosto a fobie, paradossalmente
irrazionali, come quando, al capitolo VIII dell’Essais sur les moeurs, definisce
gli ebrei «specie d’uomini inferiori». Resta il fatto che l’odio antiebraico
scorre come una linfa segreta lungo tutto il corso della storia culturale
francese (ed europea, come nota Léon Poliakov). Forse, eccettuato sicuramente
Rousseau, pochi altri pensatori francesi del XVIII e del XIX secolo vanno esenti
dal germe maligno dell’antisemitismo: per esempio, esso vegeta il Lamartine e
(in tono velato) in Balzac; in Charles Fourier e in Proudhon. Ecco perché il
processo che si sta celebrando a carico di Esterhazy viene visto da Zola come un
processo all’antisemitismo, che, nella temperie culturale francese di fine
secolo, si sposa con il patriottismo e con il militarismo, propiziando il
nascere e l’affermarsi di una miscela esplosiva che, naturalmente, alligna più
fra le classi medio- basse che nelle fasce più acculturate della popolazione. Il
terzo elemento preso in esame da Zola è la presenza degli spettatori di questa
grande tragedia nazionale ed europea, ciascuno depositario di una parte che
svolge fino in fondo. Il risultato è un pantano di interessi, di passioni, di
storie insulse e spesso inventate, di vergognosi pettegolezzi, ove il semplice
buon senso «viene schiaffeggiato ogni mattina». Zola spera che il processo in
quel momento in corso nei confronti di Esterhazy, davanti al secondo Consiglio
di Guerra, riconoscendone la colpevolezza e scagionando perciò Dreyfus, torni a
far prevalere il buon senso. Non sarà così.
Povera Francia, sei tornata alle guerre
di religione! Zola ringrazia il “coraggio” di “Le
Figaro” per aver pubblicato i suoi articoli e attacca la stampa che “avvelena il
popolo”. Scrive Émile Zola su “Le Figaro” il 5 dicembre 1897 e ripubblicato il
16 Agosto 2018 su "Il Dubbio". Quello che leggerete è il terzo e ultimo articolo
che mi fu permesso di dare a Le Figaro. Ho avuto persino qualche difficoltà a
farlo passare e, come si vedrà, ritenni saggio congedarmi con lo stesso dal
pubblico, intuendo che mi sarei trovato nell’impossibilità di continuare la mia
campagna, che tanto turbava i lettori abituali del giornale. Riconosco
perfettamente, a un giornale, la necessità di fare i conti con le abitudini e le
passioni della sua clientela. Perciò, ogni volta che ho subito questo genere di
battuta d’arresto, me la sono presa soltanto con me stesso, per essermi
sbagliato sul terreno e sulle condizioni di lotta. Le Figaro si è dimostrato
comunque coraggioso nell’accettare i miei tre articoli, e io lo ringrazio. Ah!
quale spettacolo, dopo tre settimane, e quali tragici, indimenticabili giorni
abbiamo attraversato! Non ne ricordo altri che abbiano suscitato in me tanta
umanità, tanta angoscia e tanta generosa collera. Esasperato, ho vissuto
nell’odio della stupidità e della malafede, a tal punto assetato di verità e di
giustizia da riuscire a comprendere i grandi moti dell’anima che possono portare
un placido borghese al martirio. In verità, si è trattato di uno spettacolo
inaudito, che per brutalità, per sfrontatezza, per ammissioni ignobili andava al
di là di tutto quello che di più istintivo e di più vile abbia mai confessato la
belva umana. Un simile esempio di follia e di perversione da parte di una folla
è raro ed è sicuramente per questo che, oltre a ribellarmi come uomo, mi sono
tanto appassionato come romanziere, come drammaturgo, sconvolto dall’entusiasmo
di fronte a un caso di così tremenda bellezza. Oggi, ecco, la storia entra nella
fase regolare e logica, quella che abbiamo desiderato, che abbiamo
incessantemente chiesto. Un tribunale militare è all’opera, il nuovo processo ha
come scopo la verità, e noi ne siamo convinti. Non abbiamo mai voluto altro. Non
resta, ora, che ta- cere e aspettare, perché non siamo noi a doverla dire, la
verità, è il Consiglio di guerra che la deve accertare, renderla lampante. E non
ci sarà un nostro nuovo intervento, a meno che essa non ne esca incompleta ed è
un’ipotesi del tutto inammissibile. Ma, essendo terminata la prima fase, vero
caos in piena tenebra, vero scandalo in cui tante coscienze sporche si sono
messe a nudo, dev’esserne redatto il processo verbale, bisogna trarne le
conclusioni. Perché, nella profonda tristezza delle constatazioni che si
impongono, c’è l’ammaestramento virile, il ferro rovente con cui si cauterizzano
le piaghe. Riflettiamoci: l’orrendo spettacolo che abbiamo appena dato a noi
stessi deve guarirci. Per cominciare, la stampa. Abbiamo visto la stampa
scadente in fregola, intenta a battere moneta con le curiosità malsane, a
guastare la folla per vendere le denigrazioni dei suoi scribacchini, che non
trovano più compratori da quando la nazione è calma, sana e forte. Sono
soprattutto i facinorosi nella sera, i giornali di tolleranza che adescano i
passanti con i loro titoli a caratteri cubitali, promettendo dissolutezza.
Facevano il loro commercio abituale, ma con un’impudenza significativa. Abbiamo
visto, un gradino più su, i giornali popolari, i giornali da un soldo, quelli
che si rivolgono alla massa e che formano l’opinione dei più, rinfocolare
passioni atroci, condurre furiosamente una campagna di settari, uccidendo nel
nostro caro popolo di Francia ogni generosità, ogni desiderio di verità e di
giustizia. Voglio credere alla loro buona fede. Ma quale tristezza, questi
cervelli di polemisti invecchiati, di agitatori dementi, di patrioti meschini
che, diventati conduttori di uomini, commettono il più nero dei crimini, quello
di ottenebrarne la coscienza pubblica e di fuorviare un intero popolo!
Quest’impresa è tanto più esecrabile quando è condotta, come in certi giornali,
con una bassezza di mezzi, un’abitudine alla menzogna, alla diffamazione e alla
delazione che rimarranno l’onta più grande della nostra epoca. Infine, abbiamo
visto la grande stampa, la stampa detta seria e onesta, assistere a tutto questo
con un’impassibilità, direi quasi una serenità stupefacente. Questi giornali
onesti si sono accontentati di registrare tutto con cura scrupolosa, la verità
come l’errore. Hanno lasciato che il fiume avvelenato scorresse, senza mettere
un solo abominio. Sì, certo, questa è imparzialità. Però, a stento qua e là una
timida valutazione, e non una sola voce alta e nobile, non una, capite? che si
sia alzata da questa stampa onesta, per schierarsi dalla parte dell’umanità,
dell’equità oltraggiata! E abbiamo visto soprattutto – poiché in mezzo a tanti
orrori è sufficiente scegliere il più ripugnante – abbiamo visto la stampa,
quella ignobile, continuare a difendere un ufficiale francese che aveva
insultato l’esercito e sputato sulla nazione. Non basta! Abbiamo visto giornali
che lo scusavano, altri che gli infliggevano il loro biasimo, sì, ma con qualche
riserva. Ma come! Non c’è stato un grido unanime di rivolta e di esecrazione!
Che cos’è mai accaduto perché un crimine che in un altro momento avrebbe
sollevato la coscienza pubblica in un bisogno furente di immediata repressione,
abbia potuto trovare delle circostanze attenuanti in quegli stessi giornali
tanto suscettibili in tema di fellonia e di tradimento? L’abbiamo visto, ripeto.
E ignoro cosa abbia prodotto un sintomo come questo sugli altri spettatori,
visto che nessuno parla, nessuno s’indigna. So che, per quanto mi riguarda, mi
ha fatto rabbrividire, poiché rivela con inaspettata violenza la malattia di cui
soffriamo. La stampa ignobile ha divorato la nazione e un accesso di quella
perversione, di quella corruzione in cui essa l’ha gettata, ha finito per
mettere l’ulcera completamente a nudo. L’antisemitismo, ora. È il vero
colpevole. Ho già detto come questa campagna barbara, che ci riporta indietro di
secoli, offenda il mio bisogno di fraternità, la mia passione per la tolleranza
e l’emancipazione umana. Ritornare alle guerre di religione, ricominciare le
persecuzioni religiose, volere lo sterminio tra le razze, sono cose di
un’assurdità tale, nel nostro secolo di affrancamento, che un simile tentativo
mi sembra soprattutto imbecille. Non poteva nascere che da un cervello fumoso e
squilibrato di credente, che da una grande vanità di scrittore rimasto a lungo
sconosciuto e desideroso di recitare una parte a tutti i costi, sia pure odiosa.
E non voglio ancora credere che un movimento del genere possa davvero prendere
un’importanza decisiva in Francia, in questo paese di libero esame, di bontà
fraterna e di limpida ragione. Eppure, assistiamo a misfatti terribili, devo
confessare che il male è gravissimo. Il veleno è nel popolo, anche se il popolo
non è tutto avvelenato. Dobbiamo all’antisemitismo la pericolosa virulenza che
gli scandali di Panama hanno preso qui da noi. E questo penoso caso Dreyfus è
tutta opera sua: soltanto l’antisemitismo ha reso possibile l’errore giudiziario
e sconvolto oggi la folla, impedendo che quell’errore venga tranquillamente e
nobilmente riconosciuto, per la nostra integrità eil nostro buon nome. Non c’era
niente di più semplice e di più naturale del fare luce sulla verità, appena
sorti i primi seri dubbi; come si può non capire che, perché si sia arrivati
alla pazzia furiosa in cui ci troviamo, è giocoforza che ci sia un veleno
nascosto che ci fa delirare tutti? Questo veleno è l’odio feroce contro gli
ebrei che ogni mattina, da anni, viene versato al popolo. Sono una banda, quelli
che fanno questo mestiere di avvelenatori, e il bello è che lo fanno in nome
della morale, in nome di Cristo, atteggiandosi a vendicatori e a giustizieri. E
chi ci dice che sul Consiglio di guerra non abbia agito l’ambiente stesso in cui
esso deliberava? Un ebreo traditore che vende il suo paese, la cosa va da sé. E
se anche non si trova alcuna ragione umana che spieghi il crimine, se anche
l’imputato è ricco, savio, lavoratore, senza passioni e con una vita
impeccabile, non basta forse il fatto che sia ebreo? Oggi, da quando cioè
chiediamo che si faccia luce, l’atteggiamento dell’antisemitismo è ancora più
violento, più tracotante. E’ il suo processo, quello che si sta per istruire, e
che schiaffo sarebbe per gli antisemiti qualora l’innocenza di un ebreo
trionfasse! Un ebreo innocente. Possibile? Crolla tutta un’impalcatura di bugie,
subentra l’aria pura, la buona fede, l’equità, ed è la rovina per una setta che
agisce sulla folla degli ingenui solamente in forza dei suoi eccessi ingiuriosi
e dell’impudenza delle sue calunnie. Ed ecco cos’altro abbiamo visto: il furore
di questi malfattori pubblici al solo pensiero che si possa fare un po di luce.
E inoltre, ahimè, abbiamo visto lo smarrimento della folla che costoro hanno
pervertito, e tutta questa opinione pubblica sconvolta, tutto questo caro popolo
di umili e di semplici, che oggi si scaglia contro gli ebrei e che domani
farebbe una rivoluzione per liberare il capitano Dreyfus, se qualche onest’uomo
lo infiammasse del fuoco sacro della giustizia. Infine, gli spettatori, gli
attori, voi e io, noi tutti. Quale confusione, quale pantano accresciuto di
continuo! Abbiamo visto infervorarsi di giorno in giorno la mischia delle
passioni e degli interessi, e poi storie insulse, pettegolezzi vergognosi,
smentite di inaudita impudenza, il semplice buon senso venire preso a schiaffi
ogni mattina, il vizio acclamato, la virtù zittita, insomma l’agonia di tutto
quello che costituisce l’onore e la gioia di vivere. Si è finito per odiarlo,
tutto questo, certo! Ma chi aveva voluto questo stato di cose, chi lo trascinava
per le lunghe? I nostri capi, quelli che, avvertiti da più di un anno, non
osavano far niente. Inutile supplicarli, inutile preconizzare loro, fase per
fase, la tremenda tempesta che si stava addensando. L’inchiesta l’avevano già
fatta; l’incartamento l’avevano tra le mani. Ma fino all’ultima ora, nonostante
le suppliche, si sono intestarditi nella loro inerzia, piuttosto che prendere in
mano la situazione, per limitarla, a rischio di sacrificare subito le
individualità compromesse. Il fiume di fango è straripato, com’era stato loro
predetto, ed è colpa loro. Abbiamo visto energumeni trionfare con l’esigere la
verità da quelli che dicevano di saperla, quando questi non potevano dirla
finché c’era in corso un’inchiesta. La verità è stata detta al generale
incaricato dell’inchiesta, e a lui soltanto è affidata la missione di farla
conoscere. La verità sarà inoltre detta al giudice istruttore, e lui soltanto ha
la veste per ascoltarla e per basare sulla stessa il suo atto di giustizia. La
verità! che concezione ne avete, in un’avventura come questa, che scuote tutta
un’organizzazione decrepita, per credere che sia un oggetto semplice e
maneggevole, da tenere nel cavo della mano e da mettere quando si vuole in mano
ad altri, come se fosse un sasso o una mela? La prova, ah sì, la prova che si
pretendeva, immediata, come i bambini pretendono che si mostri loro il vento che
passa. Siate pazienti e la vedrete splendere, la verità; ma occorrerà in ogni
caso un po d’intelligenza e di probità morale. Abbiamo visto sfruttare vilmente
il patriottismo, agitare lo spettro dello straniero in una questione d’onore che
riguarda unicamente la famiglia francese. I peggiori rivoluzionari hanno gridato
che si insultavano l’esercito e i suoi capi, quando, com’è giusto, si chiede
solo di non metterli troppo in alto, fuori della portata di chiunque. E, di
fronte ai caporioni, di fronte a qualche giornale che aizzava l’opinione
pubblica, ha regnato il terrore. Non un esponente delle nostre assemblee ha
avuto un grido da onest’uomo, tutti sono rimasti muti, esitanti, prigionieri dei
loro gruppi, tutti hanno avuto paura dell’opinione pubblica, sicuramente
preoccupati, in previsione delle prossime elezioni. Né un moderato, né un
radicale, né un socialista, nessuno di quelli che dovrebbero tutelare le
pubbliche libertà, si è ancora alzato a parlare secondo coscienza. Come volete
che il paese sappia orientarsi nella tormenta, se quegli stessi che si dicono
sue guide tacciono per meschina tattica di politicanti oppure per il timore di
compromettere la loro situazione personale? E lo spettacolo è stato così penoso,
così crudele, così duro per la nostra fierezza, che intorno a me sento ripetere:
«La Francia è proprio malata perché abbia potuto prodursi una simile crisi di
aberrazione pubblica» No! è soltanto sviata, fuori di sé del suo cuore e della
sua indole. Le si parli il linguaggio dell’umanità e della giustizia e si
ritroverà intera, nella sua generosità leggendaria. Il primo atto è terminato,
sull’orrendo caso è calato il sipario. Auguriamoci che lo spettacolo di domani
ci consoli e ci ridia coraggio. Ho detto che la verità era in cammino e che
niente l’avrebbe fermata. Un primo passo è fatto, un altro si farà, poi un
altro, poi il passo decisivo. E’ matematico.
Per il momento, in attesa della decisione del
Consiglio di guerra, la mia parte è terminata; ed è mio ardente desiderio che,
fatta la verità, resa giustizia, io non debba più lottare né per l’una né per
l’altra. Articolo pubblicato su “Le Figaro” il 5 dicembre 1897
La condanna di Dreyfus divenne scandalo
mondiale. Dopo la pubblicazione del J’Accuse di Emile
Zola l’intera opinione pubblica mondiale si divise tra dreyfusardi e
antidreyfusardi, scrive Vincenzo Vitale il 21 Agosto 2018 su "Il Dubbio". La
pubblicazione del J’accuse ha l’effetto di una bomba sociale. Finalmente le
coscienze, assopite, sembrano risvegliarsi non solo in Francia, ma in tutta
Europa. Ci si divide fra dreyfusardi e antidreyfusardi senza ritegno alcuno, ma
con accanimento tanto maggiore quanto più la propria posizione fosse in vista.
Si ruppero amicizie decennali, si separarono coniugi e famiglie, si litigò nei
pubblici locali e nelle dimore private, ci si sfidò a duello, si minacciò da
varie nazioni europee di non partecipare alla Esposizione Universale, prevista a
Parigi, all’ombra della torre Eiffel, per l’anno 1900. Insomma, lo scandalo
della condanna di Dreyfus divenne di portata europea e perfino mondiale, se è
vero che perfino alla Casa Bianca e al Cremlino si dibatteva della sua innocenza
o colpevolezza. Era inevitabile peraltro che, in forza dello spostamento
mimetico tipico delle persecuzioni, una volta che il meccanismo persecutorio sia
svelato, la violenza si converta a carico del rivelatore, cioè di Zola. Questi
infatti viene processato per diffamazione dei vertici militari e governativi e
dei giudici militari e, in seguito, dei periti calligrafi i quali, mentendo,
attestarono che la grafia del bordereau spionistico che fu attribuito a Dreyfus,
era effettivamente la sua. Quella che oggi si pubblica è l’autodifesa
pronunciata da Zola davanti alla giuria che l’avrebbe comunque condannato a un
anno di reclusione e a 3.000 franchi di multa. Lo scrittore denuncia subito una
evidente forzatura, tanto inammissibile quanto antigiuridica, vale a dire che il
Primo Ministro, Felix Jules Méline, ha dichiarato di aver fiducia in quei
giudici popolari davanti ai quali Zola si difende e ai quali egli affida
pubblicamente la difesa dell’esercito. Come dire che egli, il Primo Ministro, si
attende una esemplare condanna di Zola, attraverso la quale soltanto l’esercito
potrà essere ristorato del danno alla sua immagine prodotto dal J’accuse. Zola
nota subito che se per un verso ciò costituisce una indebita pressione
sull’organo giudicante, per altro verso è una colossale sciocchezza. Infatti,
accusare alcuni componenti dell’esercito, sia pure di alto grado, ma
nominativamente individuati, di aver consumato un infame delitto ai danni di
Dreyfus – come appunto ha fatto Zola – non vuol dire certo denigrare l’esercito
nel suo insieme; anzi, è un sicuro indice di voler operare all’interno
dell’esercito un salutare repulisti, allo scopo non di diffamarlo, ma di
valorizzarlo nelle sue componenti più vere e trasparenti. Come non rilevare qui
una singolare coincidenza con alcuni casi italiani, soprattutto degli ultimi
anni? Capita infatti che se un giornalista o un osservatore politico critichi
pubblicamente – ed anche duramente – l’operato di un pubblico ministero,
immediatamente salti su il Consiglio Superiore della Magistratura, lamentando
che quelle critiche delegittimano l’intera Magistratura e aprendo perfino un
fascicolo che vien definito “a tutela”. E non si sa davvero a tutela di cosa e
di chi, se non di ruoli e posizioni che in tal modo vengono posti al di là di
ogni possibile critica, collocati in una dimensione di immunità assoluta, al
punto che criticare uno significa delegittimare tutti: assurdità evidente sia
per la ragione giuridica che per quella comune, perché conferisce licenza di
fare e disfare arbitrariamente proprio a colui che invece andrebbe controllato,
in quanto se ne lamenta un qualche abuso o errore (a torto o a ragione). Come
dire che se l’insegnante richiama uno scolaro che disturba in classe, allora
necessariamente delegittima la classe intera: un corto circuito dell’intelletto
che però alligna in Italia ormai da decenni e che alla fine delegittima soltanto
l’insegnante, riducendolo al silenzio. Zola perciò sceglie di non difendersi per
nulla: e coraggiosamente, perché sa bene che alte sono le probabilità di essere
condannato, come poi in effetti sarà. Egli si limita a rilevare come ormai,
giunte a quel punto le cose, dopo che il vero colpevole, Esterhazy è stato
assolto, il caso non riguarda più soltanto Dreyfus e la sua innocenza, ma
riguarda la Francia intera e l’immagine che la Francia potrà fornire di se al
mondo: è ancora la Francia dei diritti dell’uomo, “quella che ha donato la
libertà al mondo e che doveva donargli la giustizia”? Si noti che Zola risulta
doppiamente sospetto alla opinione dei benpensanti. Da un lato, in quanto
scrittore e perciò pericolosamente votato a pensare con la propria testa;
dall’altro, in quanto di origine italiana, nato da padre veneziano. Ma lui se ne
fa un vanto, osservando che da qualsiasi luogo provenga la sua famiglia – e
proviene da Venezia, “la splendida città la cui antica gloria è cantata in tutte
le memorie” – egli è un francese a tutti gli effetti, non foss’altro che per i
quaranta volumi scritti in lingua francese e venduti in decine di milioni di
copie in tutto il mondo. La chiusa è profeticamente vera: “Un giorno la Francia
mi ringrazierà di aver contribuito a salvare il suo onore”. Non solo la Francia.
«La Francia è ancora quella dei diritti
dell’uomo?» Ecco l’autodifesa dello scrittore Emile
Zola, processato per diffamazione dei vertici militari e governativi e dei
giudici militari. Scrive Émile Zola su «L’Aurore» il 22 febbraio 1898 e
ripubblicato il 21 Agosto 2018 su "Il Dubbio". Signori giurati, nella seduta del
22 gennaio alla Camera, il signor Méline, presidente del Consiglio dei Ministri,
ha dichiarato, tra gli applausi entusiasti della sua compiacente maggioranza, di
aver fiducia nei dodici cittadini nelle cui mani rimetteva la difesa
dell’esercito. Signori, parlava di voi. Come già il generale Billot aveva
suggerito la sentenza al Consiglio di Guerra incaricato di assolvere il
comandante Esterhazy, impartendo dall’alto della sua tribuna agli ufficiali
subordinati la consegna militare di rispettare senza discuterla la cosa
giudicata, così Méline ha voluto darvi l’ordine di condannarmi in nome del
rispetto dell’esercito, che egli mi accusa di avere oltraggiato. Denuncio alla
coscienza degli onesti questa pressione dei pubblici poteri sulla giustizia del
Paese. Ci troviamo di fronte a dei costumi politici abominevoli che disonorano
una nazione libera. Vedremo se obbedirete. Ma non è affatto vero che io sia qui,
davanti a voi, per volontà del presidente Méline. Malgrado il suo personale
turbamento, egli ha ceduto alla necessità di perseguirmi perché terrorizzato di
quanto la verità in cammino avrebbe compiuto. Questa è una verità a tutti nota:
se sono davanti a voi è perché l’ho voluto. Io solo ho deciso che l’oscura, la
mostruosa questione fosse affidata alla vostra giurisdizione, e sono stato io
solo che di mia iniziativa ho scelto voi, l’emanazione più alta e diretta della
giustizia francese, affinché la Francia sappia tutto e si pronunci. Il mio atto
non ha avuto altro intento e la mia persona non conta, l’ho sacrificata
volentieri, unicamente soddisfatto per aver messo nelle vostre mani non solo
l’onore dell’esercito, ma l’onore vacillante della nazione intera. Mi
perdonerete, dunque, se nelle vostre coscienze non è ancora stata fatta piena
luce. Non dipende da me. Nel volervi portare tutte le prove, nello stimarvi i
soli degni e competenti, è come se stessi sognando. Hanno cominciato a togliervi
con la sinistra quello che fingevano di darvi con la destra. Ostentavano di
accettare la vostra giurisdizione, ma se alcuni confidavano in voi per vendicare
i membri di un tribunale militare, altri ufficiali restavano intoccabili,
superiori alla vostra stessa giustizia. Comprenda chi vuole e chi può. Si tratta
di una assurda ipocrisia e l’evidenza lampante che ne scaturisce è che hanno
avuto paura del vostro buon senso, che non hanno osato correre il pericolo di
lasciarmi dire tutto e di lasciarvi giudicare tutto. Asseriscono di aver voluto
limitare l o scandalo; e cosa pensate di questo scandalo, del mio atto che
consiste nel mettervi al corrente del caso nella volontà che fosse il popolo
incarnato in voi a fungere da giudice? Sostengono inoltre che non potevano
accettare una revisione mascherata, confessando in tal modo di non avere in
fondo che un solo timore, quello del vostro controllo sovrano. La legge trova in
voi la sua rappresentazione totale; ed è la legge del popolo eletto quella che
ho desiderato, che da buon cittadino rispetto profondamente, non già la
procedura ambigua grazie alla quale hanno sperato di poter ingannare persino
voi. Eccomi scusato, signori, di avervi distolto dalle vostre occupazioni, senza
avere avuto la possibilità di inondarvi di quella verità intera che sognavo. La
luce, la luce completa, non ho avuto che questo appassionato desiderio. E questi
dibattimenti ve lo hanno dimostrato: abbiamo dovuto lottare, passo dopo passo,
contro una volontà occultatrice incredibilmente ostinata. Abbiamo dovuto lottare
per afferrare qualche brandello di verità; hanno discusso su tutto, ci hanno
rifiutato tutto, hanno terrorizzato i nostri testimoni nella speranza di
impedirci di portare delle prove. Ed è solo per voi che ci siamo battuti,
affinché questa prova vi viene se sottoposta nella sua interezza, affinché
poteste pronunciarvi senza rimorsi della vostra coscienza. Sono convinto che
terrete nella dovuta considerazione i nostri sforzi, visto che molta chiarezza è
stata fatta. Avete ascoltato i testimoni, ora ascolterete il mio difensore che
vi racconterà la vera storia, la storia che fa uscire tutti di senno ma che
nessuno conosce. Ed eccomi qui tranquillo; la verità è ora nelle vostre mani e
procederà. Il presidente Méline ha creduto suo dovere suggerirvi la sentenza
affidandovi l’onore dell’esercito. Ed è in nome dell’onore dell’esercito che, a
mia volta, faccio appello alla vostra giustizia. Smentisco nella maniera più
assoluta il presidente Méline, io non ho mai oltraggiato l’esercito. Al
contrario ho espresso il mio affetto, il mio rispetto per la nazione in armi,
per i nostri soldati, pronti a insorgere alla prima minaccia per difendere il
suolo francese. Ed è altrettanto falso che io abbia attaccato i generali che li
condurrebbero alla vittoria. Affermare che alcuni individui degli uffici del
Ministero della Guerra hanno compromesso con la loro azione persino l’esercito
equivale forse a insultare l’esercito nel suo insieme? Non significa piuttosto
comportarsi da buon cittadino il liberarlo da ogni compromesso, gettare un grido
d’allarme affinché gli errori che ci hanno portato alla disfatta non si ripetano
e non ci conducano a nuove sconfitte? Del resto io non mi difendo, lascio alla
storia il compito di giudicare il mio atto che era assolutamente necessario. Ma
affermo che l’esercito disonorato quando si permette ai gendarmi di
solidarizzare con il comandante Esterhazy dopo le lettere abominevoli che egli
ha scritto. Affermo che questo valoroso esercito viene insultato ogni giorno da
quei banditi che, con il pretesto di difenderlo, lo insozzano della loro vile
complicità, trascinando nel fango tutto quello che la Francia ha ancora di buono
e di grande. Affermo che sono loro a disonorare il grande esercito nazionale
quando al grido di «Viva l’esercito!» mescolano quello di «A morte gli ebrei!».
E hanno gridato «Viva Esterhazy!». Gran Dio! II popolo di San Luigi, di Bayard,
di Condé e di Hoche, il popolo delle cento splendide vittorie, delle grandi
guerre della Repubblica e dell’Impero, il popolo la cui forza, grazia e
generosità hanno abbagliato l’universo, quel popolo grida «Viva Esterhazy!».
Questa è una infamia da cui può lavarci soltanto il nostro sforzo di verità e di
giustizia. Voi conoscete molto bene la leggenda che si è creata. Dreyfus è stato
condannato giustamente e legalmente da sette ufficiali infallibili, tanto che a
nessuno è permesso di sospettare l’errore senza offendere l’intero esercito.
Dreyfus espia il suo orribile mi- sfatto in una tortura vendicatrice. E, poiché
è ebreo, si crea un sindacato ebreo, un sindacato internazionale di senza
patria, che mette a disposizione centinaia di milioni con lo scopo di salvare il
traditore anche al prezzo delle più infami trame. Da quel momento questo
sindacato ha operato in modo criminale comprando le coscienze e gettando la
Francia in un’agitazione omicida, deciso a venderla al nemico, a mettere a fuoco
l’Europa con una guerra generale piuttosto che rinunciare al suo spaventoso
disegno. Come potete vedere è estremamente semplice, perfino infantile e
imbecille. Ma è di questo pane avvelenato che la stampa ignobile nutre il nostro
povero popolo da diversi mesi. E non c’è da meravigliarsi se assistiamo a una
crisi così disastrosa, perché quando si seminano l’idiozia e la menzogna non si
può che raccogliere follia. Certamente Signori, non vi farò l’affronto di
credere che vi siate finora attenuti a queste favole per bambini. Vi conosco e
so chi siete. Siete il cuore e la ragione di Parigi, della mia grande Parigi,
dove sono nato, che amo di un affetto infinito, che studio e descrivo da quasi
quarant’anni. E nel contempo so anche quello che state pensando in questo
momento, perché prima di sedere qui come accusato sono stato seduto là, sul
banco che ora occupate voi. Voi rappresentate l’opinione media, impersonate,
tutti insieme, la saggezza e la giustizia. Tra poco il mio pensiero vi seguirà
nella sala delle vostre deliberazioni e sono convinto che il vostro sforzo sarà
quello di salvaguardare i vostri interessi di cittadini, che sono naturalmente
gli interessi della nazione intera. Potrete sbagliarvi, ma sarà nella
convinzione che, assicurando il vostro bene, assicurate il bene di tutti. Vi
vedo nelle vostre famiglie, la sera, alla luce di una lampada; vi sento
conversare con i vostri amici, vi accompagnano nelle vostre officine, nei vostri
negozi. Siete tutti lavoratori: commercianti, industriali, alcuni di voi
esercitano libere professioni. E la vostra legittima preoccupazione è lo stato
deplorevole in cui sono caduti gli affari. Ovunque la crisi attuale minaccia di
trasformarsi in un disastro, gli incassi diminuiscono, le transazioni si fanno
sempre più difficili. A causa di ciò, il pensiero che qu i domina, che leggo sui
vostri volti, è che se ne ha abbastanza, che è ora di finirla. Non siete
arrivati a dire come molti: «Che importa che un innocente sia all’isola del
Diavolo! L’interesse di un singolo merita il turbamento di una grande nazione?».
Vi dite tuttavia che la nostra agitazione, quella di noi affamati di verità e di
giustizia, viene pagata troppo a caro prezzo con tutto il male che ci si accusa
di fare. E se mi condannerete, signori, non saranno che questi i motivi alla
base del vostro verdetto: il desiderio di rasserenare i vostri cari, il bisogno
che gli affari riprendano il loro corso, la convinzione che colpendo me
metterete un freno a una campagna di rivendicazione nociva agli interessi della
Francia. Ebbene, signori, vi sbagliereste nel modo più assoluto! Vogliate farmi
I’onore di credere che io qui non difendo la mia libertà. Colpendomi non farete
che ingigantirmi. Chi soffre per la verità e la giustizia diventa augusto e
sacro. Guardatemi, signori: ho l’aria di un venduto, di un mentitore e di un
traditore? Per quale motivo agirei allora? Non celo né ambizione politica né
fanatismo da settario. Sono un libero scrittore che ha dedicato la vita al
lavoro, che domani rientrerà nei ranghi e riprenderà il lavoro interrotto. E
sono delle bestie coloro che mi chiamano italiano, a me, nato da madre francese,
allevato da nonni della Beauce, contadini di quella terra generosa, a me che ho
perduto il padre a sette anni, che sono andato in Italia soltanto a
cinquantaquattro anni per documentare un libro. Il che non m’impedisce d’essere
fiero che mio padre fosse di Venezia, la splendida città la cui antica gloria è
cantata in tutte le memorie. E quand’anche non fossi francese, i quaranta volumi
in lingua francese che ho seminato in milioni di esemplari nel mondo intero
basterebbero, credo, a fare di me un francese, utile alla gloria della Francia!
Perciò non mi difendo. Ma quale errore sarebbe il vostro qualora foste convinti
che colpendo me ristabilireste l’ordine nel nostro infelice Paese! Non lo capite
che il male di cui la nazione muore è proprio l’oscurità in cui ci si ostina a
lasciarla, è l’equivoco in cui agonizza? Le colpe dei governanti si aggiungono
al le colpe, una menzogna ne rende necessaria un’altra, finché il cumulo diventa
spaventoso. È stato commesso un errore giudiziario, e da quel momento per
nasconderlo è stato necessario commettere ogni giorno un nuovo attentato al buon
senso e all’equità. La condanna di un innocente ha portato con sé l’assoluzione
di un colpevole; ed ecco che, oggi, vi si chiede di condannarmi per avere
gridato la mia angoscia nel vedere la patria avere imboccato questa terrificante
strada. Condannatemi, dunque! Ma sarà un errore che si aggiungerà agli altri, un
errore di cui in seguito porterete il peso nella storia. E la mia condanna,
lungi dal riportare la pace che desiderate, che tutti noi desideriamo, altro non
sarà che un nuovo seme di passione e di disordine. Vi avverto, la misura è
colma, non fatela straripare.Come fate a non rendervi conto della crisi tremenda
che il Paese sta attraversando? Ci considerano gli autori dello scandalo,
affermano che sono gli amanti della verità e della giustizia a fuorviare la
nazione, a spingerla alla sommossa. In verità, ciò significa ingannare il mondo
intero. Il generale Billot, tanto per fare un nome, non è stato forse avvertito
da ben diciotto mesi? Il colonnello Picquart non ha forse insistito affinché
prendesse nelle sue mani la revisione per evitare che la tempesta scoppiasse e
sconvolgesse tutto? Il senatore Scheurer- Kestner non l’ha supplicato, con le
lacrime agli occhi, di pensare alla Francia, di risparmiarle una simile
catastrofe? No, no! Il nostro desiderio è stato di facilitare le cose, di
attutirle e, se il Paese ora soffre, la colpa è del potere che, desideroso di
copri re i colpevoli, spinto da interessi politici, ha rifiutato tutto, nella
speranza di essere abbastanza forte per impedire che si facesse luce. Da quel
giorno ha manovrato sempre nell’ombra, in favore delle tenebre, ed è lui, lui
solo, il responsabile del disperato turbamento che affligge le coscienze.
L’affaire Dreyfus, signori miei, oggi è di ventato marginale, è ormai un fatto
remoto e lontano, rispetto ai terrificanti problemi che ha sollevato. Non si
tratta più dell’affaire Dreyfus, si tratta ormai di sapere se la Francia è
ancora la Francia dei diritti dell’uomo, quella che ha donato la libertà al
mondo e che doveva donargli la giustizia. Siamo ancora il popolo più nobile, il
più fraterno, il più generoso? In Europa, conserveremo ancora la nostra fama di
equità e di umanità? Allora, non sono queste tutte le conquiste che avevamo
fatto e che erano rimesse in discussione? Aprite gli occhi e capirete che se
l’anima francese è in preda a una simile confusione ciò è dovuto al fatto che è
profondamente sconvolta di fronte a un terribile pericolo. Un popolo non sarebbe
sconvolto a tal punto se la sua stessa vita morale non fosse in pericolo. L’ora
è di una gravità eccezionale, è in gioco la salvezza della nazione.Quando avrete
compreso questo, signori, avrete coscienza che esiste un solo rimedio
possibile: dire la verità e renderegiustizia. Tutto ciò che ritarderà la luce,
tutto ciò che aggiungerà tenebre a tenebre non farà che prolungare eaggravare la
crisi. Il compito dei buoni cittadini, di quelli che sentono il bisogno
imperioso di farla finita, è di esigere piena chiarezza. Siamo già in molti a
pensarlo. Gli uomini di lettere, di filosofia e di scienza si levano da ogni
luogo in nome dell’intelligenza e della ragione. E non vi parlo dei paesi
stranieri, del brivido che si è propagato in tutta l’Europa. Lo straniero non è
necessariamente sinonimo di nemico. Non parliamo dei popoli che possono essere
domani nostri avversari. Ma la grande Russia, nostra alleata, la piccola e
generosa Olanda, tutti i popoli amici del Nord, le terre di lingua francese,
come la Svizzera e il Belgio, perché mai avrebbero il cuore grosso, traboccante
di sofferenza fraterna? Sognate forse una Francia isolala dal mondo? Volete che
nessuno, quando passerete la frontiera, sorrida più alla vostra leggendaria
buona fama di equità e di umanità? Ahimè, signori! Come tanti altri, forse anche
voi aspettale l’avvenimento imprevisto, la prova dell’innocenza di Dreyfus, che
dovrebbe scendere dal cielo come la folgore. Di norma la verità non procede
affatto così; essa richiede ricerca e intelligenza. La prova! Sappiamo bene dove
potremmo trovarla. Ma lo pensiamo soltanto nel segreto delle nostre anime, e la
nostra angoscia di patrioti è che ci si sia esposti a ricevere un giorno lo
schiaffo di questa prova, dopo avere impegnato l’onore dell’esercito i n un a
menzogna. Voglio inoltre dichiarare con chiarezza che, se abbiamo notificato
come testimoni alcuni membri delle ambasciate, la nostra volontà formale era
all’inizio d i non citarli in questa sede. Si è sorriso della nostra audacia.
Non credo che ne abbiano sorriso al ministero degli Affari Esteri, dove
sicuramente hanno capito. Abbiamo semplicemente voluto dire a quelli che sanno
tutta la verità che anche noi la sappiamo. Quella verità corre per le ambasciate
e domani sarà conosciuta da tutti. E, per i l momento, ci è impossibile andarla
a cercare là dove si trova, protetta da formalità invalicabili. Il governo, che
non ignora niente, che è convinto come noi dell’innocenza di Dreyfus, potrà,
quando lo vorrà e senza rischio, trovare i testimoni che finalmente facciano
luce.Lo giuro! Dreyfus è innocente! Impegno la mia vita e il mio onore. In
questo momento così solenne, davanti a questo tribunale che rappresenta la
giustizia umana, davanti a voi, signori giurati, che siete l ‘ emanazione stessa
della nazione, davanti a tutta la Francia, davanti al mondo intero, io giuro che
Dreyfus è innocente. Per i miei quarant’ anni di lavoro, per l’autorità che
questa fatica può avermi dato, giuro che Dreyfus è innocente. E per tutto quello
che ho conquistato, per il nome che mi sono fatto, per le mie opere che hanno
contribuito all’espansione delle lettere francesi, giuro che Dreyfus è
innocente; che tutto questo crolli, che le mie opere periscano, se Dreyfus non è
innocente! Dreyfus è innocente. Tutto sembra essere contro di me, le due Camere,
il potere civile, il potere militare, i giornali a grande tiratura, l’opinione
pubblica da questi avvelenata. E io posseggo solamente i miei ideali di verità e
di giustizia. Eppure sono tranquillissimo, vincerò. Non ho voluto che il mio
Paese restasse nella menzogna e nell’ingiustizia. Oggi, qui, mi si può colpire.
Un giorno la Francia mi ringrazierà di aver contribuito a salvare il suo onore.
Pubblicata su «L’Aurore» il 22 febbraio 1898
“Il monumento più ripugnante dell’infamia
umana”. La Corte di Rennes ancora una volta e in modo
totalmente antigiuridico, condanna di nuovo Dreyfus, ma soltanto a dieci anni,
“compreso il sofferto”, scrive Vincenzo Vitale il 23 Agosto 2018 su "Il Dubbio".
Negli oltre diciotto mesi che separano la pubblicazione di questo articolo da
quella del precedente, sono accadute molte cose determinanti per le sorti della
vicenda di Dreyfus. Non solo la condanna di Zola per la presunta diffamazione a
carico dei giudici militari, ma anche la radiazione dai ranghi dell’esercito del
colonnello Picquart, colui che aveva scoperto la colpevolezza di Esterhazy e
l’innocenza di Dreyfus, ma soprattutto il fatto decisivo: il maggiore Henry
confessa al Ministro Cavaignac di aver personalmente confezionato e perciò
materialmente falsificato il documento sulla base del quale era stato condannato
Dreyfus. Subito dopo Henry si suicida, mentre Esterhazy, comprendendo che ormai
la sua posizione è indifendibile, ripara precipitosamente in Inghilterra: e
Proust sapidamente commenta: “Il caso era puro Balzac, ora diventa
shakespeariano”. Queste novità conducono naturalmente a riaprire il procedimento
nei confronti di Dreyfus, che viene riportato in Francia per un nuovo processo
da celebrare a Rennes, mentre Paty de Clam, autore primo di tutto il complotto
contro Dreyfus, viene arrestato. Tuttavia, assurdamente e contro ogni lecita
aspettativa, la Corte di Rennes ancora una volta e in modo totalmente
antigiuridico, condanna di nuovo Dreyfus, ma soltanto a dieci anni, “compreso il
sofferto”. Prevedo il quesito di ciascuno: ma potevano farlo? No. E tuttavia lo
fecero. E lo fecero per una ragione che agli occhi di quei sedicenti giudici
appariva tanto cogente da indurli ad andare contro il buon senso: continuare,
contrariamente ad ogni attesa, a difendere l’operato dei primi giudici, alla cui
corporazione (l’esercito) loro stessi appartenevano. Come dire che fra la
libertà di coscienza – che doveva di filato indurre alla assoluzione di Dreyfus
con la formula più ampia – e la difesa corporativa della classe di appartenenza,
la Corte di Rennes preferisce questa a quella. Nulla di nuovo, per carità.
Capita anche nel nostro tempo che alcuni Tribunali si facciano un po’ troppo
condizionare dall’opera di una Procura, troppo sensibilizzandosi alle sue
richieste ed alla sue attese. E tuttavia, sempre e in ogni caso, determinazione
assurda e antigiuridica, come assurda e antigiuridica fu la condanna di Rennes,
che, non a caso, ci fu, ma fu straordinariamente mite, considerata la gravità
del reato contestato (spionaggio e alto tradimento), e tenendo conto che Dreyfus
aveva trascorso già cinque anni in deportazione: segno che i componenti della
Corte di Rennes, pur decisi a difendere la corporazione, non volevano esagerare;
così, tanto per poter dormire la notte. E dormirono. Ma Zola, per queste
medesime ragioni, non dormiva. Anzi. In questo articolo, pubblicato due giorni
dopo la condanna di Rennes, egli non manca di fustigare letteralmente coloro che
si erano resi responsabili di questo ulteriore scempio perpetrato nei confronti
delle più elementari ragioni della giustizia attraverso la nuova condanna
inflitta a Dreyfus, sia pure irrogatrice di una pena assai modesta e in gran
parte già scontata. Inflitta, insomma, per salvare – come si dice con efficace
proverbio contadino – capra e cavoli: la capra della salvaguardia dell’operato
dei precedenti giudici che avevano condannato il capitano ebreo e i cavoli della
propria coscienza che avrebbe potuto loro impedire, appunto, di dormire. Così,
Zola non esita a denunciare il processo di Rennes come “il monumento più
ripugnante dell’infamia umana”. E aggiunge icasticamente che “L’ignoranza,
l’idiozia, la follia, la crudeltà, la menzogna, il crimine vi sono ostentati con
una tale spudoratezza che le generazioni future ne arrossiranno di vergogna”. E
ciò è tanto più vero, in quanto Zola aveva raggiunto la assoluta ed
incontestabile certezza della colpevolezza di Esterhazy, il quale, tempo prima,
aveva fornito documenti segreti al Colonnello Schwartzkoppen, addetto militare
presso l’Ambasciata tedesca a Parigi. Ecco perché, sulla scorta di ciò,
l’avvocato Labori, difensore di Dreyfus, aveva chiesto di sentire come testimoni
alcuni addetti militari stranieri informati della circostanza: richiesta
tuttavia puntualmente rigettata dai giudici. Come dire, chiosa Zola, che la
Corte abbia affermato, a scanso di equivoci, “non vogliamo che ci venga fornita
la prova, perché vogliamo condannare”. E, d’altra parte, perché meravigliarsi se
l’avvocato Labori, nel corso del processo, era stato addirittura ferito da una
revolverata esplosa da un sicario rimasto ignoto? Se questo era il clima in cui
questo nuovo processo veniva celebrato, cosa attendersi di diverso, se non una
nuova condanna per l’innocente Dreyfus?
Processo Dreyfus. Francia, vergognati!
Il nuovo procedimento nei confronti di Dreyfus si conclude con una nuova
condanna, anche se più lieve, scrive Émile Zola riportato il 23 Agosto 2018 da
"Il Dubbio". Sono terrorizzato. E non è più la collera, l’indignazione
vendicatrice, il bisogno di gridare il crimine commesso, di pretenderne il
castigo in nome della verità e della giustizia; è il terrore, il sacro spavento
di un uomo che vede realizzarsi l’impossibile, i fiumi risalire verso le
sorgenti, la terra capovolgersi sotto il sole. E ciò che io grido è lo sconforto
della nostra generosa e nobile Francia, è la paura dell’abisso in cui sta
scivolando. C’eravamo illusi che il processo di Rennes fosse il quinto atto
della terribile tragedia che viviamo da quasi due anni. Le pericolose peripezie
sembravano ormai dissolte, credevamo di andare verso una conclusione che
portasse alla pacificazione e alla concordia. Dopo la dolorosa battaglia, la
vittoria del diritto si rendeva inevitabile, il dramma doveva concludersi
felicemente con il classico trionfo dell’innocente. E invece ci siamo sbagliati:
si annuncia una nuova peripezia, la più inattesa, la più spaventosa di tutte,
che rende nuovamente cupo il dramma, che lo prolunga e lo proietta verso un
finale ignoto, davanti al quale la nostra ragione rimane turbata e vacilla. Il
processo di Rennes è soltanto il quarto atto. Gran Dio. Come sarà il quinto?
Quali dolori e quali nuove sofferenze potrà mai generare, verso quale espiazione
suprema getterà la nazione? Perché è più che certo che l’innocente non può
essere condannato due volte e che una conclusione del genere spegnerebbe iI sole
e solleverebbe i popoli! Ah, quel quarto atto del processo di Rennes, con quale
agonia morale l’ho vissuto dal fondo della più completa solitudine in cui mi ero
rifugiato, con lo scopo di scomparire dalla scena da buon cittadino, desideroso
di non dare altre occasioni al fanatismo e al disordine! Con quale angoscia nel
cuore aspettavo notizie, lettere, giornali, e quali ribellioni, quali sofferenze
nel leggerli! Le splendide giornate di quel mese d’agosto si rabbuiavano, e mai
ho avvertito l’ombra e il freddo di una soglia così agghiacciante sotto cieli
tanto smaglianti. Certamente in questi due anni le sofferenze non sono mancate.
Ho sentito le folle inseguirmi gridando «Amore!», ho visto passare ai miei piedi
un immondo torrente di oltraggi e di minacce, ho conosciuto per ben undici mesi
la disperazione dell’esilio. Inoltre ho subito due processi, spettacoli
lacrimevoli di viltà e d’iniquità. Ma cosa sono i miei due processi se
confrontati a quello di Rennes? Idilli, scene rinfrescanti in cui fiorisce la
speranza. Abbiamo assistito a tante mostruosità: i procedimenti giudiziari conto
il colonnello Picquart, l’inchiesta della Sezione Penale, la legge
d’incompetenza a procedere che ne è conseguita. Ma oggi che l’inevitabile
progressione ha fatto il suo corso, tutto questo sembra puerile, e il processo
di Rennes sboccia nella sua enormità all’apice come un orrendo fiore da un
letamaio. In esso abbiamo visto uno straordinario concentrato di attentati
contro la verità e la giustizia. Una banda di testimoni dirigeva il
dibattimento, ogni sera metteva a punto loschi tranelli per il giorno
successivo, avanzava richieste a colpi di menzogne al posto del pubblico
ministero, terrorizzava e insultava chi osava contraddirla, s’imponeva con
l’insolenza dei suoi galloni e pennacchi. Un tribunale, preda di questa
invasione di ufficiali, soffriva visibilmente nel vederli in veste di criminali
e obbediva a una mentalità tutta particolare, che bisognerebbe lungamente
smontare per poter giudicare i giudici. Un pubblico ministero grottesco ai
limiti dell’imbecillità, che lasciava agli storici di domani una requisitoria
nata da un animale umano non ancora classificato, la cui inconsistenza stupida e
omicida, di una crudeltà talmente senile e cocciuta da apparire incosciente,
sarà causa di un eterno stupore. Una difesa che da principio si tenta di
assassinare, poi si mette a tacere ogni volta che diventa imbarazzante, alla
quale si rifiuta di produrre la prova decisiva nel momento in cui reclama i soli
testimoni che veramente sanno. Questa vergogna è durata un mese intero al
cospetto dell’innocente, quel povero Dreyfus ridotto a un brandello umano che
farebbe piangere anche le pietre. I suoi vecchi commilitoni sono venuti a dargli
l’ennesimo calcio e i suoi vecchi superiori a schiacciarlo con i loro gradi, pur
di salvare se stessi dalla galera: non c’è stato nessun grido di pietà o un
fremito di generosità in quelle anime vili. La nostra dolce Francia ha offerto
questo spettacolo al mondo intero. Quando verrà pubblicato in extenso, il
resoconto del processo di Rennes sarà il monumento più ripugnante dell’infamia
umana. Esso supera ogni cosa e mai documento più criminale sarà stato fornito
alla storia. L’ignoranza, l’idiozia, la follia, la crudeltà, la menzogna, il
crimine vi sono ostentati con una tale spudoratezza che le generazioni future ne
arrossiranno di vergogna. In esso vi sono le prove della nostra bassezza di cui
arrossirà l’umanità intera. Ed è proprio da qui che nasce il mio sgomento,
perché se un simile processo si è potuto svolgere, se una nazione può offrire al
mondo civile una simile dimostrazione del suo stato morale e intellettuale,
bisogna che essa attraversi una crisi spaventosa. Si tratta dunque della morte
prossima? E quale bagno di bontà, di purezza, di equità ci salverà dal fango
velenoso in cui agonizziamo? Come scrivevo nel mio J’accuse, in seguito alla
scandalosa assoluzione di Esterhazy, è impossibile che un Consiglio di Guerra
cancelli ciò che un altro Consiglio di Guerra ha fatto. Ciò è contrario alla
disciplina. E la sentenza del Consiglio di Guerra di Rennes che, nel suo
imbarazzante gesuitismo, non ha il coraggio di pronunciare un sì o un no, è la
prova eclatante che la giustizia militare è impotente ad essere giusta, perché
non è libera e rifiuta l’evidenza, al punto da condannare nuovamente un
innocente piuttosto che mettere in dubbio la propria infallibilità. Si è
ostentata come un’arma d’esecuzione in mano agli ufficiali. A questo punto essa
non saprebbe essere altro che una giustizia sommaria, da tempo di guerra. Ma in
tempo di pace deve scomparire, dal momento che è incapace di equità, di semplice
logica e di buon senso. Si è condannata da sé. Ma ci rendiamo conto della
situazione atroce che ci viene imposta tra le nazioni civili? Un primo Consiglio
di Guerra, ingannato dalla sua ignoranza delle leggi e dalla sua inettitudine
nel giudicare, condanna un innocente. Un secondo Consiglio di Guerra, che a sua
volta è stato forse tratto in errore dal più spudorato complotto di menzogne e
di inganni, assolve un colpevole. Un terzo Consiglio di Guerra, dopo che è stata
fatta luce, dopo che la più alta magistratura del Paese ha deciso di lasciargli
l’onore di riparare l’errore, osa negare la chiara evidenza e condanna di nuovo
l’innocente. E l’irreparabile, è stato commesso il delitto supremo. Gesù è stato
condannato una sola volta. Ma crolli pure tutto, che la Francia sia preda delle
fazioni, che la patria in fiamme sprofondi tra le macerie, che l’esercito stesso
ci rimetta il suo onore, piuttosto che confessare che dei colleghi si sono
sbagliati e che alcuni ufficiali hanno mostrato di essere dei bugiardi e dei
falsari! L’idea sarà crocifissa, la sciabola deve regnare. Ed eccoci in questa
magnifica situazione davanti all’Europa e al mondo intero che è convinto
dell’innocenza d Dreyfus. Qualora un dubbio fosse ancora rimasto presso qualche
popolo lontano, lo scandalo lampante del processo di Rennes avrebbe ottenuto
l’effetto di illuminarlo. Le corti delle grandi potenze vicine sono informate,
conoscono documenti, hanno la prova dell’indecenza di tre o quattro nostri
generali e della paralisi vergognosa della nostra giustizia militare. La nostra
Sedan morale è perduta ed è cento volte più disastrosa dell’altra, dove si è
versato soltanto del sangue. Lo ripeto. Ciò che mi sgomenta è che questa
disfatta del nostro onore sembra insanabile. Come annullare infatti le sentenze
di tre Consigli di Guerra, dove troveremo l’eroismo di confessare la colpa per
poter camminare di nuovo a fronte alta? Dov’è il governo coraggioso e di salute
pubblica, dove sono le Camere che comprenderanno e agiranno prima
dell’inevitabile crollo? La cosa peggiore è che siamo arrivati ormai a una
fondamentale scadenza. La Francia ha voluto festeggiare il suo secolo di lavoro,
di scienza, di lotte per la libertà la verità e la giustizia. Come vedremo in
seguito, non è mai esistito secolo più nobile. E la Francia ha dato appuntamento
presso di sé a tutti i popoli per glorificare la sua vittoria, la Libertà
conquistata, la verità e la giustizia promesse al mondo. Fra qualche mese i
popoli arriveranno, ma troveranno che un innocente è stato condannato due volte,
la verità soffocata, la giustizia assassinata. Siamo caduti nel loro disprezzo,
ed essi verranno a fare bagordi, berranno il nostro vino, abbracceranno la
nostra servitù, come si usa fare nell’infima stamberga dove è consentito
comportarsi da canaglie. Possiamo mai accettare che la nostra Esposizione
Universale sia il luogo malfamato e disprezzato dove il mondo intero vorrà darsi
ai bagordi? No! Abbiamo immediatamente bisogno del quinto atto della mostruosa
tragedia, quand’anche dovessimo lasciarci ancora un po’ della nostra carne.
Abbiamo bisogno del nostro onore per accogliere i popoli in una Francia guarita
e rigenerata. Quel quinto atto che cerco e immagino mi ossessiona, non faccio
che pensarci. Nessuno si è accorto che l’affaire Dreyfus, questo gigantesco
dramma che agita l’universo, sembra messo in scena da qualche sublime
drammaturgo, desideroso di farne un incomparabile capolavoro? Ricordo le
straordinarie peripezie che hanno sconvolto tante coscienze. Ad ogni nuovo atto
la passione è aumentata e l’orrore è esploso più intenso. In questa opera
vivente, il destino è il genio che anima i personaggi e determina i fatti, sotto
la tempesta che egli stesso scatena. E poiché sicuramente desidera che il
capolavoro sia completo, ci prepara chissà quale sovrumano quinto atto che
ricollocherà la gloriosa Francia alla testa delle nazioni. Perché, siatene
convinti, è il destino che ha voluto il crimine supremo di vedere l’innocente
condannato una seconda volta. Occorreva che il crimine venisse commesso per la
grandezza della tragedia, per la bellezza sovrana, per l’espiazione che forse
permetterà l’apoteosi. Visto che è stato toccato il fondo dell’orrore, non mi
resta che aspettare il quinto atto che metterà fine al dramma, liberandoci e
ridonandoci una nuova integrità e giovinezza. Oggi parlerò con franchezza del
mio timore, che è sempre stato, come ho lasciato più volte intendere, che la
verità, la prova decisiva e schiacciante ci venga dalla Germania. Non è più
tempo di tacere su questo pericolo mortale. Diversi segnali ci dicono che
conviene considerare coraggiosamente il caso in cui fosse proprio la Germania a
portarci il quinto atto, come un fulmine a ciel sereno. Ecco la mia confessione.
Nel gennaio 1898, prima del mio processo, io venni a sapere con certezza che
Esterhazy era «il traditore», che lui aveva fornito a Schwartzkoppen un
considerevole numero di documenti, molti dei quali scritti personalmente, e che
la lista completa si trovava a Berlino al Ministero della Guerra. Io non faccio
il patriota di mestiere, ma confesso che le rivelazioni che mi furono fatte mi
sconvolsero; da quel momento la mia angoscia di buon francese non è più cessata,
ho vissuto nel terrore che la Germania, forse nostra futura nemica, ci
schiaffeggiasse con le prove che sono in suo possesso. Ma come! Il Consiglio di
Guerra del 1894 condanna Dreyfus innocente, il Consiglio di Guerra del 1898
proscioglie Esterhazy che è colpevole, la nostra nemica detiene le prove del
duplice errore commesso dalla nostra giustizia militare e tranquillamente la
Francia si ostina in quell’errore, accettando lo spaventoso pericolo dal quale è
minacciata! Dicono che la Germania non può servirsi di documenti ottenuti per
mezzo dello spionaggio. Cosa ne sappiamo? Se domani scoppiasse la guerra, non
comincerebbe forse con la perdita dell’onore del nostro esercito di fronte
all’Europa, con la pubblicazione dei documenti che mostrano l’infame ingiustizia
in cui certi ufficiali si sono intestarditi? È tollerabile un pensiero del
genere, potrà la Francia godere di un istante di riposo fin tanto che saprà in
mano allo straniero le prove del suo disonore? Lo dico con semplicità: non
riuscivo più a darmi pace. Così insieme a Labori decidemmo di citare come
testimoni gli addetti militari stranieri, pur sapendo benissimo che non li
avremmo condotti alla sbarra, ma volendo far capire al governo che sapevamo la
verità nella speranza che agisse. Hanno fatto orecchie da mercante, hanno
ironizzato e lasciato l’esercito in mano alla Germania. E le cose sono rimaste
ferme fino al processo di Rennes. Appena rientrato in Francia sono corso da
Labori, ho insistito disperatamente perché venissero fatti passi presso il
ministero per segnalare la terrificante situazione, per domandargli se non
intendesse intervenire affinché, grazie alla sua mediazione, ci venissero dati i
documenti. Certamente la questione era molto delicata, inoltre c’era quel povero
Dreyfus da salvare, ragion per cui bisognava essere pronti a tutte le
concessioni per timore di irritare l’opinione pubblica già sconvolta.
D’altronde, se il Consiglio di Guerra avesse assolto Dreyfus, i documenti
avrebbero perso il loro valore e l’arma, di cui la Germania si sarebbe potuta
servire, si sarebbe spezzata. Dreyfus prosciolto, ecco l’errore riconosciuto e
riparato. L’onore sarebbe stato salvo. E il mio tormento patriottico è
ricominciato ancora più forte, non appena ho saputo che un Consiglio di Guerra
stava per aggravare il pericolo condannando di nuovo l’innocente, l’uomo del
quale la pubblicazione dei documenti di Berlino griderà un giorno l’innocenza.
Ecco perché non ho cessato d’agire, supplicando Labori di reclamare questi
documenti e di citare come testimone Schwartzkoppen, il solo che possa fare
piena luce. E il giorno che Labori, l’eroe ferito da una pallottola sul campo di
battaglia, approfittando di un ‘ occasione offertagli dagli accusatori, ha
chiamato alla sbarra Io straniero indegno, quel giorno che si è alzato per
chiedere che venisse ascoltato l’uomo che con una sola parola poteva porre fine
all’affaire, quel giorno egli ha adempiuto fino in fondo al suo dovere, è stato
la voce eroica che nulla potrà far tacere, la cui richiesta sopravvive al
processo, e al momento opportuno dovrà fatalmente farlo ricominciare per
chiuderlo con la sola soluzione possibile: l’assoluzione dell’innocente. La
richiesta dei documenti è stata inoltrata, sfido a che quei documenti non siano
prodotti. Vedete in quale maggiore e intollerabile pericolo ci ha messo il
presidente del Consiglio di Guerra di Rennes usando il suo potere discrezionale
per impedire la pubblicazione dei documenti. Niente di più brutale, mai porta è
stata chiusa più intenzionalmente alla verità. «Non vogliamo che ci venga
fornita la prova, perché vogliamo condannare». E un terzo Consiglio di Guerra si
è aggiunto agli altri due nel cieco errore, per cui una eventuale smentita dalla
Germania colpirebbe ora tre sentenze inique. Non è demenza pura, non c’è da
urlare di ribellione e d’inquietudine? Il governo che i suoi funzionari hanno
tradito, che ha avuto la debolezza di lasciare che bambini cresciuti, dalla
mentalità ottusa, giocassero con i fiammiferi e i coltelli; il governo che ha
dimenticato che governare significa prevedere deve affrettarsi ad agire se non
vuole abbandonare a capriccio della Germania il quinto atto, l’epilogo che tutta
Ia Francia dovrebbe temere. È lui, il governo, che ha il compito di recitare al
più presto questo quinto atto, per impedire che lo facciano dall’estero. Può
procurarsi i documenti, la diplomazia ha risolto difficoltà ben più grandi. Il
giorno in cui saprà chiedere i documenti del bordereau, li otterrà. E questo
sarà il fatto nuovo che renderà necessaria una seconda revisione davanti alla
Corte di Cassazione. Questa volta spero istruita e in grado di cessare senza
alcun rinvio nella pienezza della sua magistratura sovrana. Ma se il governo
dovesse di nuovo tirarsi indietro, i difensori della verità e della giustizia
faranno quanto è necessario. Non uno di noi diserterà il suo posto. La prova
inconfutabile prima o poi finiremo per averla. Il 23 novembre saremo a
Versailles. Il mio processo ricomincerà, perché si vuole farlo ricominciare in
tutta la sua ampiezza. Se finora giustizia non è stata ancora fatta, daremo un
nuovo contributo per ottenerla. Il mio caro e valoroso Labori, il cui onore si è
nel tempo accresciuto, pronuncerà perciò a Versailles l’arringa che non ha
potuto pronunciare a Rennes; è semplicissimo, niente andrà perduto. Io non lo
farò certo tacere. Dovrà soltanto dire la verità, senza temere di nuocermi,
poiché sono pronto a pagarla con la mia libertà e col mio sangue. Davanti alla
Corte d ‘ Assise della Senna ho giurato l’innocenza di Dreyfus. La giuro davanti
al mondo intero che ora la grida con me. E torno a ripeterlo: la verità è in
cammino e niente potrà fermarla. A Rennes ha appena compiuto un passo da
gigante. Non mi resta che lo spavento di vederla piombare a saccheggiare la
patria, come una folgore scagliata dalla Nemesi vendicatrice, se non ci
affrettiamo a farla risplendere noi stessi sotto il nostro vivido sole di
Francia.
“Che l’innocente Dreyfus sia riabilitato,
soltanto allora la Francia sarà riabilitata con lui”.
La bellissima lettera, pubblicata su l’Aurore il 29 settembre 1899, che Emile
Zola scrisse alla moglie di Alfred Dreyfus riportata il 26 Agosto 2018 da "Il
Dubbio". Signora, Le rendono l’innocente, il martire. Rendono alla sua sposa, a
suo figlio, a sua figlia, il marito e il padre, e il mio primo pensiero va alla
famiglia finalmente riunita, consolata, felice. Quale che sia ancora il mio
lutto di cittadino nonostante il dolore indignato e la ribellione in cui
continuano ad angosciarsi le anime giuste, vivo con Lei questo momento
meraviglioso, bagnato di lacrime benefiche, il momento in cui Lei ha stretto tra
le braccia il morto risuscitato, uscito vivo e libero dalla tomba. E, malgrado
tutto, questo è un grande giorno di vittoria e di festa. Immagino la prima sera
alla luce della lampada, nell’intimità familiare, quando le porte sono chiuse e
tutti le infamie della strada si spengono sulla soglia di casa. I due bambini
sono là, accanto al padre tornato da un viaggio lungo e oscuro. Lo baciano in
attesa del racconto che farà più tardi. Che pace fiduciosa e che speranza per un
domani riparatore, mentre la madre si aggira con dolce premura, avendo ancora,
dopo tanto eroismo, un compito grandioso da compiere, quello di rimettere in
piedi con le sue cure e la sua tenerezza la salute del crocifisso, del povero
essere che le hanno restituito. C’è tanta dolcezza nel chiuso della casa, una
bontà infinita effonde da ogni parte nell’intimità della stanza in cui la
famiglia sorride. E noi siamo là, nell’ombra, muti, ricompensati, tutti noi che
abbiamo voluto ciò e che abbiamo lottato da tanti mesi per questo momento di
felicità. Quanto a me, confesso che il mio impegno inizialmente non è stato
altro che un’opera di solidarietà umana, di pietà e d’amore. Un innocente
soffriva il più orrendo dei supplizi, non ho visto altro e ho dato inizio a una
campagna unicamente per liberarlo dei suoi mali. Dal momento in cui mi venne
provata la sua innocenza nacque in me una straziante ossessione: il pensiero di
tutto quello che l’infelice aveva sofferto e di quello che ancora soffriva nel
carcere dove agonizzava, murato da una fatalità mostruosa di cui non poteva
nemmeno sciogliere l’enigma. Quale tempesta dentro di lui, e quale smaniosa
attesa che si rinnovava ad ogni nuova aurora! E non ho più vissuto, il mio è
stato il coraggio della pietà, e l’unico obiettivo è stato di mettere fine alla
tortura, di sollevare la pietra affinché il giustiziato ritornasse alla luce del
giorno e fosse restituito ai suoi che avrebbero curato le sue ferite. Una
questione sentimentale, come dicono i politici con una leggera alzata di spalle.
Buon Dio, sì! Ma il mio cuore era infiammato e io andavo in soccorso di un uomo
in preda allo sconforto, fosse egli ebreo, cattolico o maomettano. Allora
credevo che si trattasse di un semplice errore giudiziario, ignoravo l’enormità
del crimine che teneva quell’uomo in catene, oppresso nel fondo di un’atroce
fossa dove altri spiavano la sua agonia. Non provavo perciò nessuna collera
contro i colpevoli, peraltro ancora sconosciuti. Semplice scrittore strappato al
consueto lavoro dalla compassione non perseguivo alcun fine politico e non
lavoravo per alcun partito. Il mio unico partito all’inizio della campagna non
era altri che servire l’umanità. In seguito capii la terribile difficoltà del
nostro compito. Nello svolgersi ed estendersi della battaglia, sentivo che la
liberazione dell’innocente richiedeva sforzi sovrumani. Tutte le potenze sociali
erano alleate contro di noi che non avevamo dalla nostra che la sola forza della
verità. Dovevamo compiere un miracolo per risuscitare il sepolto. Quante volte
durante quei due anni crudeli ho disperato di riaverlo, di restituirlo vivo alla
sua famiglia! Era laggiù, nella sua tomba, e potevamo essere in cento, in mille
o in ventimila, ma la pesante pietra di iniquità era tale che temevo di vedere
le nostre braccia indebolirsi prima dell’ultimo sforzo supremo. Mai, mai più!
Forse un giorno, tra molto tempo, avremmo imposto la verità e ottenuto
giustizia. Ma l’infelice sarebbe morto e la sua sposa, i suoi figli, mai più
avrebbero potuto dargli il bacio gioioso del ritorno. Signora, ecco che oggi
abbiamo compiuto il miracolo. Due anni di lotte imponenti hanno realizzato
l’impossibile; il nostro sogno si è avverato perché il giustiziato è sceso dalla
croce, l’innocente è libero, suo marito Le è stato reso. Egli ha smesso di
soffrire, conseguentemente è fìnita anche la sofferenza dei nostri cuori e
l’intollerabile simulacro cessa di turbare i nostri sonni. Ed è per questo, lo
ripeto, che oggi è un giorno di grande festa e di grande vittoria. Tutti i
nostri cuori comunicano con discrezione col Suo, non c’è cuore di moglie e di
madre che non si sia intenerito pensando a questa prima serata d’intimità, alla
luce della lampada, nell’emozione affettuosa del mondo intero dalla cui simpatia
Lei è circondata. Signora, indubbiamente questa grazia è amara. Come è possibile
imporre dopo tante torture fisiche una simile tortura morale? E che senso di
ribellione si prova nel dirsi che si è ottenuto per pietà quel che dovrebbe
dipendere soltanto dalla giustizia! Il peggio è che tutto sembra essere stato
concertato per approdare a quest’ultima iniquità. I giudici hanno voluto tornare
a colpire l’innocente per salvare i colpevoli, pronti a rifugiarsi
nell’ipocrisia rivoltante di un’apparente misericordia. «Tu vuoi l’onore, noi ti
faremo l’elemosina della libertà, affinché il tuo disonore legale copra i
crimini dei tuoi carnefici». E non c’è, nella lunga serie di infamie commesse,
un attentato più abominevole contro la dignità umana. È veramente il colmo, far
mentire la divina pietà, farne lo strumento della menzogna, umiliare l’innocente
affinché il crimine passeggi al sole gallonato e impennacchiato! Inoltre, quale
tristezza nel constatare che il governo di un grande Paese si rassegna ad essere
misericordioso a causa della sua disastrosa debolezza, quando dovrebbe essere
giusto! Tremare di fronte all’arroganza di una fazione, credere di poter
conseguire la pacificazione con l’ingiustizia, sognare non si sa quale abbraccio
menzognero e avvelenato è il colmo dell’accecamento volontario. Il governo,
all’indomani stesso della scandalosa sentenza di Rennes, non avrebbe dovuto
deferirla alla Corte di Cassazione, alla giurisdizione suprema di cui invece si
beffa con tanta insolenza? La salvezza del Paese non era forse in quell’atto di
necessaria energia che avrebbe salvato il nostro onore agli occhi del mondo e
che avrebbe ristabilito il regno della legge? La pacificazione definitiva è
possibile solo nella giustizia, qualsiasi viltà sarà soltanto causa di una nuova
febbre, e ciò che finora ci è mancato è un governo coraggioso, che voglia
compiere il suo dovere fino in fondo per riportare sul dritto cammino la nazione
smarrita e disorientata dalle menzogne. Ma il nostro decadimento è tale che
siamo ridotti a congratularci con il governo per essersi mostrato pietoso. Ha
osato essere buono, gran Dio! Quale folle audacia, che coraggio eccezionale
esporsi ai morsi delle belve, i cui branchi selvaggi sbucati dalla foresta
ancestrale si aggirano tra di noi! Essere buoni quando non si può essere forti è
di per sé meritorio. E del resto. Signora, la riabilitazione che doveva essere
immediata per la giusta gloria del Paese stesso, suo marito può aspettarla a
fronte alta, poiché non c’è innocente che sia più innocente di lui di fronte a
tutti i popoli della terra. Signora, lasci che Le dica, l’ammirazione, la
venerazione, il culto che proviamo per Suo marito. Ha talmente sofferto senza
nessuna ragione, assalito dall’imbecillità dalla cattiveria umana, che vorremmo
curare ognuna delle sue ferite con tenerezza. Sappiamo bene che la riparazione è
impossibile, che mai la società potrà pagare il suo debito verso iI martire
vessato con un’ostinazione così atroce, ed è per questo che nei nostri cuori gli
eleviamo un altare, non potendo dargli niente di più puro, né di più prezioso di
questo culto di commossa fraternità. Egli è diventato un eroe più grande degli
altri perché ha più sofferto. L’ingiusto dolore lo ha reso sacro; è entrato,
augusto e purificato, in quel tempio dell’avvenire in cui hanno sede gli dèi, le
cui immagini toccano i cuori facendovi nascere un’eterna fioritura di bontà. Le
indimenticabili lettere che Le ha scritto, Signora, resteranno come il più
grande grido d’innocenza martirizzata che mai sia stato emesso da un’anima. E se
finora nessun uomo è stato fulminato da un destino più tragico, non c’è neppure
nessuno che sia salito più in alto di lui nel rispetto e nell’amore degli
uomini. Poi, come se i suoi aguzzini avessero voluto innalzarlo ulteriormente,
gli hanno imposto la tortura suprema del processo di Rennes. Davanti a quel
martire schiodato dalla croce, sfinito, sostenuto soltanto dalla sua forza
morale, essi hanno stilato selvaggiamente, vilmente, coprendolo di sputi,
massacrandolo di coltellate, versando sulle sue piaghe fiele ed aceto. E lui, lo
stoico, ha conservato un contegno ammirevole, senza un lamento, un coraggio
fiero, la tranquilla certezza nella verità, che susciteranno lo stupore delle
generazioni future. Lo spettacolo è stato così bello, così straziante, che
l’iniqua sentenza ha sollevato i popoli da quel dibattimento mostruoso durato un
mese, dove ogni udienza gridava più forte l’innocenza dell’accusato. Il destino
si compiva, l’innocente diventava Dio, affinché un esempio indimenticabile
venisse donato al mondo. A questo punto. Signora, arriviamo alla sommità. Non
c’è gloria, non c’è lode più nobile. Verrebbe quasi da chiedersi: a che pro una
riabilitazione legale attraverso la formulazione di un giudizio d’innocenza se
nell’universo non troveremmo più un galantuomo che non sia già convinto di
quell’innocenza? E questo innocente improvvisamente è diventato il simbolo della
solidarietà umana da un capo all’altro della terra. Laddove la religione di
Cristo aveva impiegato quattro secoli a formarsi e a conquistare alcune nazioni,
la religione dell’innocente condannato due volte ha fatto immediatamente il giro
del mondo, riunendo in una immensa umanità tutte le nazioni civili. Cerco, nel
corso della storia un analogo movimento di fraternità universale, ma non lo
trovo. L’innocente condannato due volte ha fatto più per la fraternità tra i
popoli, per l’idea di solidarietà, di giustizia, che cento anni di discussioni
filosofiche e teorie umanitarie. Per la prima volta nella storia, l’umanità
intera ha emesso un grido di liberazione ribellandosi generosamente per la
giustizia, come se ormai formasse un solo popolo, il popolo unico e fraterno
sognato dai poeti. Egli può dormire tranquillo e fiducioso. Signora, nel dolce
rifugio familiare, riscaldato dalle Sue mani pie. E Lei può contare su noi per
la sua glorificazione. Siamo noi, i poeti, a concedere la gloria, e la parte che
gli assegneremo sarà così bella che nessun altro uomo della nostra epoca lascerà
un ricordo altrettanto commovente. Sono stati già scritti molti libri in suo
onore, un’intera biblioteca si è moltiplicata per dimostrare la sua innocenza e
per esaltare il suo martirio. Mentre da pane dei suoi carnefici sono rari i
documenti volumi e gli opuscoli scritti, gli amanti della verità e della
giustizia non hanno cessato né cesseranno di contribuire alla storia, di
pubblicare gli innumerevoli documenti dell’immensa inchiesta che un giorno
permetterà di stabilire definitivamente i fatti. È il verdetto di domani che si
prepara e esso porterà all’assoluzione trionfale, alla clamorosa riparazione;
alla memoria del glorioso torturato tutte le generazioni in ginocchio
chiederanno perdono per il delitto commesso dai loro padri.E siamo sempre noi
poeti, Signora, a inchiodare i colpevoli alla gogna eterna. Coloro che noi
condanniamo le generazioni future li fischieranno e li disprezzeranno. Ci sono
nomi di criminali che, marchiati d’infamia da noi, negli anni a venire non
saranno che immondi relitti. La giustizia immanente si è riservata questo
castigo, ha incaricato i poeti di legare all’esecrazione dei secoli coloro le
cui malefatte sociali, i cui crimini enormi sfuggono ai tribunali ordinari. So
bene che per questi animi meschini e gaudenti questo è solo un castigo lontano
del quale sorridono.L’insolenza immediata li appaga. Trionfare a furia di pedate
è iI successo brutale in grado di soddisfare la loro fame volgare. Quale
importanza può avere l’indomani nella tomba o l’infamia, quando non si può più
arrossirne! La spiegazione dello spettacolo vergognoso che ci è stato offerto è
in questa bassezza d’animo: le menzogne sfrontate, le frodi provate, le
spudoratezze lampanti, tutto ciò che non dovrebbe durare più di un’ora e
costituire la rovina dei colpevoli. Ma questi non hanno una discendenza? Non
temono che il rossore della vergogna salga un giorno sui volti dei loro figli e
dei loro nipoti? Ah, poveri pazzi! Sembra che neppure Ii sfiori l’idea che
questa gogna, dove noi inchioderemo i loro nomi, è stata erettaproprio da loro.
Voglio credere che si trattidi cervelli ottusi, nei quali un particolare
ambiente e uno spirito professionaleabbiano provocato una deformazione. Come
nei giudici di Rennes checondannano nuovamenteun innocente per salvare l’onore
dell’esercito: si può immaginare qualcosa di più stupido? L’esercito, già! Lo
hanno servito bene, compromettendolo in questa avventura scellerata. Sempre lo
scopo volgare, immediato, senza alcuna accortezza per il domani! Bisognava
salvare i pochi ufficiali colpevoli, a costo di un autentico suicidio del
Consiglio di Guerra, di un sospetto gettato sull’alto comando ormai solida- le.
E del resto, fa sempre parte dei loro crimini l’avere disonorato l’esercito ed
essere stati gli artefici di nuovi disordini e di un rinnovato risentimento, al
punto che se il governo pur di pacificare un po’ gli animi ha graziato
l’innocente, lo ha fatto senza dubbio cedendo all’urgente bisogno di riparare
l’errore, essendovi costretto dal rifiuto di rendere giustizia.Ma bisogna
dimenticare, Signora, e soprattutto disprezzare. Nella vita è un grande sostegno
disprezzare le viltà e gli oltraggi. Per me è stato salutare. Sono ormai
quarant’ anni che lavoro, quarant’anni che mi tengo in piedi grazie al disprezzo
per le ingiurie che mi è valsa ciascuna delle mie opere. E, dopo due anni che ci
battiamo per la verità e la giustizia, l’ignobile moltitudine si è talmente
ingrossata attorno a noi che ne usciamo corazzati per sempre, invulnerabili alle
ferite. Per quanto mi riguarda, ho radiato dalla mia vita, i giornali ignobili,
questi fantocci di melma. Non esistono più, salto il loro nome quando me lo
trovo sotto gli occhi, salto perfino le note che citano i loro scritti. È una
semplice norma d’igiene. Ignoro quel che fanno, il disprezzo li ha cacciati
dalla mia mente in attesa che la fogna li spazzi via interamente.Ciò che io
consiglio all’innocente è l’oblio sprezzante di tante atroci ingiurie. Egli è un
uomo a parte, posto così in alto che non deve più esserne colpito. Che possa
rivivere al Suo fianco, sotto il sole limpido, lontano dalle folle sediziose,
per ascoltare soltanto il concerto di simpatia universale che sale verso di lui!
Pace al martirizzato che ha tanto bisogno di riposo, e che attorno a lui nel
rifugio dove Lei lo amerà e lo guarirà ci sia soltanto la carezza commosa delle
persone e delle cose. Quanto a noi, Signora, continueremo la lotta, ci batteremo
per la giustizia con la stessa tenacia di ieri. Ci occorre la riabilitazione
dell’innocente, non tanto per riabilitare la persona, che ha già tanta gloria,
quanto per riabilitare la Francia, che sicuramente potrebbe morire di questi
eccessi d’ingiustizia.Il nostro sforzo futuro sarà quello di riabilitare la
Francia agli occhi delle nazioni il giorno in cui casserà la sentenza infame. Un
grande Paese non può vivere senza giustizia, e il nostro resterà in lutto
fintanto che non avrà cancellate l’onta, questo schiaffo alla sua più alta
giurisdizione, questo rifiuto del diritto che colpisce ogni cittadino. Nel
momento in cui viene meno la garanzia delle leggi, i l legame sociale è sciolto
e tutto crolla. E in questo rifiuto del diritto c’è stato un tale castello
d’insolenze, un insieme di bravate così tracotanti, che non abbiamo neppure la
speranza di far scendere il silenzio sul disastro, di seppellire il cadavere in
segreto per non arrossire di fronte ai nostri vicini. Il mondo intero ha visto e
ha capito; è davanti al mondo intero che la riparazione deve avvenire, tonante
quanto I’errore.Volere una Francia senza onore, isolata e disprezzata, un sogno
criminale. Senza dubbio gli stranieri verranno alla nostra Esposizione, non ho
mai dubitato che essi invaderanno Parigi la prossima estate, come si corre ai
baracconi della fiera tra lo splendore dei lumi e il baccano delle musiche. Ma
può bastare alla nostra fierezza? Non dobbiamo tenere tanto alla stima quanto al
denaro di quei visitatori venuti da ogni parte del globo? Festeggiamo la nostra
industria, le nostre scienze, le nostre arti esponiamo i nostri lavori del
secolo. Oseremo esporre la nostra giustizia? E immagino la caricatura straniera,
l’isola del Diavolo ricostruita e mostrata al Champ de Mars. Brucio di vergogna,
non capisco come l’Esposizione possa venire inaugurata senza che la Francia
abbia ripreso il suo rango di nazione giusta. Che l’innocente sia riabilitato,
soltanto allora la Francia sarà riabilitata con lui. Concludendo, torno a
ripeterlo, Signora, Lei può affidarsi ai buoni cittadini che hanno fatto
restituire la libertà a Suo marito e che gli faranno restituire l’onore. Nessuno
abbandonerà il combattimento perché sono coscienti che lottando per la giustizia
lottano per il Paese. L’ammirevole fratello dell’innocente darà loro ancora una
volta esempio di coraggio e di saggezza. E poiché non abbiamo potuto, in un
colpo solo, renderLe l’amato libero e puro dall’accusa menzognera, Le chiediamo
soltanto ancora un po’ di pazienza, augurandoci che i Suoi figlioli non debbano
crescere ancora moltoprima che il loro nome sia legalmente lavato da ogni
macchia. Oggi il mio pensiero torna inevitabilmente verso quei cari bambini, e
li vedo tra le braccia del padre. So con quale premura gelosa e con quale
miracolo di delicatezza Lei li ha tenuti nella completa ignoranza. Credevano il
loro padre in viaggio; poi la loro intelligenza ha finito per svegliarsi,
diventavano esigenti, interrogavano, volevano una spiegazione per una così lunga
assenza. Che dire loro, quando il martire era ancora laggiù nella tomba infame,
quando la prova della sua innocenza risiedeva soltanto in qualche raro devoto?
Il Suo cuore deve essersi spezzato orribilmente. Tuttavia, in queste ultime
settimane, non appena l’innocenza ha brillato per tutti di una luminosità
solare, avrei voluto che Lei prendesse per mano tutti e due i Suoi bambini e li
conducesse nella prigione di Rennes, affinché avessero per sempre nella memoria
il padre ritrovato là, cosparso d’eroismo. Avrei voluto che avesse detto loro
che cosa aveva sofferto ingiustamente, quale grandezza morale era la sua, di
quale appassionata tenerezza dovevano amarlo per fargli dimenticare
l’ingiustizia degli uomini. Le loro piccole anime si sarebbero temprate in quel
bagno di virtù.Del resto, non è tardi. Una sera, alla luce della lampada
familiare, nella pace del focolare domestico, il padre li chiamerà a sé, li farà
sedere sulle sue ginocchia, e racconterà loro tutta la tragica storia. Bisogna
che sappiano affinché lo rispettino e adorino come merita. Quando avrà finito di
raccontare, sapranno che non c’è al mondo un eroe più acclamato, un martire la
cui sofferenza abbia sconvolto più profondamente i cuori. E saranno molto fieri
di lui, porteranno il suo nome gloriandosene, come il nome di un coraggioso e di
uno stoico che si è purificato fino al sublime, preda del più crudele dei
destini che la scelleratezza e la viltà umane abbiano mai lasciato compiersi. Un
giorno saranno i figli dei boia e non quelli dell’innocente che dovranno
arrossire tra l’orrore universale.Voglia gradire, Signora, l’espressione del mio
più profondo rispetto.
Dreyfus doveva essere assolto e non
soltanto perdonato, scrive Vincenzo Vitale il 26
Agosto 2018 su "Il Dubbio". Il 29 settembre del 1899, il Presidente della
Repubblica Loubet, per mettere fine allo scandalo della condanna doppia di un
innocente, e del quale ormai tutto il mondo sapeva, firma la Grazia per Dreyfus,
rendendolo, dopo circa sei anni di vera e propria tortura, alla moglie e ai
figli. Dieci giorni dopo, Zola pubblica questa appassionata e appassionante
lettera alla moglie di Dreyfus, che costituisce una sorta di sintesi della sua
posizione pubblica. Innanzitutto, egli mette in chiaro, con molta onestà
intellettuale, di aver creduto, sulle prime, trattarsi soltanto di un errore
giudiziario – grave e spiacevole – ma sempre un errore e nulla di più. Solo poco
alla volta, si era invece reso conto che si trattava di una mostruosa
macchinazione difficilissima da smontare e in forza della quale “tutte le
potenze sociali erano alleate contro di noi”, cioè contro coloro che difendevano
Dreyfus e che invece contavano solo sulla forza della verità. Da questo punto di
vista, Zola rappresenta davvero la figura del moderno intellettuale, libero da
condizionamenti ideologici, capace di coltivare una idea politica – in quanto
essere pensante – ma altrettanto capace di contraddirla se ce ne fosse stato
bisogno. Ecco perché, per lui, che Dreyfus fosse ebreo, cattolico o maomettano
non poteva che essere indifferente: bastava fosse un uomo. Ma Zola non manca di
mettere il dito sulla piaga, sulla vera piaga, evidenziando che la Grazia, pur
mettendo fine alle terribili sofferenze di Dreyfus, è “amara”. E perché sarebbe
amara? Lo è per il semplice motivo che mentre la Grazia concessa dal sovrano –
in questo caso dal Presidente – non si basa sul riconoscimento della innocenza
della persona graziata, ed anzi ne presuppone la colpevolezza, per ragioni di
elementare giustizia, Dreyfus doveva essere assolto nel merito da ogni
imputazione, e non soltanto perdonato. Zola denuncia senza mezzi termini la
pochezza di una nazione che – come la Francia – nella incapacità di rendere
giustizia, cioè a ciascuno il suo, debba ricorrere alla misericordia del
perdono. Ciò è null’altro che voler essere “buoni”, quando non si è capaci di
essere “forti”. Ma in questo modo – c’è da aggiungere – si mistifica allo stesso
tempo sia la giustizia, sia la misericordia. Infatti, la vera misericordia
suppone sempre che sia stata preliminarmente soddisfatta la giustizia. Solo se
la giustizia non ha più nulla da pretendere, può legittimamente entrare sul
palcoscenico del mondo la misericordia, la quale, secondo il tradizionale
insegnamento della scolastica, non nega mai la prima, ma anzi la porta a
compimento. Se per ragioni di stretta giustizia devo pagare una somma a un mio
creditore che mi concesse un prestito, non posso certo restituirgliela a titolo
di misericordia: quella somma gli è dovuta, punto e basta. Se invece farò dono
di una somma a un indigente per consentirgli di sfamarsi, quella sarà vera
misericordia. Ebbene, graziando Dreyfus, è come se la Francia abbia preteso di
concedere per la misericordia del perdono quella “elemosina della libertà” –
scrive efficacemente Zola – a chi invece aveva diritto di essere riconosciuto
del tutto innocente del delitto per cui era stato condannato. Insomma, una
meschinità della quale vergognarsi e indegna di una nazione che accampi il
merito di aver fatto da apripista nel dissodare l’aspro terreno dei diritti e
della libertà. Ecco dunque l’annuncio alla destinataria dello scritto e al mondo
intero: Zola non si fermerà, fin quando l’innocente Dreyfus non avrà ottenuto la
piena riabilitazione. Certo, lo scrittore comprendeva bene le motivazioni
empiriche che avevano indotto il Presidente Loubet a concedere la Grazia. Loubet
aveva ben compreso probabilmente l’innocenza di Dreyfus, ampiamente dimostrata
dalla precipitosa fuga del vero colpevole – Esterhazy – in Inghilterra; dal
suicidio di Henry, l’autore del falso documento che era servito per condannare
Dreyfus; dall’arresto di Paty du Clam, il vero e terribile autore della
spudorata macchinazione. E perciò sperava che la Corte di Rennes avrebbe
rimediato al misfatto, avendo del resto in mano gli elementi processuali per
farlo. Ma non aveva fatto i conti con lo spirito corporativo di quei sedicenti
giudici, tanto intenso da sfociare nella stupidità, se stupido è – secondo una
nota definizione di Carlo Cipolla (autore di un sapido libretto sulle leggi
fondamentali della stupidità umana) – colui che per danneggiare un altro
(Dreyfus), alla fine danneggia anche se stesso (la Corte di Rennes e l’intero
esercito). Di fronte a questa perdurante e in definitiva stupidissima
ostinazione della Corte di Rennes, e probabilmente diffidando della stessa
Cassazione alla quale si poteva pur inoltrare ricorso, al Presidente non restava
che la Grazia, utile per finirla una buona volta con questa terribile storia che
aveva infangato la reputazione della Francia in tutta Europa. Ma per la seconda
volta, egli non aveva fatto i conti con un’altra ostinazione, ben più ragionata
della prima: quella di Zola, nel richiedere a gran voce la piena riabilitazione
di Dreyfus. “Che l’innocente sia riabilitato, soltanto allora la Francia sarà
riabilitata con lui”.
Amnistia a Dreyfus, sì, ma questa è
un’amnistia sciagurata! Lettera riportata da "Il
Dubbio il 29 agosto 2018 di Émile Zola a Émile Loubert, presidente della
Repubblica dal 1899 al 1906 che concesse la grazia ad Alfred Dreyfus. Signor
presidente, circa tre anni fa, il I 3 gennaio 1898, indirizzai al Suo
predecessore Félix Faure una Lettera di cui egli non tenne sventuratamente conto
per la sua buona reputazione. Ora che egli dorme il sonno eterno, la sua memoria
rimane oscurata dalla mostruosa iniquità che io gli denunciavo, e della quale si
è reso complice, usando tutto il potere che gli derivava dalla sua alta
magistratura per coprire i colpevoli. Ed eccoLa ad occupare il suo posto, ecco
che l’abominevole affaire, dopo avere macchiato tutti i governi complici o vili
che si sono succeduti, si conclude sbrigativamente in un supremo diniego di
giustizia, in un’amnistia che le Camere hanno appena votato con il coltello alla
gola, e che porterà nella storia il nome di amnistia sciagurata. Il Suo governo
precipita nell’errore insieme ai governi che l’hanno preceduto, assumendosi la
più pesante delle responsabilità. Una pagina della sua vita sta per essere
macchiata, la sua magistratura rischia di uniformarsi a quella precedente, a sua
volta insozzata da una macchia indelebile. Mi permetta perciò, signor
presidente, di esprimerle tutta la mia angoscia. Visto che la mia prima Lettera
è stata una delle cause di questa amnistia, all’indomani della sua approvazione
concluderò con questa nuova Lettera. Quanto meno non mi si potrà rimproverare
d’essere un chiacchierone. Il 18 luglio 1898 partivo per l’Inghilterra e sono
tornato soltanto il 5 giugno 1899: in quegli undici mesi ho taciuto. Ho di nuovo
parlato nel settembre 1899, dopo il processo di Rennes. Poi sono ripiombato nel
più completo silenzio, che ho spezzato una solta volta nel maggio scorso, per
protestare davanti al Senato contro l’amnistia. Sono più di diciotto mesi che
aspetto giustizia, fissata ogni tre mesi e regolarmente rinviata alla sessione
successiva. Ho trovato tutto ciò tragico e comico. Oggi, al posto della
giustizia, arriva quest’amnistia scellerata e oltraggiosa. Penso pertanto che il
buon cittadino che sono stato, il silenzio che ho rispettato per non essere
causa d’imbarazzo né di disordini, la grande pazienza che ho mostrato nel
contare su una giustizia così lenta mi diano oggi il diritto e il dovere di
parlare. Lo ripeto, devo concludere la mia opera. Una prima fase dell’affaire
Dreyfus, che chiamerò il crimine assoluto, termina in questo momento. Prima di
rientrare nuovamente nel silenzio, è necessario che spieghi il punto a cui siamo
giunti, qual è stata la nostra opera e qual è la nostra certezza per domani. Non
ho bisogno di risalire alle prime infamie dell’affaire, mi è sufficiente
ritrarlo all’indomani della raccapricciante sentenza di Rennes, quella
provocazione insolente ed iniqua che ha fatto fremere il mondo intero. È qui,
signor presidente, che comincia la colpa del suo governo e conseguentemente la
sua. Sono certo che un giorno ciò che è accaduto a Rennes verrà raccontato
documenti alla mano: alludo al modo in cui il Suo governo si è lasciato
ingannare e ha creduto quindi di doverci tradire. I ministri erano convinti
dell’assoluzione di Dreyfus. Come avrebbero potuto dubitarne quando la Corte di
Cassazione credeva di avere imbrigliato il Consiglio di Guerra nei termini di
una sentenza così netta, in cui l’innocenza s’imponeva anche senza dibattimento?
Come potevano minimamente preoccuparsi, quando i loro subordinati, intermediari,
testimoni, attori perfino nel dramma, promettevano loro la maggioranza se non
l’unanimità? E sorridevano dei nostri timori, lasciavano tranquillamente il
tribunale in preda alla collusione, alle false testimonianze, alle manovre
flagranti di pressione e d’intimidazione; spingevano la loro cieca fiducia fino
a compromettere Lei, signor presidente, omettendo di avvisarla, perché voglio
credere che il minimo dubbio Le avrebbe impedito di prendere, nel suo discorso
di Rambouillet, l’impegno di inchinarsi di fronte alla sentenza, quale essa
fosse. Governare significa forse non prevedere? Ecco un governo nominato per
assicurare il buon funzionamento della giustizia e per vegliare sull’onesta
esecuzione di una sentenza della Corte di Cassazione. Esso non ignora quale
pericolo corra quella sentenza in mani fanatiche che ogni sorta di malvagità
hanno reso poco scrupolose. E non fa niente, si compiace nel suo ottimismo,
lascia che il crimine si compia alla luce del sole! Posso convenire che quei
ministri volessero allora la giustizia: ma Le chiedo, che cosa avrebbero fatto
qualora non l’avessero voluta? Poi esplode la condanna, una mostruosità fino ad
allora inaudita di un innocente condannato due volte. A Rennes, in seguito
all’inchiesta della Corte cli Cassazione, l’innocenza era evidente, non poteva
lasciare adito a dubbi di sorta. Invece arriva il fulmine e l’orrore passa sulla
Francia e su tutti i popoli. Come reagirà il governo, tradito, ingannato,
provocato, il cui incomprensibile abbandono è sfociato in un simile disastro?
Voglio ancora ammettere che il colpo che si è ripercosso così dolorosamente
nell’animo di tutti i giusti abbia turbato anche i suoi ministri che avevano
l’incarico di assicurare il trionfo del diritto. Ma cosa vorranno fare, quali
saranno le loro decisioni all’indomani del crollo di tutte le loro certezze, una
volta constatato che, lungi dall’essere stati artefici di verità e di giustizia,
hanno causato con la loro inettitudine e la loro leggerezza uno sfacelo morale
dal quale la Francia impiegherà molto tempo a riaversi? Ed è qui, signor
presidente, che ha inizio l’errore del Suo governo e Suo personale, errore che
ci ha separati da tutti voi, per una divergenza d’opinioni e di sentimenti che
non ha mai cessato d’ingrandirsi. Esitare per noi era impossibile, non c’era che
un mezzo per liberare la Francia dal male che la divorava, se la si voleva
guarire per ridarle realmente la pace: infatti non c’è pacificazione se non
nella tranquillità della coscienza, né ci sarà salvezza per noi finché sentiremo
in noi il veleno dell’ingiustizia commessa. Bisognava trovare il modo di
convocare nuovamente e immediatamente la Corte di Cassazione; e non mi si dica
che era impossibile, il governo disponeva degli elementi necessari, anche al di
fuori dell’abuso di potere. Bisognava liquidare tutti i processi in corso,
lasciare che la giustizia compisse il suo corso senza che un solo colpevole le
potesse sfuggire. Bisognava ripulire l’ulcera a fondo, dare al nostro popolo
un’alta lezione di verità e di giustizia, restituire alla Francia il suo primato
morale dinanzi al mondo. Soltanto allora si sarebbe potuto dire che la Francia
era guarita e pacificata. È stato in quel momento che il suo governo ha preso
l’altro partito, e cioè la risoluzione d’insabbiare una volta di più la verità,
di sotterrarla, pensando che ciò fosse sufficiente perché non esistesse più.
Nello sgomento in cui l’aveva gettato la seconda condanna dell’innocente, non ha
saputo escogitare che il doppio provvedimento: prima la grazia dell’innocente e
poi, per ottenere il silenzio, il bavaglio dell’amnistia. Le due misure sono
collegate e si completano, sono la rabberciatura di un governo allo stremo che è
venuto meno alla sua missione e che, per togliersi d’impaccio, non trova di
meglio che rifugiarsi nella ragion di Stato. II Suo governo ha voluto coprirla,
signor presidente, dal momento che aveva avuto il torto di lasciarla impegnare.
Ha voluto salvarsi a sua volta, credendo forse di appigliarsi alla sola azione
in grado di salvare la Repubblica minacciata. Il grande errore è stato perciò
commesso quel giorno, nel momento in cui si presentava l’ultima occasione per
agire e restituire alla patria la sua dignità e la sua forza. So bene che in
seguito, nel corso dei mesi che si sono succeduti, la salvezza è diventata
sempre più difficile. Il governo sì è lasciato schiacciare in una situazione
senza uscita e quando davanti alle Camere ha affermato che non avrebbe potuto
più governare qualora gli avessero rifiutato l’amnistia aveva senza dubbio
ragione. Ma non è stato il governo che, disarmando la giustizia quando essa era
ancora possibile, ha reso necessaria l’amnistia? Scelto per salvare tutto, ha
lasciato che tutto crollasse nella peggiore delle catastrofi. E quando è
intervenuto per trovare l’estrema riparazione, non ha saputo immaginare di
meglio che terminare come i governi Méline e Dupuy avevano cominciato:
l’insabbiamento della verità e l’assassinio della giustizia. Non è una vergogna
della Francia che nessuno dei suoi uomini politici si sia sentito
sufficientemente forte, intelligente e coraggioso per prendere in mano la
situazione, per gridarle la verità e per essere da essa seguito? Per tre anni
abbiamo visto gli uomini che si sono succeduti al potere prima vacillare e poi
sprofondare nello stesso errore. E non parlo né di Méline, l’uomo nefasto che ha
voluto il crimine, né di Dupuy, l’uomo ambiguo, asservito in partenza al partito
dei più forti. Ma parlo di Brisson, che ha avuto il coraggio di chiedere la
revisione; non è doloroso l’errore irrimediabile in cui è caduto permettendo
l’arresto del colonnello Picquart all’indomani della scoperta del falso Henry?
Parlo di Waldeck– Rousseau, i cui coraggiosi discorsi contro la legge di
incompetenza a procedere avevano avuto così nobilitazioni le risonanza in tutte
le coscienze. Non è disastroso che si sia sentito in obbligo di legare il suo
nome a questa amnistia che, con brutalità anche maggiore, dichiara incompetente
la giustizia? Ci chiediamo se un nemico al governo non ci sarebbe stato più
utile, visto che gli amici della verità e della giustizia, quando sono al
potere, non sanno trovare altri mezzi per salvare se stessi e il Paese che
quello di ricorrere a loro volta alla menzogna e all’iniquità. Signor
presidente, se la legge d’amnistia è stata votata dalle Camere con la morte nel
cuore, è chiaro che lo scopo è di assicurare al Paese la salvezza. Nel vicolo
cieco in cui si è cacciato, il suo governo ha dovuto scegliere il terreno della
difesa repubblicana, di cui ha sentito la solidità. L’affaire Dreyfus ha per
l’appunto indicato i pericoli che la Repubblica correva, a causa del doppio
complotto del clericalismo e del militarismo che agivano in nome delle forze
reazionarie del passato. E da quel momento il piano politico del governo è
semplice: sbarazzarsi dell’affaire Dreyfus insabbiandolo, lasciar in tendere
alla maggioranza che, se non obbedirà docilmente, non avrà le riforme promesse.
Tutto ciò andrebbe bene se per salvare il Paese dal veleno clericale e
militarista non lo si lasciasse immerso in un altro veleno, quello della
menzogna e dell’iniquità in cui lo vediamo agonizzare da tre anni. Senza dubbio
l’affaire Dreyfus è un terreno politico detestabile. O quanto meno lo è
diventato a causa dell’abbandono nel quale è stato lasciato il popolo, in mano
ai peggiori banditi e nel putridume della stampa ignobile. E concedo ancora una
volta che nell’ attuale momento l’azione sia difficile, se non impossibile. Ma
nondimeno l’idea che si possa salvare un popolo dal male che lo consuma,
decretando che quel male non esiste più, è una concezione miope. L’amnistia è
fatta, i processi non si faranno più e non sarà più possibile perseguire i
colpevoli: ma ciò non toglie che Dreyfus, innocente, sia stato condannato due
volte, e che questa orrenda ingiustizia finché non sarà riparata continuerà a
far delirare la Francia in preda a incubi orribili. Voi avete ben sotterrato la
verità, ma essa cammina sotto terra e un giorno riaffiorerà ovunque, esplodendo
in ve- vendicatrici. E la cosa peggiore è che voi contribuite alla
demoralizzazione degli umili, oscurando in loro il sentimento dì giustizia. Dal
momento che non ci sono puniti, non ci sono neppure colpevoli. Come vuole che
gli umili sappiano se sono in preda alle menzogne corruttrici di cui sono stati
alimentati? Occorrerebbe una lezione per il popolo, mentre al contrario gli
ottenebrate la coscienza e finite per il pervertirla del tutto. Il nodo è tutto
qui: il governo afferma di tendere alla pacificazione con la legge d’amnistia, e
noi al contrario sosteniamo che esso corre il rischio di preparare nuove
catastrofi. Torno ancora una volta a ripetere che non c’è pace nell’ingiustizia.
La politica vive alla giornata, crede all’eternità solo perché ha guadagnato sei
mesi di silenzio. È possibile che il governo goda di un po’ di tregua, e ammetto
perfino che la impiegherà utilmente. Ma la verità si risveglierà, griderà,
scatenerà delle tempeste. Da dove verranno? Lo ignoro, ma verranno. E da quanta
impotenza saranno colpiti gli uomini che non hanno voluto agire, con quale peso
li schiaccerà questa amnistia scellerata in cui hanno gettato alla rinfusa
persone oneste e delinquenti! Quando il Paese saprà, quando il Paese sollevatosi
vorrà rendere giustizia, la sua collera non comincerà col cadere su coloro che
non l’hanno illuminato quando potevano farlo? Il mio caro e grande amico Labori
l’ha dello con la sua meravigliosa eloquenza: la legge d’amnistia è una legge
dettata dalla debolezza e dalla impotenza. La viltà dei governi che si sono
succeduti si è accumulata e questa legge nasce da tutti i cedimenti degli uomini
che, messi di fronte a u n’ingiustizia insopportabile, non hanno avuto la forza
di impedirla né di porvi rimedio. Di fronte alla necessità di dover colpire in
alto, tutti si sono piegati e hanno indietreggiato. All’ultimo momento, dopo
tanti crimini, non è né l’oblio né il perdono che ci viene porto, ma la paura,
la debolezza, l’impotenza in cui si sono trovati i ministri a far semplicemente
applicare le leggi esistenti. Dicono di volerci pacificare con concessioni
reciproche: non è vero, la verità è che nessuno ha avuto il coraggio di usare la
scure con la vecchia società corrotta, e per nascondere questa codardia parlano
di clemenza, assolvendo Esterhazy il traditore, e Picquart, l’eroe al quale
l’avvenire innalzerà monumenti. Questa è un’infamia che sarà sicuramente punita
poiché non ferisce soltanto la coscienza ma corrompe la moralità nazionale. È
questa una buona educazione per una Repubblica? Quali lezioni donate alla nostra
democrazia quando le insegnate che ci sono ore in cui la verità e la giustizia
non esistono più se l’interesse dello Stato lo esige? È la ragion di Stato
rimessa sul piedistallo da uomini liberi che l’hanno condannata nella Monarchia
e nella Chiesa. Bisogna veramente che la politica sia una grande pervertitrice
d’anime. E dire che molti dei nostri amici che fin dal primo giorno hanno
validamente combattuto, aderendo alla legge d’amnistia come a una misura
politica necessaria, oggi hanno ceduto al sofisma! Mi si spezza il cuore nel
vedere l’onesto e coraggioso Rane prendere le difese di Picquart contro lo
stesso Picquart, mostrandosi felice del fatto che l’amnistia, che gli impedirà
di difendere il suo onore, lo salverà dall’odio certo di un Consiglio di Guerra.
E Jaurès, il nobile e generoso Jaurès che si è prodigato così magnificamente,
sacrificando il suo seggio di deputato in questi tempi di appetiti elettorali,
anche lui accetta di vederci amnistiati, Picquart ed Esterhazy, Reinach e du
Paty de Clam, me e il generale Mercier, tutti nello stesso sacco! La giustizia
assoluta finisce dunque là dove comincia l’interesse di un partito? Ah, quale
serenità essere un solitario, non appartenere a nessuna setta, dipendere
soltanto dalla propria coscienza, e che agiatezza nel procedere dritti per il
proprio cammino, non amare che la verità, e volerla perfino quando potrebbe
scuotere la terra e far cadere il cielo!
Signor presidente, nei giorni della speranza
dell’affaire Dreyfus, avevamo fatto un bel sogno. Non avevamo tra le mani un
caso unico, un crimine nel quale erano coinvolte le forze più reazionarie che
sono di ostacolo al libero progresso dell’umanità? Mai si era presentata
un’esperienza più decisiva e mai sarebbe stata data al popolo una lezione più
nobile. In pochi mesi avremmo illuminato la sua coscienza, avremmo fatto molto
di più per istruirlo e maturarlo di quanto un secolo di lotte politiche non
avesse fatto. Sarebbe bastato mostrargli l’operato di tutti i poteri deleteri,
complici del più esecrabile dei crimini: l’annientamento di un innocente le cui
inqualificabili torture strappavano all’umanità un grido di rivolta. Confidando
nella forza della verità attendevamo il trionfo. Sarebbe stata l’apoteosi della
giustizia: il popolo cosciente che si levava in massa acclamando Dreyfus al suo
rientro in Francia; il Paese che ritrovava la sua consapevolezza e innalzava un
altare all’equità, celebrando la festa del diritto glorioso e sovrano
riconquistato. E tutto sarebbe finito con un bacio universale, con i cittadini
pacificati e uniti dalla comunione della solidarietà umana. Ahimè, signor
presidente, sa bene ciò che è avvenuto: l’ambigua vittoria la confusione per
ogni piccola parte di verità conquistata, l’idea della giustizia a lungo
oscurata nella coscienza dello sventurato popolo. Sembra che la nostra idea di
vittoria fosse troppo immediata e grossolana. La vita non contempla trionfi
strepitosi che sollevino una nazione, che in un giorno la consacrino forte e
potente. Simili evoluzioni non si realizzano in un istante ma soltanto nello
sforzo e nel dolore. La lotta non finisce mai, ogni passo in avanti avviene al
costo di una sofferenza e soltanto i figli potranno constatare i successi
raggiunti dai padri. E se nel mio ardente amore per il popolo francese non mi
consolerò mai di non aver potuto trarre per la sua educazione civica la nobile
lezione che l’affaire Dreyfus comportava, sono altresì da molto tempo rassegnato
nel vedere la verità penetrarlo lentamente, fino al giorno in cui sarà maturo
per il suo destino di libertà e di fraternità. Non abbiamo mai pensato ad altro
che al popolo, ad un tratto l’affaire Dreyfus si è dilatato diventando un caso
sociale e umano. L’innocente che soffriva all’isola del Diavolo era soltanto
l’accidente, tutto il popolo soffriva con lui sotto il peso schiacciante di
potenze malefiche, nell’impudente disprezzo della verità e della giustizia.
Salvandolo, salvavamo tutti gli oppressi e gli umiliati. Ma soprattutto, ora che
Dreyfus è libero e restituito all’amore dei suoi, chi sono i furfanti e gli
imbecilli che ci accusano di voler riaprire l’affaire Dreyfus? Sono coloro che,
nei loro loschi maneggi politici, hanno forzato il governo ad esigere l’amnistia
continuando a corrompere il Paese con le menzogne. Che Dreyfus cerchi con tutti
i mezzi legali di ottenere la revisione del giudizio di Rennes è certamente
giusto, e noi il giorno in cui si presenterà l’occasione lo aiuteremo con tutte
le nostre forze. Immagino che perfino la Corte di Cassazione sarà felice di
avere l’ultima parola per l’onore della sua suprema magistratura. Si tratta
solamente di questo, di una questione giudiziaria, nessuno di noi ha mai avuto
la stupida idea di ravvivare quello che è stato l’affaire Dreyfus: e oggi
l’unico desiderio auspicabile e possibile è quello di trarre da questo caso le
conseguenze politiche e sociali, la messe di riforme di cui esso ha mostrato
l’urgenza. Sarà la nostra difesa in risposta alle accuse abominevoli che ci
vengono rivolte, e soprattutto sarà la nostra vittoria definitiva. Signor
presidente, un’espressione mi irrita ogni volta che la sento pronunciare, è il
luogo comune secondo il quale l’affaire Dreyfus ha fatto tanto male alla
Francia. L’ho sentita pronunciare e scrivere da tutti, miei amici la ripetono
correntemente, e forse l’avrò usata io stesso questa espressione assolutamente
falsa. E non mi riferisco all’ammirevole spettacolo che la Francia ha offerto al
mondo, questa lotta gigantesca per una questione di giustizia, questo conflitto
di tutte le forze attive in nome di un ideale. Così come non parlo dei risultati
già ottenuti: gli uffici del Ministero della Guerra ripuliti, tutti gli attori
equivoci del dramma spazzati via: poiché la giustizia, malgrado tutto, ha fatto
un po’ del suo dovere. Ma il bene immenso che l’affaire Dreyfus ha fatto alla
Francia non è, in realtà, l’essere stato l’accidente putrido, la piaga che
appare in superficie e che rivela il marciume interiore? Bisogna ritornare
all’epoca in cui il pericolo clericale faceva alzare le spalle, in cui era di
moda prendere in giro Homais, volterriano ritardato e ridicolo. Le forze
reazionarie avevano continuato a strisciare sotto il selciato della nostra
grande Parigi inando la Repubblica, contando già d’impadronirsi della città e
della Francia il giorno in cui le attuali istituzioni sarebbero crollate. Ed
ecco che l’affaire Dreyfus smaschera tutto prima che l’insabbiamento sia pronto,
ecco che i repubblicani finiscono per accorgersi che rischiano di vedersi
confiscare la loro Repubblica se non vi riportano l’ordine. Tutto il movimento
di difesa repubblicano è nato da lì, e se la Francia si salverà dal lungo
complotto della reazione lo dovrà all’affaire Dreyfus. Auspico che il governo
porti a buon fine il dovere di difesa repubblicana che ha appena invocato per
ottenere dalle Camere il voto sulla sua legge d’amnistia. E’ il solo mezzo di
cui dispone per essere finalmente coraggioso ed efficace. Ma non rinneghi
l’affaire Dreyfus, lo riconosca come il bene più grande che potesse capitare
alla Francia, e dichiari con noi che senza l’affaire Dreyfus oggi la Francia
sarebbe di sicuro nelle mani dei reazionari. Quanto alla mia questione
personale, signor presidente, io non recrimino. Sono quarant’anni che faccio il
mio lavoro di scrittore, senza inquietarmi né delle condanne né delle
assoluzioni pronunciate sui miei libri, lascio all’avvenire la cura di formulare
il giudizio definitivo. Un processo restato a metà non può dunque turbarmi
eccessivamente. È un affaire in più che la storia giudicherà. E se rimpiango la
desiderabile esplosione di verità che un nuovo processo avrebbe potuto far
scaturire, mi consolo pensando che la verità troverà ugualmente una via per
affermarsi. Eppure Le confesso che sarei stato molto curioso di sapere cosa una
nuova giuria avrebbe pensato della mia prima condanna, emessa sotto la minaccia
di generali armati della clava del terribile falso Henry. E questo non vuol dire
affatto che io abbia una grande fiducia nella giuria, così facile da sviare e da
terrorizzare in un processo puramente politico. Ciò nonostante, sarebbe stata
una interessante lezione il dibattimento che si riapriva dopo che l’inchiesta
della Corte di Cassazione aveva ottenuto la prova di tutte le accuse da me
mosse. Se lo immagina? Un uomo condannato sulla base di un falso che ritorna
davanti ai suoi giudici dopo che il falso è stato riconosciuto e confessato! Un
uomo che aveva accusato altri in base a fatti di cui un’inchiesta della Corre
Suprema ha ormai accertato l’assoluta verità! In quell’aula avrei vissuto delle
ore gradevoli, perché un’assoluzione mi avrebbe fatto piacere; e, nel caso ci
fosse stata un’altra condanna, la vile stupidità o la passione cieca hanno per
me una bellezza particolare che mi ha sempre appassionato. Ma devo essere
chiaro, signor presidente. Le scrivo unicamente per mettere fine a tutta questa
vicenda, ed è bene che io ripeta davanti a Lei le accuse che avevo esposto al
presidente Félix Faure, per stabilire definitivamente che esse erano giuste,
moderate, perfino carenti, e che la legge del suo governo ha amnistiato in me un
innocente. Ho accusato il tenente colonnello du Paty de Clam «di essere stato il
diabolico artefice dell’errore giudiziario, voglio sperare inconsapevolmente, e
di avere in seguito difeso la sua opera nefasta per tre anni attraverso le più
assurde e colpevoli macchinazioni». Per chi abbia letto il rapporto del
terribile capitano Cuignet, che al contrario si spinge fino all’accusa di falso,
mi sembra un’espressione discreta e cortese, non è vero? Ho accusato il generale
Mercier «di essersi reso complice, quanto meno per debolezza di carattere, di
una delle più grandi ingiustizie del secolo». Su questo punto faccio onorevole
ammenda e ritiro la debolezza di carattere. Ma, se il generale Mercier non ha
l’attenuante di una debole intelligenza, allora negli atti a lui ascritti che
l’inchiesta della Corte di Cassazione ha appurato e che il Codice qualifica come
criminali la sua responsabilità è totale. Ho accusato il generale Billot «di
avere le prove certe dell’innocenza di Dreyfus e di averle nascoste, di essersi
reso colpevole del crimine di lesa umanità e di lesa giustizia a scopo politico
e per salvare lo Stato Maggiore compromesso». Tutti i documenti ad oggi
conosciuti provano che il generale Billot era per forza di cose al corrente
delle manovre criminali dei suoi subordinati; inoltre aggiungo che dietro suo
ordine il dossier segreto su mio padre è stato consegnato ad un giornale
immondo. Ho accusato i generali de Boisdeffre e Gonse «di essersi resi complici
dello stesso crimine, l’uno senza dubbio per passione clericale, l’altro forse
per quello spirito di corpo che fa degli uffici della Guerra l’arca santa
inattaccabile». Il generale de Boisdeffre si è giudicato da sé all’indomani
della scoperta del falso Henry, offrendo le sue dimissioni e uscendo dalla scena
pubblica. Uscita tragica di un uomo che precipita nel nulla dopo essere stato
elevato ai più alti gradi e alle più alte funzioni: quanto poi al generale
Gonse, fa parte di coloro che l’amnistia salva dalle più pesanti e acclarate
responsabilità. Ho accusato il generale de Pellieux e il comandante Ravary «di
aver condotto un’inchiesta scellerata, intendo dire un ‘ inchiesta
mostruosamente parziale, di cui abbiamo, nel rapporto del secondo, un imperituro
monumento di ingenua audacia». Che si rilegga l’inchiesta della Corte di
Cassazione e si vedrà che la collusione è accertata e provata dai documenti e
dalle testimonianze più schiaccianti. L’istruzione dell’affaire Esterhazy non fu
che un’arrogante commedia giudiziaria. Ho accusato i tre esperti calligrafi,
Belhomme, Varinard e Couard, «di aver fatto dei rapporti falsi e fraudolenti, a
meno che un esame medico non li dichiari affetti da una malattia della vista e
della mente». Dichiaravo ciò di fronte alla straordinaria affermazione dei tre
esperti, i quali asserivano che il borderea non era stato scritto da Esterhazy;
errore che, a mio parere, un bambino di dieci anni non avrebbe commesso. Oggi
sappiamo che lo stesso Esterhazy riconosce di aver compilato il bordereau. E il
presidente Ballot Beaupré nel suo rapporto ha dichiarato solennemente che a suo
parere, non c’era nessuna possibilità di dubbio. Ho accusato gli uffici del
Ministero della Guerra «di aver condotto una campagna stampa, in particolare su
“L’Éclair” e “L’Echo d Paris”, una campagna sporca, per sviare l’opinione
pubblica e coprire la loro colpa». Non insisto; penso che la prova stia in tutto
ciò che è emerso in seguito e in quello che gli stessi colpevoli hanno dovuto
confessare. Infine, ho accusato il primo Consiglio di Guerra «di avere violato
la legge, condannando un presunto colpevole sulla base di un documento rimasto
segreto», e il secondo «di avere coperto questa illegalità, per ordine
dell’autorità, commettendo a sua volta il crimine giuridico di assolvere
coscientemente il vero colpevole». Per il primo Consiglio di Guerra, il fatto
d’avere prodotto un documento segreto è stato nettamente stabilito
dall’inchiesta della Corte di Cassazione, peraltro confermata anche al processo
di Rennes. Per il secondo è sempre l’inchiesta ad aver provato la collusione e
il continuo intervento del generale de Pellieux, nonché l’evidente pressione con
cui è stata ottenuta l’assoluzione in ossequio al desiderio dei superiori. Come
vede, signor presidente, non c’è una delle mie accuse che le colpe e i crimini
scoperti non abbiano confermato, e ripeto che queste accuse oggi appaiono assai
tenui e modeste di fronte all’agghiacciante cumulo delle infamie commesse.
Confesso che non avrei mai osato supporne una tale quantità. Allora, le chiedo,
qual è il tribunale onesto, o semplicemente ragionevole, che si coprirebbe di
vergogna condannandomi ancora, ora che la prova di tutte le mie accuse è così
chiara ed evidente? E non sembra anche a Lei, che la legge del Suo governo che
concede l’amnistia a me, innocente, insieme al branco di colpevoli che ho
denunciato, sia veramente una legge scellerata?
È dunque finita, signor presidente, almeno per il
momento, per questo primo periodo dell’affaire che l’amnistia ha chiuso
forzatamente. Come risarcimento ci promettono la giustizia della Storia. È un
po’ come il paradiso cattolico, che serve a far pazientare le vittime miserabili
strangolate dalla fame su questa terra. Soffrite, amici miei, mangiate il vostro
pane secco, dormite per terra, intanto che i felici di questo mondo dormono tra
le piume e si cibano di prelibatezze. Allo stesso modo, lasciate che gli
scellerati occupino le posizioni più alte, mentre voi, i giusti, venite spinti
nel fango. E aggiungono che, quando saremo tutti morti, ci erigeranno delle
statue. Da parte mia, voglio, e perfino spero, che la rivincita della Storia sia
più seria delle delizie del paradiso. Comunque sia, un po’ di giustizia su
questa terra mi avrebbe fatto piacere. Io non mi lamento del nostro destino
perché sono convinto che siamo quasi in porto, come si suol dire. La menzogna
non può durare all’infinito, mentre la verità, che è una sola, ha dalla sua
parte l’eternità. Così, signor presidente, il suo governo dichiara che riporterà
la pace con la legge d’amnistia, e noi dal canto nostro crediamo che prepari al
contrario nuove catastrofi. Un po’ di pazienza e si vedrà chi ha ragione.
Secondo me, non smetterò di ripeterlo, l’affaire Dreyfus non può finire finché
la Francia non saprà e non riparerà l’ingiustizia commessa. Ho detto che il
quarto atto era stato era stato recitato a Rennes, e che per forza di cose ci
sarebbe stato un quinto atto. Me ne resta nel cuore l’angoscia, ci si dimentica
sempre che l’Imperatore tedesco ha la verità tra le mani e che può sbattercela
in faccia a suo piacimento quando lo vorrà. Sarà un quinto atto agghiacciante,
che io ho sempre temuto e di cui un governo francese non dovrebbe accettarne la
spaventosa eventualità neppure per un istante. Ci hanno promesso la Storia e
anch’io rimando Lei al suo giudizio. Le riserverà una pagina dicendoci quello
che Lei avrà fatto. Pensi a quel povero Félix Faure, a quel conciatore di pelli
deificato così popolare al suo apparire, che aveva commosso perfino me con la
sua bonomia democratica: per l’avvenire sarà soltanto l’uomo ingiusto e debole
che ha permesso il martirio di un innocente. E veda se non le piacerebbe molto
di più essere ricordato sul marmo come l’uomo della verità e della giustizia.
Forse è ancora in tempo. Quanto a me, non sono che un poeta, un narratore
solitario che scrive appartato la sua opera mettendoci tutto se stesso. Ritengo
che un buon cittadino debba accontentarsi di offrire al suo Paese il lavoro che
riesce ad assolvere nel modo meno maldestro; ed è per questo che mi chiuso nei
miei libri. Ritorno dunque semplicemente ad essi, poiché la missione che mi ero
assegnato è compiuta. Ho fatto la mia parte fino in fondo, quanto più
onestamente mi è stato possibile, e rientro definitivamente nel silenzio. Devo
però aggiungere che le mie orecchie e i miei occhi rimarranno bene aperti. Sono
un po’ come suor Anna, mi preoccupo giorno e notte di quel che si profila
all’orizzonte, confesso perfino di nutrire la tenace speranza di poter vedere
presto tanta verità e giustizia avanzare verso di noi dai campi lontani dove
l’avvenire. Voglia gradire, signor presidente, l’assicurazione del mio profondo
rispetto.
Perché Zola condanna gli atti di
clemenza. L'articolo summa dell'affaire Dreyfus di
Vincenzo Vitale del 29 Agosto 2018 su "Il Dubbio". Il 14 dicembre del 1900 il
Parlamento approva una apposita legge di amnistia per tutti i reati comunque
collegati o collegabili al caso Dreyfus. Il 22 dello stesso mese Zola tuona
ancora una volta con questo articolo che, da un certo punto vista, rappresenta
una sorta di summa della sua posizione pubblica. Da questo scritto, molto
articolato, è possibile estrapolare alcuni punti che meritano adeguata
riflessione. Innanzitutto, Zola bolla l’amnistia come semplice ma terribile
manifestazione della volontà di insabbiare il caso Dreyfus. E dunque, proprio
gli organi rappresentativi del popolo francese, il parlamento e il governo,
proprio loro che avrebbero dovuto trarre un importante insegnamento, hanno
invece preferito chiudere entrambi gli occhi, insabbiando tutto nel
dimenticatoio. Insomma, quasi peggio della Grazia già elargita a Dreyfus. In
questo modo, non solo si condanna ulteriormente Dreyfus – in quanto l’amnistia
presuppone che il reato sia stato commesso e lo sia stato proprio da quegli
imputati – ma si deturpa la giustizia, umiliandola ancora una volta e
gravemente. Si persiste nello scempio del diritto e delle istituzioni
repubblicane, come nulla fosse accaduto. Questa amnistia infatti serve soltanto
a coprire, senza peraltro riuscirvi, ciò che Zola definisce il “crimine
assoluto”, la condanna, reiterata, di un innocente. E dopo la seconda
incomprensibile e grottesca condanna di Rennes, invece di ricorrere in
Cassazione – come si poteva e doveva – si preferì elargire prima la Grazia a
Dreyfus e poi l’amnistia a tutti coloro che sia pure indirettamente con il caso
avevano avuto qualcosa a che fare. La polvere sotto il tappeto. In secondo
luogo, Zola stigmatizza quanto sia illusorio ritenere che l’amnistia possa
godere di una efficacia pacificatrice delle contese asperrime nate dal caso
Dreyfus. Al contrario, essa non fa che perpetuare il disordine sociale nato da
quella vicenda, senza in realtà pacificare nessuno. Anzi. Dal momento che
l’amnistia è dettata dal senso di impotenza e di debolezza, mai potrà condurre
alla pace. Solo la giustizia feconda la pace. Non basta. Zola polemizza
intensamente con chi non perde occasione per denunciare che la vicenda Dreyfus
ha fatto molto male alla Francia, mettendone in luce mancanze e contraddizioni.
Ragion per cui sarebbe stato meglio che esso non fosse mai accaduto. Al
contrario, Zola è fermamente convinto che la vicenda di Dreyfus, per quanto
dolorosa e dotata di una grande capacità divisiva, rappresenti per la Francia
una sorta di benefica crisi di crescita e di affermazione repubblicana. Zola sa
bene insomma che prima che il caso deflagrasse con tutta la sua forza
dirompente, sotterraneamente agivano in Francia, da decenni, le forze del
militarismo, dell’antisemitismo, del nazionalismo; ma ciò accadeva in modo
pressoché silente e perciò molto pericoloso per le istituzioni repubblicane,
ancora giovani e fragili. L’esplosione del caso Dreyfus, invece, ha necessitato
di portare alla luce la posizione di tutti coloro che intendevano fare di quelle
ideologie una miscela venefica, capace di minare dall’interno la libertà e la
forza del popolo francese. Ed è noto, grazie alle osservazioni già in precedenza
fatte, che una volta che i meccanismi persecutori vengano portati alla luce,
essi si depotenziano, lasciandosi valutare per quello che in effetti sono:
persecuzione e non processo di diritto; ideologia e non verità; guerra sociale e
non pace. Paradossalmente, nonostante il suo enorme carico di dolori e di
sofferenze, il caso Dreyfus è allora servito – secondo Zola – a purificare la
Francia, a rendere noto a tutti che militarismo, nazionalismo e antisemitismo
non rappresentano che un ritorno al passato; un passato di cui la Francia non
sente il bisogno. Questo passato non va rivissuto, neppure nel ricordo. Questo
passato va seppellito definitivamente. Ne va delle sorti della Francia, per
Zola. Della stessa Europa, per noi.
Affaire Dreyfus, un caso mai chiuso. Ma
oggi esiste un nuovo Zola? Scrive Vincenzo Vitale l'1
Settembre 2018 su "Il Dubbio". Si pubblicano oggi le lettere che Dreyfus scrisse
dal carcere, alcune subito dopo il suo arresto, quando ancora nessuno poteva
lontanamente immaginare quali sviluppi avrebbe fatto registrare il caso, altre
dopo la inaspettata condanna. Ne emerge un essere umano serio, consapevole della
propria innocenza, composto e psicologicamente molto forte. E tuttavia sempre
pieno di speranza che le proprie ragioni sarebbero state prima o poi
riconosciute. Speranza riposta invano se soltanto fondata sui giudici e sui
militari. La vera speranza andava riposta invece in alcune dimensioni
irrinunciabili di ogni democrazia: la libera stampa, la libertà
dell’intellettuale, la libertà del giudizio. Non sarà mai abbastanza
sottolineata l’importanza capitale che una stampa libera da influenze e
condizionamenti è in grado di evidenziare allo scopo di salvaguardare l’assetto
di una democrazia. Non sono tanto idealista da non ammettere che ogni giornale e
ogni giornalista possano o perfino debbano avere una propria idea di politica e
di società e che, attraverso questa idea, vedranno necessariamente il mondo e ne
forniranno una interpretazione. Il problema non è questo, posto che anche i
giornalisti sono esseri umani pensanti, dotati di una precisa sensibilità, come
tutti gli altri. Il punto è che essi devono essere lasciati liberi di formarsi
una loro idea sui fatti che cadono sotto la loro osservazione e di scriverne
come ritengono, interessando quella parte di opinione pubblica che ritenga
sensate le loro prospettive. Questo fece l’Aurore di Parigi, dopo che Le Figaro
si era attestato su più prudenti posizioni filogovernative e perciò
antidreyfusarde. Ed ebbe la piena libertà di farlo. Oggi, in Italia, dopo oltre
un secolo dall’Affaire, la stampa gode della medesima libertà? Non sarei così
sicuro nel dare una risposta affermativa. Troppe volte accade che un ministro
rimbrotti un giornalista, reo di aver pubblicato una informazione sgradita; che
il potente di turno cerchi di emarginare una testata scomoda; che il Consiglio
Superiore della Magistratura si metta a strillare sol perché si metta in dubbio,
con adeguate motivazioni, la bontà di una qualche iniziativa di un pubblico
ministero. In tutti questi casi, non mi risulta che la libertà di stampa sia
stata efficacemente difesa da alcun ente o da alcuna istituzione. Semplicemente,
si preferisce far finta di nulla, lasciando che le cose vadano come devono
andare: ma chi ragiona in tal modo – un vero condensato di sciatteria del
pensiero – non sa che gioca col fuoco. Da un secondo punto di vista,
fondamentale è la libertà dell’intellettuale, cioè di colui che sia capace di
svolgere una funzione di severa critica del potere, di qualunque potere:
economico, politico, finanziario, criminale, mafioso e antimafioso, giudiziario,
editoriale, comunicativo …. Qui, il ruolo è svolto da Zola, il quale sa bene di
andare incontro allo spostamento mimetico – già segnalato – e che ne farà a sua
volta un capro espiatorio. E tuttavia, egli va ugualmente avanti, perché ne va
non solo del destino di Dreyfus e della Francia – come da lui più volte
ricordato – ma perfino della sua propria identità. E se ne ebbe mali di ogni
genere. Non solo fu condannato per diffamazione e dovette riparare a Londra; ma
fu anche personalmente calunniato in quanto di origine italiana; e lo fu anche
nella persona del padre, peraltro deceduto da tempo, in difesa della onorabilità
del quale si impegnò a scrivere diversi articoli. E resta il giallo della sua
morte. Una morte strana e su cui mai fu dissipata una qualche incertezza, per
avvelenamento di una stufa accanto alla quale si era assopito. Ci sono oggi in
Italia intellettuali come Zola? Non ne conosco. Latitano. E perciò non ci sono.
Occorre infine che sia garantita ai giudici la necessaria libertà di giudizio,
esente da pressioni di ogni genere e dall’insano desiderio di coprire gli errori
altrui, commettendone di nuovi e perciò di più gravi. Oggi i giudici italiani
sono garantiti nella loro libertà di giudizio? Non molto, a dire il vero. Anche
perché militano in senso contrario la vicinanza politica di molte forze e
soprattutto la divisione in correnti, il vero cancro della magistratura
italiana. Sicché, sembra risuoni ancora il monito espresso da Salvatore Satta
molti decenni fa, allorché notava (nei “Quaderni del diritto e della procedura
civile”) che i giudici italiani devono guardarsi, per tutelare la loro
indipendenza, proprio da quell’organo che dovrebbe tutelarla e che invece
sottilmente la insidia: il Consiglio Superiore della Magistratura. Ogni popolo
ha il suo Dreyfus, questa in fondo la lezione della storia. E non si creda che
l’affaire sia alla fine stato pacificato nella coscienza pubblica dei francesi.
Infatti, nel 1994 – appena oltre un ventennio fa – l’allora sindaco di Parigi
Chirac aveva commissionato un busto bronzeo di Dreyfus – in occasione del
centenario del caso – per collocarlo presso l’Ecoile Militaire. Ma i militari si
opposero con fermezza, dirottando la statua ai giardini delle Tuileries. Il caso
Dreyfus, per i francesi, non è ancora chiuso. E per noi?
Mia amata Lucie, urleremo la mia
innocenza fino alla fine. Pubblichiamo le lettere che
Alfred Dreyfus scrisse dal carcere alla moglie, scrive "Il Dubbio" l'1 Settembre
2018
DICEMBRE 1894. Mia amatissima, La tua lettera che
attendevo con impazienza mi ha provocato un grande sollievo e al contempo il tuo
pensiero mi ha fatto salire le lacrime agli occhi, mia amatissima. Non sono
perfetto. Quale uomo può vantarsi di esserlo? Ma quello che posso garantire è
che ho sempre seguito la via del dovere e dell’onore; non sono mai sceso a
compromessi al riguardo con la mia coscienza. Per di più, nella mia grande
sofferenza, nel più spaventoso martirio immaginabile, in questa lotta terribile
sono sempre stato sostenuto dalla mia coscienza che vegliava retta e
inflessibile. La mia riservatezza un po’ altezzosa, la libertà con cui dicevo la
mia ed esprimevo il mio giudizio, il mio essere un po’ indulgente, tutto ciò
gioca ora a mio sfavore. Non sono né flessibile, né abile, né adulatore. Noi non
abbiamo mai voluto fare visite di cortesia; restavamo appartati a casa nostra,
accontentandoci di essere felici. E oggi mi si accusa del crimine più mostruoso
che un soldato possa commettere! Ah! Se potessi mettere le mani sul miserabile
che non solamente ha tradito il suo paese, ma ha anche tentato di far ricadere
la sua infamia su di me, non so quale supplizio inventerei per fargli espiare
quello che mi ha fatto passare. Bisogna pertanto sperare che il colpevole venga
trovato. Altrimenti, se ciò non avvenisse, bisognerebbe disperare della
giustizia a questo mondo. Concentrate su questa ricerca tutti i vostri sforzi,
tutto il vostro ingegno, tutta il mio patrimonio, se necessario. I soldi non
sono niente, l’onore è tutto. Dì a M. che conto su di lui per questo compito.
Non è al di sopra delle sue forze. Debba smuovere cielo e terra, bisogna
ritrovare quel miserabile. Ti bacio mille volte quanto ti amo. Tuo devoto,
ALFRED
Mathieu Dreyfus, son frère aîné. Mille baci ai
bambini. Il mio affetto a tutti i nostri familiari e i miei ringraziamenti per
la loro devozione alla causa di un innocente.
LUNEDÌ, 11 DICEMBRE 1894. Mia amatissima, Ho
ricevuto la tua lettera di ieri, così come quella di tua sorella e di Henri.
Speriamo che ben presto mi sia fatta giustizia e che possa ritrovarmi con voi.
Con te e i nostri cari bambini, con voi tutti, ritroverò la calma di cui ho
tanto bisogno. Il mio cuore è profondamente ferito e tu puoi facilmente
comprenderlo. Aver consacrato tutta la propria vita, tutte le proprie forze,
tutta la propria intelligenza al servizio del proprio paese, e vedersi accusato
del crimine più mostruoso che un soldato possa commettere, è spaventoso. Al solo
pensiero, tutto il mio essere si rivolta e freme d’indignazione. Mi domando
ancora per quale miracolo non sia diventato folle, come la mia mente abbia
potuto resistere ad uno choc così Te ne supplico, mia amata, non assistere ai
dibattiti. È inutile che tu t’imponga ulteriori sofferenze, quelle che hai già
sopportato, con una grandezza d’animo ed un eroismo di cui sono fiero, sono più
che sufficienti. Serba la tua salute per i nostri bambini; avremo anche entrambi
bisogno di prenderci cura l’un dell’altro per scordare questa terribile prova,
la più terribile che le forze umane possano sopportare. Abbraccia forte i nostri
amati bambini per me, fintanto che non possa farlo io stesso. Vi penso tutti
affettuosamente. Ti bacio quanto ti amo. Tuo devoto, ALFRED
MARTEDÌ, 12 DICEMBRE 1894. Mia amata Lucie, Puoi
farmi da portavoce presso tutti i membri delle nostre due famiglie, presso tutti
quelli che si interessano di me, per dire loro quanto io sia stato toccato dalle
loro lettere e dalle loro testimonianze di supporto. Io non posso rispondere
loro perché cosa potrei mai raccontare? Le mie sofferenze? Possono comprenderle
da soli, e io non amo lamentarmi. D’altronde la mia mente è a pezzi e le idee
sono alle volte confuse. Solo il mio spirito resta vigoroso come il primo
giorno, davanti all’accusa spaventosa e mostruosa che mi è stata gettata in
faccia. Al pensiero tutto il mio essere si rivolta ancora. Ma la verità finisce
sempre per venire alla luce, a dispetto di tutto. Non siamo più in un secolo
dove la luce può essere offuscata. Bisognerà che la si renda totale ed assoluta,
bisognerà che la mia voce sia sentita in tutta la nostra cara Francia, come è
stato per la mia accusa. Non devo solamente difendere il mio onore ma anche
l’onore di tutto il corpo degli ufficiali di cui faccio parte e di cui sono
degno. Ho ricevuto i vestiti che mi hai inviato. Se ne hai l’occasione, potresti
inviarmi la mantellina, la pelliccia è inutile. E’ nell’armadio nell’anticamera.
Abbraccia i nostri cari per me. Ho pianto sulla bella lettera del nostro caro
Pierrot; non vedo l’ora di poterlo abbracciare, così come tutti voi. Mille baci
per te. Tuo devoto ALFRED
GIOVEDÌ, 14 DICEMBRE 1894. Mia amata Lucie, Ho
ricevuto la tua bella lettera così come delle nuove lettere dalla famiglia.
Ringrazia molto tutti da parte mia; tutte queste testimonianze di affetto e di
stima mi toccano più di quanto non sappia dire. Aver dovuto ascoltare tutto
quello che mi è stato detto, quando nella mia anima e nella mia coscienza so di
non essere mai venuto meno al mio dovere, di non aver mai commesso nemmeno la
più leggera imprudenza, è la più spaventosa delle torture morali. Dunque
cercherò di vivere per te, ma ho bisogno del tuo aiuto. Qualunque cosa avvenga
di me, bisogna assolutamente cercare la verità, smuovere cielo e terra per
scoprirla, se necessario dilapidare nell’impresa tutti i nostri soldi, al fine
di riabilitare il mio nome gettato nel fango. Bisogna lavare questa macchia
immeritata a qualunque costo. Non ho il coraggio di scriverti più a lungo.
Abbraccia da parte mia i tuoi cari genitori, i bambini, tutti quanti. Mille e
mille baci, ALFRED
Cerca di ottenere il permesso di vedermi. Penso
che non possano rifiutartelo oramai.
LUNEDÌ, 24 DICEMBRE 1894. Mia amata, Scrivo di
nuovo a te, dato che sei il solo filo che mi lega alla vita. So bene che tutta
la mia famiglia, che tutta la tua, mi amano e mi stimano; ma infine, qualora
scomparissi, il loro dispiacere, per quanto grande, finirebbe per scomparire con
gli anni. È solamente per te, mia povera cara, che ho la forza di lottare; è il
tuo pensiero che mi blocca la mano. Quanto sento, in questo momento, il mio
amore per te; non è mai stato così grande, così esclusivo. E poi, una fievole
speranza mi sostiene ancora un po’: quella di poter un giorno riabilitare il mio
nome. Ma soprattutto, credimi, se avrò davvero la forza di lottare fino alla
fine contro questo calvario, sarà unicamente per te, mia povera cara, sarà per
evitarti un ulteriore dispiacere da aggiungere a tutti quelli che hai sopportato
fino adora. Fai tutto quello che è umanamente possibile per riuscire a vedermi.
Ti bacio mille volte quanto ti amo, ALFRED
24 DICEMBRE 1894 (NOTTE TRA LUNEDÌ E MARTEDÌ). Mia
cara adorata. Ho appena ricevuto la tua lettera; spero che tu abbia ricevuto le
mie. Povera cara, come devi soffrire, come ti compiango! Ho pianto molte lacrime
sulla tua lettera, non posso accettare il tuo sacrificio. Devi restare lì, devi
vivere per i bambini. Pensa a loro prima di pensare a me; sono dei poveri
piccoli che hanno assolutamente bisogno di te. I miei pensieri mi riconducono
sempre verso di te. L’avvocato Demange, che è appena venuto, mi ha detto quanto
tu sia stata ammirevole; mi ha fatto un tuo elogio al quale il mio cuore faceva
eco. Sì, mia amata, sei impareggiabile in quanto a coraggio e devozione; vali
più di me. Ti amavo già con tutto il mio cuore e tutta la mia anima; oggi faccio
di più, ti ammiro. Tu sei certamente una delle donne più nobili su questa terra.
La mia ammirazione per te è tale che, se riuscirò a bere l’amaro calice fino
alla fine, sarà per essere degno del tuo eroismo. Ma sarà davvero terribile
subire quest’umiliazione vergognosa; preferirei trovarmi di fronte ad un plotone
d’esecuzione. Non temo la morte; non voglio il disprezzo. Qualunque cosa
avvenga, ti prego di raccomandare a tutti di alzare la testa come io stesso
faccio, di guardare il mondo in faccia senza vacillare. Non abbassate mai il
viso e proclamate la mia innocenza ad alta voce. Ora, mia amata, lascerò di
nuovo cadere la mia testa sul cuscino e penserò a te.Ti bacio e ti stringo al
cuore. ALFRED
Abbraccia forte i piccoli per me. Potresti essere
tanto buona da far depositare 200 franchi alla cancelleria della prigione?
25 DICEMBRE 1894. Mia amata, Non posso datare
questa lettera perché non so neanche a quale giorno siamo. È Martedì? È
mercoledì? Non lo so. Fa sempre notte. Appena il sonno abbandona le mie
palpebre, mi alzo per scriverti. Alle volte mi sembra che tutto ciò non sia mai
capitato, che non ti abbia mai lasciata. Durante le mie allucinazioni, tutto
quello che ci è capitato mi sembra un brutto incubo; ma il risveglio è
terribile. Non posso più credere a niente, se non che nel tuo amore,
nell’affetto di tutti i nostri cari. Bisogna sempre cercare il vero colpevole;
tutti i mezzi sono buoni. Il caso da solo non basta. Forse riuscirò a sormontare
il terrore orribile che m’inspira la pena infamante che subirò. Essere un uomo
d’onore e vedersi strappare, quando si è innocenti, il proprio onore, cosa c’è
di più spaventoso? È il peggiore tra tutti i supplizi, peggiore anche della
morte. Ah! Se arriverò fino alla fine, sarà per te, mia cara adorata, perché tu
sei il solo filo che mi lega alla vita. Come ci amiamo! Oggi soprattutto mi
rendo conto di tutto il posto che occupi nel mio cuore. Ma prima di tutto,
prenditi cura di te, occupati della tua salute. È necessario, ad ogni costo, per
i bambini, loro hanno bisogno di te. Infine, continuate le vostre ricerche a
Parigi così come laggiù. Bisogna tentare di tutto, non tralasciare niente. Ci
sono sicuramente delle persone che conoscono il nome del colpevole. Ti bacio,
ALFREDO
17.00. Sono più calmo, la tua vista mi ha fatto
bene. Il piacere di abbracciarti fisicamente e interamente mi ha fatto un bene
immenso. Non potevo più attendere per questo momento. Grazie della gioia che mi
hai donato. Quanto ti amo, mia amatissima! Infine speriamo che tutto ciò abbia
termine. Bisogna che conservi tutte le mie energie. Ancora mille baci, mia
amata, ALFRED
GIOVEDÌ, 11 DELLA SERA. Mia amata, Le notti sono
lunghe; è verso di te che mi rivolgo, è dal tuo sguardo che attingo tutte le mie
forze, è nel tuo amore profondo che trovo il coraggio di vivere. Non che la
lotta mi faccia paura, ma la sorte è stata veramente troppo crudele con me. È
possibile immaginare una situazione più spaventosa, più tragica per un
innocente? È possibile immaginare un martirio più doloroso? Fortunatamente godo
dell’affetto profondo di cui entrambe le nostre famiglie mi circondano e
soprattutto del tuo amore, che mi ripaga di tutte le mie sofferenze. Perdonami
se mi lamento delle volte; non credere affatto per questo motivo che la mia
anima sia meno vigorosa, ma persino gridare mi fa del bene e a chi altro lo
farei sentire se non che a te, moglie mia amata? Mille dolci baci per te e i
piccoli, ALFRED
MERCOLEDÌ, ORE 5. Mia amata, Voglio ancora
scriverti queste poche parole affinché tu possa trovarle domani mattina al
tuo risveglio. La nostra conversazione, anche se attraverso le sbarre della
prigione, mi ha fatto bene. Le mie gambe tremavano mentre scendevo, ma mi sono
irrigidito per non cadere a terra dall’emozione. Persino ora la mia mano non è
ancora ben ferma: il nostro incontro mi ha scosso violentemente. Se non ho
insistito affinché tu restassi più a lungo, è perché ero al limite delle mie
forze; avevo bisogno di andare a nascondermi per piangere un po’. Non credere
per questo che la mia anima sia meno vigorosa o meno forte, ma il corpo è un
po’indebolito da tre mesi di prigionia, senza aver respirato l’aria esterna. Per
poter resistere a tutte queste torture è stato necessario che io avessi una
robusta costituzione. Ciò che mi ha fatto maggiormente bene è stato di sentirti
così coraggiosa e vigorosa, così piena d’amore per me. Continua in questo modo,
moglie mia cara, imponiamo il rispetto al mondo con la nostra attitudine e il
nostro coraggio. Quanto a me, avrai notato che ero deciso a tutto; voglio il mio
onore e lo avrò, nessun ostacolo mi fermerà. Ringrazia molto tutti, ringrazia da
parte mia l’avvocato Demange per tutto quello che ha fatto per un innocente.
Riferiscigli tutta la gratitudine che provo per lui, io sono stato incapace di
esprimergliela. Digli che conto su di lui in questa lotta per il mio onore.
Abbraccia i piccoli per me. Mille baci, ALFRED
Il parlatorio è occupato domani Giovedì tra l’una
e le quattro. Dovrai quindi venire o al mattino tra le dieci e le undici o la
sera alle quattro. Ciò non avviene che di giovedì e di domenica.
IN NOME DELLO SCANDALO I GIORNALI SBEFFEGGIANO
LA VERITA’.
Si può fare giornalismo sbeffeggiando la
verità? Sempre più spesso i giornali offrono ai lettori non delle notizie, ma
dei commenti fondati sul ribaltamento delle notizie,
scrive Piero Sansonetti il 31 Marzo 2018 su "Il Dubbio". È giusto chiedere che
tra il giornalismo e i fatti realmente accaduti ci sia un qualche collegamento?
O è una fisima da vecchi, legata a un’idea novecentesca e sorpassata di
informazione? Ieri ho dato un’occhiata ai giornali – diciamo così – populisti,
quelli più vicini, cioè, alla probabile nuova maggioranza di governo, e ho avuto
l’impressione di una scelta fredda e consapevole: separiamo i fatti dalle
opinioni – come dicevano gli inglesi – ma separiamoli in modo definitivo:
cancellando i fatti, e permettendo alle opinioni di vivere in una propria piena
e assoluta autonomia dalla realtà.
Trascrivo alcuni di questi titoli, pubblicati in
prima pagina a caratteri cubitali.
Libero: «Scoprono solo ora che siamo pieni di
terroristi bastardi». (Sopratitolo, piccolino: “Retata di musulmani violenti”).
La Verità, titolo simile: «Così importiamo terroristi». Sopratitolo: “Presi i
complici di Anis Amri». Fermiamoci un momento qui. Qual è il fatto al quale ci
si riferisce? La cattura, da parte delle autorità italiane, di una serie di
persone di origine nordafricana sospettate di essere legate al terrorismo. Noi
non sappiamo se effettivamente queste persone siano colpevoli. Ogni tanto –
sapete bene vengono arrestati, o inquisiti, anche degli innocenti. E’ successo
appena una settimana fa a un tunisino, che è stato linciato (dai mass media) lui
e la famiglia prima che si scoprisse che non c’entrava niente. Ma ora non è
questo il punto. Proviamo a capire quali sono le cose certe in questa vicenda.
Che i servizi segreti italiani, o la polizia, hanno trovato dei sospetti
terroristi. Che è in corso una operazione volta a sventare attentati. Che finora
l’Italia è l’unico grande paese europeo che non è stato colpito da attentati.
Che l’Italia è l’unico paese che ha catturato diversi sospetti terroristi. Che,
tra l’altro, l’Italia è il paese che ha preso quel famoso Anis Amri (del quale
parla La Verità) e cioè l’uomo accusato di una strage in Germania. E’ sfuggito
alla polizia e agli 007 tedeschi ma non ai nostri. Punto.
Traduzione in lingua giornalistica dell’arresto di
Amri e di alcuni suoi probabili complici? “Importiamo terroristi”. Voi
penserete: li importiamo dal mondo arabo. No, dalla Germania. In Germania loro
sono liberi, qui vengono fermati.
Traduzione Invece dell’azione del governo, degli
007 e della polizia per fermare il terrorismo arabo (che ci fa invidiare da
tutti gli altri europei): «Scoprono solo ora che siamo pieni di bastardi
islamici». C’è una barzelletta famosa, che qualche anno fa fu polemicamente
raccontata ai giornalisti da Mitterrand, il presidente francese, e qualche anno
dopo da Clinton (cambiando il protagonista). In mare c’è un ragazzo che sta
affogando. Mitterrand lo vede e inizia a camminare sul pelo dell’acqua, arriva
fino a lui ormai allo stremo, con un braccio lo tira su, se lo carica sulle
spalle e lo riporta a riva. Salvandogli la vita. Tutto ciò, come avete capito,
lo fa camminando sull’acqua, e non nuotando. Il giorno dopo i giornali francesi
titolano: «Mitterrand non sa nuotare».
Mi pare che la barzelletta calzi bene e possa
essere riferita ai titoli di Libero e della Verità Il Fatto invece non si occupa
dei terroristi ma del Pd (il grado di ossessione di Libero e Verità per i
terroristi, che, come è noto, negli ultimi vent’anni hanno messo a ferro e fuoco
l’Italia, è simile al grado di ossessione del Fatto per il Pd). Titola: «Rivolta
anti- Renzi: “Basta Aventino vogliamo giocare”». La parola giocare è usata in
senso positivo: partecipare, essere attivi. La rivolta in corso sarebbe stata
avviata da Franceschini e Orlando. In cosa consisterebbe? Nel chiedere un
atteggiamento amichevole del Pd verso i 5 Stelle, in contrasto con Renzi che
invece vuole che il Pd resti all’opposizione. Dopodiché uno legge l’articolo del
direttore, cioè di Travaglio, e scopre che Orlando e Franceschini se ne stanno
in realtà zitti zitti e rintanati. E per questo Travaglio li rimprovera. Cioè li
rimprovera proprio per non aver dato il via ad alcuna rivolta, che invece
servirebbe. E servirebbe allo scopo di bloccare l’Aventino e di spingere il Pd
ad una scelta simile a quella dei socialdemocratici tedeschi, i quali hanno
chiamato i loro elettori ad un referendum interno per avere il permesso di
collaborare con la Merkel. Travaglio dice che il Pd deve fare la stessa cosa.
Però ci sono due imprecisioni, nel ragionamento. La prima è che il Pd non ha
scelto l’Aventino, ma l’opposizione. Sono due cose molto, molto diverse.
L’Aventino (cioè il ritiro dei propri deputati dal Parlamento) fu scelto dai
socialisti e dai liberali, dopo l’assassinio di Matteotti (segretario del Psi).
Socialisti e liberali, guidati da Giovanni Amendola, decisero di disertare il
parlamento per delegittimarlo e dunque delegittimare il fascismo. I comunisti
(guidati da Gramsci) fecero una scelta diversa. Dissero: restiamo dentro a
combattere. Cioè rifiutarono l’Aventino e scelsero l’opposizione. In realtà andò
male a tutti e due: il fascismo non fu delegittimato da Amendola e Turati né
fermato da Gramsci, e finì per fare arrestare sia i socialisti sia i comunisti.
Ma che c’entra tutto questo con l’attuale situazione? Niente. Qualcuno forse
pensa – o ha detto che il Parlamento non è legittimo, e che le elezioni non
valgono, e che i vincitori non sono legittimati a governare? Hanno detto tutti
l’esatto contrario.
Quanto all’alleanza tra Merkel e Spd è una
alleanza che è impossibile paragonare a una possibile alleanza tra 5 Stelle e
Pd. La Spd ha accettato di sostenere la Merkel esattamente con l’idea opposta a
quella di Travaglio: e cioè per sbarrare la strada ai populisti. La Merkel e i
socialdemocratici hanno già governato insieme e dunque non solo affatto
incompatibili. Ma lasciamo stare la polemica politica, nella quale,
effettivamente, è ovvio che le opinioni prevalgano su tutto. Restiamo nel campo
del giornalismo. La domanda che mi tormenta è sempre la stessa: il giornalismo
moderno ha bisogno dei fatti, delle notizie vere, delle verifiche, della
somiglianza con la realtà, o invece si è trasformato in una specie di nuovo
genere letterario, basato sulla fantasia, e volto esclusivamente a costruire
polemiche politiche o culturali e ad influenzare, indirizzare, spostare
l’opinione pubblica?
Naturalmente nel giornalismo c’è stata sempre
questa componente e questa aspirazione: di influenzare lo spirito pubblico. In
tutte le attività culturali c’è questa aspirazione. Anche nella pittura, anche
nel cinema. Però, fino a qualche anno fa, il giornalismo aveva – come la
fotografia – la caratteristica di essere una attività intellettuale legata
strettamente alla realtà, e il cui grado di autorevolezza si misurava
esclusivamente valutando la sua vicinanza alla verità. Sempre meno è così. I
giornali populisti vengono confezionati con un metodo che si fonda sul disprezzo
per la realtà. La loro forza è direttamente proporzionale alla lontananza dalla
realtà. Gli altri giornali oscillano, tentati dai vecchi valori e dai vecchi
schemi del giornalismo europeo e americano, ma alla fine rassegnati a inseguire
Vittorio Feltri. In dieci anni – cifra approssimativa – il giornalismo italiano
ha completamente cambiato faccia. E le possibilità per i cittadini di essere
informati si è enormemente ridotta. Dobbiamo prenderne atto e basta? Cioè
considerare il divorzio tra giornalismo e verità e la sua trasformazione in
genere letterario fantasioso, come un’inevitabile conseguenza della modernità?
Se è così però bisognerà trovare qualche altro modo per informare e informarsi.
La ricerca di questo nuovo modo dovrebbe essere la preoccupazione principale dei
politici e degli intellettuali. E anche dei tantissimi giornalisti che sono
stati tagliati fuori da questa nuova tendenza. La preoccupazione principale:
perché nessuna democrazia può sopravvivere, senza una informazione decente.
De Rita: «Dove nasce l’odio? Nasce lì,
nei giornali…». Intervista di Francesco Lo Dico del 19
Dicembre 2017 su "Il Dubbio". La riflessione sull’odio portata avanti dal nostro
giornale, dopo l’iniziativa del Cnf per il G7 dell’avvocatura, continua con
l’intervista al fondatore del Censis, Giuseppe De Rita, che proprio di recente
ha parlato della società del rancore. «Chi non conosce la verità è uno sciocco,
ma chi conoscendola la chiama bugia, è un delinquente», amava ripetere Bertolt
Brecht. Un adagio che ben si accompagna ai trombettieri delle fake news e ai
mestatori in servizio permanente effettivo nelle sentine dei social. Dalla
testata di Spada a Ostia alle testate che ogni giorno si abbattono, non meno
spregevoli, sulla dignità di cose e persone, è stato un crescendo. L’onda
anomala del disprezzo ha travolto istituzioni, ong, calciatori. Ma anche
migranti, donne, star e politici stessi, al di là di ogni ragionevole dubbio, e
spesso in direzione ostinata e contraria alla verità delle cose. Così che
l’iniziativa lanciata a settembre dal Consiglio nazionale forense contro il
linguaggio dell’odio, sembra aver assunto – di linciaggio in linciaggio – il
carattere di una premonizione. Di quel clima violento segnalato tre mesi fa dal
Cnf al G7 dell’avvocatura, e combattuto con vigore su queste pagine da
autorevoli interlocutori, l’Italia del rancore descritta di recente dal Censis
appare la cartina di tornasole. Tanto che Giuseppe De Rita, fondatore e
presidente del Centro studi che da più di mezzo secolo racconta il Paese, tiene
a riconoscere al Dubbio un impegno costante ma solitario. «È l’unico giornale
italiano – sottolinea il sociologo – che combatte l’odio e la deriva
giustizialista che trionfano invece sul resto dei quotidiani nazionali, a colpi
di titoloni e mostri in prima pagina che durano il tempo di un giorno, servono a
fare qualche spicciolo in più, ma rovinano per sempre la vita agli sfortunati
protagonisti della gogna».
Presidente, perché l’Italia e i giornali che
oggi ben la rappresentano, è diventata la terra del risentimento?
«Le ragioni che
lo spiegano sono molteplici. Ma in primo luogo, si può ben dire che l’Italia del
rancore descritta nel nostro rapporto è figlia di un incidente storicamente
provato. Dopo aver garantito a milioni di persone prospettive di vita migliore
negli anni 70, 80 e 90, il nostro ascensore sociale si è bloccato. Così che
moltissimi italiani sono rimasti sospesi a mezza strada: non raggiungono il
prestigio sociale che desiderano, non diventano qualcuno, e nonostante studi e
sacrifici non hanno stipendi migliori né promozioni in vista. E questo li rende
frustrati e risentiti: il rancore collettivo è il lutto per quel che non è stato».
Anche i lutti più dolorosi non durano per
sempre: l’Italia può uscire dalla rabbia e dalla rassegnazione?
«Il ciclo
formidabile che per cinquant’anni ha garantito al Paese un certo grado di
benessere si è concluso. Di fronte alla crisi, l’eredità di quella stagione
prospera ci ha consentito di resistere ma al prezzo di vedere congelata la
nostra condizione. Da tempo siamo entrati in una fase transitoria, che può
essere superata soltanto con un cambio di prospettiva deciso. Un nuovo paradigma
in grado di rompere le molte inerzie che hanno fermato l’ascensore sociale:
l’inerzia dell’economia sommersa, l’inerzia delle piccole e medie imprese,
l’inerzia del ceto pubblico e dell’urbanizzazione della popolazione».
Eppure la ripresa economica, seppure di entità
modesta, è stata finalmente riagganciata da un anno a questa parte. Perché
ancora non riesce a tradursi in benefici concreti per la nostra società?
«È molto
semplice: la nostra è una ripresa per pochi, trainata da pochi. Ne sono
protagoniste alcune medie imprese manifatturiere, realtà di respiro
internazionale legate alla logistica e industrie vocate all’export che hanno
tirato a ritmo indiavolato anche grazie agli specifici incentivi dell’Industria
4.0. Ma in parallelo, è stato fatto molto poco per far ripartire le botteghe
dietro l’angolo. Il mercato interno, decisivo per le sorti della maggioranza
degli italiani, non ha ripreso slancio. Invece di prenderla di petto, la
questione è stata presa di sguincio grazie ai bonus per casalinghe e dipendenti
che non hanno funzionato: la maggior parte degli italiani, insomma, non è
tornata a sorridere ed è perciò rimasta rancorosa».
È forse questo il limite che non ha premiato
l’azione del governo Renzi. C’è un problema di errata percezione politica,
dietro l’odio che alimenta la grancassa delle forze populiste?
«Il problema di
questi ultimi anni è evidente. Prima di agire, chi governa dovrebbe capire quali
sono le attese. Ma la politica ha fatto l’esatto contrario. Prima ha fatto gli
interventi, e poi li ha comunicati nell’idea che, se venivano presentati bene,
andassero incontro ai desideri della gente. Dire che hai dato tanti soldi ma che
la campagna di comunicazione non ha funzionato, è un suicidio mediatico e
intellettuale. Significa ammettere che dietro le misure non c’era una strategia
lungimirante di rilancio, ma solo l’idea che per scatenare la ripresa dei
consumi bastasse la propaganda».
E invece si è scatenata ancora di più la rabbia
sociale che trova nel linguaggio dell’odio di Lega e Cinque Stelle.
«L’ascesa delle
forze populiste non è recente. La forza del rancore si è accresciuta negli
ultimi dieci anni, quando l’opinione pubblica ha scelto di montare sul cavallo
dell’anti- casta, a prescindere da ragioni di appartenenza politica. Non si
tratta più di attaccare la casta per motivazioni ideologiche come accadeva negli
anni 50, o in funzione di una strategia economica come avveniva al tempo delle
liberalizzazioni di Berlusconi e di Bersani. Contro la casta si è scatenato un
odio cieco e totalizzante, che ha unificato i risentimenti di tutti gli
indignati e ha fatto perdere di vista i veri problemi che alimentano
l’insoddisfazione».
Dice quindi che chi oggi miete consensi
sull’odio per gli avversari politici, per i migranti, per le riforme domani non
sarà capace di placare al governo il risentimento sul quale hanno lucrato?
«Dico che fare
politica in nome della semplice idea di abbattere i privilegi è inutile e
illusorio: la storia insegna che abbattuta una casta, ne arriva subito un’altra.
Il problema del Paese non è nella casta, ma nella classe dirigente che oggi è
priva di professionalità e strategia, non ha il senso del futuro e non è
all’altezza dei suoi compiti. Tolta di mezzo la casta, la classe dirigente resta
quella che è. Ecco perché sostenevo poc’anzi che per uscire dalla spirale
dell’odio occorre un ciclo, anche breve, di radicale rinnovamento».
E come si potrebbe, dato il generale scadimento
che descrive?
«La politica
non è un’arte. La politica è un mestieraccio. Ed è proprio degli odiati
mestieranti che ha bisogno prima di tutto. Bisogna ridare spazio a chi ha fatto
gavetta nei comuni e nelle sezioni di provincia, riaprire le porte a chi il
mestiere lo conosce davvero. Ricordo ancora quello che gridava nelle stanze l’ex
ministro Francesco Compagna: “Ladri li vogliamo, ma bravi!”».
È un tema che ci porta dritti a un’altra
variazione sul tema dell’odio. Non è stata forse la furia giustizialista di
Tangentopoli a innescare un simmetrico populismo penale che oggi dai tribunali
irrompe sui giornali e sui social?
«Non sono, come
è noto, un nemico dei giornali. Ma devo dire che ci sono ampie responsabilità
dei giornalisti, dietro la cultura della politica poliziesca che ha scelto come
agenda quotidiana il casellario giudiziario. Molti procuratori coltivano
rapporti privilegiati con certa carta stampata, nella banale necessità di
mostrare la sera, agli altri soci dei loro Rotary club, di aver fatto qualcosa
di importante di cui sui giornali si parla in termini allarmanti. Ai giornalisti
del Dubbio va tuttavia il mio attestato di stima: sono i paladini solitari di
un’inversione di tendenza che richiede coraggio. Per ristabilire l’equilibrio di
giudizio, occorre che i giornali si impongano di rinunciare a qualche copia, in
nome di valutazioni più approfondite e intellettualmente oneste».
L’odio e la sproporzione sono dunque gli
effetti collaterali di pure strategie commerciali, o c’è anche una matrice
culturale dietro la deriva giustizialista?
«Quante volte
leggiamo che Tizio rischia cinque anni di carcere, salvo poi svanire nel nulla
il giorno dopo insieme alla storia allarmante di cui è il temibile protagonista?
Il problema che affligge i nostri quotidiani è la smania del titolo, la logica
pervasiva dell’evento. Lo aveva capito bene uno dei nuovi filosofi francesi,
Jean Baudrillard. “L’evento – diceva – scava la fossa in cui verrà seppellito il
giorno dopo”. Ed è proprio così. L’evento prende per un giorno tutto lo spazio
possibile, poi il giorno dopo viene sepolto e nessuno se ne occupa più. Quella
dei giornali è una catena di eventi che costruisce una storia evenemenziale, e
cioè una storia fatta di eventi, che ha un’ottica parziale. La storia non è
fatta solo di eventi. È fatta anche da processi lenti, commerciali, tecnologici,
religiosi che nessuno sembra aver più voglia di indagare. È per questa ragione
che in prima pagina non finiscono i fatti, ma le cose che hanno fatto “evento”.
Per il giornalista è una tentazione, una coazione, quasi un obbligo. La
necessità di “fare evento” alimenta ogni giorno nuovo risentimento: l’Italia del
rancore».
L’Italia del rancore ha trovato nei social la
sua più intensa e preoccupante bocca di fuoco: insulti e atti di sciacallaggio
rivolti allo zimbello di turno diventano su Twitter trending topic, salvo poi
scomparire nel nulla sostituiti da raffiche di mitra verso il prossimo
obiettivo.
«Nel rapporto
del Censis lo abbiamo scritto chiaramente: i social sono l’arena del rancore, il
Colosseo del rancore, il circo equestre del rancore. Ma allo stesso tempo
osservo che i tweet indignati scompaiono nel nulla dopo pochi minuti. In fondo
milioni di cinguetti che spariscono ogni giorno indicano che non servono a
niente e a nessuno, se non alla piattaforma che li ospita. Il problema vero non
sono i social, ma la società che li popola. Che probabilmente, tweet dopo tweet
comincerà a capire quali “eventi” vale davvero la pena discutere, e quali sono
invece montati ad arte per fare discutere. Io credo che valga per i social la
stessa parabola che ha accompagnato i talkshow: prima hanno spopolato, poi sono
diventati marginali perché sono diventati noiosi. Tutti hanno capito che erano
piccoli spettacoli da cui non usciva niente di utile per la società e la
politica».
Spesso però escono dai palinsesti social cose
false e molto dannose che arrecano danni duraturi e riescono a influenzare la
politica stessa, come dimostra il caso delle ultime elezioni negli Stati Uniti.
Che idea si è fatto delle fake news, che ormai convogliano molti rancori anche
nella Penisola?
«È un fenomeno
recente, di cui confesso di non essermi ancora fatto un’idea precisa. Sono però
allo stesso tempo convinto che, da Biden a Renzi, l’argomento è stato finora
trattato in modo confuso, e forse anche strumentale. Nutro per l’argomento delle
bufale una certa resistenza psicologica. Ho il sospetto che, ancora una volta,
quello delle fake news sia un “evento”, un argomento alla moda che come molti
altri è destinato a finire nel nulla cosmico dei tweet perduti. Io credo che i
social siano la patria del rancore, e che questa patria sia stata fondata dal
“vaffa”. Ma credo anche che l’Italia del rancore non sia destinata a durare
ancora per molto».
Nordio: «Così i magistrati hanno scalato
il potere politico». Intervista di Giulia Merlo del 20
Dicembre 2017 su "Il Dubbio". «A partire da Mani Pulite si è instaurato un
intreccio perverso tra pm e stampa: i pm facevano filtrare notizie e in cambio
ricevevano elogi. Oggi la conseguenza è che, servendosi di questo prestigio,
molti sono entrati in politica». Chiaro e diretto, da sempre è considerato
eretico dai suoi stessi colleghi. Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di
Venezia, analizza a tutto campo il cortocircuito tra poteri e non lesina
stilettate a una politica «che ha ceduto le armi» a una magistratura «che si è
servita della stampa per ottenere la fama ed entrare in politica».
Procuratore, il processo mediatico è una
patologia di questo tempo di crisi?
«Tutt’altro. Il
processo mediatico c’è sempre stato a partire dal dopoguerra: penso all’omicidio
di Wilma Montesi, che è stato il primo caso di interferenza delle indagini a
fini politici, perchè il processo era stato montato a bella posta per colpire
l’onorevole Piccioni. Questa strumentalizzazione, tuttavia, ha assunto la forma
di ordinaria patologia con Tangentopoli».
Come è fatto questo virus che ha contagiato il
nostro sistema giudiziario?
«Con Mani
pulite si è instaurato un intreccio perverso tra magistratura inquirente e
stampa. Gli inquirenti avevano canali privilegiati con alcuni giornali, ai quali
facevano filtrare le notizie più succulente per fargli fare degli scoop. In
cambio, questi pm ricevevano una serie di sperticati riconoscimenti elogiativi
che li rendevano a loro volta più credibili, prestigiosi e forti. Così si è
generato un potenziamento reciproco: più il magistrato era forte e più si
sentiva impunito se lasciava filtrare le notizie, più le lasciava filtrare e più
si rafforzava perchè riceveva in cambio una legittimazione da parte della
stampa. Tutto questo ha portato a un cortocircuito che non solo ha condizionato
la politica, ma ha anche alterato la fisiologia della giustizia e della stampa».
Parliamo di un cortocircuito iniziato
venticinque anni fa. E oggi?
«Ora ne stiamo
pagando le conseguenze, la più perniciosa delle quali è che una serie di
magistrati, servendosi del prestigio e della fama acquisiti attraverso gli elogi
della stampa, sono entrati in politica».
L’ultimo dei quali oggi è a capo di un partito
politico, il presidente del Senato, Piero Grasso.
«Di Grasso io
critico la scelta fatta ormai cinque anni fa: si è candidato alle elezioni
politiche poche ore dopo essere uscito dalla magistratura. Ecco, poichè non
credo che una candidatura si improvvisi nel giro di poche ore, questo significa
che mentre indossava la toga ha avuto dei contatti politici».
Lei ritiene che un magistrato non dovrebbe fare
politica?
«Intendiamoci,
è perfettamente legittimo che lo faccia, ma secondo me è un elemento di disturbo
nei rapporti fisiologici tra poteri. Un magistrato che indossa la toga può avere
tutte le opinioni politiche che vuole e ha il diritto di esprimerle anche sui
giornali, ma non trovo opportuno che abbia contatti diretti con la politica al
fine di procurarsi una candidatura».
E un magistrato che ha smesso la toga, invece?
«Nemmeno,
soprattutto se quel magistrato ha condotto inchieste che hanno avuto un forte
impatto politico. Se si candida, infatti, si espone al rischio che le sue
inchieste siano considerate un mezzo per procurarsi una sorta di buen
retiro politico. Parlo per me: ho condotto l’inchiesta sul Mose che ha demolito
la classe dirigente veneta. Troverei raccapricciante il solo sospetto che si
possa pensare di me che ho fatto un’inchiesta per prendere il posto di chi ho
mandato in galera. Per questo un magistrato non dovrebbe candidarsi, nemmeno
dopo essere andato in pensione».
Da vittima, la politica si è innamorata dei
carnefici. Non si contano i magistrati candidati, sia a destra che a sinistra.
«Con la caduta
delle ideologie e la fine dei partiti di massa, la classe politica ha perduto
completamente la fiducia in se stessa e, davanti all’offensiva giudiziaria, si è
definitivamente sgretolata. Così ha cercato rifugio in quelli che sembravano i
rappresentanti più significativi del Paese, cioè i magistrati».
Lei ha fissato nella legge Biondi del 1994 il
momento storico in cui la politica ha definitivamente ceduto il passo alla
magistratura.
«I quattro pm
di Mani pulite andarono in televisione, chiedendo il ritiro del decreto e
minacciando le dimissioni. Allora un politico serio avrebbe dovuto rispondere:
«Cari pm, avete diritto di critica perchè non siete giudici terzi, per questo da
domani separiamo le carriere. Inoltre, manteniamo il decreto e aspettiamo le
vostre dimissioni». Invece la politica ha ceduto le armi. Da quel momento è
finito tutto: quando un potere lascia un vuoto così clamoroso qualcuno lo occupa
e così ha fatto la magistratura».
Intravede la possibilità di una inversione di
tendenza?
«Dopo tanti
anni di patologica regressione di campo da parte della politica non è facile
ristabilire gli equilibri. lo mostra il fatto che, ogni volta che si propone una
legge che incide sui poteri dei magistrati, l’Anm insorge e il Governo fa marcia
indietro. L’unica soluzione si potrebbe trovare a livello costituzionale,
rivedendo il reclutamento dei magistrati e il funzionamento del Csm, ma
revisione non è cosa facile».
L’ordinamento non contiene già i limiti tra
poteri?
«Per ricondurre
in alveo costituzionale tutti i poteri dello Stato andrebbe attuato al 100% il
codice penale accusatorio, un codice garantista e anglosassone che è stato
attuato solo per il 20% e poi demolito dalla stessa Corte Costituzionale».
E’ una crisi ormai fisiologica e non
risolvibile, quindi?
«Guardi,
l’unica speranza è il ricambio generazionale, in magistratura come in politica.
Questo, mi sembra, sta già avvenendo».
Tutto di lei si può dire, meno che non sia
diretto. Quanto le sono costate queste posizioni in contrasto con le idee
dominanti in magistratura?
[Ride di gusto ndr] «Io non ho mai cambiato
idea e ciò che dico oggi l’ho scritto in un libro del 1997. La mia eresia di
allora mi costò la chiamata davanti ai probi viri di Anm: io ci risi sopra e
nemmeno mi presentai».
Lei, però, rimane una mosca bianca quando parla
di separazione delle carriere e di magistrati in politica.
«Le assicuro
che oggi molti magistrati la pensano come me, ma non tutti hanno poi il coraggio
di dirlo perchè entrerebbero in conflitto col pensiero dominante dell’Anm che,
attraverso il Csm decide le sorti professionali. Eppure, oggi la separazione
delle carriere non è più il tabù che era vent’anni fa e lo stesso vale per la
necessità di paletti più incisivi per l’ingresso dei magistrati in politica. Del
resto ormai si è deideologizzato tutto, non vedo perchè lo stesso non possa
accadere anche con gli ultimi pachidermici miti dell’Anm».
Ma esiste una magistratura di destra e una di
sinistra?
«Io sono
convinto che la giustizia risponda a criteri di buon senso e la distinzione
destra- sinistra sia estremamente ingannevole su questo piano».
Lei è in pensione da un anno, le manca la toga?
«Mi mancano le
amicizie che si sono un po’ diradate, ma non il lavoro. Mi piace leggere,
scrivere, andare a cavallo e ascoltare musica classica e ora ho finalmente il
tempo per farlo».
Guardandosi indietro, però, sceglierebbe ancora
il lavoro di magistrato?
«Io non ho mai
vissuto la magistratura come una missione o un sacerdozio. Anzi, diffido molto
dei magistrati che vivono così il loro ufficio, perchè il sacerdozio rischia di
sconfinare nel fanatismo. Per me, però, è sempre stata una funzione centrale per
la democrazia: dopo il medico che incide sulla salute c’è il magistrato che
incide sulla dignità e sull’onore del cittadino. Ecco, per questo sono
orgoglioso di aver indossato la toga e rifarei senza dubbio questa scelta».
«Il compito della magistratura?
Sottomettere la politica», scrive Piero Sansonetti il
6 Settembre 2017 su "Il Dubbio". Ho letto con molto interesse – e qualche
apprensione… – il resoconto stenografico degli interventi del procuratore
generale di Palermo, Roberto Scarpinato, e del sostituto procuratore della Dna
(Direzione nazionale antimafia) Nino Di Matteo, pronunciati qualche giorno fa
alla festa del Fatto Quotidiano, in Versilia. Li ha pubblicati ieri proprio
il Fatto considerandoli, giustamente, documenti di grande interesse
giornalistico e politico. Potrei scrivere per molte pagine, commentandoli. Mi
limito invece a pochissime critiche e soprattutto a una osservazione (alla
quale, contravvenendo a tutte le regole del giornalismo, arriverò alla fine di
questo articolo) che mi pare essenziale. Essenziale per capire l’Italia di oggi,
per decifrare il dibattito pubblico, e per intuire a quali pericoli sia esposta
la democrazia. Innanzitutto voglio subito notare che sebbene il Fatto pubblichi
i due interventi, intervallando brani dell’uno e brani dell’altro, quasi fossero
un unico discorso, si nota invece una differenza, almeno nei modi di
esposizione, molto netta. Roberto Scarpinato dà l’impressione di avere una
conoscenza approfondita dei fatti e anche della storia (italiana e
internazionale) nella quale vanno inquadrati. Nino Di Matteo sembra invece
soprattutto travolto da una indubbia passione civile, che però lo porta a scarsa
prudenza, sia dal punto di vista formale sia nella ricostruzione storica.
La tesi di fondo dei due interventi però è
un’unica tesi. La riassumo in cinque punti. Primo, la mafia nel 1992, dopo la
caduta del muro di Berlino, decise di intervenire nella politica italiana perché
terrorizzata dall’idea che – finite le ideologie e i veti, e il famoso fattore K
che escludeva i comunisti dal governo – potesse prendere il potere una
coalizione composta da sinistra democristiana (ex zaccagniniana) ed ex Pci,
all’epoca Pds. «Condannare i criminali? No, il compito della magistratura è
sottomettere la politica».
Secondo punto, in questa ottica, dopo le stragi
del 1993, si svolse una trattativa tra lo Stato e la mafia e questa trattativa,
pare di capire, coinvolse essenzialmente elementi dell’ex sinistra dc (Mancino,
Mannino, forse De Mita) e dell’ex Pci (Giorgio Napolitano).
Terzo punto, è stato proprio Giorgio Napolitano a
delegittimare il processo sulla trattativa tra Stato e mafia che si sta
spegnendo a Palermo tra assoluzioni e prove mancate: e la cattiva sorte di quel
processo è da imputare non a una cattiva impostazione delle indagini e delle
tesi di accusa, ma all’intervento dell’allora capo dello Stato.
Quarto, la mafia da allora ha cambiato pelle, ha
rinunciato ad usare la violenza e l’omicidio per condurre la sua strategia, e
questo la rende ancora più pericolosa, perché riesce a crescere semplicemente
usando lo strumento della corruzione e addirittura, in certe occasioni, senza
neppure commettere reati formali.
Il quinto punto lo accenno appena, perché ci
torniamo alla fine – è il punto chiave – riguarda il compito e la missione della
magistratura.
Naturalmente i primi quattro punti sono in forte
contraddizione l’uno con l’altro. Ad esempio non si capisce come facesse la
mafia, quando ha iniziato l’attacco allo Stato (che Scarpinato e Di Matteo
datano con l’uccisione di Salvo Lima del marzo 1992), a prevedere il crollo del
potere politico italiano, che allora era ancora saldamente nelle mani del
pentapartito, e non certo del Pci, che viveva un nerissimo periodo di crisi.
Nessun analista politico previde Tangentopoli (neppure dopo l’arresto di Mario
Chiesa) che esplose clamorosamente dopo l’uccisione di Falcone, né tanto- meno
le conseguenze di Tangentopoli, eppure l’attacco della mafia iniziò prima di
Tangentopoli. E non si capisce molto bene neanche perché la mafia uccidesse Lima
( destra Dc), e poi Falcone ( che era legato ai socialisti di Craxi) se voleva
colpire la sinistra Dc e l’ex Pci, che di Lima e Falcone erano nemici; né si
capisce perché furono Napolitano e Mancino ( ex Pci e sinistra dc) ad aiutare la
mafia che era terrorizzata – se capiamo bene – perché temeva che Napolitano e
Mancino andassero al potere…Fin qui, diciamo con un po’ di gentilezza, è solo un
bel pasticcio, che certo non si regge in piedi come atto d’accusa. Né
giudiziario, né politico, né tantomeno storico. E si capisce bene perché il
processo Stato- mafia stia finendo a catafascio. Scarpinato e Di Matteo da
questo punto di vista hanno avuto la fortuna di parlare, in Versilia, ad una
platea amica che non aveva nessuna voglia di fare obiezioni (così come, in
genere, non ne ha quasi mai il giornalismo giudiziario, e non solo, italiano).
Ma il punto che mi interessa trattare è il quinto.
L’idea di magistratura che – temo – va affermandosi in un pezzo di magistratura.
Cito alcuni brani, testuali, di Di Matteo, che sono davvero molto istruttivi. In
un crescendo. «Oggi si sta nuovamente (sottinteso, la politica, ndr) mettendo in
discussione l’ergastolo, l’ergastolo ostativo, cioè l’impossibilità, per i
condannati per mafia, di godere dei benefici. Si sta cominciando a mettere in
discussione, attraverso anche, purtroppo, un sempre più diffuso lassismo
nell’applicazione, l’istituto del 41 bis, il carcere duro (….)». E più avanti:
«I fatti sono fatti, anche quando vengono giudicati in sentenze come non
sufficienti per condannare qualcuno… Adesso la partita è questa: vogliamo una
magistratura che si accontenti di perseguire in maniera efficace i criminali
comuni (…) o possiamo ancora aspettarci che l’azione della magistratura si
diriga anche nel controllare il modo in cui il potere viene esercitato in
Italia? Questa è una partita decisiva per la nostra democrazia». La prima parte
di questo ragionamento è solo la richiesta di poteri speciali, non nuova, tipica
del pensiero reazionario (e non solo) da molti anni. In realtà i magistrati
prudenti sanno benissimo che il 41 bis è carcere duro (e dunque è in contrasto
aperto e clamoroso con la nostra Costituzione) ma stanno attenti a non usare mai
quella definizione. Quando, intervistando qualche magistrato, ho provato a dire
che il 41 bis è carcere duro, sono sempre stato contestato e rimproverato
aspramente: «Non è carcere duro – mi hanno detto ogni volta – è solo una forma
diversa di detenzione…». Di Matteo, lo dicevo all’inizio, è trascinato dalla sua
passione civile (che poi è la sua caratteristica migliore) e non bada a queste
sottigliezze, dice pane al pane, e carcere duro al carcere duro. Non so se
conosce l’articolo 27 della Costituzione, probabilmente lo conosce ma non lo
condivide e non lo considera vincolante. Così come non considera vincolante
l’esibizione delle prove per affermare una verità, e questo, da parte di un
rappresentante della magistratura, è un pochino preoccupante. Quel che però più
colpisce è la seconda parte del ragionamento. E cioè le frasi che proclamano in
modo inequivocabile che il compito della magistratura è mettere sotto controllo
la politica (sottometterla, controllarla, dominarla, indirizzarla), cancellando
la tradizionale divisione dei poteri prevista negli stati liberali, e non può
ridursi invece a una semplice attività di giudizio e di punizione dei crimini.
E’ probabile che siano pochi i magistrati che commettono la leggerezza di
dichiarare in modo così chiaro ed esplicito la loro idea di giustizia, del tutto
contraria non solo alla Costituzione ma ai principi essenziali del diritto; però
è altrettanto probabile che il dottor Di Matteo non sia il solo a pensarla in
questo modo. E siccome è anche probabile che esista una vasta parte del mondo
politico, soprattutto tra i partiti populisti, ma anche nella sinistra, che non
disdegna le idee di Di Matteo, e siccome non è affatto impossibile che questi
partiti vincano le prossime elezioni, mi chiedo se esista, in Italia, il rischio
di una vera e propria svolta autoritaria, e antidemocratica, come quella
auspicata da Di Matteo – non so se anche da Scarpinato – o se esita invece una
tale solidità delle istituzioni e dell’impianto costituzionale da metterci al
sicuro da questi pericoli.
I “Due stupri due misure” di Travaglio:
ma qualcuno gli ha mai spiegato il Codice Penale? Mai
una sua vera inchiesta giornalistica, mai un’indagine, che abbiano fatto
scaturire l’azione penale della magistratura. Solo e soltanto fotocopie e
salotti televisivi alla conquista di una visibilità. Senza disdegnare le aule di
giustizia per i vari processi penali e civili subiti. Dimenticando di raccontare
quelli che perde…scrive Antonello de Gennaro il 12 settembre 2017 su "Il
Corriere del Giorno". A volte mi chiedo se Marco Travaglio abbia veramente il
coraggio di credere nelle sue teorie astruse. Travaglio come ben noto ha una sua
personalissima visione delle cose, che in qualcosa mi ricorda l' “affarismo”
giornalistico editoriale di Vittorio Feltri, che chiede agli editori la
percentuale sulle copie vendute in edicola. Questa è la seconda volta che mi
tocca giornalisticamente occuparmi di lui. Il “Marchino” ha passato un’intera
vita da “gregario”, ad acquisire e fotocopiare atti processuali,
intercettazioni, interrogatori ecc. necessari a confezionare i suoi libri
enciclopedici, firmando praticamente quasi tutti i suoi libri con il
collega Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it. Travaglio è diventato
ben noto a tutti negli ultimi anni solo e soltanto grazie alla visibilità
televisiva offertagli da Michele Santoro, che stato il vero responsabile dell'
“esplosione” dell’arroganza travagliana, ma intelligentemente negli ultimi
tempi Santoro ha interrotto i contatti, uscendosene persino dagli accordi
societari con il Fatto raggiunti tempo addietro. Mai una sua vera inchiesta
giornalistica, mai un’indagine, che abbiano fatto scaturire l’azione penale
della magistratura. Solo e soltanto fotocopie per i suoi libri, e onnipresenza
nei salotti televisivi alla conquista di una visibilità. Senza disdegnare le
aule di giustizia per i vari processi penali e civili subiti. Dimenticando
chiaramente di raccontare quelli che perde…come per esempio quello davanti
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo. Oggi Travaglio (insieme
al suo fedele “scudiero” Marco Lillo), non sa più a che santo votarsi dopo che
le procure di Milano e Roma (a cui si è aggiunto anche “last minute” quella di
Napoli) hanno chiuso i rubinetti delle soffiate, che nel codice penale si
chiamano “atti d’indagine” che sono notoriamente coperti dal segreto
istruttorio, previsto dal Codice Penale, la cui pubblicazione è un reato. Quello
stesso Codice Penale che il suo compagno di spiaggia, l’ex-pm Ingroia deve
avergli ha inculcato non completamente durante le loro vacanze in spiaggia sotto
lo stesso ombrellone. Incredibilmente ieri mattina il “Marchino” ha avuto la
sfacciataggine di sostenere questa sua personalissima impressione e cioè “che
esistano due codici penali, procedurali, informativi, politici ed etici: uno per
i criminali “comuni”, l’altro per i colletti bianchi. L’affare si complica –
aggiunge Travaglio – quando lo stesso orrendo crimine – nel nostro caso
lo stupro – sono accusati di averlo commesso persone di diverso status sociale:
prima gli ultimi della graduatoria, cioè un gruppo di immigrati a Rimini; poi
due carabinieri in uniforme a Firenze”. Travaglio si lamenta sul fronte
giudiziario, scrivendo e sostenendo che “i quattro immigrati di Rimini finiscono
in carcere, mentre i due carabinieri di Firenze restano a piede libero (nemmeno
ai domiciliari)”. Eppure, per i primi come per i secondi, è arduo sostenere che
ricorrano le esigenze cautelari previste dalle rigidissime leggi italiane per
poterli arrestare prima del processo (leggi scritte apposta dai politici per non
far arrestare nessun colletto bianco, dunque nessun criminale di qualunque
specie, ceto e censo): non possono concretamente inquinare le prove (ormai
affidate all’esame del Dna, a video di telecamere o Iphone, al racconto delle
vittime e dei testimoni); né sono sul punto di scappare (il pericolo di fuga
dev’essere concreto e dimostrabile, tipo col biglietto aereo già comprato); né,
essendo indagati coram populo per stupro, è prevedibile che si dedicheranno ad
altri stupri. Ma chi andrà mai a invocare il “garantismo” o a denunciare un caso
di “manette facili” per quattro “stranieri”? Quindi, anche per tacitare
l’opinione pubblica e i politici pronti ad aizzarla, non si va tanto per il
sottile e si butta via la chiave.” Mister “simpatia” made in Piemonte, sostiene
che “per i carabinieri è diverso, anche se dovrebbe essere uguale: il caso è già
di per sé abbastanza imbarazzante per l’Arma e per l’Italia (le due vittime sono
americane), figurarsi la scena di due paia di manette sulla divisa della
Benemerita. Eppure gli immigrati di Rimini hanno ammesso più dei Carabinieri di
Firenze”. Niente di più FALSO. Gli immigrati di Rimini arrestati, in realtà non
hanno ammesso proprio niente!
Sarebbe il caso che qualche bravo avvocato, ma uno
veramente bravo e competente, o qualche magistrato serio (e ce ne sono!) e
soprattutto indipendente dalle correnti politicizzate della magistratura, gli
spiegasse qualche differenza. Mi permetto di provarci io umilmente. Travaglio
dimentica qualche particolare: gli immigrati hanno violentato e stuprato nel
vero senso della parola una povera ragazza polacca (picchiando il suo
fidanzato) ed una trans peruviana. I due Carabinieri di Firenze, non hanno
picchiato e violentato nessuno. Hanno solo approfittato dello stato alcolico
delle due studentesse universitarie, abusandone sessualmente, ed offeso la
divisa che indossano e quindi tutti i loro colleghi che in Italia garantiscono
la legalità rischiando la vita per pochi soldi. Il che sicuramente costituisce
un fatto molto grave e merita la sanzione penale e disciplinare che subiranno a
breve. Ma da qui a richiedere le manette per i Carabinieri di Firenze ponendoli
sullo stesso livello del branco di stupratori di Rimini passa un abisso!
Travaglio diventa all’improvviso “garantista” sostenendo che nessuno si sogna di
definire i quattro immigrati di Rimini dei “presunti stupratori” sostenendo che
“se poi, puta caso, si scopre che uno dei quattro non ha stuprato nessuno”, chi
se ne frega. I due carabinieri invece, essendo italiani e usi a obbedir tacendo,
hanno almeno diritto alla qualifica “presunti stupratori”. Non contento
attacca il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette e la ministra
della difesa Roberta Pinotti, sostenendo che “usano parole durissime” e, nel
dubbio, li sospendono dal servizio in via “precauzionale” ed aggiunge “Giusto:
nessuno può indossare la divisa di tutore della legge col sospetto di averla
così orrendamente violata. Dice Del Sette, senz’attendere la sentenza
definitiva, né quella provvisoria, né il rinvio a giudizio, né la richiesta del
pm, “il primo dovere di un carabiniere è quello di essere un cittadino
esemplare, di agire nell’onestà morale, nella piena legalità. Se non lo fa,
tradisce una scelta di servizio”. Parole sante. Ma siccome “il Marchino” non ha
simpatia per questo Governo che ha osteggiato sin dal suo primo minuto di vita ,
sostiene che “ad adottare il provvedimento sono un governo che non sospende
quattro suoi membri indagati o imputati per gravi reati; e un comandante (Del
Sette, appunto), indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento agli
inquisiti dello scandalo Consip, cioè per aver rovinato l’indagine sulle
tangenti per truccare l’appalto più grande d’Europa, che il Governo non
sospende, anzi conferma“. Probabilmente al “Marchino” non deve essere ancora
andato giù il fatto che il suo giornale non riesce ad avere sottobanco
assolutamente nulla dai Carabinieri, dimenticando che nel frattempo sotto
indagine (ed è ben più di una) vi è un ufficiale del NOE responsabile di far
girare troppe “balle” investigative e troppe carte intorno alla “compagnia di
giro” del Fatto Quotidiano. Secondo Travaglio “la fondatezza delle accuse a Del
Sette è pari a quella delle accuse ai due carabinieri: la parola di due
testimoni (gli ex dirigenti Consip Ferrara e Marroni) contro la sua. Certo, il
favoreggiamento non è lo stupro: ma si può seriamente sostenere che un appuntato
e un carabiniere scelto accusati di stupro infanghino l’Arma più del comandante
generale accusato di spifferare segreti agli indagati di un mega-scandalo di
corruzione?”. Marchino scrive dall’alto della sua autorefenziale superbia
giornalistica che se “il primo dovere di un carabiniere è quello di essere un
cittadino esemplare, di agire nell’onestà morale, nella piena legalità”, questo
dovrebbe valere tanto per gli ultimi anelli della catena quanto, a maggior
ragione, per il primo. Che ci fa ancora Del Sette al vertice dell’Arma? Che ci
fa il generale Emanuele Saltalamacchia, indagato per gli stessi reati, al
comando dei Carabinieri toscani (diretto superiore dei due presunti stupratori)?
E che ci fa Luca Lotti, indagato per gli stessi reati, al ministero dello
Sport?. In pratica secondo Travaglio, se uno viene indagato dovrebbe essere
rimosso dalla sua poltrona. Ma allora di conseguenza anche lui stesso dovrebbe
lasciare quella di direttore del suo giornale. Qualcuno dei suoi giornalisti
dovrebbe spiegare e raccontare al direttore del “Fatto” che nella vicenda
Consip Alfredo Romeo ha vinto il suo ricorso dinnanzi al Tribunale del Riesame e
persino in Cassazione, ed a suo carico non sono state trovate prove di
corruzione e tangenti ed infatti sono stati costretti a restituire ad Alfredo
Romeo la proprietà e gestione delle sue aziende. Così come Travaglio dovrebbe
chiedere scusa alla famiglia Renzi per aver reiteratamente diffamato Matteo
Renzi, suo padre ed il ministro Luca Lotti, accusandoli (senza alcuna prova
concreta e tangibile) di reati che non hanno mai commesso. Anzi come i fatti
hanno dimostrato, hanno solo subito!
Ma alla fine esce la vera motivazione di questo
editoriale a dir poco imbarazzante. Travaglio scrive che “Sugli stupri di Rimini
e Firenze, tv e giornali hanno pubblicato i verbali, fin nei minimi e più
raccapriccianti dettagli, degli indagati e addirittura delle vittime (che,
trattandosi di testimonianze, sono coperte dal segreto), e i pm e gli avvocati
ne hanno diffusamente parlato in interviste e conferenze stampa. (Falso! n.d.a)
Secondo noi, è giusto così, visto l’interesse pubblico delle notizie. Peccato
che le stesse regole non valgano per i politici e i potenti in genere: noi, ad
esempio, per molto meno – notizie e intercettazioni segrete su Consip che
infastidivano la Renzi Family –siamo stati perquisiti dalla Procura di
Napoli, mentre quella di Roma indagava il pm Woodcock e la sua
compagna” (cioè Federica Sciarelli, giornalista RAI notoriamente molto “vicina”
alla compagnia di giro… del Fatto Quotidiano). Peccato che il Travaglio ed il
Fatto Quotidiano non si soffermino su qualcos’altro. I pm nell’interrogatorio
agli ufficiali del NOE, il colonnello Sessa ed il capitano Scafarto. Hanno
chiesto chiarimenti sul filone che riguarda la fuga di notizie sull’inchiesta e
che vede indagati per rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento il
ministro dello sport Luca Lotti, il comandante generale dell’arma Tullio Del
Sette e quello della regione Toscana Emanuele Saltalamacchia. Il
colonnello Sessa del NOE secondo i magistrati avrebbe mentito sulle date. In
sostanza, Sessa avrebbe avvertito con largo anticipo gli alti ufficiali delle
indagini in corso, cosa che avrebbe permesso la fuga di notizie verso il
ministro Lotti e, da questi, verso Tiziano Renzi. Le conversazioni Whatsapp
trovate sul cellulare del capitano Scafarto dimostrano che lui avrebbe informato
il comandante del Noe, Generale Sergio Pascali, in estate, mentre lui ha deposto
di averlo fatto solo dopo il 6 novembre. I magistrati hanno interrogato il
capitano (ora maggiore) Scafarto al quale hanno chiesto chiarimenti sul suo
ultimo interrogatorio, durante il quale aveva chiamato in causa il sostituto
procuratore di Napoli, Henry John Woodcock, anche lui titolare di un filone di
inchiesta su Consip. “Fu lui a dirmi di fare un apposito capitolo sul
coinvolgimento dei servizi segreti”, aveva messo a verbale Scafarto. La
“storia” dei Servizi era quindi una bufala. Ma Travaglio quando vuole dimentica
(o vuole dimenticare)!
Il suo vice direttore Lillo ha raccontato questo
particolare a proposito della vicenda Consip: «Il giornalista del Corriere della
Sera Giovanni Bianconi ha svelato per primo oggi l’indagine per rivelazione di
segreto su Woodcock per l’inchiesta Consip. Io lo conosco bene. Mi ha incontrato
proprio negli uffici della Procura di Roma una ventina di minuti prima
dell’uscita del suo scoop. Né lui né l’Ansa che ha ripreso e ampliato la notizia
aggiungendo il particolare di Federica Sciarelli indagata hanno ritenuto utile
chiedere la mia versione su questa notizia. Dopo l’uscita del pezzo
sul Corriere.it ho chiamato il collega per dirgli: “Giovanni, scusa perché
quando mi hai incontrato non mi hai chiesto la mia versione come avresti fatto
con un indagato per fuga di notizie qualsiasi come Luca Lotti?”. La risposta è
stata: “Perché non ho messo il tuo nome e tu non sei una notizia”. Gli ho detto:
“Hai messo la testata e tutti sanno che sono io. E poi scusa, sono un collega.
Mi conosci. Ti avrei potuto spiegare come sono andate le cosee avresti fatto un
pezzo più completo per il tuo lettore”. Mi ha risposto che gli avrei potuto
mentire e quindi non era interessato alla mia versione». Un comportamento
corretto quello di Bianconi, che sorprende Marco Lillo ed i suoi colleghi.
Perchè? Semplice. Al Fatto Quotidiano non si preoccupano di pubblicare notizie
inesatte o tendenziose, ed hanno una certa “allergia” ad autorettificarsi. Il
“Marchino” così conclude il suo editoriale: “Dobbiamo dedurne che le fughe di
notizie sono lecite per gli stupri e proibite per le mazzette? E dove sta
scritto? Nel Codice del Marchese del Grillo?”. Travaglio purtroppo però non
spiega ai suoi esigui lettori, che sono crollati con il suo arrivo alla
direzione del Fatto Quotidiano, al posto dell’ottimo Antonio
Padellaro (rimpianto dalla stragrande maggioranza dei giornalisti “fondatori”
del giornale) quali sarebbero “le fughe di notizie sugli stupri”. Quelle sulla
vicenda Consip invece lui le conosce molto bene…. E conosce molto bene i
responsabili che hanno violato la Legge ed il Codice Penale. Povero “Marchino”
Travaglio che gli tocca fare pur di vendere qualche copia in più del giornale e
dei libri editi dalla loro casa editrice per far quadrare i conti...!
Per una più ampia valutazione del lettore,
segnaliamo alcuni “precedenti” giudiziari sul giornalismo … di Marco Travaglio:
• Nel 2000 è stato condannato in sede civile per
una causa intentata da Cesare Previti dopo un articolo su L’Indipendente del 24
novembre 1995: 79 milioni di lire, pagati in parte attraverso la cessione del
quinto dello stipendio.
• Nel giugno 2004 è stato condannato dal
Tribunale di Roma in sede civile a un totale di 85.000 euro (più 31.000 euro di
spese processuali) per un errore contenuto nel libro «La Repubblica delle
banane» scritto assieme a Peter Gomez e pubblicato nel 2001. Nel libro, a pagina
537, così si descrive «Fallica Giuseppe detto Pippo, neo deputato Forza Italia
in Sicilia»: «Commerciante palermitano, braccio destro di Gianfranco Miccicché…
condannato dal Tribunale di Milano a 15 mesi per false fatture di Publitalia. E
subito promosso deputato nel collegio di Palermo Settecannoli». Dettaglio: non
era vero. Era un caso di omonimia tuttavia spalmatosi a velocità siderale
su L’Espresso, su il Venerdì di Repubblica e su La Rinascita della Sinistra: col
risultato che il 4 giugno 2004 sono stati condannati tutti a un totale di 85mila
euro più 31mila euro di spese processuali; 50mila euro in solido tra Travaglio,
Gomez e la Editori Riuniti, gli altri sparpagliati nel Gruppo Editoriale
L’Espresso. Nel 2009, dopo il ricorso in appello, la pena è stata ridotta a
15.000 euro.
• Nell’aprile 2005 eccoti un’altra condanna di
Travaglio per causa civile di Fedele Confalonieri contro lui e Furio
Colombo, allora direttore dell’Unità. Marco Travaglio aveva scritto di un
coinvolgimento di Confalonieri in indagini per ricettazione e riciclaggio, reati
per i quali, invece, non era inquisito per niente: 12mila euro più 4mila di
spese processuali. La condanna non va confusa con quella che il 20 febbraio
2008, per querela stavolta penale di Fedele Confalonieri, il Tribunale di Torino
ha riservato a Travaglio per l’articolo Mediaset «Piazzale Loreto? Magari»
pubblicato sull’Unità del 16 luglio 2006: 26mila euro da pagare; né va confuso
con la citata condanna a pagare 79 milioni a Cesare Previti (articolo
sull’Indipendente) e neppure va confuso con la condanna riservata a Travaglio
dal Tribunale di Roma (L’Espresso del 3 ottobre 2002) a otto mesi e 100 euro di
multa per il reato di diffamazione aggravata ai danni sempre di Previti, reato –
vedremo – caduto in prescrizione.
• Nel giugno 2008 è stato condannato civilmente
dal Tribunale di Roma al pagamento di 12.000 euro più 6.000 di spese processuali
per aver descritto la giornalista del Tg1 Susanna Petruni come “personaggio
servile verso il potere e parziale nei suoi resoconti politici“. «La
pubblicazione», si leggeva nella sentenza, «difetta del requisito della
continenza espressiva e pertanto ha contenuto diffamatorio».
• Nell’aprile 2009 è stato condannato dal
Tribunale penale di Roma (articolo pubblicato su L’Unità dell’11 maggio 2007)
per il reato di diffamazione ai danni dell’allora direttore di Raiuno Fabrizio
Del Noce. Il processo sarebbe pendente in Cassazione.
• Nell’ottobre 2009 è stato condannato in
Cassazione (Terza sezione civile) al risarcimento di 5.000 euro nei confronti
del giudice Filippo Verde, che era stato definito «più volte inquisito e
condannato» nel libro «Il manuale del perfetto inquisito», affermazioni
giudicate diffamatorie dalla Corte in quanto riferite «in maniera incompleta e
sostanzialmente alterata».
• Nel giugno 2010 è stato condannato civilmente
dal Tribunale di Torino (VII sezione civile) a risarcire 16.000 euro al
Presidente del Senato Renato Schifani, avendo evocato la metafora del lombrico e
della muffa a «Che tempo che fa» il 10 maggio 2008.
• Nell’ottobre 2010 è stato condannato civilmente
per diffamazione dal Tribunale di Marsala: ha dovuto pagare 15mila euro perché
aveva dato del «figlioccio» di un boss all’assessore regionale siciliano David
Costa, arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa
e successivamente assolto in forma definitiva.
• Quindi la condanna più significativa. Si
comincia in primo grado nell’ottobre 2008: Travaglio beccò otto mesi di prigione
(pena sospesa) e 100 euro di multa in quanto diffamò Previti. L’articolo, del
2002 su l’Espresso, era sottotitolato così: «Patto scellerato tra mafia e Forza
Italia. Un uomo d’onore parla a un colonnello dei rapporti di Cosa nostra e
politica. E viene ucciso prima di pentirsi». Lo sviluppo era un classico “copia
& incolla”, dove un pentito mafioso spiegava che Forza Italia fu “regista” di
varie stragi. Chi aveva raccolto le confidenze di questo pentito era il
colonnello dei Carabinieri Michele Riccio, che nel 2001 venne convocato nello
studio del suo avvocato Carlo Taormina assieme a Marcello Dell’Utri. In quello
studio, secondo Riccio, si predisposero cose losche, tipo salvare Dell’Utri,
e Travaglio nel suo articolo citava appunto un verbale reso da Riccio. E lo
faceva così: «In quell’occasione, come in altre, presso lo studio dell’avv.
Taormina era presente anche l’onorevole Previti». E così praticamente finiva
l’articolo.
L’ombra di Previti si allungava perciò su vari
traffici giudiziari, ma soprattutto veniva associato a un grave reato: il
tentativo di subornare un teste come Riccio. Il dettaglio è che Travaglio aveva
completamente omesso il seguito del verbale del colonnello. Eccolo per intero:
«In quell’occasione, come in altre, presso lo studio dell’avv. Taormina era
presente anche l’onorevole Previti. Il Previti però era convenuto per altri
motivi, legati alla comune attività politica con il Taormina, e non era presente
al momento dei discorsi inerenti la posizione giudiziaria di Dell’Utri». Il
giudice condannò Travaglio ai citati otto mesi: «Le modalità di confezionamento
dell’articolo risultano sintomatiche della sussistenza, in capo all’autore, di
una precisa consapevolezza dell’attitudine offensiva della condotta e della sua
concreta idoneità lesiva della reputazione». In italiano corrente e più chiaro
significa che Travaglio l’aveva fatto apposta, cioè aveva diffamato ben sapendo
di diffamare. La sentenza d’Appello è dell’8 gennaio 2010 e confermava la
condanna, ma gli furono concesse attenuanti generiche e una riduzione della
pena. La motivazione, per essere depositata, non impiegò i consueti sessanta
giorni: impiegò un anno, dall’8 gennaio 2010 al 4 gennaio 2011. Così il reato è
caduto in prescrizione. «La sentenza impugnata deve essere confermata nel
merito… (vi è) prova del dolo da parte del Travaglio». Il quale, ad Annozero, ha
raccontato di un ricorso in Cassazione: attendiamo notizia sull’esito. Secondo
voi, se sarà negativo Travaglio nè darà notizia? Abbiamo seri dubbi …
“Ciliegina sulla torta”. La Corte Europea dei
Diritti Umani. I tribunali italiani non hanno violato il diritto alla libertà
d’espressione di Marco Travaglio quando in primo e secondo grado, nel 2008 e
2010, l’hanno condannato per aver diffamato Cesare Previti nell’articolo ‘Patto
scellerato tra mafia e Forza Italia’ pubblicato nel 2002 sull’Espresso. L’ha
stabilito la Corte europea dei diritti umani dichiarando inammissibile il
ricorso presentato dal giornalista nel 2014. Secondo i giudici di Strasburgo i
tribunali italiani hanno ben bilanciato i diritti delle parti in causa, da un
lato quello di Travaglio alla libertà d’espressione e dall’altro quello
di Cesare Previti (che nella decisione odierna è indicato solo con l’iniziale
P.), al rispetto della vita privata. I togati europei hanno quindi dato ragione
ai colleghi italiani che hanno condannato Travaglio per aver pubblicato solo una
parte della dichiarazione del colonnello dei Carabinieri Michele Riccio
“generando così nel lettore – si legge nella decisione della Corte
– l’impressione che il ‘signor P.’ fosse presente e coinvolto negli incontri
riportati nell’articolo”. La Corte osserva “che, come stabilito dai tribunali
nazionali, tale allusione era essenzialmente fuorviante e confutata dal resto
della dichiarazione non inclusa dal ricorrente nell’articolo”. La Corte di
Strasburgo ha quindi ribadito che uno sputtanamento è uno sputtanamento e che le
post verità…si possono definire solo in un modo: menzogne. E pubblicare una
storia a metà, con il metodo del “taglia e cuci”, non è un fatto alternativo:
è una non verità. E per fortuna c’è un giudice a Strasburgo. Ma tutto questo
“Marchino” Travaglio evidentemente non ama ricordarlo, figuriamoci scriverlo!
Travaglio: “I giornali a Taranto non scrivono
nulla perchè sono comprati dalla pubblicità”. E’ vero, ma non per tutti…Lettera
aperta al direttore de IL FATTO QUOTIDIANO dopo il suo intervento-show al
Concerto del 1 maggio 2015 a Taranto di Antonello de Gennaro del 2 maggio 2015
su "Il Corriere del Giorno". "Caro Travaglio, come non essere felice
nel vedere Il Fatto Quotidiano, quotidiano libero ed indipendente da te diretto,
occuparsi di Taranto? Lo sono anche io, ma nello stesso tempo, non sono molto
soddisfatto della tua “performance” sul palco del Concerto del 1° maggio di
Taranto. Capisco che non è facile leggere il solito “editoriale”, senza il
solito libretto nero che usi in trasmissione da Michele Santoro, abitudine
questa che deve averti indotto a dire delle inesattezze in mezzo alle tante cose
giuste che hai detto e che condivido. Partiamo da quelle giuste. Hai centrato il
problema dicendo: “A Taranto i giornali non scrivono nulla perchè sono comprati
dalla pubblicità”. E’ vero e lo provano le numerose intercettazioni telefoniche
contenute all’interno degli atti del processo “Ambiente Svenduto” e per le
quali il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti di
Puglia tergiversa ancora oggi nel fare chiarezza sul comportamento dei
giornalisti locali coinvolti, cercando evidentemente di avvicinarsi il più
possibile alla prescrizione amministrativa dei procedimenti disciplinari e
“salvarli”. Intercettazioni che ti segnalo, solo il quotidiano che dirigo, ha
pubblicato “integralmente”. Hai detto qualche inesattezza. Forse qualcuna di
troppo. Innanzitutto il giornalista dell’emittente Blustar TV, che hai citato e
fatto passare come un “eroe-vittima”, in realtà non ha mai fatto un’inchiesta
giornalistica sullo stabilimento siderurgico, bensì ha solo rivolto una domanda
scomoda ad Emilio Riva al termine di un convegno, a confronto della quale,
credimi, le domande fatte ai malcapitati dagli inviati di Striscia la
Notizia e Le Iene nei loro servizi, potrebbero tranquillamente concorrere ed
aspirare a vincere il “Premio Pulitzer“ E poi, caro Travaglio, quella
televisione cioè Blustar TV, che sta per chiudere, la pubblicità dall’ ILVA la
incassava anche lei ! Le domande “scomode” di quel giornalista a Riva sono
arrivate solo, guarda caso…quando i rubinetti della pubblicità si erano chiusi
da tempo! Hai paragonato ingiustamente ed erroneamente l’attuale Sindaco di
Taranto Ippazio Stefàno ai suoi predecessori Giancarlo Cito e Rossana Di Bello,
senza sapere che a differenza dei degli altri due, l’attuale primo cittadino di
Taranto, al suo secondo mandato consecutivo, è stato eletto con i voti di una
sua lista civica, senza della quale il centrosinistra non avrebbe mai governato
la città di Taranto, sindaco che gestisce ed amministra la città in “dissesto
economico” finanziario da circa 8 anni, dopo quanto ha ricevuto in “eredità”…dal
precedente sindaco di Forza Italia Di Bello. Hai ha detto erroneamente che il
dissesto di Taranto ammontava a 900mila euro, dimenticando qualche “zero”.
Magari fossero stati solo così pochi! In realtà il “buco” era di 900 milioni di
euro!
Se ti avessero informato e documentato meglio,
caro Travaglio, invece di ironizzare sulla pistola alla cinta del Sindaco,
avresti appreso delle pesanti minacce ricevute dal primo cittadino di Taranto,
persino nel suo studio a Palazzo di Città, ad opera di appartenenti
alla criminalità organizzata, la quale grazie a dei consiglieri comunali collusi
silenziosamente si era infiltrata anche all’interno dell’amministrazione
comunale (mi riferisco all’ “operazione Alias” della DDA di Lecce).
Paragonandolo al tuo amico ed ex pm Ingroia che se ne andava girando in lungo e
largo per l’Italia con la “scorta” di Stato, almeno il sindaco di Taranto non è
costato nulla al contribuente, e la sua pistola è rimasta sempre al suo posto.
Caro Travaglio ti anticipo subito un possibile dubbio. Non sono un elettore,
simpatizzante o apostolo, nè tantomeno amico o parente dell’attuale Sindaco di
Taranto, ma sull’ onestà di Ippazio Stefàno non sono il solo a sostenerla. Ti
informo che oltre al sottoscritto c’è “qualcuno” come il Procuratore capo della
repubblica di Torino, Armando Spataro (tarantino) che dovresti ben conoscere, il
quale essendo persona seria, coerente ed attendibile, sono sicuro sarà pronto a
ripetere quello che disse al sottoscritto: “Sull’onestà di Ippazio Stefàno sono
pronto a mettere la mano sul fuoco”. Non ti ho sentito dire neanche una sola
parola sui tuoi “amici” “grillini”, che difendi spesso e volentieri in
televisione e nei tuoi articoli. Se ti fossi informato bene, avresti scoperto
che i due “cittadini” eletti in Parlamento a Taranto del M5S, sono stati i primi
dopo qualche mese dalla loro elezione ad abbandonare il movimento
di Grillo e Casaleggio. Rinunciare allo stipendio “pieno” da parlamentare è cosa
dura ed ardua. Soprattutto per uno come Alessandro Furnari (ex disoccupato) ed
una come l’ex-cittadina-pentastellata-deputata Vincenza Labriola la quale, due
anni prima si era candidata alle elezioni comunali per il M5S, ricevendo dal
“popolo grillino” e dai cittadini di Taranto un grande…consenso: la bellezza
di 1 voto. Forse il suo! Per avere traccia della loro attività parlamentare, e
conoscere il loro impegno per Taranto, credo che sia consigliabile alla nostra
brava collega Federica Sciarelli conduttrice di “Chi l’ha visto”. Chissà se ci
riesce …Hai raccontato di intercettazioni, avvenute realmente, fra gli uomini
dell’ILVA e la stessa famiglia Riva, che si intrattenevano telefonicamente con
non pochi politici pugliesi, da destra a sinistra, compreso il neo (ma già ex)
deputato Ludovico Vico. Hai accusato il Pd di averlo fatto rientrare in
Parlamento. Peccato che (purtroppo) gli spettasse di diritto in quanto primo dei
non eletti nel collegio jonico-salentino alle ultime elezioni politiche. O forse
bisognava fare una “legge ad personam” per impedirglielo? Tutta roba vecchia,
riciclata, caro Travaglio, non hai rivelato nulla di nuovo rispetto a quanto già
pubblicato (con audio) dai colleghi del quotidiano La Repubblica, e che noi
umili cronisti di provincia del Corriere del Giorno, abbiamo approfondito con
l’ulteriore pubblicazione integrale online delle intercettazioni più salienti.
Eppure tutto questo, il vostro giovane collaboratore locale Francesco
Casula poteva raccontartelo….ma forse era troppo impegnato nelle sue
conversazioni nell’ufficio dove lavora a Taranto, e cioè un centro di
formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (dove viene
retribuito quindi con soldi pubblici) in cui il giovane collega lavora
insieme alla figlia dell’ex-presidente della Provincia di Taranto Gianni
Florido (PD – area CISL) un politico arrestato a suo tempo anch’egli per l’
inchiesta “Ambiente Svenduto“… Chissà !!! ??? Hai citato il procuratore capo di
Taranto Franco Sebastio ed i suoi magistrati, come se fossero stato loro
gli artefici con una propria azione “autonoma” a far decollare l’inchiesta
giudiziaria sull’ ILVA. Ed anche in questo caso… in realtà non è andata proprio
così perchè l’inchiesta “Ambiente Svenduto” è nata grazie a degli esposti e
denunce di associazioni ambientaliste tarantine, e proprio del sindaco Ippazio
Stefàno, esposti e denunce che non potevano essere dimenticate nei cassetti,
come invece accade tuttora per molti altri casi. Hai
dimenticato caro Travaglio di ricordare che a Taranto un pubblico ministero è
stato arrestato e condannato a 15 anni …, e ti è sfuggito che un giudice del
Tribunale civile di Taranto è stato arrestato anch’egli mentre intascava una
“mazzetta”. Se vuoi gli atti, te li mando tutti. Completi. Hai dimenticato
anche qualcos’altro. E cioè qualcosa che non poteva e non doveva sfuggire alla
tua nota competenza in materia giudiziaria. Anche perchè il quotidiano che ora
dirigi ne aveva parlato. La Procura di Taranto aveva realizzato (solo sulla
carta) uno dei sequestri più grossi della storia giudiziaria italiana, nei
confronti della famiglia Riva, sotto indagine per disastro ambientale
nell’ambito dell’inchiesta ILVA. Un decreto di sequestro per equivalente,
firmato nel maggio scorso dal gip Patrizia Todisco su richiesta appunto della
procura tarantina, che imponeva di mettere i sigilli a beni per 8,1 miliardi di
euro senza peraltro mai trovarli ed identificarli! Quindi un sequestro
“fittizio”, rimasto solo sulla carta. E guarda caso, proprio in merito a
questo “strombazzato” grande sequestro… la Corte di Cassazione ha stabilito che
i beni posti sotto sequestro della holding Riva Fire, società proprietaria
di ILVA spa, su richiesta del pool di inquirenti composto dal procuratore capo
Franco Sebastio, dall’aggiunto Pietro Argentino e dai sostituti Mariano
Buccoliero, Giovanna Cannarile e Remo Epifani, non andavano confiscati motivo
per cui ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro, che era
stato confermato nel giugno 2014 anche dal Tribunale del riesame di Taranto. Il
che vuol dire come puoi ben capire da solo, che sui Riva a Palazzo di Giustizia
di Taranto, avevano “toppato” tutti! In ordine: la Procura della Republica,
l’ufficio del GIP, ed il Tribunale del Riesame. Altro che complimenti! Per
fortuna ci ha pensato la Procura di Milano (procedendo per reati di natura
fiscale), grazie alla preziosa cooperazione che intercorre sui reati finanziari
fra la Banca d’ Italia, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza che
hanno scovato un rientro fittizio (cioè mai effettuato) dall’estero in Italia di
capitali della famiglia Riva, operazione camuffata come “scudata” del valore
di 1miliardo e 200 milioni di euro a cui stanno per aggiungersene
altri 3-400 come ha annunciato in audizione al Senato il procuratore aggiunto
milanese Francesco Greco, che sono in pratica i soldi che la gestione
commissariale dell’ ILVA in amministrazione straordinaria ha richiesto
ed ottenuto (ma non ancora sui conti bancari) in utilizzo dal Gip del tribunale
di Milano, previa tutta una serie di garanzie legali a posteriori, in quanto il
contenzioso giudiziario fra Adriano Riva (il fratello e “patron” del
Gruppo, Emilio è deceduto diversi mesi fa) e lo Stato non si ancora concluso,
neanche in primo grado. In compenso, sei stato molto bravo a spiegare con
chiarezza gli effetti reali e vergognosi (mi trovi d’accordo con te al 100%) dei
vari “decreti Salva Ilva”. Permettimi di provocarti: a quando una bella
inchiesta del Fatto Quotidiano su quello che accade dietro le quinte di Taranto,
possibilmente coordinata dall’ottimo Marco Lillo per evitare cattive figure? Ci
farebbe piacere non dover restare i soli dover scoperchiare i “tombini” di
questa città, che per tua conoscenza è ILVA-dipendente a 360°. Concludendo caro
Travaglio, pur riconoscendoti delle innate capacità giornalistiche e narrative,
e stimandoti personalmente, questa volta te lo confesso mi hai deluso. Hai
dimenticato di farti qualche domanda molto importante come questa: “Come mai al
“referendum sull’ inquinamento ambientale “a Taranto hanno aderito e votato solo
20 mila tarantini?” su circa 200mila elettori. Oppure come questa: “Ma gli
altri 180mila tarantini che non sono andati a votare al referendum, dov’erano?”.
Eppure sarebbe stato facile chiederglielo. Ieri sera caro Travaglio, li avevi
più o meno tutti di fronte al tuo palco …. Domande serie,
caro collega Travaglio, non le fotocopie di “seconda mano” che ti hanno passato.
MARCELLO DELL’UTRI. VITTIMA SACRIFICALE.
Dell’Utri, perché non lo fuciliamo?
Scrive Piero Sansonetti il 6 Dicembre 2017 su "Il Dubbio". Ma allora perché non
lo fuciliamo, come si faceva una volta con i politici in disgrazia? In Italia, è
vero, da una settantina d’anni non si usa più: l’ultimo credo che fu Buffarini
Guidi. Luglio 1945. Però si può fare un’eccezione, e chiedere alla commissione
antimafia, magari, di scegliere il plotone di esecuzione. Sto parlando di
Marcello dell’Utri, naturalmente. Ieri il caso della sua carcerazione è andato
davanti al tribunale di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza nelle
prossime ore dovrà decidere se mandarlo a curarsi in ospedale o lasciarlo in
carcere ad aspettare la fine. Dell’Utri ha un tumore maligno alla prostata, il
cuore in condizioni pessime, il diabete altissimo. Non può operarsi perché le
sue condizioni cardiache non lo permettono. Il Procuratore generale ha chiesto a
dei periti di sua fiducia di visitare Dell’Utri. Che è stato visitato anche dai
periti nominati dalla difesa, che sono quelli di Antigone, e dai periti del
tribunale. I periti dell’accusa hanno dato lo stesso responso dei periti della
difesa: le sue condizioni non sono compatibili con il regime carcerario. E hanno
proposto i nomi di cinque istituti ospedalieri, di Roma e di Milano, in grado di
ricoverarlo e di curarlo. Ma il Procuratore generale, nell’udienza di ieri, ha
detto di fidarsi dei periti del tribunale e non dei periti nominati da lui. E
siccome i periti del tribunale dicono che può restare in carcere, il
Procuratore, smentendo clamorosamente i suoi periti, in un breve intervento
(circa 2 minuti, poche parole succinte e chiare) ha chiesto che dell’Utri resti
in cella. Non si conoscono precedenti di una situazione di questo genere. Un
procuratore che dice di non credere ai periti che lui ha nominato è una novità
assoluta in giurisprudenza, e anche nella vita di tutti i giorni. Ora bisognerà
aspettare la decisione dei giudici. I quali dovranno tener conto delle richieste
del Procuratore e delle perizie dei periti del tribunale, ma non potranno non
prendere atto anche delle perizie dei medici scelti dalla Procura. Se i giudici
dovessero decidere di rispedire Dell’Utri in carcere, la sua vita sarebbe in
serissimo pericolo. Riassumiamo brevemente i fatti. Marcello Dell’Utri, braccio
destro di Silvio Berlusconi e fondatore di Forza Italia, è stato condannato con
sentenza definitiva a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione
mafiosa. Questo reato non esiste nel codice penale, e dunque la condanna
confligge seriamente con l’articolo 1 del codice penale, il quale recita
esattamente così: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da
essa stabilite». Da tempo però i magistrati hanno stabilito che il reato di
associazione esterna esiste in quanto combinazione dell’articolo 110 (concorso
in reato) e dell’articolo 416 bis (associazione mafiosa). E che di conseguenza è
ammissibile l’ipotesi che una persona faccia parte di una associazione pur non
facendone parte, e sia interno a quell’associazione pur restandone fuori. E che
le pene si decidano di volta in volta. In questo modo sono state comminate
svariate condanne, anche a Dell’Utri. Nel frattempo però la Corte europea ha
stabilito che si può anche ammettere che il reato ora esista, in quanto passato
al vaglio dei tribunali italiani e della Cassazione, ma comunque esiste da non
prima del 1994. Il problema è che Dell’Utri è accusato (ed è stato condannato)
per fatti avvenuti tutti negli anni 80. Quando, dunque, il reato sicuramente non
esisteva. Dell’Utri ha fatto ricorso alla Corte europea, contro la sentenza, ed
è praticamente certo che la Corte gli darà ragione (visto che ha dato ragione a
Bruno Contrada, ex dirigente dei servizi segreti, condannato per lo stesso reato
e nelle stesse condizioni). Il problema è che la Corte europea è lenta, e
probabilmente la sentenza e l’ordine di scarcerazione arriveranno quando
dell’Utri avrà finito di scontare la pena, oppure sarà morto. Nel frattempo
Dell’Utri si è ammalato, ha superato i 75 anni, ha scontato molto più della metà
della pena. Esistono non alcune ragioni per scarcerarlo: esistono vagonate di
ragioni (perché non esiste il reato, o perché è anziano, o perché è malato, o
perché ha scontato più della metà della pena…). Perché nessuno muove un dito?
Perché la procura generale di Roma ha smentito i suoi periti pur di non
accettare che Dell’Utri sia curato come tutte le altre persone, libere o
detenute? Ci sono state pressioni per impedire la scarcerazione? La verità che
tutti sanno è che Dell’Utri non viene scarcerato per ragioni assolutamente, e
squisitamente, e ormai del tutto palesemente politiche. Dell’Utri è Berlusconi.
E questo viene ritenuto imperdonabile. Dell’Utri è accusato di essere stato uno
dei cervelli pensanti del berlusconismo, e questo viene ritenuto imperdonabile.
Dell’Utri è siciliano. E questo viene ritenuto imperdonabile. Dell’Utri è stato
per molti anni un parlamentare. E questo, naturalmente, viene ritenuto più che
mai imperdonabile e comunque una aggravante. Talmente imperdonabili sono queste
sue colpe (assai di più di qualunque associazione esterna) che sono mosche
bianche quelli che hanno il coraggio di difenderlo. Perché – mi chiedo, per
esempio – non esiste neppure un parlamentare di sinistra che abbia la sensatezza
di dire: «Sta male, rischia la vita, fatelo uscire»? Naturalmente speriamo che,
come spesso accade, tra i giudici che alla fine sono chiamati a giudicare,
prevalga il buon senso e la conoscenza della Costituzione italiana, e i principi
sacri dell’umanità. Se non sarà così Dell’Utri rischia la vita. Se Dell’Utri
morirà in carcere nessuno potrà considerare la sua morte una cosa diversa da un
delitto politico.
NICOLA MANCINO. VITTIMA SACRIFICALE.
Massacro di un democristiano per bene,
scrive Piero Sansonetti il 20 Dicembre 2017 su "Il Dubbio". La persecuzione
giudiziaria contro uno che ha fatto la storia della nostra democrazia. Mi dicono
che Nicola Mancino non sta bene. Vive chiuso in casa, non vuol veder nessuno, è
molto malinconico. Il modo nel quale lo hanno messo in mezzo, senza motivo, nel
processo Stato- Mafia, non gli è andato giù. Sente l’ingiustizia, l’accanimento
immotivato: non sa spiegarseli. Mancino ha 86 anni, li ha spesi quasi tutti per
la politica. È difficile, oggi, far capire a un ragazzo cosa vuol dire questa
espressione: «spesi per la politica». Ma c’è stato un periodo, nella storia
d’Italia, nel quale la politica era una cosa molto seria, un mestieraccio (come
diceva ieri Giuseppe De Rita su questo giornale) che richiedeva passione,
intelligenza, strategia, impegno, rapporto con le masse. Noi di sinistra
dicevamo così: «con le masse». Chi voleva far politica doveva “spenderci” tutte
le energie che aveva. E doveva studiare, applicarsi, conoscere, parlare, stare a
sentire. Ho conosciuto Nicola Mancino nei primissimi anni 80. Lui era il vice
presidente dei senatori della Dc. Era già una autorità. Io un giovane cronista
politico dell’Unità. Fronti opposti. Mi ricordo ancora di un articolo molto
critico che scrissi su di lui (forse un po’ offensivo) e di un biglietto di
protesta che mi mandò: era molto seccato ma non era aggressivo, o minaccioso, e
accettava di discutere e di far polemica mettendosi sullo stesso piano di un
ragazzino come me. Devo dire che oggi mi dispiace di avere scritto
quell’articolo con la baldanza sfacciata e spavalda dei giovani. Credo che nella
discussione avessi ragione io, ma alle volte, magari, prima di sputare addosso
alla gente bisognerebbe conoscere meglio come stanno le cose. Mancino è stato un
grande democristiano. Era uno dei leader del partito in Campania. E uno dei
dirigenti nazionali nella sua corrente, corrente gloriosa e forte della sinistra
Dc. Si chiamava La Base. L’avevano fondata Dossetti e Marcora, negli anni
cinquanta, e avevano allevato una covata di giovanotti, come De Mita, Galloni,
Granelli e lo stesso Mancino. Poi Dossetti lasciò la politica ma la corrente
di Base andò avanti e fu un pilastro ben piantato del centrosinistra. Moro era
Moro, certo, era su un altro pianeta. Ma sul piano della politica organizzata e
anche della ricerca teorica, la Base fu essenziale – insieme alla corrente di
Donat Cattin – nella svolta riformista che l’Italia visse negli anni sessanta e
settanta. Mancino era lì. Spesso finiva nella bufera delle polemiche. Ma
resisteva bene. Fu accusato tante volte soprattutto del «reato di clientelismo».
Lo dico con cognizione di causa, perché noi dell’Unità eravamo tra gli
accusatori più tenaci. Avevamo ragione? Un po’ sì. Un po’ però avevano ragione
loro. È vero che in quegli anni il clientelismo (o l’assistenzialismo)
democristiano fu uno dei motori della politica italiana. Ma il clientelismo non
era un semplice fenomeno di corruzione. Era un meccanismo molto complicato che
permise una grandiosa redistribuzione del lavoro, dell’assistenza, della
ricchezza e dello stato sociale. L’Italia in quegli anni crebbe in tempi
velocissimi, e la crescita non comportò un aumento, ma una riduzione drastica
delle diseguaglianze sociali. La Dc era al centro di questo fenomeno. Luigi
Pintor, grande giornalista comunista, una volta fece sul manifesto un titolo che
diceva più o meno così: «Non vogliamo morire democristiani». Pintor morì nel
2003. Al governo c’era Berlusconi: chissà, magari lui in fin dei conti avrebbe
preferito morire democristiano… Mancino è stato uno degli uomini forti della
Democrazia Cristiana. Da parlamentare o da ministro ha accompagnato la crescita
dell’Italia durante tutti gli anni della Prima Repubblica. Poi a un certo punto
due giovani Pm di Palermo, che si erano convinti che tra il 1992 e il 1994 ci fu
una trattativa tra Stato e Mafia, hanno deciso di puntare i loro strali contro
Mancino, perché Mancino all’epoca era ministro dell’Interno e perchè alla loro
costruzione accusatoria faceva comodo immaginare un ministro dell’Interno
favorevole alla trattativa. Anzi, immaginare questa circostanza era
indispensabile, altrimenti il castello dell’accusa andava giù. E su cosa si
basava tutta l’accusa? Sul racconto del figlio di Vito Ciancimino (ex sindaco dc
di Palermo, legato alla mafia), il quale figlio di Ciancimino poi fu condannato
tante volte per calunnia. Non avevano nient’altro in mano i Pm. E allora
sostennero che il socialista Amato, nel 92, cacciò il dc Vincenzo Scotti dal
ministero dell’interno perché lo riteneva contrario alla trattativa, e mise al
suo posto il morbido Mancino. E imputarono a De Mita questa scelta. il povero de
Mita – che all’epoca era il segretario della Dc, spiegò ai Pm ( che conoscevano
poco poco la storia d’Italia di quegli anni, forse perché erano troppo giovani)
che nel 1992, esplosa Tangentopoli, la Dc aveva deciso di sancire
l’incompatibilità tra ruolo di ministro e mandato parlamentare. Siccome Scotti
voleva restare parlamentare, non si poteva farlo ministro. E fu indicato
Mancino. Tutto qui. Del resto tutta la biografia di mancino depone per il suo
impegno nella lotta alla mafia. Poi, negli anni successivi, Scotti e Martelli
(all’epoca ministro della Giustizia) sollevarono molte polemiche contro Mancino,
ma questo rientra nella fisiologia delle invidie e dei rancori in politica.
Quello che lascia un po’ sgomenti è che su questa panna montata è stata
costruita l’accusa di falsa testimonianza che tiene ancora Nicola Mancino dentro
un processo senza capo né coda, dove non si sa più nemmeno chi è accusato e di
che cosa, e dove i Pm svolgono requisitorie che in realtà smontano i teoremi
accusatori. Si capisce bene che lui che ne soffre. Ne soffre anche la Storia,
strattonata da tutte le parti, e ne soffre la sostanza della democrazia. Fa un
po’ rabbia che dei Pm un tantino sprovveduti, nella loro foga di provare teoremi
fantasiosi e di scoprire complotti inconfessabili, pestino l’acqua nel mortaio e
buttino fango sulla vita di uno dei protagonisti della democrazia italiana.
Maroni: «Il Sisde spiava Mancino»,
scrive Errico Novi il 16 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". L’allora ministro
dell’Interno: “Trovai sul mio predecessore dossier segreti da usare nella lotta
politica. Dissi no alla nomina di Mori e al decreto che ostacolava le inchieste
di mafia”. «Quando ero ministro dell’Interno avevo avuto modo di leggere una
serie di fascicoli del Sisde che riguardavano di fatto un’attività di
dossieraggio nei confronti di esponenti dei vari partiti politici tra i quali
uno sul mio predecessore al Viminale». Sono le parole durissime dell’ex ministro
dell’Interno, Roberto Maroni, sentito nel processo sulla trattativa Stato-
mafia. Che poi continua: «Anche questa vicenda – ha proseguito – mi indusse a
rimuovere Domenico Salazar che era direttore del Sisde. Da ministro dell’Interno
Maroni spiazzò tutti: anziché mettere a capo del Sisde uno dei nomi graditi a
Palazzo Chigi, tra i quali Mario Mori, scelse uno sconosciuto generale dei
carabinieri, Gaetano Marino, che «nell’Arma si occupava di formazione».
Irregolare come capo del Viminale, controcorrente come teste al processo Stato-
mafia: il governatore lombardo dà ai pm Nino Di Matteo e Francesco Del Bene
risposte che gran parte degli altri testimoni aveva sfumato nelle nebbie
dell’irrilevanza. Non che offra all’accusa e alla Corte d’assise di Palermo seri
elementi di prova: anche dopo la deposizione di ieri non sembra accresciuta la
possibilità di arrivare a qualche condanna. Ma almeno Maroni dà notizie sulle
vicende di quegli anni, in particolare sul ’ 94: una di queste rappresenta
l’imputato Nicola Mancino addirittura come vittima di impropri dossieraggi da
parte dei servizi. «Appena nominato ministro dell’Interno nel primo governo
Berlusconi», racconta l’attuale presidente della Lombardia, «trovai una serie di
dossier del Sisde su alcuni politici, persino sul mio predecessore all’Interno»,
Mancino appunto. Secondo l’allora direttore del servizio segreto civile Domenico
Salazar «si trattava di informazioni legate a motivi di sicurezza». Ma davanti a
pm e giudici palermitani Maroni obietta: «Se il dossier era sulla sua sicurezza
Mancino ne doveva essere informato, se non lo era a maggior ragione pensai che
non erano dossier autorizzati». Certo il caso è sconcertante: il Sisde
“pedinava” per scopi incomprensibili lo stesso ministro dell’Interno. Che
d’altra parte era in buona compagnia: la documentazione trovata da Maroni
riguardava «diversi politici, compreso Francesco Cossiga». Nel caso
dell’imputato al processo in cui depone il governatore lombardo, «capii che quei
pedinamenti servivano a sapere chi incontrava e a raccogliere informazioni da
usare nella battaglia politica». Lui, Maroni, prima chiuse i faldoni in una
cassaforte del suo studio «per evitare che li facessero sparire», poi li portò
in Senato. Si muoveva da “mina vagante”, l’allora capo del Viminale: «Ero il
primo che non venisse dalla Dc». Fece fuori Salazar, scartò Mori e altri
possibili successori segnalati da Parisi e preferì appunto Marino. Il cuore
dell’udienza, negli auspici dei pm, riguarderebbe il decreto del 14 luglio ’ 94,
a cui Maroni e la Lega si opposero fino a farlo ritirare: «Il testo arrivato in
Consiglio dei ministri non era quello originario. Ne parlai col procuratore di
Palermo Caselli, mi disse che quelle norme rendevano più difficile la lotta alla
mafia: c’era l’obbligo di riferire all’indagato dell’inchiesta in corso. Secondo
Caselli indagini complicate sarebbero diventate impossibili». In realtà nel
primo “report” fatto in proposito alla Procura, durante l’interrogatorio del 4
luglio scorso, Maroni aveva detto di aver stroncato il provvedimento in
un’intervista al Tg3 per le limitazioni alle misure cautelari nei confronti di
indagati per corruzione e concussione. Probabile dunque che il “movente” del
decreto non fosse compiacere i mafiosi. Il no della Lega bastò a farlo
accantonare. Così come il no di Berlusconi non impedì a Maroni di «nominare
Gianni De Gennaro vice capo della polizia: io», dice in aula il governatore,
«volevo ribadire la volontà di contrastare la mafia e, soprattutto, sparigliare
i vecchi schemi». Il Cavaliere non voleva un poliziotto ritenuto “di sinistra”.
Il che non emerge nella deposizione di ieri, ma non è che servisse il processo
Statomafia per accertarlo.
CLEMENTE MASTELLA. VITTIMA SACRIFICALE.
Mastella assolto 9 anni dopo la caduta di
Prodi: ho sofferto tanto. Accusato con la moglie
Sandra Lonardo, l’ex leader dell’Udeur si dimise da Guardasigilli e mandò in
crisi il governo, scrive Fulvio Bufi il 12 settembre 2017 su "Il Corriere della
Sera”. Per quanto Berlusconi ci provò con la compravendita dei senatori, la vera
causa della caduta del governo Prodi nel 2008 furono le dimissioni di Clemente
Mastella da ministro della Giustizia. Scelse di farsi da parte, ma anche di
ritirare l’appoggio dell’Udeur alla coalizione, quando dalla Procura di Santa
Maria Capua Vetere lo misero sotto inchiesta accusandolo di concussione nei
confronti del governatore della Campania dell’epoca, Antonio Bassolino.
Il terremoto politico. Sono passati oltre nove
anni da quell’inchiesta e ieri Mastella è stato assolto. Non impose cariche per
esponenti del suo partito, non commise nessun altro tipo di reato. Assolti anche
tutti gli altri imputati, tra i quali la moglie dell’attuale sindaco di
Benevento, Sandra Lonardo, che all’epoca conobbe addirittura gli arresti
domiciliari Nel gennaio del 2008 il Paese subì dunque un terremoto politico e
una crisi di governo per nulla, si scopre oggi. E Mastella ne ricorda, però,
soprattutto le conseguenze sul piano personale e familiare. «Ho sofferto tanto»,
commenta adesso. E aggiunge: «La mia famiglia e io abbiamo patito cose
inimmaginabili. Sono contento soprattutto per la giustizia, perché questa
sentenza conferma che la giustizia esiste e bisogna crederci, anche quando i
tempi sono molto lunghi». Lui nel frattempo ha vissuto anni lontano dalla
politica, ma non ce l’ha fatta a non tornare in gioco, anche se in qualche
momento avrà pensato che era davvero fuori da tutto.
La vittoria a Benevento. Invece ora è sindaco a
Benevento, e alla luce della sentenza emessa ieri dal Tribunale di Napoli, può
tranquillamente restare al suo posto. In caso di condanna (il pubblico ministero
Ida Frongillo aveva chiesto una pena di due anni e sei mesi) sarebbe invece in
corso in quanto prevede la legge Severino e avrebbe dovuto lasciare la carica di
primo cittadino. L’inchiesta nei confronti di Mastella disegnò l’Udeur come un
centro di potere basato su illeciti di vario tipo. L’accusa principale rivolta
al leader fu quella di aver imposto a Bassolino una importante nomina
all’interno della Asl div Benevento, minacciando, in caso contrario, di ritirare
la fiducia alla giunta regionale e di costringerla quindi a capitolare. Per la
verità il primo a discolpare Mastella, nel corso di questi anni, è stato proprio
Bassolino, che ha sempre negato di aver subito pressioni di alcun tipo. Alla
fine se ne sono convinti anche i giudici.
Le indagini. Nelle indagini, oltre a Sandra
Lonardo, furono coinvolti numerosi altri esponenti dell’Udeur, ma ieri tutti
sono stati assolti. In alcuni casi erano maturati anche i tempi per la
prescrizione (la cui applicazione è stata chiesta dal pm) ma il Tribunale ha
preferito entrare nel merito e pronunciarsi per una assoluzione piena. Di quella
vicenda di quasi dieci anni fa rimane — oltre a un’inchiesta finita nel nulla e
a una crisi di governo — soltanto il ricordo di una surreale conferenza stampa,
con il procuratore dell’epoca di Santa Maria Capua Vetere, Mariano Maffei, che
non si rese conto di essere ripreso da decine di telecamere e che al termine
provò a pretendere che nessuna immagine venisse mandata in onda. In realtà era
già stato tutto trasmesso in diretta e in diretta andò anche la sua piccatissima
reazione.
Clemente Mastella assolto dall'inchiesta
che nove anni fa causò la caduta del Governo Prodi. Aveva lasciato la carica di
ministro della Giustizia dopo un avviso garanzia e l'arresto della moglie Sandra
Lonardo, scrive Roberto Fuccillo il 12 settembre 2017
su "La Repubblica". Assoluzione per Clemente Mastella. È la sentenza di primo
grado al processo nato nel 2008 a Santa Maria Capua Vetere, e che costò tra
l’altro la caduta dell’allora governo Prodi. Il verdetto è stato emesso dopo
oltre sei ore di camera di consiglio dalla quarta sezione del Tribunale di
Napoli. "È una riparazione a dieci anni di sofferenze - commenta Mastella,
attualmente sindaco di Benevento - perchè è una vicenda che ha toccato tutta la
mia famiglia". E aggiunge: "Non auguriamo a nessuno quello che è successo a noi.
Ricordo quello che mi disse Andreotti: a me hanno risparmiato la famiglia, a te
neppure quella". L’allora Guardasigilli (siamo nel 2008) reagì dimettendosi
all’arresto della moglie Sandra Lonardo, disposto proprio nell’ambito
dell’indagine. Le contestazioni si riferivano a presunte pressioni per le nomine
in alcuni incarichi. Fra queste anche quella ipotizzata su Antonio Bassolino,
all’epoca presidente della Regione, per una nomina alla Asi di Benevento.
Pressione smentita dallo stesso Bassolino, ascoltato in aula. Nella sua
requisitoria, il pm Ida Frongillo aveva comunque chiesto per l'ex ministro la
condanna a due anni e otto mesi, modificando l'originaria imputazione di tentata
concussione in indebita induzione. Al tempo stesso aveva sollecitato invece la
prescrizione per Sandra Lonardo. Ieri, a quasi dieci anni da un passaggio che fu
storico anche per le istituzioni italiane, la sentenza assolve l’ex ministro,
oggi sindaco di Benevento, la consorte e gli altri due coimputati, l’ex
consuocero Carlo Camilleri e l’avvocato Andrea Abbamonte, anch’essi all’epoca
dei fatti dirigenti dell’Udeur. Il sindaco di Benevento, che all'epoca dei fatti
ricopriva la carica di ministro della Giustizia ed era leader dell'Udeur, era
accusato in particolare di "induzione indebita a dare o promettere utilità". Una
ipotesi per la quale il pm aveva chiesto due anni e otto mesi di reclusione. La
sentenza chiude una vicenda processuale tormentata, che culminò nel gennaio 2008
- quando l'inchiesta era condotta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere -
nell'emissione dell'avviso di garanzia nei confronti del Guardasigilli. Una
indagine che coinvolse anche la moglie del leader Udeur, Alessandra Lonardo,
all'epoca presidente del consiglio regionale della Campania. Mastella si dimise
dalla carica di ministro e pochi giorni dopo ritirò il suo appoggio al Governo
Prodi, circostanza che contribuì alla caduta dell'esecutivo e alle elezioni
anticipate che videro il successo della coalizione guidata da Berlusconi.
Mastella e tutti i co-imputati, difesi dagli avvocati Alfonso Furgiuele e Fabio
Carbonelli, sono stati assolto per tutti e tre i capi di imputazione con formula
piane, anche per i due capi per i quali il pm aveva chiesto la prescrizione:
perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste. Il capo di
imputazione principale si riferiva a una presunta concussione ai danni
dell'allora presidente della Regione Campania Antonio Bassolino. Secondo
l'iniziale impostazione accusatoria, Mastella avrebbe imposto al Governatore la
nomina di una persona da lui segnalata a commissario di una Asl, minacciando in
caso di rifiuto di ritirare due assessori Udeur dalla Giunta. Una circostanza
negata dallo stesso Bassolino nel corso del processo: l'ex presidente della
Regione affermò di non aver subito alcuna pressione. Si sarebbe trattato di
normali accordi politici. Il reato di concussione era stato derubricato dalla
Procura in una induzione indebita a dare o promettere utilità. Il Tribunale ha
ritenuto invece che si sarebbe potuto configurare un abuso di ufficio,
concludendo comunque che il fatto attribuito a Mastella non costituisce reato.
Il tribunale ha assolto con formula ampia anche la moglie di Mastella, l'ex
presidente del Consiglio regionale della Campania Sandra Lonardo nonché i due ex
assessori regionali dell'Udeur Nicola Ferraro e Andrea Abbamonte e l'ingegnere
Carlo Camilleri, consuocero dell'ex ministro della Giustizia.
Mastella, cosa significa l'assoluzione
nove anni (e otto mesi) dopo. L'ex ministro ha sempre
parlato di manovre dei servizi segreti, ma forse ha pagato la sua idea di
riforma della giustizia, scrive Maurizio Tortorella il 13 settembre 2017 su
Panorama. Non è nemmeno la prima volta che Clemente Mastella, ex ministro della
Giustizia, viene assolto. Era già accaduto l’8 marzo 2008, nell’inchiesta “Why
not” avviata dall’ex sostituto procuratore di Catanzaro (e oggi sindaco di
Napoli) Luigi De Magistris: Mastella, all’epoca Guardasigilli del governo di
Romano Prodi, era stato indagato nell’ottobre 2007 per abuso d’ufficio. Il
giudice lo aveva prosciolto scrivendo che "non vi erano neanche gli estremi per
poter iscrivere Mastella nel registro degli indagati". Certo, in quel caso erano
bastati cinque mesi. In questa seconda, grande assoluzione dall’inchiesta della
procura di Santa Maria Capua Vetere, iniziata il 16 gennaio 2008 con l’arresto
di sua moglie, invece, di mesi ne sono occorsi 116. I giornali hanno tutti
titolato stamattina sui 9 anni occorsi perché si arrivasse alla sentenza di
primo grado, ma in realtà sono stati 9 anni e otto mesi. Il reato contestato dai
pubblici ministeri nel 2008 era grave: tentata concussione ai danni dell’allora
governatore della Campania, Antonio Bassolino, per la nomina di un commissario
di Asl. Non era servito a nulla che Bassolino negasse il ricatto, parlando di
“normali trattative politiche”. Trasferito poi a Napoli, il procedimento è
andato avanti. Ma con clamorosa lentezza: sono trascorsi oltre sei anni dal
rinvio a giudizio all’assoluzione piena di ieri. Non è un record, va detto anche
questo, perché se è vero che la media nazionale dei processi di primo grado è di
6-700 giorni, ci sono comunque casi in cui le sentenze arrivano dopo sette,
otto, nove anni. Oggi Mastella, da sindaco di Benevento, protesta (giustamente)
per la sua carriera politica (ingiustamente) ridimensionata a livello nazionale.
Protesta per le sofferenze patite da lui e da sua moglie, che dopo aver patito
gli arresti domiciliari fu sottoposta anche a un raro caso di divieto di dimora
nella regione Campania. L’ex ministro aggiunge di essere sempre convinto che
dietro la vicenda “non ci siano i giudizi ma i servizi”, e questa è una vecchia
storia: “Alcuni cronisti” racconta Mastella “ricevettero una chiavetta
informatica con le mie intercettazioni da un emissario della prefettura di
Napoli”. Resta un altro sospetto, forse ancora più concreto: e cioè che Mastella
abbia pagato per il suo tentativo d’imporre una riforma della giustizia molto
poco gradita alla categoria dei magistrati: con importanti cambiamenti nel
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e una stretta alla
divulgabilità delle intercettazioni.
Mastella, sfogo a «Porta a porta»: «I
Servizi segreti dietro la mia vicenda», scrive
Mercoledì 13 Settembre 2017 ”Il Mattino di Napoli”. «Non furono i giudici ma i
servizi a farmi fuori. Nessuno dei miei colleghi ministri mi mostrò solidarietà,
tanti mi trattarono come un 'nipotino di Belzebù». Clemente e Sandra Mastella,
all'indomani della clamorosa assoluzione a loro carico, un pò spauriti uno a
fianco dell'altro nel salotto di Porta a Porta ripercorrono il racconto del loro
calvario giudiziario durato nove anni. Emozionati, a tratti in lacrime,
trattengono a stento la rabbia contro chi, in questi lunghi anni, li ha ignorati
o denigrati, in una conversazione che alterna sensazioni umane a considerazioni
politiche. «Ero un obbiettivo facile, uno piccolo e nero, meridionale della
prima repubblica...», lamenta l'ex Guardasigilli con i lucciconi. Ammette il
dolore profondo: «Credo che un Paese in cui uno si alza e finisce in galera non
vada lontano. Ora serve una riconciliazione. No a guerre tra politica e
giustizia, ma lavoriamo assieme soprattutto sui tempi del giudizio». Si leva
comunque qualche sassolino dalle scarpe che gli fa male da tanti anni: «Nessun
collega volle venire in tv a esprimermi solidarietà, anche quella ipocrita.
Nessuno tra chi era ministro grazie a me. Solo Chiti mi fu vicino al Senato». Ma
lo fa senza alcuna animosità. Solo la moglie, elegante in un completo scuro, si
lascia andare all'emozione, ma con grande dignità: «Abbiamo resistito grazie
alla grande unità della nostra famiglia, e non è un fatto scontato», sottolinea
con la voce rotta. Ma l'ex delfino di De Mita, ministro sia con Berlusconi, sia
con Prodi, non rinuncia a parlare di politica. Prima a Benevento, poi a Porta a
Porta, racconta che nelle ultime ore in tanti gli hanno offerto una candidatura.
«Non mi interessa, continuerò a fare il Sindaco di Benevento», chiarisce. Prodi
ha evitato ogni commento. Mastella si morde il labbro, non vuole polemizzare. Ma
dopo la puntata si lascia andare a un piccolo sfogo, l'unico: «Per lui è comodo
dire che cadde per colpa mia. Ma se fosse sincero dovrebbe dire che ci fu una
strategia per fotterlo portata avanti da Veltroni. Ma così metterebbe in crisi
l'Ulivo e tutta la stagione successiva. Io ero parte lesa». Un collaboratore gli
porge il cellulare. È Silvio Berlusconi che gli esprime la sua solidarietà. E lo
stesso farà con la signora. Quindi chiarisce che a suo giudizio, dietro
l'inchiesta giudiziaria, ci fu qualche manina oscura. «Ebbi subito la percezione
che ci fossero di mezzo i servizi segreti, magari deviati. E che vi fosse la
volontà di far cadere quel governo. Credo che ci fosse l'obbiettivo di colpire
me, l'anello più debole, per destabilizzare l'Italia. È certo che chi compete
con l'Italia - sintetizza - avesse la volontà di indebolirci». Complotto o non
complotto, quello che all'ex Sindaco di Ceppaloni sta a cuore oggi è difendere
l'onore suo, della sua famiglia e dei suoi elettori. «In pochi giorni venne
messo in galera un intero partito. Come se l'Udeur fosse un'associazione a
delinquere. Nemmeno la Dc, il Psi, il Pci dei tempi di tangentopoli ebbero quel
trattamento, malgrado la presenza di tangenti. Ora che è arrivata la sentenza -
sottolinea in chiusura di trasmissione - sono qui per difendere tutta quella
gente comune che mi è stata sempre vicina».
Mastella: «Voglio le scuse degli Usa.
Indagato, mi vietarono un viaggio». L’ex ministro,
incassata l’assoluzione dopo nove anni di attesa, si toglie alcuni sassolini.
Attacca il governo Usa. «La sentenza mi restituisce la dignità», scrive Cesare
Zapperi il 13 settembre 2017 su “Il Corriere della Sera”. All’indomani
dell’assoluzione, attesa nove anni, Clemente Mastella è andato a ringraziare la
Madonna delle Grazie a Benevento cui ha dedicato un cero. «Avevo fatto un voto»
ha spiegato. Poi si è dedicato alla sua tormentata vicenda giudiziaria che lo
costrinse ad abbandonare il ministero di Grazia e Giustizia e il governo Prodi.
L’attuale sindaco di Benevento ne ha per tutti. «Mi auguro che il Governo degli
Stati Uniti mi porga le scuse perché tre anni fa mi impedirono di imbarcarmi in
aeroporto a Fiumicino pur avendo il visto per gli Usa» ha detto. «Sul web
circolavano notizie false o imprecise sul mio processo. È come se per gli Stati
Uniti fossi stato un condannato, quando in realtà ero semplicemente indagato. E
quando contattai l’ambasciata mi venne sconsigliato di partire perché non
avrebbero fatto atterrare l’aereo». «Per questi motivi - ha continuato Mastella
- voglio che Wikipedia cancelli quello che è scritto nella mia pagina altrimenti
non esiterò a querelare chi diffonde notizie false su internet. Io sono stato
assolto, questo è il dato. Sono stanco di quanti hanno diffuso fake news sulla
sua vicenda giudiziaria facendomi passare come il nipote di Belzebù». «Nelle
ultime ore ho ricevuto tantissime telefonate da parte di molti magistrati,
politici (Bassolino, Casini, De Mita, Fassino, De Girolamo, ecc.), ma
soprattutto da tantissima gente comune». Così Clemente Mastella incontrando la
stampa. E alla domanda se gli avessero telefonato Prodi e Berlusconi, ha
risposto con un secco «no». Quanto al suo futuro, Mastella fa sfoggio di
serenità. «Continuerò a fare il sindaco di Benevento e a impegnarmi in politica,
nonostante le proposte di candidatura che ho ricevuto anche durante la notte. La
sentenza di ieri - ha aggiunto Mastella - mi restituisce la dignità politica,
quella personale no in quanto la gente ha sempre avuto fiducia in me e nella mia
famiglia». Poi si è soffermato sui temi della giustizia. «Non occorrono guerre
tra schieramenti o tra magistrati e avvocati, o tra giudici e politici: tutti
insieme dobbiamo lavorare per rendere la giustizia più giusta, soprattutto nei
tempi». «Su questo - ha continuato Mastella - continuerò a impegnarmi su tutti i
livelli perché mentre io, oggi, posso, attraverso i media, rendere pubblico il
dramma che ho vissuto con la mia famiglia, oltre agli amici che mi sono stati
vicini in undici anni di calvario, ci sono tanti altri cittadini che da anni
attendono giustizia». E, a riguardo, Mastella rivela che «proprio questa mattina
un imprenditore di Caserta, facendomi gli auguri per l’assoluzione, mi
confessava che lui era ancora in attesa di una sentenza da 25 anni presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere».
Ora è lady Mastella che accusa: Bindi dovrebbe
scusarsi con me. La moglie dell’ex Guardasigilli Sandra Lonardo: «Quando mi
mise tra gli impresentabili svenni», scrive Simona Brandolini il 13
settembre 2017 su "Il Corriere della Sera”. Al momento delle dimissioni in Aula,
tra i banchi del governo, c’era solo Vannino Chiti. Oggi la solidarietà è totale
e piena, o quasi. Ma non commenta Romano Prodi, uno dei pochi a non aver
telefonato a Clemente Mastella. E l’ex Guardasigilli lo sottolinea: «Allora era
facile colpevolizzarmi, io piccolo e nero, meridionale della Prima Repubblica.
Per Prodi è comodo dire che il governo cadde per colpa di Mastella. Ma se
volesse essere sincero fino in fondo dovrebbe dire che ci fu una strategia
per fotterlo, portata avanti da Veltroni. Io in quella vicenda sono stato parte
lesa». Clemente Mastella comincia a svelare qualche retroscena di una vicenda
che dal punto di vista umano e politico ha travolto la sua famiglia e il suo
partito, l’Udeur. «Credo che dietro la mia vicenda non ci siano i giudici ma i
servizi: i cronisti ricevettero i file delle mie intercettazioni a Napoli da uno
della prefettura. E questo la dice lunga». Il Mastella day comincia con la
visita al Santuario di Ceppaloni, prosegue con una conferenza stampa a
Benevento, città di cui è il sindaco, e termina a Roma, negli studi di Porta a
Porta. Al suo fianco Sandra Lonardo, sua moglie, anche lei assolta.
Signora Lonardo, l’inchiesta riguardava
presunte irregolarità nelle nomine della sanità. Sua era la frase riferita al
manager dell’Asl di Caserta Luigi Annunziata: «Per me è un uomo morto». La
ripeterebbe?
«Ho chiesto un parere all’Accademia della Crusca
che mi ha dato ragione. Dire “è un uomo morto” significa “non lo voglio più
vedere”. Certo che lo ripeterei. Non mi pento mai delle cose che dico».
Dopo dieci anni di processo cosa pensa di aver
perso?
«Mi sono chiesta tante cose. Certo dovrei essere
felice, sono più tranquilla, ma non è una bella giornata. Sono stati anni di
disperazione, di dolore, è cambiato tutto. Io ero presidente del Consiglio
regionale, Clemente ministro della Giustizia, un partito si è sciolto come neve
al sole. Niente e nessuno potrà mai ripagarci. Ci vorrebbe una class action».
Ha detto spesso di sentirsi umiliata,
l’assoluzione potrà cancellare tutto questo?
«San Filippo Neri utilizzava la metafora del pollo
spennato. La maldicenza e la calunnia non si possono mai recuperare del tutto,
come le penne sparse. L’80% delle persone è solidale con noi, ci stima. Ma ci
sarà sempre un 20% per il quale saremo colpevoli».
All’epoca lei era in Consiglio regionale. Ma
scattarono prima gli arresti domiciliari e poi il divieto di dimora in
Campania.
«Un incubo. Se non avessi avuto l’aiuto di due
psicologici non l’avrei superata. Feci la campagna elettorale da Roma, con
un avatar, grazie al web. Hanno scritto due tesi di laurea su quella scelta. Ora
scriverò un libro, c’è tanto da raccontare».
Crede nella giustizia?
«Certo, ho creduto anche nel pm che mi ha messo
sotto inchiesta. Ho sempre avuto rispetto di tutte le istituzioni. Ma serve una
seria riforma della giustizia e anche la modifica di alcune leggi, cominciando
dalla Severino».
Nel 2015, si ripresentò alle elezioni e finì
nella lista degli impresentabili della commissione Antimafia, presieduta da Rosy
Bindi.
«Senza nessuna condanna, Rosy Bindi dovrebbe
dimettersi se ha una coscienza. Ma non ne ha. Ha giocato con la vita delle
persone. Quantomeno dovrebbe chiedermi scusa. Svenni quando un giornalista me lo
disse al telefono».
Cosa fa più male perdere, il potere o la
dignità?
«Entrambe le cose quando sei in sella».
Tornerà a fare politica?
«Non so rispondere ora. Per anni mi sono occupata
di altro. La cucina, il cibo. Tra un po’ lancio una mia linea di prodotti
tipici».
Biografia di Clemente Mastella
da Alberto Spada.
• Ceppaloni (Benevento) 5 febbraio 1947. Politico.
Sindaco di Benevento dal 20 giugno 2016. Eletto alla Camera nel 1976, 1979,
1983, 1987, 1992, 1994, 1996, 2001 (Dc, Ccd, Margherita), al Senato nel 2006
(Udeur), al Parlamento Europeo nel 2009 (Pdl, ricandidato e non eletto nel 2014
con Fi). Sottosegretario alla Difesa nell’Andreotti VI e VII (1989-1992). Già
ministro del Lavoro nel Berlusconi I (1994-1995), ministro della Giustizia nel
Prodi II (2006-2008): le sue dimissioni portarono alla caduta del governo e alla
fine della XV legislatura. «Conosce la storia del castoro? Quella citata da
Gramsci? Un tempo, il castoro era molto ricercato dai cacciatori, perché dai
suoi testicoli si traeva una sostanza considerata miracolosa. Quando il povero
animale si vedeva circondato, si strappava i testicoli e li gettava ai
cacciatori, per aver salva la vita. Ecco, quel castoro sono io. Quando mi sono
visto circondato da giudici, giornalisti, servizi segreti, ho lasciato il
ministero, insomma mi sono strappato i testicoli. E mi hanno risparmiato» (ad
Aldo Cazzullo).
• «Da quando, nel 1976, è entrato in politica, ha
fatto il deputato, il senatore e l’eurodeputato ininterrottamente. Un primato.
L’uomo di Ceppaloni non colleziona soltanto seggi. Ma anche partiti: ne ha
fondati una mezza dozzina; è stato nella Dc ed è in Forza Italia. Ha un debole
per le poltrone di governo: due volte sottosegretario e due volte ministro.
Nelle cerimonie pubbliche usa il risvolto dei pantaloni per pulirsi le scarpe.
Confonde le Mura di Gerico con il Muro del pianto. Ed è persino convinto che
Mosè abbia attraversato il Mar Rosso da solo» (Guido Quaranta) [Esp 2/5/2014].
• Figlio di un maestro, laureato in Filosofia
(«primo in una famiglia di analfabeti»), giornalista, lavorò in Rai e fu capo
dell’ufficio stampa della Democrazia cristiana guidata da Ciriaco De Mita: il
segretario faceva “ragionamenti” e lui «li traduceva in notizie per gli amici
giornalisti. Tanti». «Cordialone con i cronisti ossequiosi e arrogante con gli
altri, era soprannominato “la voce del padrone”». Al congresso della Dc del
febbraio 1989 si guadagnò gli onori delle cronache e di un neologismo, le
“truppe mastellate”, coniato da Giampaolo Pansa per lo zelo con cui organizzò e
diresse la claque.
• Nel ’93 tentò lui stesso di fare il segretario
della Dc, proponendosi come il simbolo del rinnovamento. «Più che il nuovo che
avanza, è l’avanzo del vecchio», commentò il suo compagno di partito Hubert
Corsi.
• «A Montecitorio dal ’76 (fino al 2008, quando
non si è ricandidato, nonostante l’offerta di un posto da capolista nelle liste
del Psi – ndr), si è segnalato, come legislatore, per tre idee. Ha proposto di
introdurre la settimana corta nelle scuole per consentire agli studenti e ai
loro genitori di godersi un lungo fine settimana. Ha suggerito di far suonare
l’inno nazionale all’avvio di ogni partita di calcio non solo come antidoto alle
violenze negli stadi ma anche per dare solennità agli incontri. E ha auspicato
l’istituzione di un tribunale speciale per i giornalisti sfrontati con i
potenti. Nessuna di queste idee è stata presa sul serio» (Guido Quaranta).
• Nel ’98 raccolse l’appello dell’ex presidente
Francesco Cossiga, si staccò dal Ccd e diede vita ai Cristiano democratici per
la Repubblica, presto confluiti nell’Udr (di cui diventò segretario). L’Udr
diede la fiducia al governo D’Alema. Dopo circa un anno trasformò il progetto
iniziale in Udeur (Unione democratici per l’Europa) lavorando al progetto di un
grande centro. Quindi strinse un accordo con l’Ulivo e si presentò col
centrosinistra («un centro-sinistra scritto col trattino, anzi col trattone»)
alle regionali del 2000. • «Incarnazione del centro del centro del
centrosinistra, che però, all’occorrenza, potrebbe trasformarsi nel centro del
centro del centrodestra» (Antonio Padellaro). Contrario al referendum sulla
legge elettorale (che avrebbe cancellato la sua Udeur, ferma all’1,5 per cento),
minacciò più volte di uscire dal governo e di costringere il Paese al voto
anticipato per evitarlo. Salvo poi tornare sui suoi passi dichiarando
l’intenzione di rifondare un partito cattolico di centro insieme a Casini.
• Fu l’unico ministro a non votare il disegno di
legge sui Dico varato dal governo. E in una puntata di Anno zero dedicata
proprio ai Dico, provocato da una vignetta di Vauro, per protesta se ne andò
dallo studio in diretta tv (il conduttore Michele Santoro lo attaccò, Vauro da
allora in poi lo soprannominò “madre Mastella di Calcutta”). Nel maggio 2007 fu
uno dei due ministri che parteciparono al Family Day (l’altro era Beppe
Fioroni).
• Sull’esperienza nel Prodi II: «L’indulto: nasce
dall’accordo tra i grandi partiti, e l’hanno gettato addosso a me. Il volo di
Stato (per andare al Gp di Monza del settembre 2007, ci fu anche un’inchiesta
per abuso d’ufficio poi archiviata, ndr): avevo chiesto il permesso alla
presidenza del Consiglio! Che fastidio dava mio figlio su un aereo che tiene
cento persone! Vallettopoli: una sera mi telefona un cronista del Secolo XIX e
mi chiede se sono io il politico in barca con due donne e un trans. Passi per le
donne, ma il trans! Che schifo! Incontro per caso al Bolognese Lele Mora, lo
saluto, e la Guardia di finanza fa irruzione al ristorante per sapere se mi ha
pagato il conto! Compro la casa a Roma che affitto da 33 anni, e mi massacrano.
Vado al Columbus Day, e trovo contestatori anche lì. Una manovra di
avvolgimento: Santoro, Travaglio, l’Espresso, Grillo... Sono stato il loro
Mamurio Veturio, il personaggio che nell’antica Roma veniva vestito di pelli e
cacciato a bastonate, per purificare l’intera comunità».
• Al momento dell’approvazione dell’indulto, nel
luglio 2006, Mastella manifestò comunque commozione ed esultanza, ricordando il
forte appello in questa direzione di Giovanni Paolo II a Camere riunite («ci
benedice dal cielo», disse). L’indulto (provvedimento di clemenza che estingue o
diminuisce la pena senza cancellare il reato) fu deciso soprattutto per
alleggerire la situazione insostenibile delle carceri: oltre 60 mila detenuti a
fronte di una capienza regolamentare di 43 mila. Passò con il consenso dei due
terzi del Parlamento (indispensabili per questo tipo di legge), vale a dire
anche con i voti di Forza Italia e Udc, che pretesero peraltro che fossero
inclusi nel perdono i reati finanziari. Nel governo Di Pietro votò contro, e fu
la prima grande frattura con il Guardasigilli. Qualche mese più tardi anche il
ministro dell’Interno Amato si disse pentito. Oltre 24 mila persone risultarono
beneficate, i reati registrarono un aumento, molti tornarono in carcere. Un anno
dopo i detenuti erano già 47 mila.
• Nell’ottobre 2007 il pm di Catanzaro Luigi De
Magistris fece sapere di aver messo Mastella sotto inchiesta, insieme al premier
Prodi, per abuso d’ufficio, finanziamento illecito ai partiti, concorso in
truffa nell’ambito di finanziamenti europei e nazionali. La decisione del
procuratore capo di Catanzaro di avocare a sé il fascicolo scatenò un duro
scontro con Di Pietro, che accusò Mastella di interferenza nel lavoro del
magistrato (già sotto inchiesta del Csm per volere del Guardasigilli).
• Il 16 gennaio 2008 il terremoto giudiziario che
coinvolge gran parte della famiglia e l’Udeur campana. Mastella è indagato per
concussione, falso e concorso esterno in associazione per delinquere. La moglie
Alessandrina Lonardo (Ceppaloni 9 marzo 1953), presidente del consiglio
regionale della Campania, viene messa agli arresti domiciliari (venendolo a
sapere dalla tv) con l’accusa di tentata concussione nei confronti del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e Sebastiano di Caserta, Luigi
Annunziata. Arresti domiciliari anche per il sindaco di Benevento Fausto Pepe e
due assessori e due consiglieri regionali, tutti fedelissimi di Mastella. Fra i
quattro finiti in carcere c’è poi il consuocero, Carlo Camilleri. L’inchiesta è
della procura di Santa Maria Capua Vetere: «Dallo scenario disegnato
nell’ordinanza del gip - che parla di “un vero e proprio sistema illecito che
lascia francamente basiti per i metodi sfacciatamente irregolari con cui veniva
esercitato” - l’Udeur in Campania appare più che un partito politico, una lobby
dedita a occupare posti di potere» (Fulvio Bufi).
• La signora Mastella sulla vicenda giudiziaria
che l’ha vista protagonista (intervistata da Maria Corbi): «Io non ho mai
raccomandato nessuno. Vedo messo in discussione tutto il lavoro che ho fatto in
questi anni per due medici che non ho mai raccomandato. Peraltro non mi pare che
la raccomandazione sia un reato e in ogni caso chi è senza peccato scagli la
prima pietra». E la storia di Annunziata che per lei, da intercettazione,
sarebbe “un uomo morto”? «Significava che con quella persona non voglio
personalmente averci più nulla a che fare».
• «“Nella buona e nella cattiva sorte”: non poteva
che andare così, la love story di Clemente & Alessandrina, sancita quando lui
diede a lei il primo bacio sulla spiaggia newyorkese di Oyster Bay, Long Island.
Insieme al catechismo, insieme nella gioventù cattolica, insieme all’altare,
insieme nella scalata al potere, insieme nei guai giudiziari. Roba da
fotoromanzi d’altri tempi. Quelli in cui lui dice a lei: “Salvati! Sono
perduto!” E lei: “Mai! Piuttosto morta!”» (Gian Antonio Stella).
• Gli arresti domiciliari per la moglie, che venne
a saperlo dalla tv, furono forse la goccia che fece traboccare il vaso. «Per non
dimettersi da Guardasigilli, con conseguente crisi di governo, il segretario
dell’Udeur aveva chiesto la solidarietà del centrosinistra al completo. Il
premier Romano Prodi e il ds Max D’Alema erano dispostissimi a prestarla. Non
però Antonio Di Pietro, che lo detesta. Era il pomeriggio di martedì 22 gennaio
2008. L’indomani il governo andava incontro a un altro problema: il voto sul
ministro Alfonso Pecoraron Scanio che il centrodestra voleva sfiduciare.
Clemente minacciò: “Se non date la solidarietà a me, l’Udeur non darà la fiducia
a lui”. Come dire, se anche non mi dimetto, il governo cade lo stesso. Era un
buon motivo di pressione su Di Pietro che Prodi poteva fare valere. Ci si stava
lavorando, quando dal Sannio, feudo mastelliano, arriva a Clemente la drammatica
telefonata dei suoi: “Cleme’ statt’ accuorte, oltre ad arrestare tua moglie e
Pellegrino, il tuo consuocero, i giudici stanno intercettando i cellulari dei
tuoi figli e di tua nuora”. Bianco in volto e fremente, il guardasigilli è
sbottato: “È un assedio. Vogliono la nostra ecatombe. Vaffan’ tutti quanti” e si
è dimesso all’istante trascinando con sé l’intero gabinetto. La magistratura e i
suoi metodi avevano fatto il colpo grosso. A questo punto, indette le elezioni,
Clemente aveva ancora carte da giocare. Ma le ha buttate tutte, in un crescendo
di cupio dissolvi. Per salvare sé e l’Udeur, ha iniziato il giro delle sette
chiese. Incontra per primo il Cav che lo accoglie con benevolenza e gli promette
l’elezione di un numero di parlamentari sufficiente a fare sopravvivere il suo
partito. Ma, stretto il patto tra loro, l’altro big del Pdl, Gianfranco Fini,
s’impanca e lo boccia. Un provvidenziale sondaggio fa sapere che l’ingresso di
Mastella procurerebbe la perdita di 10 punti al centrodestra. “Mi spiace, non
posso più” gli spiega il Cav. Clemente comincia a sentirsi in braghe di tela, ma
ci riprova con gli ex dc sparsi ai quattro venti. “Siamo gente di parrocchia, ci
capiremo” si dà coraggio. E va da Pier Ferdinando Casini nel momento peggiore.
Costui era a sua volta umiliato e offeso per essere stato accolto con
condiscendenza nella Rosa bianca, il neopartito dei suoi due transfughi, Bruno
Tabacci e Mario Baccini. Nervosetto assai, Pierferdy gli risponde picche. Il
povero Clemente entra allora nell’idea di sciogliere l’Udeur» (Giancarlo Perna).
• Nell’aprile 2008 il Gip di Catanzaro ha
archiviato la posizione di Clemente Mastella, indagato per abuso d’ufficio dal
pm Luigi de Magistris nell’ambito dell’inchiesta Why not sulle presunte frodi
milionarie ai danni dell’Unione europea, perché mancavano i presupposti per
l’iscrizione nel registro degli indagati: «Contento? Intanto mi hanno ammazzato
politicamente. Chi mi ripagherà adesso?».
• Nel marzo 2011 è stato rinviato a giudizio,
assieme alla moglie Sandra Lonardo, per truffa e appropriazione indebita (per
l’acquisizione di due appartamenti a Roma di proprietà dell’Udeur e della
testata giornalistica Il Campanile) e per abuso d’ufficio (per l’assegnazione di
incarichi da parte dell’Arpac, l’agenzia regionale di protezione ambiente).
• Nell’aprile 2014 rinviato a giudizio dalla
procura di Napoli per associazione a delinquere insieme alla moglie e a 17 ex
dirigenti dell’Udeur. Secondo l’accusa, l’attività dei vertici dell’Udeur in
Campania era finalizzata «alla commissione di una serie indeterminata di delitti
contro la pubblica amministrazione, e soprattutto all’acquisizione del controllo
delle attività pubbliche di concorso per il reclutamento di personale e gare
pubbliche per appalti e acquisizioni di beni e servizi bandite da Enti
territoriali campani, Aziende sanitarie e Agenzie regionali, attraverso la
realizzazione di numerosi reati».
• Nel 2010 ha sciolto l’Udeur e dato vita al
movimento Popolari per il Sud, che «intende colmare il vuoto politico nel sud a
livello locale, confermando al contempo la strategica alleanza con il Pdl».
• Un debole per le citazioni colte che gli ha
causato qualche gaffe, da ultimo nel gennaio del 2008 quando, durante il
discorso in parlamento con cui rassegnava le sue dimissioni da ministro,
attribuì al poeta cileno Pablo Neruda versi della scrittrice brasiliana Martha
Medeiros («Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine» ecc.).
• I tre figli si chiamano Elio (nel 2008
protagonista di uno scontro con la Iena Alessandro Sortino su chi fosse più
raccomandato), Pellegrino (protagonista il 29 luglio 2006 di uno storico
matrimonio con 600 invitati, nello stesso periodo fu tirato in ballo
nell’inchiesta sulla Gea, vicenda alla quale risultò peraltro del tutto
estraneo, vedi Alessandro Moggi), Sasha (bielorussa adottata quando aveva 8
anni).
GIORGIO DELL’ARTI, scheda aggiornata al 21 giugno
2016
“Siamo tutti Mastella”:
di Marco Travaglio. (di Marco Travaglio – Il Fatto Quotidiano) – Ieri, tra le
varie telefonate di strani “colleghi” a caccia di un mio commento, anzi di un
mio pentimento per l’assoluzione di Mastella, come se l’avessi indagato e
rinviato a giudizio io, mi chiama uno dei miei avvocati. Mi racconta di un
processo a mio carico per diffamazione a proposito di un mio trafiletto del
lontano 2010 (una giornalista del Tg1 che aveva diffuso dati imprecisi sul
numero delle intercettazioni), ancora in udienza preliminare. E mi chiede
elementi per dimostrare la fondatezza di ciò che scrissi sette anni fa. Per
fortuna ho un buon archivio e riesco a trovare i dati necessari a difendermi. In
34 anni di carriera ho subìto quasi 200 processi (e non so quante indagini:
molte querele vengono archiviate all’insaputa del querelato) per diffamazione e,
a parte una multa di mille euro (a Previti!), sono sempre stato assolto. Dunque
dovrei strillare ogni giorno alla persecuzione giudiziaria, alla gogna
mediatica, al giustizialismo a tutto l’armamentario del finto garantismo
italiota – scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano nell’editoriale di oggi
14 settembre 2017, dal titolo “Siamo tutti Mastella”. Naturalmente me ne sto
zitto, mi difendo nei processi, spendo un capitale in avvocati (che devo pagarmi
anche quando le querele vengono archiviate, grazie ai nostri legislatori
“garantisti”) e mi faccio una cultura in diritto e procedura penali. Per
esempio, ho imparato a distinguere tra fatti e reati: i processi per
diffamazione non devono accertare se ho davvero scritto una certa cosa (che è lì
stampata, a disposizione di chiunque voglia valutarla), ma se quella cosa sia o
meno diffamatoria. E a quel punto parte il terno al lotto, a seconda del
giudice, nulla essendo più aleatorio e soggettivo di concetti come la
“continenza”, il diritto di satira o di critica (se fai una battuta, devi
sperare che il giudice la capisca). Un’altra cosa che ho imparato è che la
legittimità di un’indagine non dipende dalla sentenza: altrimenti 199 delle 200
inchieste a mio carico sarebbero state infondate solo perché seguite da
altrettante assoluzioni, e io dovrei domandarmi cosa ho fatto di male per stare
sulle palle a decine di Procure. Le indagini nascono da una notizia di reato:
una querela, una denuncia, un’inchiesta della polizia giudiziaria, un’iniziativa
del pm, un articolo di giornale, un’inchiesta tv. Quando le aprono, i pm non
sanno se il reato c’è né chi l’ha commesso: indagano apposta per scoprirlo. Se
poi pensano di avere trovato il reato e il colpevole, chiedono il rinvio a
giudizio al gup che, se ritiene che esistano elementi sufficienti per un
processo, lo dispone. Accade ogni giorno a migliaia d’italiani e nel 2008 capitò
anche a Clemente Mastella e alla moglie Sandra Lonardo. Lui era ministro della
Giustizia del governo Prodi, lei presidente del Consiglio regionale della
Campania. La Procura di Santa Maria Capua Vetere li indagò (la signora finì pure
ai domiciliari) insieme allo stato maggiore dell’Udeur campana, in base a
intercettazioni e testimonianze sulla presunta gestione clientelare di cariche
pubbliche (Asi e Asl) e appalti (Arpac). Mastella, furibondo col premier e la
maggioranza, a suo dire non abbastanza solidali, si dimise da Guardasigilli e
poi ritirò l’Udeur dal centrosinistra, tornando al centrodestra e facendo cadere
il governo. L’inchiesta passò per competenza alla Procura di Napoli, che la
biforcò in due filoni: uno minore (Asi e Asl: concussione e abuso d’ufficio),
approdato l’altroieri all’assoluzione di tutti gli imputati; l’altro più grave
(Arpac: presunti falsi, concussioni, turbative d’asta, abusi e un’associazione a
delinquere prima confermata e poi bocciata dalla Cassazione), ancora in
dibattimento. Dunque è presto per dire che l’inchiesta del 2008 fosse basata sul
nulla. Sia perché manca la sentenza principale, sia perché il dispositivo di
quella appena emessa non esclude che i fatti esistessero. Mastella era accusato
di aver concusso l’allora governatore Bassolino per costringerlo a nominare un
amico all’Asi di Benevento: il pm ha riformulato la concussione in induzione
indebita (perché nel 2012 la legge Severino ha modificato e in parte svuotato il
primo reato), che poi il Tribunale ha derubricato in abuso d’ufficio, salvo poi
concludere sorprendentemente che “il fatto non costituisce reato” (ma allora
perché dire che era un abuso? Lo scopriremo dalle motivazioni). La signora
Mastella era accusata di tentata concussione a Luigi Annunziata, il manager
dell’ospedale di Caserta (“per me è un uomo morto”) che resisteva a presunte
pressioni clientelari Udeur: anche quel fatto parrebbe accertato, anche se per i
giudici “non è previsto dalla legge come reato” (per la Severino o per cosa? Lo
sapremo dalle motivazioni). […]
Mastella: Travaglio condannato a risarcimento da
10mila euro, scrive il 19 maggio 2014 "Editoria TV". Il Tribunale di Benevento
ha condannato il giornalista Marco Travaglio ed “Il Fatto Quotidiano” al
risarcimento in favore di Clemente Mastella di 10mila euro e l’editore alla
pubblicazione della sentenza su tre quotidiani nazionali. I fatti risalgono al
23 novembre 2010 allorquando Travaglio su “Il Fatto Quotidiano”, scrisse un
articolo dal titolo: “Salvate il soldato Mastella”, articolo che
l’allora segretario nazionale dell’Udeur, ritenne riportasse notizie non
veritiere e per questo lo querelò. Alla richiesta di commentare l’esito della
sentenza, Mastella ha risposto con un secco “no comment” salvo poi affidare, più
tardi, ad un comunicato il suo pensiero: “Poco alla volta la verità si fa
strada. Dopo l’assoluzione piena di alcuni giorni fa, oggi un altro giudice mi
dà ragione, riconoscendo la diffamazione nei miei confronti. Una ragione in più
per guardare avanti con serenità e determinazione”.
CULTURA E CIVILTA’ GIURIDICA. CESARE BECCARIA.
DEI DELITTI E DELLE PENE.
“Dei delitti e delle pene”
di Cesare Beccaria, scrive Vincenzo Vitale il 10 Agosto 2017 su "Il Dubbio". Da
oggi, tutti i giorni, pubblichiamo a puntate «Dei delitti e delle pene», il
capolavoro di Cesare Beccaria che cambiò la storia del diritto occidentale. Da
oggi, tutti i giorni, pubblichiamo a puntate «Dei delitti e delle pene», il
capolavoro di Cesare Beccaria che cambiò la storia del diritto occidentale.
Cesare Bonesana Beccaria, Marchese di Gualdrasco e di Villareggio, nasce al
centro di Milano, in via Brera, il 15 marzo 1738. Suddito quindi dell’impero
asburgico, studia dai gesuiti e si laurea a vent’anni a Pavia in Giurisprudenza
e, pur di sposare Teresa Blasco, rompe con la famiglia. Il celebre pamphlet di
cui Beccaria è autore – Dei delitti e delle pene – che si presenta qui,
rappresenta probabilmente il frutto più maturo di quell’illuminismo giuridico e
sociale lombardo che si era raccolto attorno alla Accademia dei Pugni e alla
celebre rivista Il Caffè. Accademia e rivista che ebbero vita breve di qualche
anno appena, ma che comunque riuscirono a segnare in modo incisivo uno snodo
fondamentale della cultura giuridica e politica europea della metà del
settecento, quello che non a caso è stato definito da molti e attenti studiosi
il secolo riformatore. Il celebre libello va letto e inquadrato dunque
all’interno di questa cornice culturale che trasse il suo primo alimento
dall’illuminismo francese, anche se bisogna sempre rifuggire dagli schematismi
eccessivi e pervasivi: per esempio, come è noto, l’illuminismo europeo non fu
certo soltanto di matrice francese (basti pensare a Kant, il quale peraltro
nella Metafisica dei Costumi criticò aspramente Beccaria), come, del resto, il
romanticismo non fu soltanto tedesco (basti pensare a Rostand). Rimane il fatto
comunque che Beccaria era affascinato da Rousseau, da d’Alembert, da d’Holbach,
da Diderot, al punto da mostrare nei confronti di codesti esponenti della
filosofia dei lumi una sorta di timore reverenziale che si trasformò poi –
quando divenuto celebre si recò a Parigi con Alessandro e Pietro Verri, da loro
medesimi invitato – in una strana nevrosi, ragion per cui repentinamente fece
ritorno a Milano. E tanto immotivatamente, da suscitare lo sconcerto dei suoi
illustri ospiti oltre che il malumore dei Verri, i quali evidentemente
immaginavano per l’illustre amico ben altri trionfi nei salotti parigini che
invece non ci furono mai. Eppure, di quei trionfi ci sarebbe stata ragione in
quanto la riflessione di Beccaria, pubblicata all’inizio del 1764, inaugura una
nuova pagina nel diritto penale europeo: quella del contrattualismo di matrice
utilitaristica che fa da argine al potere assoluto del monarca. In qualche modo
rivoluzionario e pericoloso per il potere asburgico dunque il libro di Beccaria,
tanto che la censura se ne accorse e ne arginò in parte gli effetti
(sottovalutandoli), vietandone la pubblica vendita tranne che “per la gente
dotata di giudizio”: una sorta di censura di seconda categoria, quasi inutile in
punto di fatto. Si è detto contrattualismo: ed infatti la visione di Beccaria si
inserisce nel solco di quelle correnti culturali (si pensi a Rousseau o a
Bentham) che vedono nello Stato il risultato di un contratto sociale, stipulato
fra i sudditi che cedono al Sovrano pezzi della loro libertà in cambio della
sicurezza interna ed esterna. In quanto tale, il contrattualismo si oppone
all’organicismo, visione tradizionale della filosofia politica, in virtù della
quale lo Stato possiede una sua autonoma fisionomia che va come tale conosciuta
e riconosciuta: esso è appunto organico. E si è detto anche utilitarismo, per
significare che i patti che da quel contratto scaturiscono sono razionali, in
quanto utili sia ai singoli, sia alla collettività ed al monarca stesso, ben più
di quanto possa esserlo il potere dispoticamente esercitato dal Sovrano
assoluto. Insomma, la Sovranità, per essere utile, deve essere razionale e per
essere razionale deve nascere da un patto fra sudditi e Sovrano, un patto chiaro
e da tutti comprensibile e soprattutto da tutti accettabile. Da qui, ovviamente,
la necessaria moderazione delle pene e la contrarietà alla pena di morte, in
quanto le pene estreme sono non utili perché irrazionali. Idee, come si vede,
per noi ben note, anche se oggi da riscoprire perché poco praticate; e questo
rende addirittura necessaria la pubblicazione di Beccaria alla quale ci si
accinge. Idee nuovissime a quel tempo, tanto che Caterina II di Russia gli offrì
la presidenza di una commissione per la riforma del codice penale largamente
ispirata al suo pensiero, che però egli – come sempre incerto e restio ad
assumere ruoli di primo piano – finì col rifiutare. Beccaria finì i suoi giorni
in modo quasi oscuro, nominato burocrate presso il Supremo Consiglio di
Economia. Le sue pagine invece gli sopravvissero e intrisero molte delle riforme
europee del codice penale e di procedura penale, benchè pesantemente osteggiate
da alcuni ecclesiastici: Padre Ferdinando Facchinei si scagliò contro
violentemente, ma Padre Frisi le apprezzava e diffondeva. Oggi tuttavia vanno
ricordate a coloro che sembrano averle dimenticate. E non sono pochi.
DEI DELITTI E DELLE PENE. A CHI LEGGE. Alcuni
avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe
che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co’ riti
longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti,
formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell’Europa ha
tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d’oggi che una
opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con
iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui con sicurezza
obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli
uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de’ secoli i piú barbari, sono
esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale, e
i disordini di quelle si osa esporli a’ direttori della pubblica felicità con
uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua
indagazione della verità, quella indipendenza delle opinioni volgari con cui è
scritta quest’opera è un effetto del dolce e illuminato governo sotto cui vive
l’autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità che ci reggono, amano
le verità esposte dall’oscuro filosofo con un non fanatico vigore, detestato
solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione;
e i disordini presenti da chi ben n’esamina tutte le circostanze sono la satira
e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e de’ suoi
legislatori. Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben
comprendere lo scopo a cui è diretta quest’opera, scopo che ben lontano di
diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se piú che la forza
può negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l’umanità la giustificano agli
occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano
su confuse nozioni, e mi obbligano d’interrompere per un momento i miei
ragionamenti agl’illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni
adito agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna invidia. Tre
sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e politici regolatori
degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della
società. Non vi è paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di
lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di
questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell’ultima non è l’escludere i
rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benché divine ed immutabili,
furono per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni
di vizio e di virtú in mille modi nelle depravate menti loro alterate, cosí
sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò
che nasca dalle pure convenzioni umane, o espresse, o supposte per la necessità
ed utilità comune, idea in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve
necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrappresa quella che sforza
anche i piú pervicaci ed increduli a conformarsi ai principii che spingon gli
uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtú e di
vizio, religiosa, naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere
in contradizione fra di loro, ma non tutte le conseguenze e i doveri che
risultano dall’una risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la rivelazione
lo esige la legge naturale, né tutto ciò che esige questa lo esige la pura legge
sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa
convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini, perché tale è il
limite di quella forza che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo senza
una speciale missione dell’Essere supremo. Dunque l’idea della virtú politica
può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtú naturale sarebbe sempre
limpida e manifesta se l’imbecillità o le passioni degli uomini non la
oscurassero; quella della virtú religiosa è sempre una costante, perché rivelata
immediatamente da Dio e da lui conservata. Sarebbe dunque un errore l’attribuire
a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse principii
contrari o alla legge naturale o alla rivelazione; perché non parla di queste.
Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello stato di
società, lo prendesse nel senso hobbesiano, cioè di nessun dovere e di nessuna
obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione
della natura umana e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore
l’imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto
sociale, di non ammetterle prima del patto istesso. La giustizia divina e la
giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perché la
relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana,
o sia politica, non essendo che una relazione fra l’azione e lo stato vario
della società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società
quell’azione, né ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e
mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sí tosto che questi principii
essenzialmente distinti vengano confusi, non v’è piú speranza di ragionar bene
nelle materie pubbliche. Spetta a’ teologi lo stabilire i confini del giusto e
dell’ingiusto, per ciò che riguarda l’intrinseca malizia o bontà dell’atto; lo
stabilire i rapporti del giusto e dell’ingiusto politico, cioè dell’utile o del
danno della società, spetta al pubblicista; né un oggetto può mai pregiudicare
all’altro, poiché ognun vede quanto la virtú puramente politica debba cedere
alla immutabile virtú emanata da Dio. Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi
delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principii distruttori
o della virtú o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei
principii, e in vece di farmi incredulo o sedizioso procuri di ritrovarmi
cattivo logico o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che
sostenga gl’interessi dell’umanità; mi convinca o della inutilità o del danno
politico che nascer ne potrebbe dai miei principii, mi faccia vedere il
vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia
religione e della sommissione al mio sovrano colla risposta alle Note ed
osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe
superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini
onesti e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principii, di
qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che cerca di
rispondere quanto un pacifico amatore della verità.
INTRODUZIONE. Gli uomini lasciano per lo piú in
abbandono i piú importanti regolamenti alla giornaliera prudenza o alla
discrezione di quelli, l’interesse de’ quali è di opporsi alle piú provide leggi
che per natura rendono universali i vantaggi e resistono a quello sforzo per cui
tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e
della felicità e dall’altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo
esser passati framezzo mille errori nelle cose piú essenziali alla vita ed alla
libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all’estremo, non
s’inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le piú
palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti
volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni
tutte di un pezzo, piú per tradizione che per esame. Apriamo le istorie e
vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non
sono state per lo piú che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da
una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore
della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una
moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: la massima
felicità divisa nel maggior numero. Felici sono quelle pochissime nazioni, che
non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane
facesse succedere all’estremità de’ mali un avviamento al bene, ma ne
accelerarono i passaggi intermedi con buone leggi; e merita la gratitudine degli
uomini quel filosofo ch’ebbe il coraggio dall’oscuro e disprezzato suo gabinetto
di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili
verità. Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e
fralle diverse nazioni; il commercio si è animato all’aspetto delle verità
filosofiche rese comuni colla stampa, e si è accesa fralle nazioni una tacita
guerra d’industria la piú umana e la piú degna di uomini ragionevoli. Questi
sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno
esaminata e combattuta la crudeltà delle pene e l’irregolarità delle procedure
criminali, parte di legislazione cosí principale e cosí trascurata in quasi
tutta l’Europa, pochissimi, rimontando ai principii generali, annientarono gli
errori accumulati di piú secoli, frenando almeno, con quella sola forza che
hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza,
che ha dato fin ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i
gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i
barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non
provati o chimerici, la squallidezza e gli orrori d’una prigione, aumentati dal
piú crudele carnefice dei miseri, l’incertezza, doveano scuotere quella sorta di
magistrati che guidano le opinioni delle menti umane. L’immortale Presidente di
Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L’indivisibile verità mi
ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand’uomo, ma gli uomini
pensatori, pe’ quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me
fortunato, se potrò ottenere, com’esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e
pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce fremito con cui
le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl’interessi della umanità!
Distinguere tra reato e peccato,
scrive Vincenzo Vitale l'11 Agosto 2017, su "Il Dubbio". Probabilmente, il
merito più significativo di Beccaria è quello di aver distinto in modo netto e
inequivocabile fra peccato e reato, cosa che oggi sembra semplice affermare,
mentre non lo era affatto due secoli e mezzo fa. L’ordine del mondo, per
Beccaria, è retto da sistemi diversi – quello religioso e quello civile – che
non debbono assolutamente intersecarsi l’un l’altro: il potere politico deve
interessarsi soltanto dei reati, mai, per dir così, dell’anima del reo,
territorio riservato alla religione. Ne viene che, quando si commettono reati,
per Beccaria occorrono quelli che egli definisce in modo alquanto sibillino
“motivi sensibili”, capaci di distogliere dalla commissione di illeciti penali,
e che altro non sono se non “le pene stabilite contro gli infrattori delle
leggi”. Beccaria spiega subito che si tratta di motivi “sensibili”, in quanto
“percuotono i sensi”, vale a dire che sono percepibili in modo diretto sulla
pelle di coloro che ne siano i destinatari. Seguendo Montesquieu, la pena è
legittima soltanto se assolutamente necessaria: altrimenti è tirannica. Beccaria
parla ovviamente di diritto di punire da parte del Sovrano, evitando di fare un
passo in più, come poi avrebbe fatto Kant, il quale teorizza invece un autentico
“dovere di punire” da parte dello Stato: eppure il suo discorso avrebbe condotto
di filato proprio a questo esito, vale a dire a riconoscere come il potere
sovrano stesso sia al servizio delle leggi, invece che esserne padrone: e se ne
è al servizio, il Sovrano non tanto ha il diritto di punire, quanto il dovere.
Ma Beccaria non giunge a tanto, preferendo invece sottolineare come le pene
siano dovute per giustizia e come questa debba intendersi in senso formale e
giuridico, quale il vincolo capace di tenere insieme tutti gli interessi
particolari e mai in senso fattuale – quale semplice forza fisica – o in senso
teologico – ove pene e ricompense sono dispensate da Dio. Ovviamente,
l’irrogazione delle pene ha delle conseguenze importanti. La prima è quello che
oggi chiamiamo il principio di legalità: le pene possono essere stabilite
soltanto dalla legge, mai da altri, neppure dalla volontà del Sovrano. E’ certo
difficile comprenderlo in pieno, ma affermare due secoli e mezzo fa che il
Sovrano non gode del potere di stabilire le pene, doveva sembrare un atto quasi
rivoluzionario. La seconda conseguenza sta nel principio di giurisdizione e di
separazione dei poteri: dal momento che il Sovrano è parte stipulante del
contratto sociale, non può egli medesimo giudicare gli imputati dei reati –
essendo ogni cittadino, anche imputato, l’altra parte stipulante dello stesso
contratto – ma occorre un soggetto terzo ed imparziale: il magistrato. La terza
conseguenza è che le pene, per non tralignare in pure e semplici sopraffazioni,
non debbono mai essere atroci, termine che Beccaria usa per significare una loro
speciale carica afflittiva. Ma il capitolo certo più interessante è quello in
cui Beccaria affronta il problema della interpretazione della legge e della sua
possibile oscurità. E qui Beccaria si mostra fino in fondo figlio
dell’illuminismo giuridico che egli ha tanto contribuito a diffondere e dei suoi
ineliminabili limiti. Infatti, egli propone, allo scopo di esorcizzare lo
spettro della pluralità delle interpretazioni possibili della legge, che apre la
porta ad ogni anarchia interpretativa, il tradizionale schema sillogistico: la
premessa maggiore sta nella legge; la minore nel fatto commesso; la conclusione
nella condanna o nella assoluzione. Beccaria riprende qui la ben nota teoria di
Montesquieu del giudice che si limita ad essere “bouche de la lois”, vale a dire
semplice cinghia di trasmissione, del tutto neutra, di una volontà che è e
rimane soltanto del Sovrano. E ciò – lo si ribadisce – per esorcizzare il
pericolo delle molteplici interpretazioni a volte confliggenti. Ma si tratta di
una costruzione irreale e perniciosa, anche se ovviamente Beccaria, immerso
nella cultura giuridica del suo tempo, non poteva immaginarlo. Irreale, in
quanto ogni magistrato, interpretando le formule della legge, non può certo
diventare un meccanismo automatizzato, ma reca con se un tesoro di conoscenze,
di esperienze, di premesse che inevitabilmente influiscono sul suo operato.
Perniciosa, in quanto ignorare la realtà equivale a divenirne schiavi. Come ha
invece mostrato a sufficienza tutta la lezione ermeneutica che a partire da
Gadamer – ma anche oltre Gadamer: si pensi a Pareyson, a Betti, a Mathieu – si è
occupata del tema, ogni interprete muove da una pre- comprensione del testo da
comprendere; e il bello è che non può evitarlo, dovendo soltanto esserne
consapevole.
Il problema allora non è fare del giudice ciò che
egli mai potrà essere – una sorta di macchina automatica che, sfornando
sentenze, si illuda e illuda di trasmettere fedelmente la volontà del
legislatore – ma far si che la necessaria pre-comprensione da cui egli muove sia
trasparente, conoscibile e non frutto di follia argomentativa o conoscitiva.
Certo, non facile, ma unica strada realisticamente percorribile Quanto poi alla
oscurità dei testi di legge e alla loro scarsa comprensibilità, meno male che
Beccaria non può leggere le odierne leggi italiane, zeppe di errori di
grammatica, di contorsionismi argomentativi, di litoti, di punteggiature
approssimative: ne morrebbe di nuovo.
CAPITOLO PRIMO ORIGINE DELLE PENE. Le leggi sono
le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società,
stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa
inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per
goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste
porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una
nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle;
ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private
usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere
dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli
altri. Vi volevano de’ motivi sensibili che bastassero a distogliere il
dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi della
società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl’infrattori
delle leggi. Dico sensibili motivi, perché la sperienza ha fatto vedere che la
moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel
principio universale di dissoluzione, che nell’universo fisico e morale si
osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di
continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni
delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né l’eloquenza, né
le declamazioni, nemmeno le piú sublimi verità sono bastate a frenare per lungo
tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.
CAPITOLO SECONDO DIRITTO DI PUNIRE. Ogni pena che
non derivi dall’assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica;
proposizione che si può rendere piú generale cosí: ogni atto di autorità di uomo
a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di
che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di
difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e
tanto piú giuste sono le pene, quanto piú sacra ed inviolabile è la sicurezza, e
maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore
umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano
di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla
politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell’uomo.
Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria che
vince alla fine, in quella maniera che una forza benché minima, se sia
continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.
Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista
del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne’ romanzi; se fosse possibile,
ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero;
ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo. La moltiplicazione
del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la
sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre piú
s’incrocicchiavano tra di loro, riuní i primi selvaggi. Le prime unioni
formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e cosí lo stato di
guerra trasportossi dall’individuo alle nazioni. Fu dunque la necessità che
costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo
che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion
possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato
di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di piú
è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto. Osservate che la parola
diritto non è contradittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una
modificazione della seconda, cioè la modificazione piú utile al maggior numero.
E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti
gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato
d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare
questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a
questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza
fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli
uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno
intendo quell’altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi
immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.
CAPITOLO TERZO CONSEGUENZE. La prima conseguenza
di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e
quest’autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta
la società unita per un contratto sociale; nessun magistrato ( che è parte di
società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della
società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle
leggi è la pena giusta piú un’altra pena; dunque non può un magistrato, sotto
qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un
delinquente cittadino. La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare è
legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per
un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che
discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il piú grande e il
piú miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di
tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche
di un solo, comincia ad autorizzare l’anarchia. Il sovrano, che rappresenta la
società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i
membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché
allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano,
che asserisce la violazione del contratto, e l’altra dall’accusato, che la nega.
Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la
necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano
in mere assersioni o negative di fatti particolari. La terza conseguenza è che
quando si provasse che l’atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al
ben pubblico ed al fine medesimo d’impedire i delitti, fosse solamente inutile,
anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtú benefiche
che sono l’effetto d’una ragione illuminata che preferisce il comandare ad
uomini felici piú che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una
perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla
natura del contratto sociale medesimo.
CAPITOLO QUARTO INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI.
Quarta conseguenza. Nemmeno l’autorità d’interpetrare le leggi penali può
risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono
legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri
come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che
la cura d’ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano
rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell’attuale risultato della
volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d’un antico giuramento,
nullo, perché legava volontà non esistenti, iniquo, perché riduceva gli uomini
dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o
espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al
sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l’intestino fermento
degl’interessi particolari. Quest’è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi
sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario
delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo
l’esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un’azione contraria alle leggi? In
ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore
dev’essere la legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la
conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare
anche soli due sillogismi, si apre la porta all’incertezza. Non v’è cosa piú
pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della
legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che
sembra un paradosso alle menti volgari, piú percosse da un piccol disordine
presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso
principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e
tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto piú sono
complicate, tanto piú numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono.
Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un
diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o
cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe
dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle
relazioni del giudice coll’offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le
apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo. Quindi veggiamo la
sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi
tribunali, e le vite de’ miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o
dell’attuale fermento degli umori d’un giudice, che prende per legittima
interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che
gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale
puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e
fissa voce della legge, ma l’errante instabilità delle interpetrazioni.
Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge
penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla
interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e
necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione
dell’incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le
arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si
debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di
esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge
scritta, quando la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni
sí del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di
controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole
tirannie di molti, tanto piú crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre
e chi fa soffrire, piú fatali che quelle di un solo, perché il dispotismo di
molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un
dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Cosí acquistano i
cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo per cui
gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di
esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresí che
acquisteranno uno spirito d’indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e
ricalcitrante a’ supremi magistrati, bensí a quelli che hanno osato chiamare col
sacro nome di virtú la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose
opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di
trasmettere agl’inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai
superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile
collo spirito di lettura.
CAPITOLO QUINTO OSCURITÀ DELLE LEGGI. Se
l’interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro
l’oscurità che strascina seco necessariamente l’interpetrazione, e lo sarà
grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo
ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual
sarebbe l’esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di
un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare
degli uomini, riflettendo esser questo l’inveterato costume di buona parte della
colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli che
intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men
frequenti saranno i delitti, perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e
l’incertezza delle pene aiutino l’eloquenza delle passioni. Una conseguenza di
quest’ultime riflessioni è che senza la scrittura una società non prenderà mai
una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle
parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si
corrompano passando per la folla degl’interessi privati. L’esperienza e la
ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni
umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non
esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla
forza inevitabile del tempo e delle passioni? Da ciò veggiamo quanto sia utile
la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante
leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d’intrigo
che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e
realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo
sminuita in Europa l’atrocità de’ delitti che facevano gemere gli antichi nostri
padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di
due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso e della
mollezza nacquero le piú dolci virtú, l’umanità, la beneficenza, la tolleranza
degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamasi a
torto antica semplicità e buona fede: l’umanità gemente sotto l’implacabile
superstizione, l’avarizia, l’ambizione di pochi tinger di sangue umano gli
scrigni dell’oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi,
ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di
sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono
l’opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.
Le pene sproporzionate danneggiano la
società, scrive Vincenzo Vitale il 12 Agosto 2017 su
"Il Dubbio". Naturalmente, un principio fondamentale della razionalità
giuridica, non rinunciabile, risiede nella proporzione fra la gravità del
delitto commesso e la pena prevista per lo stesso. Si badi. Compatibilmente alla
impostazione utilitaristica tipica di Beccaria, tale proporzione non risponde ad
alcuna esigenza di carattere metafisico, nel senso della sostanza essenziale
delle cose, ponendosi invece nell’ottica del tutto illuministica della necessità
di opporre al peso gravitazionale del delitto, un contrappeso di segno eguale e
contrario, ma in ogni caso non eccessivo rispetto al primo. Beccaria, non
estraneo ad una cultura matematizzante tipica del settecento, ama infatti
ricorrere ad un lessico di tipo fisicogeometrico per far meglio intendere e
spiegare i propri assunti teorici: ecco dunque l’uso del paragone con la
gravitazione dei corpi. Si capisce bene la prospettiva da cui muove Beccaria,
considerando la chiusa del capitoletto in questione, laddove egli nota che se la
medesima pena fosse comminata per delitti che siano di gravità diseguale, “gli
uomini non troveranno un più forte ostacolo per commetter il maggior delitto, se
con esso vi troveranno unito un maggior vantaggio”. Insomma, la eventuale
sproporzione delle pene non tanto si profila come intrinsecamente ingiusta –
cosa che a Beccaria importava poco – quanto si palesa come inutile, anzi perfino
disutile, contraria alla compagine sociale e al suo mantenimento. Come fare
allora a rendere davvero le pene proporzionate al delitto commesso? Beccaria
scarta decisamente i criteri allora più diffusi fra i criminalisti. Non la
semplice dignità della persona offesa può costituire misura della pena: se così
fosse, si giungerebbe all’assurdo di punire con più severità, per esempio, la
blasfemia, in quanto offensiva della divinità, che non l’omicidio, offensivo
della vita umana. Non la gravità del peccato commesso, che è intrinseco per
molti aspetti al delitto contestato: se così fosse, infatti, si appiattirebbe
ogni delitto sul dato strettamente teologico che invece deve rimanere
completamente escluso dalla politica penale e criminale, rispondendo ad una
logica autonoma e indipendente. E neppure può esserlo l’intenzione del reo: se
così fosse infatti, per un verso, sarebbe necessario disporre una legge apposita
per ogni uomo, vale a dire una previsione specifica per ogni intenzione, cosa
evidentemente impossibile; per altro verso, non va ignorato – si noti qui
l’attento realismo del giurista milanese – che uomini con la più prava delle
intenzioni finirono col giovare molto alla società, mentre uomini dotati della
migliore intenzione la danneggiarono moltissimo. Unico criterio di
commisurazione delle pene per Beccaria non può essere allora che il danno “fatto
alla nazione”. Per nazione Beccaria intende naturalmente la compagine sociale.
Va notato come Beccaria qui sia stato in grado di indicare – e forse questo è un
altro dei suoi più significativi meriti – il criterio del danno prodotto quale
unico criterio accettabile per mantenere la proporzione fra pene e delitti,
fondando in tal modo – ed essendone l’illustre precursore – la teoria del danno
e del bene giuridico protetto dalla norma, quale premessa culturale necessaria a
tutta quella ricca dottrina che – sia in campo penalistico che civilistico –
costituisce la lezione giuridica fondamentale della nostra epoca. Ogni giurista
infatti sa bene che la giurisprudenza e la dottrina negli ultimi decenni non
hanno fatto altro che affaticarsi incessantemente alla ricerca di nuove e sempre
più precise configurazioni del danno risarcibile – in sede civilistica – e
punibile – in sede penalistica, per la miglior tutela della parte lesa: ebbene,
la genesi di tanta qualità giuridica va ritrovata fra queste pagine, fra queste
idee. E’ poi ovvio che la diversa commisurazione delle pene trae seco la
necessità di distinguere come logica premessa i delitti secondo la loro gravità.
I più gravi, per Beccaria, sono quelli tradizionalmente chiamati di “lesa
maestà”: sono quelli che attentano direttamente alla società, avendo di mira la
sua totale distruzione. Pensiamo oggi alla strage, al terrorismo, all’attentato
agli organi costituzionali dello Stato… Poi ci sono i delitti che ledono le
sfere giuridiche dei privati, i loro beni, i loro interessi, le loro legittime
aspettative. Tuttavia, l’aspetto più interessante sta nel fatto che Beccaria
afferma qui senza alcuna timidezza un vero dogma del diritto penale che oggi
informa di se la legislazione di ogni autentico Stato di diritto: è permesso ad
ogni cittadino fare ciò che non è espressamente vietato. In atre parole,
Beccaria apre qui – e lo tiene ben fermo – l’ombrello della libertà e lo apre
proprio al riparo di quelle leggi di cui ha precedentemente difeso l’esistenza e
la indefettibile funzione. Nulla di più esemplare come lezione di diritto: la
libertà nasce e si fonda sulle leggi, non contro o senza di esse; e le leggi
devono esser tali da far nascere e sviluppare la pianta della libertà:
altrimenti sarebbero solo espressione di tirannia.
CAPITOLO VI PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE.
Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano piú
rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque piú forti debbono
essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono
contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti.
Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene. È impossibile di
prevenire tutti i disordini nell’universal combattimento delle passioni umane.
Essi crescono in ragione composta della popolazione e dell’incrocicchiamento
degl’interessi particolari che non è possibile dirigere geometricamente alla
pubblica utilità. All’esattezza matematica bisogna sostituire nell’aritmetica
politica il calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle storie e si
vedranno crescere i disordini coi confini degl’imperi, e, scemando nell’istessa
proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione
dell’interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi: perciò la necessità di
aggravare le pene si va per questo motivo sempre piú aumentando. Quella forza
simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a
misura degli ostacoli che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la
confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si
offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il
cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità
medesima inseparabile dall’uomo, e il legislatore fa come l’abile architetto di
cui l’officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità e di far
conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell’edificio. Data la necessità
della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla
opposizione medesima degl’interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei
quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la
società, e l’ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri
di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben
pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili,
decrescendo dal piú sublime al piú infimo. Se la geometria fosse adattabile alle
infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala
corrispondente di pene, che discendesse dalla piú forte alla piú debole: ma
basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar
l’ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell’ultimo. Se vi
fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una
probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di
umanità o di malizia delle diverse nazioni. Qualunque azione non compresa tra i
due sovraccennati limiti non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se
non da coloro che vi trovano il loro interesse nel cosí chiamarla. La incertezza
di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contradice alla
legislazione; piú attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una
moltitudine di leggi che espongono il piú saggio alle pene piú rigorose, e però
resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtú, e però nata l’incertezza
della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi
politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro
annali, troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtú, di buon cittadino o di
reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che
accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi
all’interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che
successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso che le
passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le
passioni forti, figlie del fanatismo e dell’entusiasmo, indebolite e rose, dirò
cosí, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all’equilibrio,
diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del
forte e dell’accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e
di virtú, e tali sono perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa
sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne che sono
bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale geografia. Se il
piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che
spingono gli uomini anche alle piú sublimi operazioni, furono destinati
dall’invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di
queste ne nascerà quella tanto meno osservata contradizione, quanto piú comune,
che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena uguale è
destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non
troveranno un piú forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso
vi trovino unito un maggior vantaggio.
CAPITOLO VII ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE. Le
precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l’unica e vera misura
dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero
vera misura dei delitti l’intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla
impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente:
esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla velocissima
successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque
necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una
nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore.
Lintenzione fanno il maggior male alla società; e alcune altre volte colla piú
cattiva volontà ne fanno il maggior bene. Altri misurano i delitti piú dalla
dignità della persona offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico.
Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all’Essere degli
esseri dovrebbe piú atrocemente punirsi che l’assassinio d’un monarca, la
superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza
dell’offesa. Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse
nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi
d’un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra
uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto
nascere dall’urto delle passioni e dalle opposizioni degl’interessi l’idea della
utilità comune, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di
dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sé solo il
diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perché egli solo può
esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla
sua onnipotenza, qual sarà l’insetto che oserà supplire alla divina giustizia,
che vorrà vendicare l’Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli
oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli
esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla
imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza
rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i
delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e
perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione
coll’Onnipossente nell’offenderlo, possono anche esserlo col punire.
CAPITOLO VIII DIVISIONE DEI DELITTI. Abbiamo
veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società. Questa
è una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di
quadranti, né di telescopi per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun
mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non
sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini
d’ogni nazione e d’ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite
d’autorità e di potere hanno, la maggior parte delle volte per insensibili
spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli
uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia
delle nascenti società ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci
riconduca, con quella maggior fermezza però che può essere somministrata da un
esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi. Or
l’ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorte di
delitti e la maniera di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse
circostanze dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e
noioso. Mi basterà indicare i principii piú generali e gli errori piú funesti e
comuni per disingannare sí quelli che per un mal inteso amore di libertà
vorrebbono introdurre l’anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini
ad una claustrale regolarità. Alcuni delitti distruggono immediatamente la
società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un
cittadino nella vita, nei beni, o nell’onore; alcuni altri sono azioni contrarie
a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben
pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perché piú dannosi, son quelli
che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l’ignoranza, che confondono i
vocaboli e le idee piú chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la
massima pena, a’ delitti di differente natura, e rendere cosí gli uomini, come
in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benché privato,
offende la società, ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le
azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono
diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo
spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l’ordinario la
filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall’eterna verità fu con
immutabili rapporti distinto. Dopo questi seguono i delitti contrari alla
sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni
legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del dritto di
sicurezza acquistato da ogni cittadino alcuna delle pene piú considerabili
stabilita dalle leggi.
L’opinione che ciaschedun cittadino deve avere di
poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi senza temerne altro
inconveniente che quello che può nascere dall’azione medesima, questo è il dogma
politico che dovrebb’essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla
incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può
essere legittima società, giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di
quell’azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere sensibile,
e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose
e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtú che sa
resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può
soffrire un’esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la
sicurezza e libertà dei cittadini sono uno de’ maggiori delitti, e sotto questa
classe cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli
ancora dei grandi e dei magistrati, l’influenza dei quali agisce ad una maggior
distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e
di dovere, e sostituendo quella del diritto del piú forte, pericoloso del pari
in chi lo esercita e in chi lo soffre.
«La pena deve essere la meno tormentosa
possibile», scrive Vincenzo Vitale il 15 Agosto 2017
su "Il Dubbio". Pubblichiamo a puntate il capolavoro di Cesare Beccaria “Dei
delitti e delle Pene”. Un’opera che propone un’idea del diritto un po’ più
moderna dell’idea che prevale oggi. Il testo è preceduto da un commento di
Vincenzo Vitale. È giunto il momento ormai per Beccaria di scendere più nel
particolare, cercando di esaminare alcune figure particolari di comportamenti
illeciti. Il primo è il caso dell’offesa recata all’onore, che oggi diremmo
piuttosto reputazione, occasionando insomma quelli che potremmo chiamare, con
terminologia moderna, i reati di opinione. Da tempo è noto che esiste una forte
tendenza a depenalizzare i reati d’opinione in Italia, che tuttavia si è
scontrata – ed è risultata fino ad oggi perdente – con l’opposta teoria che
invece vuole a tutti i costi mantenerne la rilevanza penale: e da molti forse a
ragione si pensa che dietro quest’ultima opinione si possa celare un qualche
interesse personale sensibile ai risarcimenti a volte cospicui che ne possano
derivare. Beccaria non lascia di far trapelare in modo chiaro il suo fastidio
per questo genere di illecito penale ed in ciò si può forse scorgere una netta
influenza della lezione di Rousseau, il cui problema capitale filosoficamente
sintetizzato, come è noto, era “far riapparire l’essere al di là dell’apparire”.
Beccaria denuncia ironicamente come purtroppo molti mettano questo onore –
inteso come “i suffragi degli uomini” quale condizione stessa della propria
esistenza. Le violazioni dell’onore danno origine ai duelli, reato fra i più
odiosi, in quanto originati dalla “anarchia delle leggi” e abituali fra gli
aristocratici – e non fra la plebe – in quanto son proprio costoro a guardarsi
con “sospetto e gelosia”, i quali appunto esigono che l’offesa all’onore sia
lavata col sangue del duello. E’ appena il caso di rilevare la per nulla
scontata franchezza del giurista milanese nel denunciare i vizi della classe
alla quale egli medesimo apparteneva, oltre che la fermezza nel vedere come
reato un comportamento che a metà del settecento era giudicato lecito e perfino
doveroso, quale il duello. Beccaria precorreva i tempi: e di molto. Dal punto di
vista della filosofia della pena, Beccaria si colloca nella prospettiva che oggi
chiameremmo della prevenzione speciale o anche generale, in quanto ritiene che
lo scopo della stessa sia duplice: da un lato, scoraggiare il colpevole dalla
commissione di altri reati; dall’altro, scoraggiare in genere la collettività
dal commetterne. Da ciò discende che la pena deve essere “durevole” negli animi
degli uomini e la meno “tormentosa” per il corpo. Kant avrebbe tuonato contro
questa impostazione filosofica, perché contraria all’imperativo etico
categorico, sfociando nel rischio che il fine preventivo possa fare del singolo
colpevole un mezzo per impressionare gli altri soggetti della collettività, e
non già – come invece predicava il filosofo di Konigsberg – un fine in se. Ma
per Beccaria – e per noi – va bene così. Passando poi all’esame della
testimonianza, transitando cioè dal codice penale a quello di procedura penale,
Beccaria afferma un principio giuridico basilare, ma spesso dimenticato anche
oggi, con enormi danni alla amministrazione della giustizia e a coloro che ne
ricevono effetti negativi spesso irreparabili. Egli afferma infatti che se un
testimone afferma e uno nega l’accusa, questa deve ritenersi non provata perché
le testimonianze opposte si elidono reciprocamente e perché comunque deve
prevalere la presunzione di innocenza. Molti sedicenti giuristi di oggi
dovrebbero leggere e meditare queste pagine. Ancora. Esaminando le prove e la
logica relativa alla loro valutazione, Beccaria dovrebbe vedere fra i propri
attenti lettori anche molti giuristi della nostra epoca. Citiamo solo un
esempio. Sostiene Beccaria che se le prove di un certo fatto si sostengono fra
di loro, allora quanto più numerose sono codeste prove, tanto minore è la
probabilità del fatto, perché le censure che si posson muovere alle precedenti
colpiscono anche le seguenti; e ancora che se le prove di un certo fatto
dipendono da una sola, il numero delle prove non aumenta la probabilità del
fatto, perché il loro valore si risolve in quello della sola prova da cui
dipendono. Insomma, un esempio perfetto di logica giudiziaria che sarebbe bene
far studiare agli studenti di Giurisprudenza, troppo presi purtroppo
dall’informatica – vale a dire dal mezzo di comunicazione – per preoccuparsi del
diritto e della giustizia – vale a dire dei contenuti di quel mezzo, che poi son
la sola cosa che davvero conti. Terribili poi le critiche da Beccaria riservate
alla delazione, vale a dire alle accuse segrete e immuni da responsabilità. Esse
infatti aprono la strada alla calunnia dalla quale è molto difficile difendersi
proprio in quanto segreta. Ne viene che nessuna accusa – neppure la più grave –
giustifica la delazione e che perciò l’accusa dovrà sempre essere pubblica, mai
segreta, indipendentemente dalla forma dello Stato e della Costituzione. Infine
al calunniatore dovrà irrogarsi la medesima pena che toccherebbe a colui che fu
ingiustamente accusato. Come si vede, una bella e concreta lezione di civiltà
giuridica, che oggi purtroppo per molti aspetti pare dimenticata.
DEI DELITTI E DELLE PENE. CAPITOLO IX DELL’ONORE.
V’è una contradizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi piú d’ogni
altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che
chiamasi onore, che vi preferisce l’opinione. Questa parola onore è una di
quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza
attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane che
le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno
con piú distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime nozioni
morali, fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti delle passioni le
sospingono e l’ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà
l’apparente paradosso se si consideri che come gli oggetti troppo vicini agli
occhi si confondono, cosí la troppa vicinanza delle idee morali fa che
facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne
confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol
misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia
nell’indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per
avventura bisogno di tanto apparato di morale, né di tanti legami per render gli
uomini felici e sicuri. Quest’onore dunque è una di quelle idee complesse che
sono un aggregato non solo d’idee semplici, ma d’idee parimente complicate, che
nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de’
diversi elementi che le compongono; né conservano che alcune poche idee comuni,
come piú quantità complesse algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar
questo comune divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell’onore è
necessario gettar rapidamente un colpo d’occhio sulla formazione delle società.
Le prime leggi e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai
disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore
della società, e questo fine primario si è sempre conservato, realmente o in
apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori; ma l’avvicinamento
degli uomini e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una
infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri,
sempre superiori alla providenza delle leggi ed inferiori all’attuale potere di
ciascuno. Da quest’epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l’unico
mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali
le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l’opinione è quella che tormenta
il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l’apparenza della virtú al di
sopra della virtú stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato,
perché vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero
non solo utili, ma necessari, per non cadere al disotto del comune livello.
Quindi se l’ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come
testimoni del proprio merito, si vede l’uomo d’onore esigerli come necessari.
Quest’onore è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria
esistenza. Nato dopo la formazione della società, non poté esser messo nel
comune deposito, anzi è un instantaneo ritorno nello stato naturale e una
sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che in quel caso
non difendono bastantemente un cittadino. Quindi e nell’estrema libertà politica
e nella estrema dipendenza spariscono le idee dell’onore, o si confondono
perfettamente con altre: perché nella prima il dispotismo delle leggi rende
inutile la ricerca degli altrui suffragi; nella seconda, perché il dispotismo
degli uomini, annullando l’esistenza civile, gli riduce ad una precaria e
momentanea personalità. L’onore è dunque uno dei principii fondamentali di
quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito, e in esse sono quello che
negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di
natura, ed un ricordo al padrone dell’antica uguaglianza.
CAPITOLO X DEI DUELLI. Da questa necessità degli
altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch’ebbero appunto la loro origine
nell’anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all’antichità, forse perché
gli antichi non si radunavano sospettosamente armati nei tempii, nei teatri e
cogli amici; forse perché il duello era uno spettacolo ordinario e comune che i
gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano
d’esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli
editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo
costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono piú che la
morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l’uomo d’onore si prevede
esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un
uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl’insulti e dell’infamia, che
colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il
minuto popolo non duella per lo piú come i grandi? Non solo perché è disarmato,
ma perché la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe che in
coloro che, essendo piú elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia. Non
è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè che il miglior metodo di
prevenire questo delitto è di punire l’aggressore, cioè chi ha dato occasione al
duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere
ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l’opinione, ed ha dovuto mostrare
a’ suoi concittadini ch’egli teme le sole leggi e non gli uomini.
CAPITOLO XI DELLA TRANQUILLITA’ PUBBLICA.
Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che
turbano la pubblica tranquillità e la quiete de’ cittadini, come gli strepiti e
i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio de’
cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della
curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori e piú
dall’oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la
quale mai non opera sopra una gran massa d’uomini. La notte illuminata a
pubbliche spese, le guardie distribuite ne’ differenti quartieri della città, i
semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra
tranquillità dei tempii protetti dall’autorità pubblica, le arringhe destinate a
sostenere gl’interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei
parlamenti o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per
prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un
ramo principale della vigilanza del magistrato, che i francesi chiamano della
police; ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite
da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla
tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non
trovo eccezione alcuna a quest’assioma generale, che ogni cittadino deve sapere
quando sia reo o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati
arbitrari, sono necessari in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della
sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L’incertezza
della propria sorte ha sacrificate piú vittime all’oscura tirannia che non la
pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi piú che non gli avvilisce.
Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull’opinione, che previene
il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o
nel fuoco delle passioni, o nell’ignoranza del pericolo. Ma quali saranno le
pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente utile e
necessaria p er la sicurezza e pel buon ordine della società? La tortura e i
tormenti sono eglino giusti, e ottengon eglino il fine che si propongono le
leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono
elleno egualmente utili in tutt’i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi?
Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a
cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non
posson resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il
primo all’Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre nazioni hanno osato
scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i
diritti degli uomini e dell’invincibile verità contribuissi a strappare dagli
spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o
dell’ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche d’un solo
innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli
uomini.
CAPITOLO XII FINE DELLE PENE. Dalla semplice
considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle
pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un
delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per
passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli
albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei
deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non
ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d’impedire il
reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne
uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle deve esser prescelto che,
serbata la proporzione, farà una impressione piú efficace e piú durevole sugli
animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.
CAPITOLO XIII DEI TESTIMONI. Egli è un punto
considerabile in ogni buona legislazione. il determinare esattamente la
credibilità dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che
abbia una certa connessione nelle proprie idee e le di cui sensazioni sieno
conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura
della di lui credibilità non è che l’interesse ch’egli ha di dire o non dire il
vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile
l’applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed
incoerente la nota d’infamia negl’infami quando non abbiano alcun interesse di
mentire. La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell’odio, o
dell’amicizia, o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Piú d’un
testimonio è necessario, perché fintanto che uno asserisce e l’altro nega niente
v’è di certo e prevale il diritto che ciascuno ha d’essere creduto innocente. La
credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto piú
cresce l’atrocità di un delitto o l’inverisimiglianza delle circostanze; tali
sono per esempio la magia e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è piú
probabile che piú uomini mentiscano nella prima accusa, perché è piú facile che
si combini in piú uomini o l’illusione dell’ignoranza o l’odio persecutore di
quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad
ogni essere creato. Parimente nella seconda, perché l’uomo non è crudele che a
proporzione del proprio interesse, dell’odio o del timore concepito. Non v’è
propriamente alcun sentimento superfluo nell’uomo; egli è sempre proporzionale
al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un
testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand’egli sia membro d’alcuna
società privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse
dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.
Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio quando si faccia delle
parole un delitto, poiché il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che
siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano
e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile il ripeterle
quali precisamente furon dette. Di piú, le azioni violenti e fuori dell’uso
ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di sé nella moltitudine
delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono
che nella memoria per lo piú infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è
adunque di gran lunga piú facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di
un uomo, poiché di queste, quanto maggior numero di circostanze si adducono in
prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.
CAPITOLO XIV INDIZI, E FORME DI GIUDIZI. Vi è un
teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la
forza degl’indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l’una
dall’altra, cioè quando gl’indizi non si provano che tra di loro, quanto
maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perché i
casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti.
Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero
delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il
loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le
prove sono indipendenti l’una dall’altra, cioè quando gli indizi si provano
d’altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto piú cresce
la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce
sull’altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena
debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera che rigorosamente
la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata
certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una
consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione;
la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che
determina ogni uomo nelle operazioni piú importanti della vita. Possono
distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette
quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette
quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la
condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una
perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile
che uno non sia reo, per l’unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che
non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali può il reo giustificarsi
e non lo faccia a dovere divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove
è piú facile il sentirla che l’esattamente definirla. Perciò io credo ottima
legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e
non dalla scelta, perché in questo caso è piú sicura l’ignoranza che giudica per
sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e
precise l’officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto.
Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel
presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal
risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso,
meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei e che
tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da’ suoi studi. Felice quella
nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella
che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perché, dove si tratta della libertà
e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la
disuguaglianza; e quella superiorità con cui l’uomo fortunato guarda l’infelice,
e quello sdegno con cui l’inferiore guarda il superiore, non possono agire in
questo giudizio. Ma quando il delitto sia un’offesa di un terzo, allora i
giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari dell’offeso; cosí,
essendo bilanciato ogni interesse privato che modifica anche involontariamente
le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora
conforme alla giustizia che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro
che gli sono sospetti; e ciò concessoli senza contrasto per alcun tempo,
sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e
pubbliche le prove del reato, perché l’opinione, che è forse il solo cemento
delle società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perché il popolo
dica noi non siamo schiavi e siamo difesi, sentimento che inspira coraggio e che
equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non
accennerò altri dettagli e cautele che richiedono simili instituzioni. Niente
avrei detto, se fosse necessario dir tutto.
CAPITOLO XV ACCUSE SEGRETE. Evidenti, ma
consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della
constituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e
coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un
inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e,
coll’uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro
medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principii
chiari ed immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare
delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che gli minacciano;
passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro;
privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi
di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine
divorati, gli consolano d’esser vissuti. E di questi uomini faremo noi
gl’intrepidi soldati difensori della patria o del trono? E tra questi troveremo
gl’incorrotti magistrati che con libera e patriottica eloquenza sostengano e
sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi
l’amore e le benedizioni di tutti i ceti d’uomini, e da questo rendano ai palagi
ed alle capanne la pace, la sicurezza e l’industriosa speranza di migliorare la
sorte, utile fermento e vita degli stati? Chi può difendersi dalla calunnia
quand’ella è armata dal piú forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorta
di governo è mai quella ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico ed
è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno? Quali sono i motivi
con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la
sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana
costituzione, dove chi ha per sé la forza, e l’opinione piú efficace di essa,
teme d’ogni cittadino? L’indennità dell’accusatore? Le leggi dunque non lo
difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi piú forti del sovrano! L’infamia
del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la pubblica!
La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico
si chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi
possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia
interesse di tutti la pubblicità dell’esempio, cioè quella del giudizio? Io
rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche
volta la natura delle circostanze che può credersi l’estrema rovina il togliere
un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se avessi a
dettar nuove leggi, in qualche angolo abbandonato dell’universo, prima di
autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità
dinanzi agli occhi. È già stato detto dal Signor di Montesquieu che le pubbliche
accuse sono piú conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe
la prima passione de’ cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è
debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il
destinare de’ commissari, che in nome pubblico accusino gl’infrattori delle
leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare
la pena che toccherebbe all’accusato.
«La tortura questo infame metodo di
indagine», scrive Vincenzo Vitale il 17 Agosto 2017 su
"Il Dubbio". Pubblichiamo a puntate il capolavoro di Cesare Beccaria “Dei
delitti e delle Pene”. Un’opera che propone un’idea del diritto un po’ più
moderna dell’idea che prevale oggi. Il testo è preceduto da un commento di
Vincenzo Vitale. Siamo così giunti finalmente al tema più scottante e che più di
ogni altro ha fatto discutere in passato i criminalisti, fino a diventare un
paradigma di riferimento obbligato per saggiare il tasso di giuridicità di un
ordinamento: la tortura. Beccaria si preoccupa di chiarire immediatamente con
logica inoppugnabile i termini reali del problema: o il delitto è certo oppure è
incerto; se è certo, la tortura è del tutto inutile in quanto la confessione del
reo è superflua; se invece è incerto, la tortura è indebita, in quanto sarebbe
applicata ad un innocente, quale deve essere considerato l’accusato fino alla
prova definitiva e inoppugnabile della sua colpevolezza. Non so fino a che punto
ci si renda conto della preziosa posizione di Beccaria in ordine alla
presunzione di innocenza, difesa e razionalmente affermata oltre due secoli e
mezzo or sono, quando nessuno neppure ne parlava o la ipotizzava, presunzione
che oggi purtroppo a volte viene dimenticata o messa fra parentesi. Per questo,
Beccaria insiste che nessuno può chiamarsi reo fino a quando la sua colpevolezza
sia accertata attraverso la sentenza del giudice. Per il giurista milanese,
nessuno dei motivi che vengono tradizionalmente offerti per giustificare la
tortura – atterrire gli uomini, purgare l’infamia ecc. – regge ad una seria
critica. A ben vedere, secondo Beccaria la tortura è equiparabile alle celebri
prove legali in uso nel medioevo, quali la prova del fuoco, quella dell’acqua
bollente, insomma ai cosiddetti giudizi di Dio e di questi soffre tutta la
irrazionalità giuridica e la casualità...Secondo la retta ragione, la sola
differenza fra le prove barbaricamente legali e la tortura risiede nel fatto che
mentre nelle prime l’esito dipende da fattori estrinseci e del tutto eventuali,
in questa l’esito dipende in buona parte dalla volontà dell’accusato. E’ pur
vero – nota ancora il giurista – che la confessione fatta durante la tortura
necessita, per essere valida, della conferma sotto giuramento fatta in un
momento successivo, ma è anche vero che, assurdamente, in molti Stati se
l’accusato non conferma quanto in precedenza dichiarato sotto tortura, verrà di
nuovo sottoposto ai tormenti ( in certi Stati solo per tre volte, in altri a
discrezione del giudice): insomma, un cane che si morde la coda, non se ne esce
più. Ma la vera argomentazione che rivela la assurdità della tortura sta nel
fatto che l’innocente si trova in una posizione di svantaggio rispetto al
colpevole. Se infatti, viene torturato l’innocente, questi o confessa – per far
cessare il tormento – ciò che non ha fatto e allora sarà condannato; oppure, non
confessando, viene assolto e allora avrà patito ingiustamente una enorme
sofferenza. Se invece viene torturato il colpevole, se questi stoicamente sa
resistere al dolore, verrà assolto. Ne viene che mentre l’innocente avrà sempre
perso qualcosa, il colpevole è messo in grado di guadagnare la propria impunità.
Nell’ambito di questa cornice giudiziaria, il giudice non è più un terzo
imparziale, ma diviene “nemico del reo”, afferma in modo preciso Beccaria, non
cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto attraverso la
tortura. E qui, Beccaria alza il tono del discorso attingendo compiutamente
luoghi che oggi potremmo definire propri di una teoria generale del processo
penale. Infatti, egli distingue fra un processo penale offensivo, dove per
essere dichiarati innocenti, bisogna prima esser detti rei, e perciò anche
essere sottoposti alla tortura; e un processo penale informativo, dove invece
prevale la ricerca imparziale del fatto da chiunque commesso. In Europa, a metà
del settecento, il secondo era sconosciuto, mentre il primo era l’unico
concretamente sperimentato: oggi, usando il linguaggio dei giuristi
contemporanei, diremmo che il processo inquisitorio deve lasciar spazio a quello
accusatorio. Oggi. Ma a metà del settecento era pericoloso affermare quelle che
sembrano ovvie verità. Beccaria conclude questa sezione della sua opera,
criticando l’uso di far giurare gli accusati – come oggi avviene ancora
purtroppo in America. E ciò sia per motivi pratici, perchè mai il giuramento
potrà spingere l’accusato a dichiararsi colpevole, sia che questi lo sia
davvero, o anche se non lo sia; inoltre, l’uso del giuramento mescola quei due
piani che per Beccaria devono restare sempre distinti, quello divino e quello
umano. C’è bisogno di aggiungere altro?
CAPITOLO XVI DELLA TORTURA. Una crudeltà
consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo
mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per
le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non
so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per
altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato. Un uomo
non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può
toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati
i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello
della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino,
mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il
delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la
stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la
confessione del reo; se è incerto, è non devesi tormentare un innocente, perché
tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io
aggiungo di piú, ch’egli è un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un
uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il
crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e
nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti
scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di
questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i
Romani, barbari anch’essi per piú d’un titolo, riserbavano ai soli schiavi,
vittime di una feroce e troppo lodata virtú. Qual è il fine politico delle pene?
Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e
private carnificine, che la tirannia dell’uso esercita su i rei e
sugl’innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è
inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle
tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v’è rimedio, non può esser punito dalla
società politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell’impunità.
S’egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per
virtú, rispettano le leggi che di quelli che le infrangono, il rischio di
tormentare un innocente deve valutarsi tanto di piú, quanto è maggiore la
probabilità che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che
disprezzate. Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione
dell’infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua
deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest’abuso non dovrebbe esser
tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione,
purghi l’infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo? E
l’infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare
all’origine di questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una
nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e
rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest’uso preso dalle idee religiose e
spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni
e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte
dall’umana debolezza e che non hanno meritata l’ira eterna del grand’Essere,
debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l’infamia è una macchia
civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed
incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile
che è l’infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si
esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel
misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale
del sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi piú sicuri della
rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d’ignoranza,
cosí ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa le piú
assurde e lontane applicazioni. Ma l’infamia è un sentimento non soggetto né
alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona
una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà
l’infamia dando l’infamia. Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti
rei quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi che il timore della
pena, l’incertezza del giudizio, l’apparato e la maestà del giudice,
l’ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl’innocenti, non debbano
probabilmente far cadere in contradizione e l’innocente che teme e il reo che
cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono
tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell’animo tutto
assorbito nel pensiero di salvarsi dall’imminente pericolo. Questo infame
crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell’antica e selvaggia
legislazione, quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e
dell’acqua bollente e l’incerta sorte dell’armi, quasi che gli anelli
dell’eterna catena, che è nel seno della prima cagione, dovessero ad ogni
momento essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani. La
sola differenza che passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell’acqua
bollente, è che l’esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e
delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è
solo apparente e non reale. È cosí poco libero il dire la verità fra gli spasimi
e gli strazi, quanto lo era allora l’impedire senza frode gli effetti del fuoco
e dell’acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato
alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità
di ogni uomo è limitata. Dunque l’impressione del dolore può crescere a segno
che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere
la strada piú corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la
risposta del reo è cosí necessaria come le impressioni del fuoco o dell’acqua.
Allora l’innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far
cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo,
che si pretende impiegato per ritrovarla. È superfluo di raddoppiare il lume
citando gl’innumerabili esempi d’innocenti che rei si confessarono per gli
spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma né
gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le
sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura,
che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l’uso, il tiranno delle menti, lo
rispinge e lo spaventa. L’esito dunque della tortura è un affare di temperamento
e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e
della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe
meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la
sensibilità delle fibre d’un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà
confessar reo di un dato delitto. L’esame di un reo è fatto per conoscere la
verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all’aria, al gesto, alla
fisonomia d’un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le
convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della
maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità.
Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti
per cui si distingue talora il vero dal falso.
Queste verità sono state conosciute dai romani
legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli
schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; queste dall’Inghilterra, nazione
in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze,
e perciò della potenza, e gli esempi di virtú e di coraggio non ci lasciano
dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia,
abolita da uno de’ piú saggi monarchi dell’Europa, che avendo portata la
filosofia sul trono, legislatore amico de’ suoi sudditi, gli ha resi uguali e
liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che
possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La
tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la
maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò doversene piú
d’ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande
la tirannia dell’uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi
induriti alle stragi ed al sangue il piú umano metodo di giudicare. Questa
verità è finalmente sentita, benché confusamente, da quei medesimi che se ne
allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è
confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il
delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono
questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri
dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due uomini ugualmente
innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco
ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: Io giudice dovea
trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e
però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la
confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi
tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato. Una strana
conseguenza che necessariamente deriva dall’uso della tortura è che l’innocente
è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al
tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa il
delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena
indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla
tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena
maggiore in una minore. Dunque l’innocente non può che perdere e il colpevole
può guadagnare. La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini,
resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor
proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in
voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando
di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei
muscoli e gli slogamenti delle ossa. Dassi la tortura per discuoprire se il reo
lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a
questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di
cent’altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio
di verità; le leggi ti tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo, perché
voglio che tu sii reo. Finalmente la tortura è data ad un accusato per
discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella non è un
mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i
complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l’uomo che accusa se
stesso non accusi piú facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini
per l’altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall’esame dei testimoni,
dall’esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei
mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell’accusato? I
complici per lo piú fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno,
l’incertezza della loro sorte gli condanna da sé sola all’esilio e libera
la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle
forze ottiene l’unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da
un simil delitto.
CAPITOLO XVII DEL FISCO. Fu già un tempo nel quale
quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio
del principe. Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di
lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa.
L’oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l’esattore di queste
pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico,
che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa
ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità
dell’esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piuttosto che un
indifferente ricercatore del vero, un agente dell’erario fiscale anzi che il
protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il
confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era
lo scopo delle procedure criminali d’allora, cosí la confessione del delitto, e
confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni
fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le
cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali.
Senz’essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della
stabilita, senz’essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima
specie che possa aver commessi. Con questa il giudice s’impadronisce del corpo
di un reo e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo
acquistato tutto il profitto che può. Provata l’esistenza del delitto, la
confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta
cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo
tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i
prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si
escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono
le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza che si
risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che
potrebbe perdere quest’ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene
nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai
tormenti, all’avvenire il piú terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca
nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e
di far torto a quella infallibilità che l’uomo s’arroga in tutte le cose.
Gl’indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché uno si provi innocente
deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un processo offensivo, e tali
sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le
procedure criminali. Il vero processo, l’informativo, cioè la ricerca
indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari
adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed
indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato
laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla piú felice posterità!
I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell’uomo la possibile
verificazione di un tale sistema.
CAPITOLO XVIII DEI GIURAMENTI. Una contradizione
fralle leggi e i sentimenti naturali all’uomo nasce dai giuramenti che si
esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse
di esser falso; quasi che l’uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla
propria distruzione, quasi che la religione non tacesse nella maggior parte
degli uomini quando parla l’interesse. L’esperienza di tutt’i secoli ha fatto
vedere che essi hanno piú d’ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del
cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati
piú saggi l’hanno sovente violata? Troppo deboli, perché troppo remoti dai
sensi, sono per il maggior numero i motivi che la religione contrappone al
tumulto del timore ed all’amor della vita. Gli affari del cielo si reggono con
leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani. E perché
comprometter gli uni cogli altri? E perché metter l’uomo nella terribile
contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina? talché
la legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo cristiano
o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità,
distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione, unico
pegno dell’onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i
giuramenti lo ha fatto vedere l’esperienza, perché ciascun giudice mi può esser
testimonio che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa
vedere la ragione, che dichiara inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi
che si oppongono ai naturali sentimenti dell’uomo. Accade ad esse ciò che agli
argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente
abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi gli corrode e gli
mina insensibilmente.
Processi rapidi, diceva Beccaria…250 anni
fa, scrive Vincenzo Vitale il 18 Agosto 2017 su "Il
Dubbio". Commento ai capitoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24. A questo punto Beccaria
non evita di toccare un tasto dolente oggi più di ieri: la durata dei processi.
Egli tiene a chiarire subito che se fra il delitto commesso e la pena irrogata
attraverso la sentenza trascorre troppo tempo, allora tale pena sarà avvertita
come ingiusta e il reo vi si opporrà con ogni moto dell’anima. Inoltre, la
carcerazione preventiva va applicata in modo che essa duri il minor tempo
possibile e che sia la meno dura possibile, proprio in quanto l’accusato va
ritenuto innocente fino a sentenza definitiva. Non si può fare a meno di
rilevare come tali preziosi avvertimenti siano ancor oggi assolutamente da
ribadire e da tener presenti, per il semplice motivo che sembra che Beccaria non
abbia mai scritto queste cose. Chiunque sa infatti che oggi la durata media di
un processo penale è abnorme e che la custodia cautelare in carcere viene
adoperata con eccessiva spregiudicatezza, nonostante nei convegni e nelle tavole
rotonde si predichi il contrario. In certi casi sembra che senza il ricorso alla
custodia cautelare non si possano fare i processi: peccato poi se, come accade
in questi giorni in alcuni casi agli onori delle cronache, intervenga la
Cassazione ad annullare un ordine di custodia emesso sei mesi prima. In buona
sostanza, un essere umano viene arrestato preventivamente, rimane in carcere per
sei mesi o più e poi la Cassazione gli dice che non potevano arrestarlo per
mancanza dei presupposti di legge: e Beccaria? Un illustre sconosciuto! Questo
illustre sconosciuto – che sarebbe bene oggi fosse studiato nei corsi
universitari invece di perdere tempo con emerite sciocchezze – afferma ancora
che i delitti commessi con violenza contro le persone vanno puniti con pene
corporali, mentre quelli contro il patrimonio con sanzioni pecuniarie: evidenti
ed insormontabili ragioni di simmetria formale impediscono a Beccaria di
eliminare del tutto le pene corporali dal proprio orizzonte concettuale, pur
limitandole a casi estremi. Molto interessante e testimone della libertà di
pensiero di Beccaria è invece il fatto che egli critichi aspramente la
possibilità, allora vigente, secondo cui le pene inflitte ai nobili fossero
diverse – e assai meno aspre – di quelle inflitte invece al volgo. E’ noto
infatti come la pena capitale inflitta ad un plebeo fosse accompagnata sempre da
atroci supplizi sia precedenti, sia contestuali: la ruota, il taglio delle mani,
il fuoco, ecc.; e basti in proposito por mente a quali atrocità furono
sottoposti Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, condannati a morte in quanto
untori, e di cui narra Manzoni nella sua celebre Storia della colonna infame.
Invece l’esecuzione dei nobili era quanto mai rapida e indolore: una semplice
decapitazione che nell’attimo in cui staccava la testa dal collo donava una
morte celere e quasi inavvertita. Da qui evidentemente, la grande importanza
attribuita alla capacità del boia che, se adeguatamente esercitato e competente,
non doveva in alcun modo fallire il primo colpo di scure, perché, in caso
contrario, avrebbe causato al condannato intollerabili sofferenze che invece
dovevano ad ogni costo essergli evitate. Beccaria denuncia questa disparità come
una inaccettabile diseguaglianza, mentre tutti, nobili e plebei, vanno
considerati eguali davanti alla legge. E piace pensare – cosa del tutto
probabile – che quando i giacobini ghigliottinavano i nemici della rivoluzione –
venticinque anni dopo la pubblicazione dell’opera di Beccaria – indistintamente
se fossero nobili o plebei, non esitando a farlo anche per il re e la regina,
avessero proprio in mente la lezione di Beccaria. Del resto, è stato Hegel a
notare – nelle Lezioni di Filosofia della storia – come il senso fenomenologico
della ghigliottina sia proprio questo: parificare davanti alla morte tutti gli
uomini, senza distinzioni di classi o di condizioni economiche. La ghigliottina
insomma è la vera espressione della raggiunta democrazia giacobina. Sotto la
lama affilatissima e cieca della ghigliottina non ci son più re o poveri
diavoli, perchè essa non distingue nessuno e tutti tratta allo stesso modo,
destinandoli ad una morte rapida e pressochè indolore. Strano che se Beccaria
influenzò a tal punto i giacobini rivoluzionari, non altrettanto sia riuscito a
fare con tanti sedicenti giuristi ed esperti del nostro tempo. Ma certo non è
colpa sua.
O i processi sono rapidi o le pene sono
ingiuste.
CAPITOLO XIX PRONTEZZA DELLA PENA. Quanto la pena
sarà piú pronta e piú vicina al delitto commesso, ella sarà tanto piú giusta e
tanto piú utile. Dico piú giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri
tormenti dell’incertezza, che crescono col vigore dell’immaginazione e col
sentimento della propria debolezza; piú giusta, perché la privazione della
libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la
necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d’un cittadino
finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve
durare il minor tempo possibile e dev’essere meno dura che si possa. Il minor
tempo dev’esser misurato e dalla necessaria durazione del processo e
dall’anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza
della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per
non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev’essere finito nel
piú breve tempo possibile. Qual piú crudele contrasto che l’indolenza di un
giudice e le angosce d’un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato
da una parte e dall’altra le lagrime, lo squallore d’un prigioniero? In generale
il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev’essere la piú efficace per
gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può
chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli
uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili. Ho detto che la
prontezza delle pene è piú utile, perché quanto è minore la distanza del tempo
che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è piú forte e piú durevole
nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena, talché
insensibilmente si considerano uno come cagione e l’altra come effetto
necessario immancabile. Egli è dimostrato che l’unione delle idee è il cemento
che forma tutta la fabbrica dell’intelletto umano, senza di cui il piacere ed il
dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto piú gli uomini
si allontanano dalle idee generali e dai principii universali, cioè quanto piú
sono volgari, tanto piú agiscono per le immediate e piú vicine associazioni,
trascurando le piú remote e complicate, che non servono che agli uomini
fortemente appassionati per l’oggetto a cui tendono, poiché la luce
dell’attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono
parimente alle menti piú elevate, perché hanno acquistata l’abitudine di
scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far
contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talché il risultato,
che è l’azione, è meno pericoloso ed incerto. Egli è dunque di somma importanza
la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti
volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente
riscuotasi l’idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro
effetto che di sempre piú disgiungere queste due idee, e quantunque faccia
impressione il castigo d’un delitto, la fa meno come castigo che come
spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori
l’orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il
sentimento della pena. Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre
piú l’importante connessione tra ‘ l misfatto e la pena, cioè che questa sia
conforme quanto piú si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita
mirabilmente il contrasto che dev’essere tra la spinta al delitto e la
ripercussione della pena, cioè che questa allontani e conduca l’animo ad un fine
opposto di quello per dove cerca d’incamminarlo la seducente idea
dell’infrazione della legge.
CAPITOLO XX VIOLENZE. Altri delitti sono attentati
contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente
esser puniti con pene corporali: né il grande né il ricco debbono poter mettere
a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze,
che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell’industria, diventano
l’alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono
che in alcuni eventi l’uomo cessi di esser persona e diventi cosa: vedrete
allora l’industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle
combinazioni civili quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è
il magico segreto che cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano del
forte è la catena con cui lega le azioni degl’incauti e dei deboli. Questa è la
ragione per cui in alcuni governi, che hanno tutta l’apparenza di libertà, la
tirannia sta nascosta o s’introduce non prevista in qualche angolo negletto dal
legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s’ingrandisce. Gli uomini
mettono per lo piú gli argini piú sodi all’aperta tirannia, ma non veggono
l’insetto impercettibile che gli rode ed apre una tanto piú sicura quanto piú
occulta strada al fiume inondatore.
CAPITOLO XXI PENE DEI NOBILI. Quali saranno dunque
le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali formano gran parte
delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria
tra nobili e plebei sia utile in un governo o necessaria nella monarchia, se
egli è vero che formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due
estremi, o non piuttosto formi un ceto che, schiavo di se stesso e di altrui,
racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo
cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli arenosi e
vasti deserti d’Arabia, e che, quando sia vero che la disuguaglianza sia
inevitabile o utile nelle società, sia vero altresí che ella debba consistere
piuttosto nei ceti che negl’individui, fermarsi in una parte piuttosto che
circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che nascere e
distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo
rango, asserendo che esser debbono le medesime pel primo e per l’ultimo
cittadino. Ogni distinzione sia negli onori sia nelle ricchezze perché sia
legittima suppone un’anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano
tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli
uomini che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo abbiano detto: chi sarà
piú industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne’ suoi
successori; ma chi è piú felice o piú onorato speri di piú, ma non tema meno
degli altri di violare quei patti coi quali è sopra gli altri sollevato. Egli è
vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali
decreti esistono negl’immobili rapporti delle cose, non distruggono quei
vantaggi che si suppongono prodotti dalla nobiltà e ne impediscono
gl’inconvenienti; rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada
all’impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non
è realmente la stessa per la diversità dell’educazione, per l’infamia che
spandesi su di un’illustre famiglia, risponderei che la sensibilità del reo non
è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto è fatto da
chi è piú favorito; e che l’uguaglianza delle pene non può essere che
estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l’infamia di una
famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza
all’innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengon
luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?
CAPITOLO XXII FURTI. I furti che non hanno unito
violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca d’arricchirsi
dell’altrui dovrebbe esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per
l’ordinario che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di
quella infelice parte di uomini a cui il diritto di proprietà ( terribile, e
forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza, ma come le
pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello de’ delitti e
che tolgono il pane agl’innocenti per toglierlo agli scellerati, la pena piú
opportuna sarà quell’unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè
la schiavitù per un tempo delle opere e della persona alla comune società, per
risarcirla colla propria e perfetta dipendenza dell’ingiusto dispotismo usurpato
sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev’essere
parimente un misto di corporale e di servile. Altri scrittori prima di me hanno
dimostrato l’evidente disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti
violenti da quelle dei furti dolosi facendo l’assurda equazione di una grossa
somma di denaro colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò
che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano piú d’ogni
altra il moto concepito e sono le piú lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono
delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell’assioma di
matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l’infinito che le separa.
CAPITOLO XXIII INFAMIA. Le ingiurie personali e
contrarie all’onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino
ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll’infamia.
Quest’infamia è un segno della pubblica disapprovazione che priva il reo de’
pubblici voti, della confidenza della patria e di quella quasi fraternità che la
società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che
l’infamia della legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle
cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai
sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione
che inspirano. Se l’una è differente dall’altra, o la legge perde la pubblica
venerazione, o l’idee della morale e della probità svaniscono, ad onta delle
declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni per
sé indifferenti sminuisce l’infamia delle azioni che son veramente tali. Le pene
d’infamia non debbono essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran numero
di persone in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo
frequenti delle cose d’opinione indeboliscono la forza della opinione medesima,
non il secondo, perché l’infamia di molti si risolve nella infamia. Le pene
corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che, fondati sull’orgoglio,
traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo
e l’infamia, pene che frenano l’orgoglio dei fanatici coll’orgoglio degli
spettatori e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la
verità stessa si libera. Cosí forze opponendo a forze ed opinioni ad opinioni il
saggio legislatore rompa l’ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata da un
falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne al volgo
l’originaria Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura
invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo ed operando
incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si
scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno per principio
universale l’imitazione fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la
vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poiché ella non è
altro che l’arte di meglio dirigere e di rendere conspiranti i sentimenti
immutabili degli uomini.
CAPITOLO XXIV OZIOSI. Chi turba la tranquillità
pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini
si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev’esser escluso dalla
società, cioè dev’essere bandito. Questa è la ragione per cui i saggi governi
non soffrono, nel seno del travaglio e dell’industria, quel genere di ozio
politico confuso dagli austeri declamatori coll’ozio delle ricchezze accumulate
dall’industria, ozio necessario ed utile a misura che la società si dilata e
l’amministrazione si ristringe. Io chiamo ozio politico quello che non
contribuisce alla società né col travaglio né colla ricchezza, che acquista
senza giammai perdere, che, venerato dal volgo con stupida ammirazione,
risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la
vittima, che, essendo privo di quello stimolo della vita attiva che è la
necessità di custodire o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni
di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è ozioso
politicamente chi gode dei frutti dei vizi o delle virtú de’ propri antenati, e
vende per attuali piaceri il pane e l’esistenza alla industriosa povertà,
ch’esercita in pace la tacita guerra d’industria colla opulenza, in vece della
incerta e sanguinosa colla forza. E però non l’austera e limitata virtú di
alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l’ozio da punirsi. Sembra
che il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali, accusati di un atroce
delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro, di
esser rei; ma per ciò fare è necessario uno statuto il meno arbitrario e il piú
preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione
nella fatale alternativa o di temerlo o di offenderlo, lasciandogli però il
sacro diritto di provare l’innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi
contro un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima
volta che contro chi lo fu piú volte.
Una lezione per i nostri legislatori,
scrive Vincenzo Vitale il 19 Agosto 2017su "Il Dubbio".
Commento ai capitoli 25, 26 e 27. Una delle pene abituali dell’epoca di Beccaria
era il bando, che veniva irrogato a coloro che venivano riconosciuti colpevoli
di delitti dotati di particolare disvalore sociale, e che producevano un
turbamento della pubblica tranquillità. Si trattava ad una pena simile a quella
dell’esilio, tradizionale negli ordinamenti europei del diritto comune e che, a
sua volta, traeva ispirazione dall’antichissimo istituto dell’ostracismo, vale a
dire da quel referendum al quale erano chiamati i cittadini ateniesi allo scopo,
appunto, di bandire dalla città un soggetto considerato indesiderabile. Beccaria
non crede alla utilità sociale del bando e, ancor meno, a ciò che
inevitabilmente ne era la conseguenza giuridica forse più penalizzante: la
confisca dei beni del soggetto bandito. Infatti, tale confisca gli appare
inaccettabile per almeno due motivazioni. Innanzitutto, perché finisce col
colpire anche soggetti diversi da quello colpito dal bando, vale a dire il
coniuge, i figli e in genere i parenti o coloro che avrebbero potuto godere di
diritti sui beni confiscati. In secondo luogo, perché, privando costoro dei
diritti ereditari sui beni confiscati, ne causa la completa rovina, collocandoli
in una situazione di tale disperazione da indurli a commettere eventuali delitti
allo scopo di sopravvivere o di vendicarsi del male ricevuto, senza che loro ne
avessero commesso alcuno. Insomma, il bando e ancor più la conseguente confisca
appaiono a Beccaria del tutto irrazionali e perciò inutili e dannosi alla
compagine sociale. Nel tentativo poi di spiegare la cornice concettuale
all’interno della quale nasce la propria avversione alle due pene sopra
menzionate, Beccaria opera una lunga digressione di carattere non giuridico, ma
sociologico o, forse, di filosofia sociale, dagli esiti tutt’altro che
disprezzabili, e che testimoniano la versatilità del suo ingegno. In sintesi,
Beccaria oppone una concezione angusta e asfittica di società – quella che la
vede come la somma di più famiglie – ad una invece ampia e liberante – quella
che la vede come l’insieme di molti esseri umani. La differenza non è di poco
conto, in quanto se si considerano quali componenti sociali in prima istanza le
famiglie, ne verrà che gli individui, prima ancora di essere parte della
società, saranno parte della famiglia e perciò saranno sottoposti prima al capo
della famiglia e soltanto dopo al potere dello Stato: una concezione familistica
della società che Beccaria condanna duramente e senza mezzi termini, quale
corrosiva del legame sociale autentico e universale. Per quanto certamente
Beccaria nulla potesse sapere di mafia e di simili fenomeni sociali, la sua
analisi rimane valida ancor oggi soprattutto in relazione ai legami familistici
che, nell’ottica della cultura mafiosa, sono destinati sempre e in ogni caso a
prevalere su quelli sociali e perfino a negarli o a combatterli. Beccaria
insiste poi molto su una circostanza dettata dallo spirito utilitaristico a cui
è improntata tutta la sua opera: la pena produce efficacia intimidatrice
maggiore non in ragione della sua crudeltà, ma della sua certezza. Si tratta di
una considerazione che il legislatore del nostro tempo dimentica in modo che
direi perfino studiato e sistematico. Si pensi alle numerose occasioni in cui,
dopo il ripetersi di un certo delitto, il parlamento si affretta ad aumentare la
pena per esso prevista dal codice penale: Beccaria ne riderebbe sconsolato. E
avrebbe perfettamente ragione. Infatti, mai si è visto che un soggetto si
astenga dal delinquere – se ne abbia sufficiente spinta psicologica – per il
timore della gravità della pena, se ragionevolmente possa ritenere che di fatto
non la sconterà mai. Al contrario, anche una pena relativamente mite è in grado
di scoraggiare il futuro delinquente, se questi sia ragionevolmente certo che ne
sarà effettivo destinatario. Dal punto di vista della sua gravità, la pena
otterrà il suo effetto – conclude il giurista milanese – sol che “il male della
pena ecceda il bene che nasce dal delitto”; e, fedele al suo spirito
matematizzante, aggiunge che in questo eccesso di male “dev’essere calcolata
l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe”. Il
legislatore del nostro tempo ignora completamente queste osservazioni assai
calzanti e dotate di buon senso. E, forse, per indurlo a prestarvi attenzione,
bisognerebbe fermasse il suo sguardo sulla conclusione finale di Beccaria il
quale sagacemente annota: “Tutto il di più è dunque superfluo e perciò
tirannico”. Il nostro parlamento lo ignora.
«Non è la crudeltà delle pene che frena i
delitti!».
CAPITOLO XXV BANDO E CONFISCHE. Ma chi è bandito
ed escluso per sempre dalla società di cui era membro, dev’egli esser privato
dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il
perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere
alcuni casi in cui, proporzionatamente a’ delitti, vi sia la perdita di tutto o
di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando
intimato dalla legge sia tale che annienti tutt’i rapporti che sono tra la
società e un cittadino delinquente; allora muore il cittadino e resta l’uomo, e
rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte
naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi
successori piuttosto che al principe, poiché la morte ed un tal bando sono lo
stesso riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza che oso
disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto che le confische
sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono
che, quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché
per esser tali debbono esser necessarie, ed un’utile ingiustizia non può esser
tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante
tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri,
sprezzando l’esterminio futuro e le lacrime d’infiniti oscuri. Le confische
mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all’innocente la pena
del reo e pongono gl’innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere
i delitti. Qual piú tristo spettacolo che una famiglia strascinata all’infamia
ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle
leggi impedirebbe il prevenirgli, quand’anche vi fossero i mezzi per farlo!
CAPITOLO XXVI DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA. Queste
funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche piú
illuminati, ed esercitate dalle repubbliche piú libere, per aver considerato
piuttosto la società come un’unione di famiglie che come un’unione di uomini. Vi
siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è
composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se
l’associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta
mila schiavi; se l’associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e
nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole
monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo
spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche
mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo
caso, come le leggi ed i costumi sono l’effetto dei sentimenti abituali dei
membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico
s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno
frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento
spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di
dettaglio e limitato a’ piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche,
padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi
principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di
famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti
ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi.
Avezzi a piegare ed a temere nell’età piú verde e vigorosa, quando i sentimenti
son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come
resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtú nella
languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si
oppone ai vigorosi cambiamenti? Quando la repubblica è di uomini, la famiglia
non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l’età
gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno
di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città, e si
assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini
liberi nella grande società. Nel primo caso i figli, cioè la piú gran parte e la
piú utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non
sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci
reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici
ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto
da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi. Tali contradizioni fralle leggi
di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di
altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere
un perpetuo conflitto nell’animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e
timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la
beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a
stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se
stesso a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è
il bene d’alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi
senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del
fanatismo, che previene l’azione. Tali contrasti fanno che gli uomini si
sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e confusa, e in quella
lontananza che nasce dall’oscurità degli oggetti sí fisici che morali. Quante
volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi
malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene piú
piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce
proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno
come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de’ quali crescendo,
l’economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato
debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti,
crescendo l’una e l’altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti
un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto. Una repubblica troppo vasta
non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche
federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il
coraggio di Silla, e tanto genio d’edificare quant’egli n’ebbe per distruggere.
Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt’i secoli lo aspetta, se sarà
filosofo, le benedizioni de’ suoi cittadini lo consoleranno della perdita
dell’autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A
misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si
rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però sotto il
dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le virtú sempre mediocri
di famiglia sono le piú comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere
quanto fossero limitate le viste della piú parte dei legislatori.
CAPITOLO XXVII DOLCEZZA DELLE PENE. Ma il corso
delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del
quale debbo affrettarmi. Uno dei piú gran freni dei delitti non è la crudeltà
delle pene, ma l’infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei
magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere
un’utile virtú, dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza
di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il
timore di un altro piú terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i
mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la
speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre
l’idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l’avarizia e la
debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L’atrocità stessa della pena fa
che si ardisca tanto di piú per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va
incontro; fa che si commettano piú delitti, per fuggir la pena di un solo. I
paesi e i tempi dei piú atroci supplicii furon sempre quelli delle piú
sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava
la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario. Sul trono
dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano. Nella privata
oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi. A misura che i
supplicii diventano piú crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono
sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, s’incalliscono, e la forza
sempre viva delle passioni fa che, dopo cent’anni di crudeli supplicii, la ruota
spaventi tanto quanto prima la prigionia. Perché una pena ottenga il suo effetto
basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo
eccesso di male dev’essere calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del
bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di piú è dunque superfluo e perciò
tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono,
e non su quelli che ignorano. Si facciano due nazioni, in una delle quali, nella
scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la
schiavitù perpetua, e nell’altra la ruota. Io dico che la prima avrà tanto
timore della sua maggior pena quanto la seconda; e se vi è una ragione di
trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l’istessa ragione
servirebbe per accrescere le pene di quest’ultima, passando insensibilmente
dalla ruota ai tormenti piú lenti e piú studiati, e fino agli ultimi
raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai tiranni. Due altre funeste
conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di
prevenire i delitti. La prima è che non è sí facile il serbare la proporzione
essenziale tra il delitto e la pena, perché, quantunque un’industriosa crudeltà
ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare
quell’ultima forza a cui è limitata l’organizzazione e la sensibilità umana.
Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a’ delitti piú dannosi e
piú atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d’uopo per prevenirgli.
L’altra conseguenza è che la impunità stessa nasce dall’atrocità dei supplicii.
Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sí nel bene che nel male, ed uno
spettacolo troppo atroce per l’umanità non può essere che un passeggiero furore,
ma non mai un sistema costante quali debbono essere le leggi; che se veramente
son crudeli, o si cangiano, o l’impunità fatale nasce dalle leggi medesime. Chi
nel leggere le storie non si raccapriccia d’orrore pe’ barbari ed inutili
tormenti che da uomini, che si chiamavano savi, furono con freddo animo
inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la piú
sensibile nel vedere migliaia d’infelici che la miseria, o voluta o tollerata
dalle leggi, che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad
un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti
impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d’altro che di esser
fedeli ai propri principii, da uomini dotati dei medesimi sensi, e per
conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità e con lente torture
lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?
Pena di morte: né utile né necessaria,
scrive Vincenzo Vitale il 22 Agosto 2017 su "Il Dubbio". Siamo così giunti al
cuore dei temi affrontati da Beccaria, al punto che potrebbe affermarsi, senza
tema di esagerare, che ogni altro argomento da lui espresso tendeva verso questo
come scopo ultimo da trattare: la pena di morte. Gli interrogativi sulla pena di
morte attraversano tutta la storia del pensiero occidentale, il quale da sempre
si è preoccupato di reperire un fondamento teorico ad una pratica che per molti
secoli aveva soddisfatto la gestione del potere politico. Non è certo questa la
sede per censire le innumerevoli posizioni che sono state al riguardo elaborate,
ma un punto fermo va comunque messo: Beccaria non propone alcun argomento
teorico o filosofico contro la pena di morte, limitandosi a respingerla per
motivazioni di carattere pratico e utilitaristico. Ciò non è senza rilievo per
diverse ragioni. Infatti, per un verso, si tratta di argomentazioni che possono
essere ritenute valide da chiunque e dovunque, fatto questo particolarmente
importante se si pensa che in quel tempo non vi era Stato ove la pena di morte
fosse sconosciuta: il primo ad abolirla, come è noto, fu il Granducato di
Toscana, per mano di Leopoldo, molto influenzato proprio dalle idee di Beccaria,
il 30 novembre 1786. Per altro verso, proporre motivi legati alla non utilità
della pena di morte, espelleva in modo determinante dal dibattito ogni argomento
di carattere teorico che potesse essere escogitato a favore, restringendo in
modo sensibile il territorio del confronto tra i favorevoli e i
contrari. Ebbene, Beccaria rigetta la pena di morte essenzialmente con due
motivazioni, entrambe molto pratiche. Innanzitutto, perché l’effetto deterrente
che molti sostengono essa abbia, inducendo la collettività ad astenersi dal
commettere gravi delitti, si fa cogliere come inesistente. Con fine occhio di
osservatore delle dinamiche sociali e psicologiche, Beccaria infatti rileva che
la pena di morte “con la sua forza, non supplisce alla pronta dimenticanza”, e
che essa “non ha mai distolti gli uomini determinati dall’offendere la società”.
Il giurista milanese sa bene che ciò che viene più difficilmente dimenticato
dagli uomini non è un male grave e puntualmente individuato nel tempo – quale
una esecuzione capitale, che appunto egli definisce uno “spettacolo”- ma la
visione di un male, pur meno lacerante, ma duraturo nel tempo, tale da generare
uno sgomento non transeunte – quale appunto una “perpetua schiavitù”, che oggi
diremmo ergastolo ( il quale, non a caso, va abolito oggi proprio in quanto
rappresenta una sorta di pena di morte diluita nel tempo). La pena di morte non
gode allora in punto di fatto di una reale forza deterrente verso la
collettività, non mostra alcuna utilità. Da un secondo punto di vista, Beccaria
ritiene assurdo in chiave psicologica e sociale che le stesse leggi dello Strato
che puniscono l’omicidio, ne possano poi ordinare un altro allo scopo di
sanzionare il primo. Anche da questa prospettiva, la pena di morte mostra tutta
la sua inconcludenza e la sua inutilità. Infatti, si palesa del tutto inutile
tentare di scoraggiare i sudditi dal commettere gravi reati, utilizzando leggi
che, per punirli, legalizzassero proprio il comportamento punito. Si tratta di
una insanabile contraddizione che Beccaria non manca di denunciare non tanto in
sede teorica, ma di pratica utilità, allo scopo di far intendere ai governanti
come sia impossibile proporre un simile schema di pseudo- ragionamento,
destinato a fallire in partenza appunto perché autocontraddittorio. Come si è
detto, queste idee dilagarono in Europa e, poco alla volta, tutti gli Stati,
anche se a volte con grande lentezza, si risolsero ad abolire la pena di morte.
Beccaria, da uomo esperto del mondo, sapeva bene quanta fatica ci sarebbe voluta
per giungere a tale esito e, ricorrendo ad una immagine perfino poetica, scrive
che “la storia degli uomini ci dà l’idea di un immenso pelago di errori, fra i
quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano”.
Egli non si faceva illusioni e sapeva quante resistenze si sarebbero incontrate
lungo la via dell’abolizione delle esecuzioni capitali. Oggi, se essere europei
espone a tante critiche e stigmatizza tante incapacità politiche, tuttavia
giustifica un orgoglio: l’Europa è l’unico continente in cui tutti gli Stati –
nessuno escluso – hanno abolito la pena di morte. Questa si chiama civiltà: e la
dobbiamo a Beccaria.
«La pena di morte non è né utile né necessaria»
CAPITOLO XXVIII DELLA PENA DI MORTE. Questa
inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha
spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene
organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di
trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le
leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di
ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l’aggregato delle
particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini
l’arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di
ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu
fatto, come si accorda un tal principio coll’altro, che l’uomo non è padrone di
uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla
società intera? Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato
che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché
giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non
essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità. La
morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo,
quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che
interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una
rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche
cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua
libertà, o nel tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di
leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per
la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di
dentro dalla forza e dalla opinione, forse piú efficace della forza medesima,
dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano
piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un
cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per
distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può
credersi giusta e necessaria la pena di morte. Quando la sperienza di tutt’i
secoli, nei quali l’ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati
dall’offendere la società, quando l’esempio dei cittadini romani, e vent’anni di
regno dell’imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei
popoli quest’illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate
col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il
linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello dell’autorità,
basta consultare la natura dell’uomo per sentire la verità della mia assersione.
Non è l’intensione della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma
l’estensione di essa; perché la nostra sensibilità è piú facilmente e
stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma
passeggiero movimento. L’impero dell’abitudine è universale sopra ogni essere
che sente, e come l’uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei
aiuto, cosí l’idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed
iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di
uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che,
divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha
offesa, che è il freno piú forte contro i delitti. Quell’efficace, perché
spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a
cosí lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai piú
possente che non l’idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura
lontananza. La pena di morte fa un’impressione che colla sua forza non supplisce
alla pronta dimenticanza, naturale all’uomo anche nelle cose piú essenziali, ed
accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli
uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che
di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e
tranquillo governo le impressioni debbono essere piú frequenti che forti. La
pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di
compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano piú
l’animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende
inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l’ultimo
perché è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle
pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a
prevalere su di ogni altro nell’animo degli spettatori d’un supplicio piú fatto
per essi che per il reo. Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli
gradi d’intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è
alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della
propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque
l’intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha
ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di piú:
moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo,
chi per vanità, che quasi sempre accompagna l’uomo al di là dalla tomba, chi per
un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il
fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto
il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli
comincia. L’animo nostro resiste piú alla violenza ed agli estremi ma
passeggieri dolori che al tempo ed all’incessante noia; perché egli può per dir
cosí condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la
vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione
dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un
delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e
durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter
delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro:
dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perché questo supplicio sia
utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l’impressione che far dovrebbe,
cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavitù
perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò
che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche di
piú, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua
forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che
spaventa piú chi la vede che chi la soffre; perché il primo considera tutta la
somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall’infelicità del momento presente
distratto dalla futura. Tutti i mali s’ingrandiscono nell’immaginazione, e chi
soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute e non credute
dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all’animo incallito
dell’infelice. Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un
assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi che la
forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un’arte
che s’apprende colla educazione; ma perché un ladro non renderebbe bene i suoi
principii, non per ciò essi agiscon meno. Quali sono queste leggi ch’io debbo
rispettare, che lasciano un cosí grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi
nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non
conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai
degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un
ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime
della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad
alcuni pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l’ingiustizia nella sua sorgente.
Ritornerò nel mio stato d’indipendenza naturale, vivrò libero e felice per
qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verrà forse il
giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un
giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero,
correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e
palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro
cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello
scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una
quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l’orrore di quell’ultima
tragedia. Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d’anni, o anche
tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia
a’ suoi concittadini, co’ quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi
dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll’incertezza
dell’esito de’ suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne goderebbe i
frutti. L’esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria
inavvedutezza, gli fa una impressione assai piú forte che non lo spettacolo di
un supplicio che lo indurisce piú che non lo corregge. Non è utile la pena di
morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la
necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi
moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero
esempio, tanto piú funesto quanto la morte legale è data con istudio e con
formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica
volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime,
e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio.
Quali sono le vere e le piú utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che
tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata
dell’interesse privato o si combina con quello del pubblico. Quali sono i
sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d’indegnazione
e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente
esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben
pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i
valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l’origine di questa contradizione? E
perché è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perché
gli uomini nel piú secreto dei loro animi, parte che piú d’ogn’altra conserva
ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere
la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità, che col suo
scettro di ferro regge l’universo. Che debbon pensare gli uomini nel vedere i
savi magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente
tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un
misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il
giudice con insensibile freddezza, e fors’anche con segreta compiacenza della
propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah!, diranno essi,
queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e crudeli
formalità della giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione per
immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in sacrificio,
all’idolo insaziabile del dispotismo. L’assassinio, che ci vien predicato come
un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore
adoperato. Prevalghiamoci dell’esempio. Ci pareva la morte violenta una scena
terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di
momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto
ciò che ha di doloroso! Tali sono i funesti paralogismi che, se non con
chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti a’ delitti, ne’ quali,
come abbiam veduto, l’abuso della religione può piú che la religione medesima.
Se mi si opponesse l’esempio di quasi tutt’i secoli e di quasi tutte le nazioni,
che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si
annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che
la storia degli uomini ci dà l’idea di un immenso pelago di errori, fra i quali
poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani
sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusargli? Che
alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la
morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla
fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in
paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor
giunta l’epoca fortunata, in cui la verità, come finora l’errore, appartenga al
piú gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora
che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col
rivelarle. La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di
tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi
sulla faccia della terra mi faranno eco nell’intimo de’ loro cuori; e se la
verità potesse, fra gl’infiniti ostacoli che l’allontanano da un monarca, mal
grado suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co’ voti
segreti di tutti gli uomini, sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa
fama dei conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra
i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani. Felice l’umanità, se
per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni
di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtú, delle scienze,
delle arti, padri de’ loro popoli, cittadini coronati, l’aumento dell’autorità
de’ quali forma la felicità de’ sudditi perché toglie quell’intermediario
dispotismo piú crudele, perché men sicuro, da cui venivano soffogati i voti
sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se
essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà
infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un
motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo
accrescimento della loro autorità.
Carcerazione preventiva e il limite della
discrezionalità dei giudici, scrive Vincenzo Vitale il
23 Agosto 2017 su "Il Dubbio". Il commento ai capitoli 29, 30 e 31. Come era
naturale, Beccaria non manca poi di occuparsi di aspetti rilevanti della
politica criminale non solo del suoi tempo, ma di ogni tempo, compreso il
nostro. Così, il primo problema che il giurista milanese si pone è quello della
cattura degli accusati dei delitti. E di una cosa egli è assolutamente certo. Il
magistrato non può mai e in nessun caso esser designato arbitro dei casi e delle
modalità della carcerazione preventiva di un accusato, dovendo invece essere le
leggi a determinare come e quando questo possa legittimamente avvenire. In altre
parole, Beccaria ritiene che la discrezionalità dei giudici nell’ambito della
cattura preventiva dell’accusato debba esser ridotta a zero, dovendosi invece
rimettere alle leggi ogni indicazione al riguardo. Ora, abbiamo già visto prima
che l’idea che il giudice possa farsi semplice cinghia di trasmissione fra la
legge e il fatto da giudicare sia improponibile, anche se Beccaria la ripropone
ogni volta con forza, fedele all’insegnamento illuminista del suo tempo: ciò non
potrà mai accadere per il semplice motivo che il giudice è un essere umano e,
come tale, portatore di una visione del mondo specifica che mai potrà essere
messa nel nulla. Tuttavia, l’insistenza di Beccaria in tal senso può rivestire
comunque il carattere di una preziosa indicazione utilissima per il nostro
tempo, il tempo che vede purtroppo il protagonismo di diversi magistrati far
aggio sulle legittime pretese della legge. Anche oggi i giudici – se leggessero
le pagine di Beccaria – dovrebbero cercare di limitare al massimo la propria
libertà interpretativa, che a volte sfocia nella incomprensibilità
dell’arbitrio, per prestare maggiore ascolto alle indicazioni della legge, come
risultano dai testi scritti in lingua italiana: insomma, anche alle
interpretazioni c’è un limite e questo non va impunemente valicato. A margine –
per modo di dire – Beccaria lamenta poi che nel suo tempo nonostante l’accusato
possa essere stato assolto da ogni addebito, ciononostante, porti seco una nota
“d’infamia”. Lezione molto utile per il nostro tempo, un tempo in cui non basta
essere assolti con formula piena per vedersi restituita quella credibilità
sociale di cui si era stati ingiustamente spogliati. Ne sanno qualcosa coloro –
e non son pochi – che dopo anni di calvario, sono stati riconosciuti del tutto
estranei ai fatti contestati, ma che non hanno potuto pubblicizzare l’esito
positivo con la stessa forza e capillare diffusione con cui invece fu
pubblicizzato il loro arresto o la loro messa in stato d’accusa. Altro tema oggi
scottante è quello della prescrizione dei delitti, ma Beccaria lo affronta con
la serenità intellettuale che ne dimostra la libertà da ogni asservimento
ideologico. Egli suddividendo i delitti in due grandi categorie – quelli più
gravi che attaccano la vita e la incolumità e quelli meno gravi che attaccano i
beni – difende una prescrizione più lunga per i primi e una più breve per i
secondi. Non gli passa neppure per la testa di eliminarla del tutto o di ridurla
drasticamente, come invece oggi alcuni Soloni del diritto italiano vorrebbero.
Infine, in relazione a particolari delitti considerati di difficile
dimostrabilità – quali l’adulterio o l’infanticidio – Beccaria sostiene
giustamente che primo onere delle leggi non è punire chi commetta reati, ma
cercare di prevenirne la commissione, attraverso un’opera attenta di politica
sociale. Quale politica sociale abbiamo oggi in Italia, ammesso ce ne sia una,
lasciamo ai commentatori odierni delle vicende politiche individuare. Insomma,
da molti versanti, Beccaria parla non soltanto ai suoi contemporanei, ma anche a
noi, lanciandoci come un guanto di sfida che sta a noi raccogliere. Il fatto è
che in Italia nessuno lo raccoglie, probabilmente perché chi di ragione sa che
con Beccaria sarebbe una sfida perduta in partenza. E perciò finge di non
sentire e di non sapere.
Chi va in prigione e poi è assolto non può
essere infamato per sempre.
CAPITOLO XXIX DELLA CATTURA. Un errore non meno
comune che contrario al fine sociale, che è l’opinione della propria sicurezza,
è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi d’imprigionare un
cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e di
lasciare impunito un amico ad onta degl’indizi piú forti di reità. La prigionia
è una pena che per necessità deve, a differenza d’ogn’altra, precedere la
dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l’altro
essenziale, cioè che la sola legge determini i casi nei quali un uomo è degno di
pena. La legge dunque accennerà gl’indizi di un delitto che meritano la custodia
del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la
fuga, la stragiudiciale confessione, quella d’un compagno del delitto, le
minaccie e la costante inimicizia con l’offeso, il corpo del delitto, e simili
indizi, sono prove bastanti per catturare un cittadino; ma queste prove devono
stabilirsi dalla legge e non dai giudici, i decreti de’ quali sono sempre
opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una
massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno
moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la
compassione e l’umanità penetreranno le porte ferrate e comanderanno
agl’inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno
contentarsi d’indizi sempre piú deboli per cattura- re. Un uomo accusato di un
delitto, carcerato ed assolto non dovrebbe portar seco nota alcuna d’infamia.
Quanti romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal
popolo riveriti e di magistrature onorati! Ma per qual ragione è cosí diverso ai
tempi nostri l’esito di un innocente? Perché sembra che nel presente sistema
criminale, secondo l’opinione degli uomini, prevalga l’idea della forza e della
prepotenza a quella della giustizia; perché si gettano confusi nella stessa
caverna gli accusati e i convinti; perché la prigione è piuttosto un supplicio
che una custodia del reo, e perché la forza interna tutrice delle leggi è
separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite
dovrebbon essere. Cosí la prima sarebbe, per mezzo del comune appoggio delle
leggi, combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con
immediata podestà, e la gloria, che accompagna la pompa, ed il fasto di un corpo
militare toglierebbero l’infamia, la quale è piú attaccata al modo che alla
cosa, come tutt’i popolari sentimenti; ed è provato dall’essere le prigionie
militari nella comune opinione non cosí infamanti come le forensi. Durano ancora
nel popolo, ne’ costumi e nelle leggi, sempre di piú di un secolo inferiori in
bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le
feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri. Alcuni hanno sostenuto
che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un’azione contraria alle
leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile,
cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser
suddito di un dominio ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero
senza contradizione esser subordinate a due sovrani e a due codici sovente
contradittori. Alcuni credono parimente che un’azione crudele fatta, per
esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l’astratta ragione
che chi offende l’umanità merita di avere tutta l’umanità inimica e
l’esecrazione universale; quasiché i giudici vindici fossero della sensibilità
degli uomini e non piuttosto dei patti che gli legano tra di loro. Il luogo
della pena è il luogo del delitto, perché ivi solamente e non altrove gli uomini
sono sforzati di offendere un privato per prevenire l’offesa pubblica. Uno
scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro,
può essere temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed
escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici dei patti, non della
malizia intrinseca delle azioni. Sogliono i rei di delitti piú leggieri esser
puniti o nell’oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana
e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini
non s’inducono in un momento a commettere i piú gravi delitti, la pubblica pena
di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed
impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti piú leggeri, ed a’
quali l’animo è piú vicino, farà un’impressione che, distogliendolo da questi,
l’allontani viepiú da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate
fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d’infliggerle. Alcuni
liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni,
atto conforme alla beneficenza ed all’umanità, ma contrario al ben pubblico,
quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione
la necessità dell’esempio, come può condonare il risarcimento dell’offesa. Il
diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano.
Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare
quella degli altri.
CAPITOLO XXX PROCESSI E PRESCRIZIONE. Conosciute
le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il
tempo e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo cosí breve che non
pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de’
principali freni de’ delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra contrario
a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio se si rifletta che i pericoli
dell’innocenza crescono coi difetti della legislazione. Ma le leggi devono
fissare un certo spazio di tempo, sí alla difesa del reo che alle prove de’
delitti, e il giudice diverrebbe legislatore se egli dovesse decidere del tempo
necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali
lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna
prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti
minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l’incertezza della sorte di
un cittadino, perché l’oscurità in cui sono stati involti per lungo tempo i
delitti toglie l’esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di
divenir migliore. Mi basta accennar questi principii, perché non può fissarsi un
limite preciso che per una data legislazione e nelle date circostanze di una
società; aggiungerò solamente che, provata l’utilità delle pene moderate in una
nazione, le leggi che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo
della prescrizione, o il tempo delle prove, formando cosí della carcere medesima
o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione
di poche pene dolci per un gran numero di delitti. Ma questi tempi non
cresceranno nell’esatta proporzione dell’atrocità de’ delitti, poiché la
probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque
scemarsi il tempo dell’esame e crescere quello della prescrizione, il che
parrebbe una contradizione di quanto dissi, cioè che possono darsi pene eguali a
delitti diseguali, valutando il tempo della carcere o della prescrizione,
precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea,
distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa
comincia dall’omicidio, e comprende tutte le ulteriori sceleraggini; la seconda
è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella
natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la
sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de’ motivi che spingon gli
uomini oltre il naturale sentimento di pietà è di gran lunga minore al numero
de’ motivi che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un
diritto, che non trovano ne’ loro cuori ma nelle convenzioni della società. La
massima differenza di probabilità di queste due classi esige che si regolino con
diversi principii: nei delitti piú atroci, perché piú rari, deve sminuirsi il
tempo dell’esame per l’accrescimento della probabilità dell’innocenza del reo, e
deve crescere il tempo della prescrizione, perché dalla definitiva sentenza
della innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della
impunità, di cui il danno cresce coll’atrocità del delitto. Ma nei delitti
minori scemandosi la probabilità dell’innocenza del reo, deve crescere il tempo
dell’esame e, scemandosi il danno dell’impunità, deve diminuirsi il tempo della
prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi non dovrebbe
ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell’impunità quanto cresce la
probabilità del delitto. Riflettasi che un accusato, di cui non consti né
l’innocenza né la reità, benché liberato per mancanza di prove, può soggiacere
per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi
indicati dalla legge, finché non passi il tempo della prescrizione fissata al
suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere
e la sicurezza e la libertà de’ sudditi, essendo troppo facile che l’una non sia
favorita a spese dell’altra, cosicché questi due beni, che formano
l’inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti e
custoditi l’uno dall’aperto o mascherato dispotismo, l’altro dalla turbolenta
popolare anarchia.
CAPITOLO XXXI DELITTI DI PROVA DIFFICILE. In vista
di questi principii strano parrà, a chi non riflette che la ragione non è quasi
mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o piú atroci o piú oscuri
e chimerici, cioè quelli de’ quali l’improbabilità è maggiore, sieno provati
dalle conghietture e dalle prove piú deboli ed equivoche; quasiché le leggi e il
giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto;
quasiché di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo quanto
la probabilità dell’innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella
maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per i grandi
delitti che per le grandi virtú, per cui pare che gli uni vadan sempre
contemporanei colle altre in quelle nazioni che piú si sostengono per l’attività
del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene che per la massa loro o
la costante bontà delle leggi. In queste le passioni indebolite sembran piú atte
a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza
importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo
deperimento. Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella
società e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo
della probabilità dell’innocenza, ed il danno dell’impunità essendo tanto meno
valutabile quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi
dal pericolo dell’impunità, il tempo dell’esame e il tempo della prescrizione
devono diminuirsi egualmente. E pure gli adulterii, la greca libidine, che sono
delitti di difficile prova, sono quelli che secondo i principii ricevuti
ammettono le tiranniche presunzioni, le quasi-prove, le semi-prove ( quasi che
un uomo potesse essere semi innocente o semi-reo, cioè semi punibile e
semi-assolvibile), dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona
dell’accusato, nei testimoni, e persino in tutta la famiglia di un infelice,
come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per
norma e per legge. L’adulterio è un delitto che, considerato politicamente, ha
la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini
e quella fortissima attrazione che spinge l’un sesso verso l’altro; simile in
molti casi alla gravità motrice dell’universo, perché come essa diminuisce colle
distanze, e se l’una modifica tutt’i movimenti de’ corpi, cosí l’altra quasi
tutti quelli dell’animo, finché dura il di lei periodo; dissimile in questo, che
la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo piú prende
forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi. Se io avessi a parlare a
nazioni ancora prive della luce della religione direi che vi è ancora un’altra
differenza considerabile fra questo e gli altri delitti. Egli nasce dall’abuso
di un bisogno costante ed universale a tutta l’umanità, bisogno anteriore, anzi
fondatore della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa
hanno un’origine piú determinata da passioni momentanee che da un bisogno
naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l’uomo, sempre
uguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili,
anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi che cercassero diminuirne
la somma totale, perché il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei propri
e degli altrui bisogni, ma sagge per lo contrario sarebbero quelle che, per dir
cosí, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la
somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni
parte e l’aridità e l’allagamento. La fedeltà coniugale è sempre proporzionata
al numero ed alla libertà de’ matrimoni. Dove gli ereditari pregiudizi gli
reggono, dove la domestica potestà gli combina e gli scioglie, ivi la galanteria
ne rompe secretamente i legami ad onta della morale volgare, il di cui offetti,
perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi,
vivendo nella vera religione, ha piú sublimi motivi, che correggono la forza
degli effetti naturali. L’azione di un tal delitto è cosí instantanea e
misteriosa, cosí coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto, velo
necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa in vece di scemarlo,
le occasioni cosí facili, le conseguenze cosí equivoche, che è piú in mano del
legislatore il prevenirlo che correggerlo. Regola generale: in ogni delitto che,
per sua natura, dev’essere il piú delle volte impunito, la pena diviene un
incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione che le difficoltà, se non
sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d’animo di ciascun
uomo, eccitano piú vivamente l’immaginazione ed ingrandiscono l’oggetto, perché
elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile
immaginazione di sortire dall’oggetto, e costringendola a scorrere tutt’i
rapporti, piú strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui piú
naturalmente l’animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui
fugge e si allontana. L’attica venere cosí severamente punita dalle leggi e cosí
facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell’innocenza, ha meno il suo
fondamento su i bisogni dell’uomo isolato e libero che sulle passioni dell’uomo
sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei
piaceri, quanto da quella educazione che comincia per render gli uomini inutili
a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case dove si condensa l’ardente
gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto
il vigore della natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l’umanità,
anzi ne anticipa la vecchiaia. L’infanticidio è parimente l’effetto di una
inevitabile contradizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per
violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l’infamia e la morte di un essere
incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile
a cui sarebbero esposti ella e l’infelice frutto? La miglior maniera di
prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza
contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi col manto
della virtú. Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi
delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una
conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che
vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato
il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d’una nazione per prevenirlo.
Indulgente verso i suicidi e i
contrabbandieri, scrive Vincenzo Vitale il 24 Agosto
2017 su "Il Dubbio". l commento ai commenti 32 e 33. Non sembri strano che
Beccaria si soffermi anche sul tema del suicidio. Infatti, esso ha sempre
interrogato in modo sottile e inquietante la coscienza del giurista, fino a
propiziare una vera congerie di opinioni spesso in contrasto fra di loro. E ciò
anche dal punto di vista sanzionatorio, cosa che può appunto apparire strana ai
nostri occhi, se si pensa che Platone già proponeva che al cadavere di suicida
fosse tagliata la mano e che questa fosse seppellita lontano dal corpo (tipo di
sanzione simbolica). Invece, per San Tommaso, chi si toglie la vita uccide pur
sempre un uomo e perciò merita una sanzione di un qualche tipo. Ovviamente, si
pone un problema ulteriore per il tentato suicidio: qui, in astratto, si
potrebbe sottoporre a pena il soggetto che abbia tentato di suicidarsi – senza
riuscirvi – ma rimane il fatto che l’astratta comminatoria di una sanzione
avrebbe l’esito di indurre il soggetto a meglio predisporre i comportamenti
autolesionisti, per timore di incorrere nella sanzione in caso di insuccesso.
Nessuno in realtà ha mai dubitato – nella storia dell’Occidente – che il
suicidio sia un atto illecito, tranne qualche corrente della filosofia stoica o
del libertarismo anglosassone; si tratta di capire se e come possa essere
sanzionato. In certi casi la sanzione cadeva sui familiari sopravvissuti,
attraverso sanzioni civili che incidevano sulla capacità di accedere all’eredità
del suicida. Ebbene, Beccaria rigetta questa possibilità, in quanto la sanzione
cadrebbe su persone diverse dal suicida e soprattutto – e qui rifulge la sua
mentalità tipicamente utilitaristica perché una tale prospettiva sanzionatoria
non sarebbe assolutamente in grado di fermare in tempo la mano di chi voglia
usare violenza su se stesso. Da notare come anche in questo caso Beccaria metta
in campo considerazioni di taglio strettamente utilitaristico, rifuggendo da
ogni osservazione di tipo sostanziale, che afferisca cioè all’essenza del
fenomeno. Non a caso, egli evita argomentazioni di quest’ultimo genere, dal
momento che sa bene come esse in passato abbiano condotto a contrapposizioni
sterili e infruttuose, tali da non condurre ad alcun esito condiviso o
condivisibile. Una particolare clemenza Beccaria mostra poi per il reato di
contrabbando il quale, se pur dannoso per le patrie finanze, non viene quasi mai
percepito dai suoi autori nella sua reale consistenza: perciò, per il giurista
milanese, le pene per costoro debbono essere diverse da quelle previste per i
ladri o addirittura per i sicari. Qui Beccaria ripropone la sua netta avversione
per i delitti che attentano direttamente alla incolumità personale o a quella
dei beni privati, rispetto a quelli che attentano alle casse dello Stato, ma non
si tratta di insensibilità per i beni pubblici: si tratta di effettiva ed
immediata lesività dei comportamenti.
L’inutilità di fare dello Stato una prigione.
CAPITOLO XXXII SUICIDIO. Il suicidio è un delitto
che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, poiché ella non può
cadere che o su gl’innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa
non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una
statua, quella è ingiusta e tirannica, perché la libertà politica degli uomini
suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano
troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda li conferma in questo amore. La
seducente immagine del piacere e la speranza, dolcissimo inganno de’ mortali,
per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli
alletta troppo perché temer si debba che la necessaria impunità di un tal
delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle
leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il
motivo che tratterrà la mano disperata del suicida? Chiunque si uccide fa un
minor male alla società che colui che ne esce per sempre dai confini, perché
quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso con parte
del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de’ cittadini,
col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione fa un doppio danno di
quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La
questione dunque si riduce a sapere se sia utile o dannoso alla nazione il
lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa. Ogni legge
che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non
deve promulgarsi; e come sugli animi regna l’opinione, che ubbidisce alle lente
ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle dirette e violente,
cosí le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento
alle leggi anche piú salutari, che sono risguardate piú come un ostacolo da
superarsi che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i nostri
sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti
estranei alle leggi tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo
principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili
conseguenze, che, esponendole, mi allontanerebbono troppo dal mio soggetto, che
è di provare l’inutilità di fare dello stato una prigione. Una tal legge è
inutile perché, a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile non dividano
un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di
esso e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può, da che lo ha
fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può piú punirsi,
e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un
comandare all’intenzione, parte liberissima dell’uomo dall’impero delle umane
leggi. Il punire l’assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed
inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta,
arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione. Il punirlo quando ritornasse il
reo, sarebbe l’impedire che si ripari il male fatto alla società col rendere
tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese ne
aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai
forestieri di non introdurvisi. Che dovremo pensare di un governo che non ha
altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime
impressioni dell’infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La piú sicura
maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben essere
relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo perché la bilancia del
commercio sia in nostro favore, cosí è il massimo interesse del sovrano e della
nazione che la somma della felicità, paragonata con quella delle nazioni
circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali
elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla
disuguaglianza, che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le
ricchezze si addenserebbono in una sola mano. Dove i confini di un paese si
aumentano in maggior ragione che non la popolazione di esso, ivi il lusso
favorisce il dispotismo, sí perché quanto gli uomini sono piú rari tanto è
minore l’industria; e quanto è minore l’industria, è tanto piú grande la
dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto piú difficile e men temuta la
riunione degli oppressi contro gli oppressori, sí perché le adorazioni, gli
uffici, le distinzioni, la sommissione, che rendono piú sensibile la distanza
tra il forte e il debole, si ottengono piú facilmente dai pochi che dai molti,
essendo gli uomini tanto piú indipendenti quanto meno osservati, e tanto meno
osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in
maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perché
anima l’industria e l’attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e
comodi al ricco perché quegli d’ostentazione, che aumentano l’opinione di
dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi che negli stati
vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso
d’ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati piú che vasti
il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio ed
il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque
facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e
solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talché non impedisce il
sentimento della miseria, piú cagionato dal paragone che dalla realità. Ma la
sicurezza e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle che formano la base
principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la
popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia. Siccome le
fiere piú generose e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei
boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all’uomo
insidiatore, cosí gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia gli
distribuisce. Egli è dunque dimostrato che la legge che imprigiona i sudditi nel
loro paese è inutile ed ingiusta. Dunque lo sarà parimente la pena del suicidio;
e perciò, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche
dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena, in vece di
cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse che
una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall’uccidersi, io
rispondo: che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia
l’esistenza quaggiù, talché vi preferisce un’infelice eternità, deve essere
niente mosso dalla meno efficace e piú lontana considerazione dei figli o dei
parenti.
CAPITOLO XXXIII CONTRABBANDI. Il contrabbando è un
vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di lui pena non
dev’essere infamante, perché commesso non produce infamia nella pubblica
opinione. Chiunque dà pene infamanti a’ delitti che non sono reputati tali dagli
uomini, scema il sentimento d’infamia per quelli che lo sono. Chiunque vedrà
stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano ed a
chi assassina un uomo o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna
differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti
morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a
prodursi nell’animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l’aiuto
dei piú sublimi motivi e un tanto apparato di gravi formalità. Questo delitto
nasce dalla legge medesima poiché, crescendo la gabella, cresce sempre il
vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando e la facilità di
commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi e colla diminuzione del
volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita e la roba che
l’accompagna è giustissima, ma sarà tanto piú efficace quanto piú piccola sarà
la gabella, perché gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che
l’esito felice dell’impresa produrrebbe. Ma perché mai questo delitto non
cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per
conseguenza alla nazione medesima?
Rispondo che le offese che gli
uomini credono non poter essere loro fatte, non l’interessano tanto che basti a
produrre la pubblica indegnazione contro di chi le commette. Tale è il
contrabbando. Gli uomini su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime
impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando,
anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che il danno fatto
al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi chi fa un
contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi
falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere. Principio
evidente che ogni essere sensibile non s’interessa che per i mali che conosce.
Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere?
No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo,
parte cosí essenziale e cosí difficile in una buona legislazione, che un tal
delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla
servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per
esempio la prigionia del contrabbandiere di tabacco non dev’essere comune con
quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e
servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i piú conformi
alla natura delle pene.
Il pentitismo è la manifesta debolezza
della legge, scrive Vincenzo Vitale il 25 Agosto 2017
su "Il Dubbio". Il commento ai capitoli 34, 35, 36 e 37. Dove Beccaria si mostra
davvero innovatore è nel campo dei reati che oggi chiameremmo di tipo
fallimentare, derivanti cioè dall’attività commerciale di un certo soggetto.
Beccaria infatti distingue fra il fallito colpevole e quello innocente, vale a
dire fra quello che dolosamente abbia frodato i creditori nell’ambito della
propria attività e quello che invece sia stato vittima incolpevole di
circostanze avverse che ne hanno cagionato l’insolvenza. Il primo va punito in
modo proporzionato alla gravità dei fatti commessi, mentre il secondo va invece
perfino aiutato dallo Stato, proprio in quanto del tutto incolpevole. Oggi ci
sembra la scoperta dell’acqua calda, ma se si pensa che Beccaria scriveva queste
cose e diffondeva queste idee oltre due secoli e mezzo fa – quando ancora il
debitore veniva incarcerato – allora non sarà difficile comprendere la portata
davvero rivoluzionaria delle sue pagine. Del tutto contrario è poi Beccaria alla
imposizione di taglie, che oggi stranamente tornano a far capolino di tanto in
tanto per iniziativa di qualche associazione privata, allo scopo di scoprire i
colpevoli di reati commessi contro un qualche socio. Il giurista milanese
osserva che tale tipo di iniziativa è sommamente inutile, in quanto “in vece di
prevenire un delitto, ne fa nascer cento”, poiché induce al tradimento, armando
la mano dei cittadini contro altri cittadini e mentre punisce un reato, un altro
ne propizia. Insomma, una prassi nefasta che produce più danni di quanti
vorrebbe evitarne. E finalmente Beccaria tocca il tema della impunità che alcuni
Tribunali offrono al complice di un grave delitto che farà il nome dei suoi
sodali: oggi diremmo il tema del pentitismo. Ora, pur in presenza di
indubitabili vantaggi (scoprire gli autori di gravi reati e prevenirne altri),
Beccaria sostiene che gli svantaggi siano di gran lunga più significativi:
infatti, sollecitare la delazione, pur fra scellerati, significa da un lato
autorizzare il tradimento e, dall’altro, manifestare la debolezza della legge,
“che implora l’aiuto di chi l’offende”. Questa posizione dovrebbe essere
meditata da quanti – ed oggi non sono pochi – con eccessiva superficialità e
spregiudicatezza intendono sempre e comunque far ricorso allo strumento della
delazione legalizzata, come si trattasse di una innocente strategia di politica
criminale. Beccaria non riesce proprio a tollerare questa impostazione,
nonostante sembri quasi che faccia di tutto per autoconvincersi in senso
contrario. Ecco perchè così egli conclude sul punto: “Ma invano tormento me
stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il
monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento e
alla dissimulazione”. Beccaria si pone qui degli interrogativi che non sono
esclusivamente di carattere etico, ma anche di carattere giuridico,
interrogativi che invece i giuristi di oggi in Italia fingono di non conoscere
neppure e per i quali non mostrano comunque alcuna sensibilità. Di fatto oggi in
Italia nessuno si pone queste domande. Eppure, qualcuno dovrebbe porsele, se non
altro perché esse hanno un senso compiuto. Il pentitismo viene di solito difeso
con il tipico ragionamento del fine che giustifica i mezzi, di sapore
machiavellico. Ora, a parte che un tale concetto non fu mai espresso dal
segretario fiorentino, rimane che si tratta di un ragionamento assurdo: si sa
quanto lo criticasse Hegel, il quale chiariva che il fine non giustifica mai i
mezzi, ma li specifica soltanto. Si prega perciò i Soloni di casa nostra di non
usare più questo argomento che è semplicemente inesistente.
Chi ha la forza per difendersi non cerca di
comprarla con le taglie.
CAPITOLO XXXIV DEI DEBITORI. La buona fede dei
contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare
ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo importante il
distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser
punito coll’istessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete, poiché
il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni
de’ cittadini, non è maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse.
Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi
a’ suoi giudici che o l’altrui malizia, o l’altrui disgrazia, o vicende
inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual
barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell’unico e tristo
bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce dei colpevoli, e
colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza
colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non era in sua
balìa di non offendere, leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli
sofferte per quella speranza che per lo piú scintilla nell’animo umano, la quale
ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri e gli avantaggiosi
per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i piú obvii amano le leggi
crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell’interesse di ciascuno
che fossero moderate, perché è piú grande il timore di essere offesi che la
voglia di offendere. Ritornando all’innocente fallito, dico che se
inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione fino al totale pagamento, se
non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate e
di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebb’esser
costretta sotto pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare
proporzionalmente ai progressi, qual sarà il pretesto legittimo, come la
sicurezza del commercio, come la sacra proprietà dei beni, che giustifichi una
privazione di libertà inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavitù
svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella
supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore
degl’inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno
pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi.
Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave,
la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al
primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con
privazione di libertà, riserbando all’ultima la scelta libera dei mezzi di
ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori.
Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial
legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni
dei limiti sono cosí necessarie nella politica come nella matematica, tanto
nella misura del ben pubblico quanto nella misura delle grandezze. Proprietà dei
beni, che giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di
far coi mali della schiavitù svelare i secreti di un supposto fallito innocente,
caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima
legislatoria che il valore degl’inconvenienti politici sia in ragione composta
della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di
verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla
leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei
delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà,
riserbando all’ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla
terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave
e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla
pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono
cosí necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben
pubblico quanto nella misura delle grandezze. Con quale facilità il provido
legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e
rimediare alle disgrazie dell’innocente industrioso! La pubblica e manifesta
registrazione di tutt’i contratti, e la libertà a tutt’i cittadini di
consultarne i documenti bene ordinati, un banco pubblico formato dai saggiamente
ripartiti tributi sulla felice mercatura e destinato a soccorrere colle somme
opportune l’infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente
avrebbero ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici,
le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere
nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d’inni immortali di
riconoscenza di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men
cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del
momento presente, una guardinga rigidezza alle novità s’impadroniscono dei
sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.
CAPITOLO XXXV ASILI. Mi restano ancora due
questioni da esaminare: l’una, se gli asili sieno giusti, e se il patto di
rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei sia utile o no. Dentro i confini di
un paese non dev’esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse
seguir deve ogni cittadino, come l’ombra segue il corpo. L’impunità e l’asilo
non differiscono che di piú e meno, e come l’impressione della pena consiste piú
nella sicurezza d’incontrarla che nella forza di essa, gli asili invitano piú ai
delitti di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili è il
formare tante piccole sovranità, perché dove non sono leggi che comandano, ivi
possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito
opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere
che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinioni degli
uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le nazioni, io non
ardirei decidere questa questione finché le leggi piú conformi ai bisogni
dell’umanità, le pene piú dolci, ed estinta la dipendenza dall’arbitrio e
dall’opinione, non rendano sicura l’innocenza oppressa e la detestata virtú;
finché la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre piú
unisce gl’interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure
dell’Asia, quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che
perdoni ai veri delitti sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.
CAPITOLO XXXVI DELLA TAGLIA. L’altra questione è
se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo ed armando
il braccio di ciascun cittadino farne un carnefice. O il reo è fuori de’
confini, o al di dentro: nel primo caso il sovrano stimola i cittadini a
commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo cosí un’ingiuria ed
una usurpazione d’autorità negli altrui dominii, ed autorizza in questa maniera
le altre nazioni a far lo stesso con lui; nel secondo mostra la propria
debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di piú, un tal
editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtú, che ad ogni minimo vento
svaniscono nell’animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo
puniscono. Con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia, di
parentela, di amicizia, e coll’altra premia chi gli rompe e chi gli spezza;
sempre contradittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi
sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt’i cuori. In vece di
prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle
nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un
edificio rovinoso che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una
nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre
piú tendono a confondersi colla vera politica. Gli artificii, le cabale, le
strade oscure ed indirette, sono per lo piú prevedute, e la sensibilità di tutti
rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d’ignoranza
medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla
privata, servono d’instruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi
che premiano il tradimento e che eccitano una guerra clandestina spargendo il
sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa cosí necessaria
riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro
felicità, le nazioni la pace, e l’universo qualche piú lungo intervallo di
tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.
CAPITOLO XXXVII ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITÀ.
Perché le leggi non puniscono l’intenzione, non è però che un delitto che
cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo non meriti
una pena, benché minore all’esecuzione medesima del delitto. L’importanza di
prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l’attentato e
l’esecuzione vi può essere un intervallo, cosí la pena maggiore riserbata al
delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano piú
complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa
ragione. Quando piú uomini si uniscono in un rischio, quant’egli sarà piú grande
tanto piú cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque piú difficile trovare
chi si contenti d’esserne l’esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri
complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all’esecutore fosse fissato un
premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio la pena dovrebbe
esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà
essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia
possibile tra i compagni di un delitto. Alcuni tribunali offrono l’impunità a
quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente
ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl’inconvenienti sono che la nazione
autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perché sono meno
fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quegli di viltà: perché il primo
non è frequente, perché non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo
faccia conspirare al ben pubblico, e la seconda è piú comune e contagiosa, e
sempre piú si concentra in se stessa. Di piú, il tribunale fa vedere la propria
incertezza, la debolezza della legge, che implora l’aiuto di chi l’offende. I
vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli
effetti ed occulti gli autori intimoriscono il popolo; di piú, si contribuisce a
mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che
manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse la
impunità al complice palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una
speciale dichiarazione in un caso particolare, perché cosí preverrebbe le unioni
col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo;
il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso
particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare
l’impunità col bando del delatore… Ma invano tormento me stesso per distruggere
il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della
pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla
dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi se si mancasse
all’impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio
ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all’invito delle leggi! Non sono
rari nelle nazioni tali esempi, e perciò rari non sono coloro che non hanno di
una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il piú destro e il
piú potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto
ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con
imperturbabile sagacità i sentimenti piú cari e le passioni piú violente, sí
tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici
gli stromenti.
Il divieto di porre domande “suggestive”
e l’uso della tortura, scrive Vincenzo Vitale il 26
Agosto 2017 su "Il Dubbio". Commento ai capitoli 38, 39, 40 e 41. L’etimo di
“suggestivo” ci dice che tale aggettivo proviene dal verbo “suggerire”: ecco
perché i nostri codici di procedura proibiscono di porre al testimone delle
domande suggestive, vale a dire tali da indicare implicitamente, cioè da
suggerire, la risposta che si attende di ricevere. Al tempo di Beccaria valeva
la medesima regola, perfino ovvia allo scopo di non influenzare le deposizioni
dei testimoni in un senso o nell’altro. Sia detto fra parentesi, tale divieto
non vale solo per le parti – cioè il pubblico ministero e il difensore – ma vale
anche per il giudice, il quale, nel porre una domanda al teste, non può certo
suggerire implicitamente la risposta che da lui si attende: la nostra
giurisprudenza sul punto arranca, stentando ad ammettere questa lampante verità,
quasi che il giudice, per sue misteriose virtù, possa sottrarsi alle normali
leggi della razionalità giuridica, e spingersi lecitamente a suggerire al teste
la risposta alla propria domanda. Ma la cosa davvero interessante è che Beccaria
trae spunto da questa regola procedurale, per tornare a scagliarsi contro la
tortura con un argomento ineccepibile. Infatti, egli stigmatizza un ordinamento
giuridico che da un lato proibisce le domande suggestive, mentre dall’altro
autorizza la tortura: cosa più “suggestivo” del dolore fisico insopportabile?
Ecco la stridente contraddizione degli ordinamenti del suo tempo, che egli non
manca di rilevare e di censurare. Beccaria non giunge però ad ammettere che
l’accusato possa rifiutarsi di rispondere, come invece garantito nei codici di
procedura penale dei moderni Stati di diritto, con l’istituzione del “diritto al
silenzio” dell’imputato, limitandosi egli a rilevare che nessuna pena ulteriore
va all’accusato irrogata nel caso in cui le domande postegli siano inutili, in
quanto certa la sua colpevolezza. Anche qui dunque, dominante, la prospettiva
utilitaristica. Tace invece, e a ragione, Beccaria su delitti che davano luogo
alla pena del rogo; e ne tace perché non di delitti si trattava, ma di peccati
e, come è noto, egli distingue nettamente e separa i primi dai secondi, questi
ultimi dovendosi lasciare alla competenza di altra autorità. Ma siccome abbiamo
visto più volte che Beccaria non tradisce la propria ispirazione utilitarista,
non poteva mancare un accenno a quelle che chiama “false idee di utilità”. Tali
sono le leggi che sacrificano vantaggi reali a favore di inconvenienti puramente
immaginari, quelle che toglierebbero agli uomini “il fuoco perché incendia e
l’acqua perché annega”. Con un pizzico di umorismo che non guasta, Beccaria
rende benissimo la sua idea, che forse oggi potremmo definire, forzando un po’,
antiproibizionista. Così, Beccaria si dichiara contrario alle leggi che
proibiscono di portare armi, in quanto esse disarmeranno soltanto coloro che non
sono “inclinati” a portarle, mentre i veri delinquenti che si avvalgono delle
armi come normale strumento delle loro malefatte non si lasceranno certamente
scoraggiare da una legge che punisce il porto dell’arma, se questa serve per
commettere i ben più gravi delitti ai quali si son già preparati. Massima e
certa utilità sta dunque, per Beccaria, più che nel punire i delitti, nel
prevenirli. Il modo più sicuro per il giurista milanese sta nel fare leggi
“chiare e semplici”, tali da poter essere da tutti intese e seguite. Ora, a
parte il limite del razionalismo illuminista, di cui anche Beccaria partecipava,
in forza del quale basterebbe conoscere la verità delle cose, per seguirla (cosa
che non è, perché non sempre la volontà segue la ragione: e basti citare in
proposito un celebre distico di Terenzio: “video bona proboque, deteriora
sequor”), rimane il fatto incontestabile che in un sistema di leggi scritte,
quale il nostro, o esse sono chiare e comprensibili oppure sono inutili. Basti
por mente alla situazione italiana di oggi, dove un esasperante ed
intricatissimo groviglio di norme e precetti che si rincorrono, si
sovrappongono, si escludono vicendevolmente, si presenta come un vero rompicapo
per il giurista. E da qui naturalmente una pluralità di interpretazioni, di
rimandi, di conflitti: insomma, la incertezza del diritto elevata a fisiologico
canone interpretativo. Beccaria ne sarebbe inorridito, bollando buona parte
delle nostre leggi vigenti con l’infamante marchio della inutilità.
Per prevenire i delitti servono leggi chiare e
semplici.
CAPITOLO XXXVIII INTERROGAZIONI SUGGESTIVE,
DEPOSIZIONI. Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni che chiamansi
suggestive in un processo: quelle cioè secondo i dottori, che interrogano della
specie, dovendo interrogare del genere, nelle circostanze d’un delitto: quelle
interrogazioni cioè che, avendo un’immediata connessione col delitto,
suggeriscono al reo una immediata risposta. Le interrogazioni secondo i
criminalisti devono per dir cosí inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare
giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono o per non
suggerire al reo una risposta che lo metta al coperto dell’accusa, o forse
perché sembra contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da sé.
Qualunque sia di questi due motivi è rimarcabile la contradizione delle leggi
che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocché qual
interrogazione piú suggestiva del dolore? Il primo motivo si verifica nella
tortura, perché il dolore suggerirà al robusto un’ostinata taciturnità onde
cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole suggerirà la confessione
onde liberarsi dal tormento presente piú efficace per allora che non il dolore
avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perché se una
interrogazione speciale fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli
spasimi lo faranno molto piú facilmente: ma gli uomini piú dalla differenza de’
nomi si regolano che da quella delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica
i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello che rende
nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato; egli è morto
civilmente, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un morto non è
capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si
sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione se la
verità dovesse cedere alle formule giudiciali. Purché le deposizioni di un reo
condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perché
non dovrassi concedere, anche dopo la condanna, e all’estrema miseria del reo e
agl’interessi della verità uno spazio congruo, talché adducendo egli cose nuove,
che cangino la natura del fatto, possa giustificar sé od altrui con un nuovo
giudizio? Le formalità e le ceremonie sono necessarie nell’amministrazione della
giustizia, sí perché niente lasciano all’arbitrio dell’amministratore, sí perché
danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e
regolare, sí perché sugli uomini imitatori e schiavi dell’abitudine fanno piú
efficace impressione le sensazioni che i raziocini. Ma queste senza un fatale
pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla
verità, la quale, per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di
qualche esterna pompa che le concilii il popolo ignorante. Finalmente colui che
nell’esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli merita
una pena fissata dalle leggi, e pena delle piú gravi che siano da quelle
intimate, perché gli uomini non deludano cosí la necessità dell’esempio che
devono al pubblico. Non è necessaria questa pena quando sia fuori di dubbio che
un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talché le interrogazioni siano
inutili, nell’istessa maniera che è inutile la confessione del delitto quando
altre prove ne giustificano la reità. Quest’ultimo caso è il piú ordinario,
perché la sperienza fa vedere che nella maggior parte de’ processi i rei sono
negativi.
CAPITOLO XXXIX DI UN GENERE PARTICOLARE DI
DELITTI. Chiunque leggerà questo scritto accorgerassi che io ho ommesso un
genere di delitti che ha coperto l’Europa di sangue umano e che ha alzate quelle
funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani,
quand’era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l’udire i
sordi confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di
membra umane, fra lo stridere dell’ossa incarbonite e il friggersi delle viscere
ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il secolo e
la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo
lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare come debba essere necessaria
una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l’esempio di molte
nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune
sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure
possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza
delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che mentre
alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e
soprannotando le vere, le false si sommergono nell’oblio, altre, mal sicure per
la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo
lungo sarebbe il provare come, quantunque odioso sembri l’impero della forza
sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi
l’avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e
fraternità comandato dalla ragione e dall’autorità che piú veneriamo, pure sia
necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e
conforme ai veri interessi degli uomini, se v’è chi con riconosciuta autorità lo
esercita. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal
patto sociale, e non dei peccati, de’ quali le pene, anche temporali, debbono
regolarsi con altri principii che quelli di una limitata filosofia.
CAPITOLO XL FALSE IDEE DI UTILITÀ. Una sorgente di
errori e d’ingiustizie sono le false idee d’utilità che si formano i
legislatori. Falsa idea d’utilità è quella che antepone gl’inconvenienti
particolari all’inconveniente generale, quella che comanda ai sentimenti in vece
di eccitargli, che dice alla logica: servi. Falsa idea di utilità è quella che
sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di poca
conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché incendia e l’acqua
perché annega, che non ripara ai mali che col distruggere. Le leggi che
proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i
non inclinati né determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di
poter violare le leggi piú sacre della umanità e le piú importanti del codice,
come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto
facili ed impuni debbon essere le contravenzioni, e l’esecuzione esatta delle
quali toglie la libertà personale, carissima all’uomo, carissima all’illuminato
legislatore, e sottopone gl’innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei?
Queste peggiorano la condizione degli assaliti,
migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli
accrescono, perché è maggiore la confidenza nell’assalire i disarmati che gli
armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici ma paurose dei delitti, che
nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla
ragionata meditazione degl’inconvenienti ed avantaggi di un decreto universale.
Falsa idea d’utilità è quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri
sensibili la simmetria e l’ordine che soffre la materia bruta e inanimata, che
trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla
moltitudine, per dar forza ai lontani, de’ quali brevissima e debole è
l’impressione, se una forza d’immaginazione, non ordinaria nella umanità, non
supplisce coll’ingrandimento alla lontananza dell’oggetto. Finalmente è falsa
idea d’utilità quella che, sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico
dal bene di tutt’i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo
stato di natura, che l’uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto basta per
far bene a sé stesso, ma l’uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi
a offender altri senza far bene a sé. Il dispotico getta il timore e
l’abbattimento nell’animo de’ suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior
forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è piú solitario e domestico
tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è
piú pubblico ed agita una moltitudine piú grande di uomini tanto è piú facile
che vi sia o l’imprudente, o il disperato, o l’audace accorto che faccia servire
gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti piú grati e tanto piú
seducenti quanto il rischio dell’intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il
valore che gl’infelici danno alla propria esistenza si sminuisce a proporzione
della miseria che soffrono. Questa è la cagione per cui le offese ne fanno
nascere delle nuove, che l’odio è un sentimento tanto piú durevole dell’amore,
quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che
indebolisce il secondo.
CAPITOLO XLI COME SI PREVENGANO I DELITTI. È
meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d’ogni
buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o
al minimo d’infelicità possibile, per parlare secondo tutt’i calcoli dei beni e
dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo piú falsi ed
opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività
degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le
costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si
turbino nei loro movimenti cosí nelle infinite ed oppostissime attrazioni del
piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed
il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il
comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è
prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli
è un definire a piacere la virtú ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed
immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò che
può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l’uomo dell’uso de’ suoi sensi. Per
un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille
che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti
dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei
motivi, l’ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di
commettergli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un
tributo di tutti al comodo di alcuni pochi. Volete prevenire i delitti? Fate che
le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia
condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle.
Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi.
Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è
salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini
schiavi sono piú voluttuosi, piú libertini, piú crudeli degli uomini liberi.
Questi meditano sulle scienze, meditano sugl’interessi della nazione, veggono
grandi oggetti, e gl’imitano; ma quegli contenti del giorno presente cercano fra
lo strepito del libertinaggio una distrazione dall’annientamento in cui si
veggono; avvezzi all’incertezza dell’esito di ogni cosa, l’esito de’ loro
delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione che gli
determina. Se l’incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per
clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità. Se cade in una
nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l’attività in un infinito numero
di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore e che
fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza. Se cade su
di una nazione coraggiosa e forte, l’incertezza vien tolta alla fine, formando
prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla
libertà.
La grandiosità e il limite di Beccaria:
l’illuminismo, scrive Vincenzo Vitale il 29 Agosto
2017 su "Il Dubbio". Il commento ai capitoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Siamo così
giunti, dopo questa veloce cavalcata, alla conclusione della fatica di Beccaria
e questi ne profitta per ribadire alcuni concetti già espressi, ma che egli
ritiene particolarmente rilevanti e significativi del suo pensiero. Insiste
così sulla necessità della diffusione del sapere e, sulle tracce di Rousseau,
della educazione dei cittadini, certo che quando entrambi saranno consolidati, i
delitti saranno quasi depennati dai comportamenti sociali. Ora, che il sapere e
la educazione civica debbano essere diffusi e a tutti garantiti è cosa di cui
nessuno dubita, ma, come già in precedenza accennato, possiamo esser certi che
ciò non basterà affatto a debellare la commissione di delitti. Ribadisco qui che
dunque Beccaria, oltre i suoi enormi meriti, incappa nel limite proprio della
formazione illuministica del suo tempo, consistente in una sorta di endemico
socratismo giuridico sociale, tanto più fragile quanto più autentico. Come è
noto, per Socrate, la conoscenza della virtù è la strada maestra per seguirla,
tutto risolvendosi appunto nella necessità di vincere l’ignoranza che affligge
l’animo umano. Non è così, come l’esperienza insegna. In moltissimi casi, non
basta conoscere la virtù – morale o sociale – per seguirne le tracce senza
esitazioni. Occorre invece, dopo averla conosciuta, volerla seguire in modo
deliberato e consapevole. Il razionalismo socratico – che poi è quello medesimo
di Beccaria – incorre infatti proprio in questo limite insuperabile: mettere in
primo piano la ragione, ma senza far i conti, come invece sembra necessario, con
la volontà degli uomini. Se fosse come sostiene Beccaria, basterebbe un’opera
massiccia di scolarizzazione sociale per debellare i delitti. Ebbene, in Italia,
nel dopoguerra, la percentuale di analfabeti, si è pressocchè azzerata, ma non
sembra che i delitti siano diminuiti in modo considerevole; anzi, negli ultimi
decenni, essi sono lievitati di numero e di gravità in modo esponenziale. In
altri termini, non basta conoscere la virtù per fare il bene ed evitare il male:
bisogna esercitarsi con la volontà, usando rettamente di questa nei casi
specifici e concreti. Va da se che in un modello sociale come quello auspicato
da Beccaria – dove al massimo sapere corrisponde la quasi scomparsa dei delitti
– il potere che normalmente viene riconosciuto quale prerogativa della
sovranità, quello di concedere la grazia, va debitamente escluso. Infatti, egli
definisce “felice” la nazione ove la clemenza e il perdono del sovrano
divenissero non solo meno necessari, ma addirittura funesti. Ora, in un modello
ideale ciò può anche essere, a patto però che si abbia consapevolezza che
appunto si tratti di un modello ideale e non reale. Molto meno convincente è
tale conclusione, se ci si pone davanti alla cruda realtà dei rapporti sociali e
dei comportamenti umani. Allora, si vedrà che del potere di concedere la grazia
da parte del sovrano nessun ordinamento reale potrà mai fare a meno, per il
semplice motivo che mai è possibile rinunciare alla correzione del diritto e
della sentenza, mai alla possibilità di rovesciare un verdetto, mai a quella di
rimediare ad un errore, mai insomma a quello che Radbruch definiva come “un
raggio di luce che penetra nel freddo ed oscuro mondo del diritto”. Preziosa è
infine la sintesi finale con cui, prendendo congedo dai lettori, Beccaria
ripropone le caratteristiche che la pena deve possedere per non essere
tirannica. La pena deve dunque essere pubblica, perché tutti le possano
conoscere e valutare; pronta, perchè l’eccessivo trascorrere del tempo dopo la
commissione del delitto non ne vanifichi il significato e la portata;
necessaria, perché essa non sembri frutto di arbitrio e di dispotismo; minima,
perché tutti vedano che di essa non si abusa, ma si usa con la necessaria
moderazione; proporzionata, perché, se non lo fosse, la pena medesima
commetterebbe grave ingiustizia; dettata dalle leggi, perché non sembri
stabilita dai singoli magistrati o dal potere sovrano, ma prevista per tutti in
modo imparziale e indifferente. Tutte dimensioni della pena che per noi oggi
suonano come normali ed ovvie, al punto che se ne mancasse soltanto una,
grideremmo al misfatto e alla tirannia del potere. Non così, al tempo di
Beccaria; e di questo, nell’accostarsi a queste pagine, dobbiamo sempre
mantenere adeguata consapevolezza. Per questa ragione, tutti i popoli europei
conserviamo verso queste pagine un enorme debito di riconoscenza, nel duplice
senso del ringraziamento e della continua meditazione. Se Beccaria non avesse
illuminato la storia con queste sue coraggiose riflessioni, probabilmente oggi
non potremmo esercitare la nostra libertà di cittadini come siamo soliti fare.
Tuttavia, molto del suo insegnamento va sempre riproposto, in quanto ancora non
sufficientemente assimilato dal nostro sistema giuridico, come abbiamo cercato
di mostrare nel corso di questo commento. Molto, ancora e nonostante tutto, va
ancora imparato e messo in pratica. Dopo quasi tre secoli, non credo che
Beccaria ne sarebbe contento.
La pena deve essere pubblica, pronta,
necessaria, minima, proporzionata e dettata dalle leggi.
CAPITOLO XLII DELLE SCIENZE. Volete prevenire i
delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle
cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella
diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni
di un popolo ignorante e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni
facilitando i paragoni degli oggetti e moltiplicandone i punti di vista,
contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano
vicendevolmente, tanto piú facilmente quanto si preveggono negli altri le
medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione
nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e trema l’autorità disarmata di
ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perché non v’è uomo
illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza,
paragonando il poco d’inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le
libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire
conspiranti contro di lui. Chiunque ha un’anima sensibile, gettando uno sguardo
su di un codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto che la
funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono e chi lo
occupa. Non è vero che le scienze sian sempre dannose all’umanità, e quando lo
furono era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell’uman genere
sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti piú rozze, le prime
leggi, che erano patti momentanei che nascevano colla necessità e con essa
perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi
erano giusti, perché la loro indolenza e poca sagacità gli preservava
dall’errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre piú col moltiplicarsi degli
uomini. Erano dunque necessarie impressioni piú forti e piú durevoli che gli
distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d’insociabilità, che si
rendeva sempre piú funesto. Fecero dunque un gran bene all’umanità quei primi
errori che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico) e che
crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli
uomini quegli che osarono sorprendergli e strascinarono agli altari la docile
ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che loro fuggivan
davanti a misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perché non mai
ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto,
che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni
che si formarono da’ popoli selvaggi, questa fu l’epoca della formazione delle
grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di
quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli piú straordinari e le grazie piú
segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell’errore di
sottodividersi all’infinito, cosí le scienze che ne nacquero fecero degli uomini
una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si
scompigliano di modo che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono
persino l’antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o
per dir meglio le opinioni, sono dannose. La seconda è nel difficile e terribil
passaggio dagli errori alla verità, dall’oscurità non conosciuta alla luce.
L’urto immenso degli errori utili ai pochi potenti contro le verità utili ai
molti deboli, l’avvicinamento ed il fermento delle passioni, che si destano in
quell’occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette
sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto
all’epoche principali, vi troverà piú volte una generazione intera sacrificata
alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio
dalle tenebre dell’ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla
libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto
l’incendio che ha purgata la nazione dai mali che l’opprimono, la verità, i di
cui progressi prima son lenti e poi accelerati, siede compagna su i troni de’
monarchi ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai
asserire che la luce che illumina la moltitudine sia piú dannosa delle tenebre,
e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciute dagli uomini lor sien
funesti? Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere,
poiché questi aggiunge ai mali della prima quegli dell’errore inevitabile da chi
ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, l’uomo illuminato è il
dono piú prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, che lo
rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità e a
non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell’opinione non mai
abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtú della maggior parte
degli uomini, assuefatto a contemplare l’umanità dai punti di vista piú elevati,
avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la
distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore quanto è maggiore la massa
dell’umanità che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degli
interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire
nella pubblica luce i principii predicati nell’oscurità, ed acquistano
l’abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la
felicità di una nazione, ma felicità momentanea se le buone leggi non ne
aumentino talmente il numero che scemino la probabilità sempre grande di una
cattiva elezione.
CAPITOLO XLIII MAGISTRATI. Un altro mezzo di
prevenire i delitti si è d’interessare il consesso esecutore delle leggi
piuttosto all’osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il
numero che lo compone tanto è meno pericolosa l’usurpazione sulle leggi, perché
la venalità è piú difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono
tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la
porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo
dell’intrapresa. Se il sovrano coll’apparecchio e colla pompa, coll’austerità
degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede
oppresso, avvezzerà i sudditi a temere piú i magistrati che le leggi, essi
profitteranno piú di questo timore di quello che non ne guadagni la propria e
pubblica sicurezza.
CAPITOLO XLIV RICOMPENSE. Un altro mezzo di
prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtú. Su di questo proposito
osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d’oggi. Se
i premi proposti dal- le accademie ai discuopritori delle utili verità hanno
moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perché non i premi distribuiti
dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbeno altresí le azioni
virtuose? La moneta dell’onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del
saggio distributore.
CAPITOLO XLV EDUCAZIONE. Finalmente il piú sicuro
ma piú difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l’educazione,
oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi sono prescritto, oggetto, oso
anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo perché non
sia sempre fino ai piú remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e
solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand’uomo, che illumina l’umanità
che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali
massime di educazione veramente utile agli uomini, cioè consistere meno in una
sterile moltitudine di oggetti che nella scelta e precisione di essi, nel
sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sí morali che fisici che il
caso o l’industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla
virtú per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la
infallibile della necessità e dell’inconveniente, e non colla incerta del
comando, che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.
CAPITOLO XLVI DELLE GRAZIE. Amisura che le pene
divengono piú dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice
la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtú che è
stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutt’i doveri del trono,
dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci
ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi
vive nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono
necessarie in proporzione dell’assurdità delle leggi e dell’atrocità delle
condanne. Quest’è la piú bella prerogativa del trono, questo è il piú
desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita disapprovazione che
i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice che con tutte
le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed
imponente corredo d’infiniti commentatori, il grave apparato dell’eterne
formalità e l’adesione dei piú insinuanti e meno temuti semidot- ti. Ma si
consideri che la clemenza è la virtú del legislatore e non dell’esecutor delle
leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari; che il
far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne è
la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far
credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto
violenze della forza che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il
principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con
un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto
d’impunità. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse
nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio
architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell’amor proprio, e
l’interesse generale sia il risultato degl’interessi di ciascuno, e non sarà
costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni momento
il ben pubblico dal bene de’ particolari, e ad alzare il simulacro della salute
pubblica sul timore e sulla diffidenza. Profondo e sensibile filosofo, lasci che
gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di
felicità che lo immenso sistema, stabilito dalla prima Cagione, da quello che è,
fa loro godere in quest’angolo dell’universo.
CAPITOLO XLVII CONCLUSIONE. Conchiudo con una
riflessione, che la grandezza delle pene dev’essere relativa allo stato della
nazione medesima. Piú forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi
induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine
per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura
che gli animi si ammolliscono nello stato di società cresce la sensibilità e,
crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi
la relazione tra l’oggetto e la sensazione. Da quanto si è veduto finora può
cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all’uso, legislatore
il piú ordinario delle nazioni, cioè: perché ogni pena non sia una violenza di
uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica,
pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze,
proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi.
L’INCIVILTA’ GIURIDICA. IL RITO INQUISITORIO.
Franco Coppi: “Siamo ancora nel rito
inquisitorio E i pm dominano”, Intervista il 22 luglio
2017 de "Il Dubbio". Il professore Franco Coppi non ha dubbi: «Nel 1989 abbiamo
adottato il rito accusatorio per superare il codice Rocco e arrivare ad una
effettiva parità fra accusa e difesa. La realtà è che il rito che è rimasto
inquisitorio». Il professore Franco Coppi, 78 anni ben portati, è sicuramente
uno degli avvocati penalisti più famosi d’Italia. Nato a Tripoli in Libia, da
oltre 50 anni è protagonista di molti dei processi più importanti del Paese.
Storico difensore di Giulio Andreotti, è stato il legale di Silvio Berlusconi
nei processi Mediaset e Ruby. Attualmente assiste il ministro dello Sport Luca
Lotti accusato di rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito dell’indagine
Consip. Ma oltre ai processi “politici”, Coppi ha curato la difesa di Vittorio
Emanuele di Savoia, di Francesco Totti, del direttore del Sismi Niccolò Pollari
per il sequestro dell’imam Abu Omar e del governatore di Bankitalia Antonio
Fazio nel processo Antonveneta. E’ stato anche il legale di Sabrina Misseri nel
delitto di Avetrana. «Una tragedia che mi angoscia disse all’indomani della
conferma dell’ergastolo per la cugina di Sara Scazzi – sono ossessionato
dall’idea di non essere riuscito a dimostrare l’innocenza di quella sventurata».
Attualmente il suo nome è in predicato per la Corte Costituzionale. Incarico
prestigioso che ha, però, declinato. Come dice chi lo conosce bene, Coppi ha
sempre fatto l’avvocato e non ha intenzione adesso di diventare giudice.
Professor Coppi, com’è lo stato della giustizia
in Italia?
«La situazione
è ormai tragica. Un disastro che riguarda sia il settore penale che quello
civile».
Ci parli del penale.
«Nel 1989
abbiamo adottato il rito accusatorio. L’idea di fondo era quella di superare il
codice Rocco e di arrivare ad una effettiva parità fra accusa e difesa. La
realtà è che questa riforma del processo penale è stata fatta “all’italiana” e
adesso abbiamo un rito che sostanzialmente è rimasto inquisitorio, solo con i
tempi molto più lunghi».
Può farci un esempio?
«Certo. Nel
rito inquisitorio il processo si celebrava sulla base degli elementi raccolti
dal pubblico ministero. Con l’attuale rito la prova deve formarsi in
dibattimento attraverso il contraddittorio fra accusa e difesa. Bene, con il
meccanismo delle contestazioni, ovvero il dare lettura da parte del pm dei
verbali delle dichiarazioni rese nelle fase delle indagini preliminari dalla
persona che viene sentita nel corso del processo, entra nel fascicolo del
dibattimento ciò che ha fatto il pm prima e a prescindere da qualsiasi attività
difensiva: materiale che quindi sarà utilizzato dal giudice per la sua decisione
pur se la difesa non aveva alcun ruolo in quella fase».
Le contestazioni da parte del pm possono essere
fra le cause dell’allungamento dei tempi del processo?
«Le cause sono
molteplici. Oggi, ad esempio, si fanno troppi processi. Però, restando alle
contestazioni, se prima i processi si celebravano con una o due udienze, adesso
ne servono come minimo dieci. Udienze che poi sono diventate lunghissime,
proprio perché il pm è solito rileggere tutti i verbali».
Non mi sembra un bel risultato.
«Si. E sul
punto è necessario un intervento drastico da parte del legislatore. Che non può
pensare di risolvere il problema dello sfascio del sistema giudiziario solo
allungando la prescrizione di processi che già adesso durano una vita. Il
processo penale deve essere rivisto totalmente».
Normalmente viene data la colpa della lunghezza
dei processi agli avvocati….
«Guardi, ho
assisto una persona accusata di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti
risalgono al 2002. La sentenza, di condanna, di primo grado è del 2009. Nel 2017
è stato fissato l’appello. I giudici, penso provando un senso di vergogna per un
processo che si trascinava da 15 anni, riqualificando il fatto, hanno disposto
la prescrizione “per la tenuità del fatto”. Un modo elegante per chiudere questo
lungo processo».
Parliamo dei giudici e della qualità delle
sentenze.
«In cinquanta
anni di attività professionale non ho notato grandi differenze. Tranne sull’uso
della lingua italiana. Ma quello è un problema complessivo che riguardo la
scuola e l’università. Ad esempio è sparito l’uso del pronome. La società è
cambiata e, conseguentemente, anche i magistrati sono figli di questo
cambiamento. L’altro giorno ero in Cassazione. In un’aula c’erano dei giovani
magistrati neo vincitori di concorso in tirocinio. Mentre parlava il procuratore
generale, alcuni masticavano le gomme, gesticolando e confabulando fra di loro,
altri poi erano completamenti distratti. Non è stato un bel vedere».
Tornado alla sentenza, il Csm sta lavorando a
delle linee guida che si fondano sulla sinteticità e completezza dell’atto. Può
essere d’aiuto?
«Io sul punto
sono alquanto perplesso. Capisco l’esigenza di smaltire l’arretrato ma non credo
sia possibile stabilire a priori un numero di pagine per la sentenza. Io ho un
profondo amore per la motivazione perché permette di capire il ragionamento
fatto dal giudice. Non è possibile, a priori, dare una misura della motivazione
che valga per qualunque tipo di processo. Ogni caso richiede, come il sale nelle
ricette, un “quanto basta” di motivazione».
La sintesi però è importante.
«Guardi,
abbiamo bisogno di giudici “normali”, che focalizzino l’attenzione sul fatto e
chi siano calati nelle realtà quotidiana. Contesto, poi, la relazione più volte
citata che collega l’inefficienza della giustizia al previo filtro di
inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità non la migliore la risposta
di giustizia per la parte. Dietro quel ricorso c’è una storia, una persona che
non capirebbe perché sia stata respinta la sua istanza per un vizio di forma».
«Non rispondete al pm». E lui indaga gli
avvocati, scrive Simona Musco il 22 luglio 2017 su "Il
Dubbio". Indagati per aver suggerito al proprio assistito di avvalersi della
facoltà di non rispondere. L’incredibile storia ha come protagonisti due
avvocati di Udine, che il 23 giugno hanno visto perquisire i propri studi e le
abitazioni perché accusati di infedele patrocinio. Indagati per aver suggerito
al proprio assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’incredibile
storia ha come protagonisti due avvocati di Udine, che il 23 giugno hanno visto
perquisire i propri studi e le abitazioni perché accusati di infedele
patrocinio. Secondo il pm che ha ottenuto la perquisizione e il sequestro, uno
dei due avvocati avrebbe violato la legge suggerendo ad una cliente, accusata di
favoreggiamento, di rimanere in silenzio durante un interrogatorio. Un’accusa,
secondo il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine, «strana e incongrua»,
dato che quel suggerimento è un diritto previsto dal nostro ordinamento. Ma non
solo: l’indagata avrebbe commesso il reato di favoreggiamento a vantaggio del
marito, quando il codice penale prevede il vincolo matrimoniale «quale causa di
non punibilità». L’altro legale, invece, difensore del marito, è stato tirato in
ballo per un altro strano reato: la sua colpa è quella di essersi scambiato
informazioni con il collega, comportamento, evidenzia il Coa, previsto dal
codice deontologico. Ma ad indignare è stata anche la rilevanza data sulla
stampa alla notizia, che sebbene non riportasse i nomi dei due avvocati ha
provocato «pregiudizio e nocumento dell’intera categoria professionale». Rilievo
che, invece, non è stato dato alla decisione del Riesame, che il 13 luglio ha
annullato il provvedimento restituendo il materiale sequestrato, «non essendo
ravvisabile il fumus del reato di patrocinio infedele». La linea difensiva
seguita non può essere censurata, dice il Tribunale, in quanto «diritto
espressamente riconosciuto». Un atto di prepotenza, dunque, anche per quanto
riguarda lo scambio di informazioni tra i due avvocati. La vicenda, per il Coa,
rappresenta «un concreto pregiudizio all’indipendenza del difensore» e al
principio «dell’inviolabilità del diritto alla difesa». Un’interferenza nel
rapporto tra difensore e difeso, motivata, forse, dal fatto che la linea della
difesa non era evidentemente «suscettibile di condurre all’acquisizione di
elementi di prova a sostegno della tesi accusatoria», denuncia il Coa. Che vede
nell’atteggiamento della Procura una forma di condizionamento degli avvocati
che, non volendo essere incriminati, cambierebbero strategia. Ma il Coa alza la
voce: «non fatevi intimorire».
I giudici non siano torri
d’avorio. Il diritto ha bisogno di armonia.
L’importante memorandum siglato il 15 maggio scorso dalle massime cariche della
giustizia, promosso dall’Associazione Italiadecide diretta da Luciano Violante,
scrive Sabino Cassese il 19 luglio 2017 su "Il Corriere della Sera". Un gruppo
di lavoro promosso da Italiadecide, l’Associazione per la qualità delle
politiche pubbliche diretta da Luciano Violante, ha concluso i suoi lavori
ponendo le basi per un accordo tra le corti supreme italiane, la Corte di
cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e i procuratori generali
presso la prima e la terza corte, accordo che è stato poi firmato dai presidenti
e dai procuratori generali il 15 maggio scorso. Questo accordo costituisce una
pietra miliare nella storia della giustizia italiana. Provo a spiegare perché.
Partiamo da lontano. Lo Stato contemporaneo, quello italiano in particolare, non
è solo lo Stato hobbesiano che assicura sicurezza e pace all’interno, ma è —
come dicono i tedeschi — Jurisdiktionsstaat: in esso i giudici sono
onnipresenti, non c’è area immune dalla giurisdizione. Basti pensare alla enorme
crescita del numero di sentenze rispetto alla crescita della popolazione, e —
procedendo a ritroso — alla quantità di conflitti che finiscono davanti ai
giudici, conflitti dovuti anche all’aumento delle aree regolate da leggi. Con la
moltiplicazione dei giudizi e delle sentenze, aumenta il pericolo che ogni
giudice vada per conto suo, lasciando il cittadino senza quella sicura guida
sulla interpretazione e applicazione del diritto che l’ordinamento giuridico
dovrebbe garantire. Questo problema è accentuato dalla penetrazione nell’ordine
giuridico nazionale di almeno altri due nuovi produttori di norme e di sentenze,
l’Unione Europea con la Corte di giustizia europea e il Consiglio d’Europa con
la Corte europea dei diritti dell’uomo. Occorre, allora, armonizzare l’operato
delle corti, specialmente quelle supreme, stabilire canali di dialogo
istituzionalizzato, garantire cooperazione, specialmente tra i giudici che sono
al vertice, i tre che ho menzionato all’inizio, che sono i giudici legittimati a
eleggere propri componenti nella Corte costituzionale. Ecco, quindi, l’idea del
«memorandum», l’accordo firmato il 15 maggio scorso, tra i vertici giudiziari.
Un accordo difficile, che ha pochi precedenti. Difficile perché la tradizione
culturale italiana considera ciascun giudice una turris eburnea, un polo isolato
da tutti gli altri, che decide da solo, in silenzio, senza guardare ad altro che
non sia il caso che ha davanti. Per questo motivo, si tratta anche di un accordo
che ha pochi precedenti. In Italia, quello illustre del «concordato
giurisprudenziale» del 1929, firmato da Mariano D’Amelio, presidente della
Cassazione, e da Santi Romano, presidente del Consiglio di Stato, e
successivamente ratificato dalle Sezioni unite della Cassazione e dall’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato. Ma quell’accordo aveva un unico oggetto, la
stabilizzazione dei criteri del riparto della giurisdizione tra giudice civile e
giudice amministrativo. L’altro precedente non è italiano, ed è l’accordo
Skouris-Costa del 2011. Lo firmarono il presidente della Corte di giustizia
europea e il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed aveva
anche esso una portata limitata (all’applicazione della Carta di Nizza e
all’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo). L’importanza e la novità del nuovo accordo, quello sottoscritto a
maggio, stanno nel fatto che questo è il primo passo per una cooperazione
stabile e che esso non ha oggetti pre-definiti, ma si estende su tutta l’area
della giurisdizione. Con il nuovo accordo, avremo una attenzione maggiore
all’attività delle giurisdizioni superiori che viene chiamata nomofilattica.
Queste debbono assicurare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del
diritto, garantire indirizzi interpretativi uniformi, in una parola assicurare
l’unità dell’ordinamento. Si tratta di «beni» che sono divenuti rari,
considerati il moltiplicarsi delle corti, il ricorso sempre più frequente dei
cittadini ad esse, ma anche la confusione della nostra legislazione, l’aumento
dei produttori di diritto (Unione Europea, Stato, Regioni, ma anche organismi
globali), nonché il cosiddetto dualismo giurisdizionale che fa parte della
tradizione italiana (come di quella francese), cioè il fatto che vi sono due
giudici, uno civile, uno amministrativo. In conclusione, è un gran bene che tre
presidenti illuminati e due procuratori generali aperti alle esigenze della
collettività, con l’aiuto di una attiva fondazione privata, abbiano posto le
premesse perché il modernoÉtat de justice non parli con troppe voci discordanti.
Errori giudiziari e orrori del sistema,
scrive il 25 febbraio 2017 Mauro Mellini su "L'Opinione" Si sono succedete negli
ultimi giorni le notizie di alcuni spaventosi errori giudiziari. Spaventosi per
la banalità degli equivoci in base ai quali dei disgraziati erano stati
dichiarati colpevoli. Spaventosi per i lunghissimi periodi di carcerazione
sofferti dalle vittime di questi errori. Occorrerebbe aggiungere: spaventosi per
la facilità, che tali episodi dimostrano, che la giustizia (cosiddetta) commette
crimini del genere. Perché di crimini si tratta. Eppure c’è nell’aria, nella
stampa che ce ne dà notizia, un non celato sentimento di “fastidio”, non per
questi “incidenti”, ma per il fatto che se ne debba parlare. “L’errore
giudiziario non esiste”: non è solo l’etichettatura di una pretesa idolatra di
una giustizia autoreferenziale della sua infallibilità. Leggiamo i sapienti e
sottili discorsi di qualche esemplare di magistrato “lottatore” e vedremo che
quella non è una proposizione astratta di una fantasia letteraria. Del resto è
lo stesso Codice penale a restringere i casi di “revisione” (cioè di
accertamento dell’ingiustizia di una condanna definitiva) in modo tale da
escluderne la possibilità quando tale ingiustizia dipende da un errore. La
revisione è ammessa quando “sopravvengano nuove prove” che consentano un diverso
giudizio. Ma se un poveraccio è stato condannato con una sentenza demenziale, in
base alla prova di un’accusa di omicidio rappresentata dal fatto che un
“testimone di giustizia” (denominazione assurda, che qualifica gli altri “di
ingiustizia”) lo ha visto volare a cavallo di un asino sul luogo del delitto
lanciando scariche elettriche, quella sentenza, se mai fosse “passata in
giudicato”, non potrebbe essere oggetto di revisione. C’è poco da scherzare. Ho
conosciuto magistrati matti capaci di sentenze del genere. C’è poi la categoria
di condanne senza prove, in base a preconcetti, arzigogoli, coglionerie
inconcepibili. Se non ci sono prove non ci possono essere “nuove prove”. E, poi,
le condanne per reati che sono “inventati” dalla “giurisprudenza”, che è, poi,
“imprudenza” nel concepire una “giustizia di lotta”. Se domani s’arrivasse a
cancellare la vergogna del “reato giurisprudenziale” (tale riconosciuto e
conclamato) di “concorso esterno in associazione mafiosa”, i condannati per
quella “bella pensata” dei nostri magistrati non potrebbero adire la via della
revisione dei loro processi. Ci sono poi delle “spie” del vizio di
“disinvoltura” nel condannare: basti pensare che, quando nel Codice di procedura
è stata aggiunta la frase per cui la condanna può essere emessa quando “la
colpevolezza” dell’imputato “è provata al di là di ogni ragionevole dubbio”, non
è successo assolutamente niente. Non è aumentato il numero delle assoluzioni,
non è intervenuto nei processi ancora in grado di appello una falcidia di
precedenti condanne in casi assai dubbi. Semplicemente, tutti i dubbi sulla
colpevolezza sono divenuti “irragionevoli”. E tira a campà. E allora, cari
amici, anche di fronte alle mostruosità emesse in questi giorni non mi pare si
possa parlare di “casi” di ingiustizia, di errori, ma di assassinio morale,
questo sì. È il sistema che fa dell’errore giudiziario “quello che non può
esistere”. E del quale è scandaloso, quindi, lamentarsi. Un’ultima
considerazione: l’“Orlando Curioso”, ministro della Giustizia, ha mandato gli
ispettori a Torino per un caso di intervenuta prescrizione di un processo, tra
l’altro nato male. Non mi risulta che abbia mandato ispettori a rivedere le
carte dei cosiddetti “casi” di errori giudiziari. Già, dopo tanto tempo (passato
in galera dalle vittime) che c’è da andare a cavillare? Sono cose che capitano.
In Italia certamente sì.
W il giudice che mena la
moglie,
scrive Franco Bechis il 20 giugno 2012 su "Libero Quotidiano”. Cinque dicembre
2009. Lite accesa in una casa di Lecco. Volano parole grosse, qualche urla,
forse c'è una colluttazione. Tre marzo 2010: al tribunale di Lecco viene
presentata denuncia-querela da parte di un avvocato, Donatella Cianfa. Accusa il
marito, Gian Marco Fausto De Vincenzi di violenza privata, maltrattamenti
famigliari e lesioni personali dolose. I fatti raccontati sono proprio quelli
del 5 dicembre. Atti giudiziari di questo tipo sono piuttosto numerosi nei
tribunali italiani. Quella lite però non è da poco: la presunta vittima è un
avvocato, il marito che avrebbe commesso violenza, un giudice delle indagini
preliminari dello stesso tribunale di Lecco (oggi è giudice monocratico). Il
procedimento viene trattato in tempo record. Il 9 marzo la moglie, l'avvocato
Cianfa, ritira la denuncia- querela. Il giorno prima aveva trovato un'intesa
sulla separazione dal marito e soprattutto sugli alimenti. Il procedimento è
destinato a morire, e così sarà: proscioglimento da due accuse, estinzione del
reato per la terza grazie alla remissione della querela. Nel frattempo però il
fascicolo giudiziario è arrivato al ministero della Giustizia che ha promosso
l'azione disciplinare nei confronti del De Vincenzi davanti al Csm. La procura
generale della Cassazione sostiene che non c'è materia, essendo intervenuta la
remissione della querela. La commissione disciplinare è di diverso avviso,
perché quella violenta lite familiare è comunque esistita e può avere leso il
prestigio della magistratura. Il capo di imputazione davanti al Csm è assai
duro: sostiene che il Gip avrebbe "ripetutamente percosso" la consorte, e che in
un'occasione l'avrebbe "sbattuta contro il muro e a terra", causandole lesioni
giudicate guaribili in due settimane da un referto medico. In quella occasione
per altro il De Vincenzi avrebbe impedito alla moglie di recarsi al pronto
soccorso "sottraendole e distruggendole le chiavi della sua auto" e
costringendola a "sedersi sul letto accanto a lui per tutta la notte mentre le
tratteneva i polsi", dicendole "sei una donna inutile, fai schifo". Le accuse
sono tratte dalla stessa querela poi ritirata dalla signora, ma sono approdate
il 15 giugno scorso alla disciplinare del Csm. Dove il diretto interessato si è
difeso quasi considerandosi vittima e negando qualsiasi impatto sulla propria
funzione di magistrato, perché nessuno avrebbe conosciuto la vicenda (finita
invece su molti giornali locali e nazionali). "Devo rimarcare", ha spiegato De
Vincenzi, " che tutta la vicenda è personale, dolorosissima. Purtroppo sono anni
ancora che -diciamo- si trascina questa cosa. Dal punto di vista professionale,
di immagine, credo che assolutamente non abbia inciso minimamente non fosse
altro perché assolutamente nessuno ne è venuto a conoscenza, è una cosa che è
rimasta --da questo punto di vista fortunatamente- in una sfera del tutto
privatissima e personale". La vera sorpresa è però venuta da chi doveva
sostenere l'accusa, Vincenzo Geraci, sostituto procuratore generale della Corte
di Cassazione, che invece ha chiesto l'assoluzione con motivazioni stupefacenti:
"Non mi pare che siano emersi degli altri fatti che consentano di dire che ci
sia stata una lesione della immagine del magistrato. E' spiegato come il tutto
si sia risolto e mantenuto all'interno di un tormentato rapporto di coppia che
ha avuto queste disdicevoli manifestazioni come dire anche fisiche e
contundenti...". Anche i magistrati dunque hanno diritto alla loro dose di botte
familiari. Con la pubblica accusa così è quasi certa l'assoluzione. Anche se
tutto è stato rinviato al 22 novembre prossimo per ascoltare un teste (l'ex capo
del tribunale di Lecco) prima di sentenziare. E difatti… Csm: lesioni alla
moglie, disciplinare assolve giudice.
Lecco, condannati giudice e
avvocato: "Ci fu dolo intenzionale".
Otto mesi di pena, ecco le
motivazioni della sentenza, scrive il 30 luglio 2016 “Il Giorno". Giudice e
avvocato sono stati condannati a otto mesi con sospensione della pena.
Depositate le motivazioni della condanna a otto mesi di un giudice e avvocatessa
lecchese. L’accusa: tentato abuso d’ufficio. I fatti risalgono al 29 settembre
2011 a Lecco e il processo - essendo coinvolto un magistrato - si è tenuto
al tribunale di Brescia. Il collegio giudicante, composto da Vittorio Masia come
presidente, Maria Chiara Minazzatio e Tiziana Gueli, quest’ultima nel ruolo di
giudice estensore, ha condannato, senza le attenuanti generiche, Gian Marco De
Vincenzi e Tatiana Balbiani perché «nello svolgimento delle loro funzioni di
pubblici ufficiali non agivano con esclusivo riguardo alla cura e interessi
della persona del beneficiario e senza tener conto dei suoi bisogni». Di fatto
l’avvocatessa ha esercitato un ruolo di amministratrice di sostegno, assegnatole
dal giudice De Vincenzi. Nella sentenza si legge: «Il giudice tutelare
autorizzava in data 29 settembre 2011 l’acquisto di un immobile, operazione
rispetto alla quale vi era un conflitto di interessi con l’amministrata, avente
ad oggetto compravendita di un bene gravato da ipoteca». «Così compiendo atti
idonei e diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente a B.P. un
danno ingiusto, rappresentato dall’eccessivo prezzo del bene e a procurare un
ingiusto vantaggio» Nelle 24 pagine del dispositivo delle sentenza sono stati
ricostruiti i fatti, sentiti testimoni e nella valutazione della prova i giudici
bresciani scrivono: «L’operato del dottor De Vincenzi rivela il dolo
intenzionale del reato insito nel proposito di voler favorire l’amministratrice,
avvocato Balbiani». Durante il processo sono emerse delle responsabilità – sulla
base delle deposizioni dei testimoni chiave – e il giudice Masia ha accolto la
richiesta del sostituto procuratore che chiedeva un anno di pena. Il giudice De
Vincenzi e l’avvocatessa Balbiani sono stati condannati entrambi a otto mesi e
interdetti dai pubblici uffici per la durata della pena sia il giudice e che
l’avvocatessa. I giudici bresciani hanno deciso la sospensione condizionale
della pena e «la non menzione della condanna». Dopo la sentenza di primo grado è
stato preannunciato il ricorso.
Dodici anni al 41 bis per una bufala del
pentito, scrive Paolo Delgado il 23 luglio 2017 su "Il
Dubbio". Poco prima della sentenza di Mafia capitale, erano state annullate le
condanne per 9 persone tirate in ballo da Scarantino. Massimo Carminati è da 31
mesi in regime di carcere duro, il famoso art. 41bis al quale possono essere
sottoposti non solo i condannati ma anche i sospettati di mafiosità, cioè i
detenuti in attesa di giudizio. Dati i capi d’accusa era inevitabile che per il
cecato scattasse quell’articolo: non si trattava infatti, secondo l’accusa, di
un qualsiasi soldato di mafia ma di un boss a pieno titolo e di prima grandezza:
come don Totò Riina o "Sandokan", per intendersi. La sentenza di Roma smantella
quell’accusa da ogni punto di vista. Non solo, infatti, Carminati non è stato
condannato ai sensi dell’art. 416 bis, quello che riguarda l’associazione
mafiosa, ma non è stata riconosciuta neppure l’aggravante del ‘ metodo mafioso’.
Per quanto riguarda l’imputato numero 1 del processone è un passaggio cruciale:
in assenza di atti di violenza e di conclamate violenza il ‘ metodo mafioso’,
nell’impianto accusatorio, era costituito dalla semplice presenza di Massimo
Carminati, che comportava di per sé una ‘ riserva di violenza’ tale da
giustificare la richiesta di aggravante. Infine è caduto, secondo i giudici
della X Sezione del Tribunale di Roma, il nesso materiale con le mafie
propriamente dette. I due imputati calabresi accusati di costituire il tramite
con le ‘ndrine, Rocco Rotolo e salvatore Ruggiero, sono infatti stati assolti e
già scarcerati. In sostanza la sentenza sgombra il campo da ogni accusa di mafia
per quanto riguarda sia Carminati che Salvatore Buzzi, anche lui a lungo in
regime di 41bis ma passato alcuni mesi alla detenzione normale. Gli avvocati di
Carminati hanno già chiesto che venga eliminato il regime di carcere duro ed è
probabile, che se non certo, che otterranno il passaggio alla detenzione comune.
Del resto l’ex Nar ha seguito tutto da lontano, in videoconferenza. «Era
convinto che sarebbe andata male. Temeva che tutte le pressioni mediatiche
avrebbero portato a un responso negativo per lui. Mi ha anche detto che adesso
lo devo togliere dal 41 bis, questo è il suo primo pensiero e la sua prima
preoccupazione», ha spiegato l’avvocato Ippolita Naso al termine del colloquio
telefonico con lui. La sentenza ha dunque certificato l’esistenza di un grande
sistema corruttivo ma nulla a che vedere con la pesantezza delle accuse mosse
dalla Procura. La vera domanda a questo punto è però se fosse davvero necessario
tenere per 31 mesi in condizioni che il Comitato prevenzione tortura del
Consiglio d’Europa assimila alla tortura un detenuto in attesa di giudizio, per
il quale dovrebbe cioè valere la presunzione d’innocenza sancita dalla
Costituzione. Nel caso di Carminati, essendo fuori discussione il rischio di
mantenere contatti con un’organizzazione ormai sgominata così come l’eventualità
di un pentimento in- dotto dal carcere duro prima del giudizio, la decisione di
mantenerlo in regime di 41bis sembra dipendere essenzialmente dalla necessità di
confermare quella ‘ straordinaria caratura criminale’ che era in realtà la
pietra angolare dell’impianto accusatorio. Di fatto Carminati è stato tenuto per
31 mesi in un regime che il Consiglio d’Europa assimila alla tortura soprattutto
per confermare che era davvero quel pericolosissimo boss mafioso di cui parlava
l’accusa. Per sinistra coincidenza, pochi giorni prima, senza che se ne
accorgesse nessuno salvo Adriano Sofri e pochissimi altri, il tribunale di
Catania aveva annullato le condanne per nove persone già condannate
all’ergastolo per la strage di via D’Amelio, sulla base delle denunce del falso
pentito Scarantino. Erano fuori di galera dal 2008, da quando cioè il vero
pentito Spatuzza li aveva scagionati, ma solo con la formula interlocutoria
della ‘ sospensione della pena’. Prima di quella data, però, avevano passato ben
12 anni nelle condizioni, allora molto più dure di quelle attuali, dettate dal
41bis. E’ opportuno ricordare che le "rivelazioni" di Scarantino, dettategli
stando alle sue parole dall’allora capo ella Mobile di Palermo Arnaldo La
Barbera, poi distintosi alla Diaz nella mattanza di Genova e scomparso nel 2002,
erano state subito considerate fortemente dubbie, come hanno ricordato sia Ilda
Boccassini che Antonio Ingroia. I casi in questione sono particolarmente
vistosi, anche se il particolare del 41bis indebito quasi non è citato nei
commenti sulla sentenza di Roma e lo scempio siciliano è stato di fatto
dimenticato nonostante la sentenza di Catania. Ma di certo non sono casi unici.
La decisione di comminare il carcere duro anche ai presunti innocenti rende
inevitabili casi come quello di Massimo Carminati. L’eventualità di errori
giudiziari, soprattutto in processi che dipendono in buona misura dalle parole
dei pentiti, è inevitabile. Ce ne sarebbe a sufficienza per decidersi a riaprire
il capitolo 41bis una volta per tutte.
"Aggredito e picchiato da quel ragazzo
straniero. Ora mi licenziano pure". Il capotreno di
Trenord: "Mi è sfuggita una frase razzista nella concitazione. Ma la vittima
sono io", scrive Cristina Bassi, Giovedì 21/12/2017, su "Il Giornale". «Sono
stato aggredito e picchiato. E adesso vengo licenziato per una frase - lo
ammetto: razzista - che mi è sfuggita nella concitazione. In questa storia
assurda la vittima sono io». Giordano Stagnati, capotreno cremonese di 25 anni,
il 23 settembre scorso era in servizio sulla linea ferroviaria Brescia-Cremona.
Ha discusso con un passeggero senza biglietto, un senegalese di 23 anni, sono
volati insulti reciproci e poi le botte. In un video girato con il telefonino da
un'altra viaggiatrice Stagnati apostrofa lo straniero con un «negro di m...»,
getta dal finestrino la sua carta prepagata senza credito. Moussa Diatta spinge
a terra il capotreno, che lo morde a un braccio, e gli strappa via il palmare e
il Pos aziendali. Il senegalese è stato arrestato per rapina, Stagnati
licenziato da Trenord.
Se lo aspettava?
«Mi aspettavo un qualche provvedimento
disciplinare, ma non una misura tanto severa. Così dice la lettera di
licenziamento: ha tenuto un comportamento non consono alle mansioni proprie
della sua figura professionale e della nostra Azienda che Lei comunque
rappresenta mentre indossa l'uniforme aziendale ed esercita funzioni di
incaricato di pubblico servizio per conto di Trenord. Inoltre avrei messo a
repentaglio la mia sicurezza e quella dei viaggiatori».
Il video della rissa, in cui tra l'altro lei ha la
peggio, è finito su internet e molti le hanno dato del razzista.
«Mi dispiace molto per quello che è successo. Ma
mi è capitata questa brutta cosa, sono stato aggredito e mi è scappata una frase
sgradevole. A bocce ferme è facile per chi non ci si è trovato chiamarmi
razzista. Ora so di aver sbagliato e chiedo scusa. Però chissà gli altri al mio
posto cosa avrebbero fatto».
Ci saranno strumentalizzazioni...
«Io non sono iscritto ad alcun partito politico,
non uso i social e non ho mai espresso opinioni contro gli stranieri».
Aveva mai avuto problemi di questo tipo?
«No. Ho sempre avuto un comportamento educato con
tutti i passeggeri. Non ho mai trasceso, neppure con quelli che alzano la voce
con me. Non è vero che ho usato io le mani per primo con quel ragazzo straniero.
Nel mio lavoro non ho mai gridato né tanto meno alzato le mani. Anche in questo
caso stavo facendo il mio dovere e lui non ha esitato ad aggredirmi».
Si è accanito su di lui perché era straniero?
«Assolutamente no. Ho chiesto il biglietto a tutto
il vagone, non era certo un fatto personale. I passeggeri sprovvisti erano solo
Diatta e due ragazze, cui ho fatto pagare il biglietto con la maggiorazione
prevista. Sono le stesse che poi hanno postato il video, forse perché erano
arrabbiate con me, aggiungendo commenti offensivi nei miei confronti. I
passeggeri senza biglietto sono spesso anche gli italiani e per i molti
stranieri sprovvisti ce ne sono altrettanti con l'abbonamento».
Ha avuto paura quel giorno?
«Sì. Quel ragazzo mi ha detto razzista, bastardo,
italiano di m.... Mi sono sentito in pericolo, ricordate cos'è successo al
capotreno Carlo Di Napoli? (una gang di latinos gli amputò quasi un braccio con
un machete, ndr). Poteva andarmi molto peggio e potevo finire con più di una
contusione a un polso».
Adesso cosa farà?
«Assistito dall'avvocato Massimiliano Cortellazzi,
farò ricorso contro il licenziamento. Inoltre mi costituirò parte civile nel
processo per rapina contro Diatta. E ho querelato per diffamazione l'autrice del
filmato».
Vorrebbe continuare a lavorare a Trenord?
«Mi trovo bene in questa azienda, mi hanno assunto
a giugno di quest'anno. Vorrei tornare a lavorare. Ho superato una selezione e
fatto mesi di formazione per arrivarci. Il mio è un bel lavoro, di
responsabilità, anche se alcune volte è difficile».
Il caso Seregno. Il romanzo della mafia
brianzola pieno di cumenda e senza l’ombra di un boss,
scrive Tiziana Maiolo il 29 Settembre 2017 su "Il Dubbio". La regola è sempre la
stessa: strillare su giornali e tv che i nostri territori sono invasi dalle
mafie, poi diffondere un pacco di intercettazioni e una bella grande foto con al
centro un personaggio politico che non c’entra niente ma che viene subito
guardato con sospetto. E’ successo con Mafia Capitale, che mafia non era, come
certificato dalla sentenza di primo grado. Sta capitando qualcosa di simile in
Lombardia, dove un’inchiesta sulla ’ ndrangheta è stata mescolata in un
minestrone velenoso con le indagini su un sindaco pressato da un imprenditore
forse un po’ troppo trafficone e chiacchierone, che in qualche telefonata diceva
di avere come punto di riferimento politico il senatore Mario Mantovani. Gli
ingredienti ci sono tutti. Che in Brianza come un po’ in tutto il nord ci sia la
‘ ndrangheta, è fatto certo. Del resto le mafie vanno dove c’è maggiore
accumulazione di capitali. E si sa anche di quali reati, oltre a quello
associativo, si rendono responsabili gli uomini della criminalità organizzata:
traffico di droga, estorsioni, incendi, ricatti, detenzione di armi, omicidi. Di
questa parte dell’inchiesta, presentata in gran pompa nei giorni scorsi al
palazzo di giustizia di Milano dalla Dda di Milano e Monza, però non si sa
pressoché nulla, nessun mezzo di comunicazione ne parla. Il che è un po’
singolare, se viene lanciato un allarme (attenzione cittadini, siete invasi dai
mafiosi) è bene che tutti sappiamo da chi dobbiamo difenderci. Invece niente.
Evidentemente nella conferenza stampa non se ne è parlato. Oppure i nostri
colleghi non lo hanno ritenuto interessante. Sappiamo invece tutto su quel che
sarebbe accaduto un paio di anni fa all’interno del Comune di Seregno, pacifica
(fino a ora, visto che la giunta ieri si è anche sciolta) cittadina di 45.000
abitanti nel cuore della ricca Brianza. Un centinaio di pagine di
intercettazioni ambientali è dedicato a discussioni, litigi e pettegolezzi tra
un gruppo di tecnici che battibeccavano sulle procedure necessarie per una
variazione d’uso di un terreno su cui un imprenditore, Antonino Lugarà,
intendeva costruire un supermercato. Il terreno andava forse prima bonificato,
ma non tutti erano d’accordo. La delibera doveva essere di giunta o di
consiglio? Di cose così si discuteva. Lugarà è stato arrestato per corruzione,
perché con i voti per le elezioni del 2015 si sarebbe comprato il sindaco
Edoardo Mazza (anche lui in manette), che avrebbe ricambiato con la variazione
d’uso del suo territorio. E fino a qui sarà tutto nelle mani dei giudici (se si
arriverà a processo) valutare se ci siano state irregolarità tecniche e anche,
eventualmente, se i voti, che l’imprenditore valuta nel numero di 30, siano da
considerarsi “altra utilità”, come prevede il codice per stabilire se un
pubblico ufficiale, che non ha incassato mazzette, sia stato comunque corrotto.
Che cosa c’entra la ‘ ndrangheta? Il fatto è che Antonino Lugarà viene descritto
come un capomafia. Infatti quando viene svaligiata la casa della figlia, cui
vengono rubati tutti i gioielli, l’imprenditore sparge la voce, e chiede non
alla polizia ma ad “altri” se si riesce a recuperarli. Ma invano. Strano
comportamento per un capomafia, che si lascia svaligiare e non è neanche in
grado di recuperare la refurtiva. Va anche detto però che Lugarà è calabrese
(questo è già sospetto) e magari frequenta qualche ambiente un po’ borderline.
Forse, non sappiamo. Ma il vero peccato mortale di questo imprenditore che passa
le giornate a stressare per il supermercato i tecnici del comune di Seregno e
anche il sindaco Mazza (il quale a un certo punto si lascerà scappare al
telefono «ogni promessa è debito») è la sua conoscenza con l’ex vicepresidente
della Regione Lombardia, il senatore Mario Mantovani, che considera un suo punto
di riferimento politico. Mantovani come ha detto nell’intervista al nostro
giornale – è stato a Seregno durante la campagna elettorale del 2015, come altri
dirigenti del centrodestra hanno fatto, e ha festeggiato insieme agli altri la
vittoria. Ma quando, tramite Lugarà, gli viene chiesto (mentre era assessore
alla sanità) di trasferire un certo primario e di promuoverne un altro, non lo
fa. Il che dimostra, non solo che non c’entra con la mafia, ma neppure con
eventuali intrallazzi o clientelismi a Seregno. Inoltre non c’è una sua
intercettazione nell’inchiesta, ma solo conversazioni di altri su di lui. Si
dice che è forte, che è potente. Gravissimo. Ma c’è quella foto in cui lui è con
il sindaco presunto corrotto e con l’imprenditore presunto corruttore e anche
presunto mafioso. Come negargli un’informazione di garanzia e soprattutto una
bella gogna mediatica? Il ministro Poletti si è salvato da quella foto di Mafia
capitale, e così sarà per Mantovani. Ma intanto…
Il teorema Seregno crolla ma la giunta
(ops!) adesso non c’è più…, scrive Tiziana Maiolo il
22 Ottobre 2017 su "Il Dubbio". Il Comune brianzolo fu azzerato da un’inchiesta
ma il Riesame scarcera tutti. Il “teorema Seregno” che un mese fa, con un’azione
congiunta dei magistrati monzesi e della Pm milanese Ilda Boccassini aveva
portato all’arresto di 24 persone e azzerato la giunta della città brianzola di
Seregno, è già a pezzi. Il tribunale del riesame non solo ha scarcerato per
grave mancanza di indizi l’imprenditore Antonino Lugarà, considerato punto
centrale dell’inchiesta, ma ha demolito il pilastro dell’accusa che tanto aveva
ingolosito i giornalisti- trombettieri delle procure, e cioè l’infiltrazione
della ‘ ndrangheta nel Comune di Seregno, con la benedizione del senatore Mario
Mantovani. Intanto va chiarita una cosa, che evidentemente ai nostri colleghi di
troppi quotidiani è sfuggita (si fa per dire), mentre titolavano “’ ndrangheta
in Comune”. Né il sindaco di Seregno Edoardo Mazza e il consigliere comunale
Stefano Gatti (ambedue ai domiciliari), né il senatore Mario Mantovani
(indagato) né men che meno l’imprenditore Lugarà (arrestato) sono mai stati
inquisiti per reati di mafia. Si dice solo che l’imprenditore, che è calabrese,
è “sospettato”. Ma sospettato da chi? In genere i magistrati sanno bene come
tradurre in provvedimenti giudiziari i propri sospetti. E sospettato di che
cosa? Di aver intrattenuto rapporti. Ma non si sa bene con chi. Resta il fatto
che il reato contestato a tutti è quello di corruzione, per la presunta
accelerazione di una pratica di concessione edilizia di un supermercato. Proprio
il fatto che oggi, con la scarcerazione di Lugarà per mancanza di gravi indizi
di colpevolezza, il tribunale del riesame ha distrutto. A quanto pare c’è una
perizia d’ufficio sbagliata, inoltre i voti raccolti come corrispettivo per la
corruzione sono forse qualche decina e i famosi “eventi conviviali” cui avrebbe
partecipato Mario Mantovani si riducono a un aperitivo in un bar. Così come
semplici vanterie sono considerate le spacconate del figlio di Lugarà sui suoi
rapporti con l’esponente di Forza Italia.
Tutto normale? Normale dialettica processuale? Eh
no, perché i risultati sono politici, e nel frattempo la Giunta Comunale si è
sciolta e a Seregno è arrivato il commissario. Una volta di più l’improvvido
Circo mediatico- giudiziario ha vanificato un risultato elettorale. Ha rilevanza
il fatto che nel maggio- giugno 2015 gli elettori abbiano premiato a Seregno i
candidati del centro- destra? Speriamo non sia così, ma che siamo di fronte
soltanto all’ennesima (grave) superficialità e sciatteria di qualche magistrato.
Ma nel caso di Seregno c’è qualcosa di più e qualcosa di molto più inquietante
della disattenzione. Usiamo come traccia un qualunque articolo del 26 settembre
di un non- qualunque grande quotidiano nazionale. La cronaca è molto ampia e
molto ben costruita. Si riferisce di una conferenza stampa congiunta tra alcuni
magistrati di Monza e quelli della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano,
con la presenza della dirigente Ilda Boccassini, che spiega quale è il succo del
blitz che, dopo indagini durate 7 anni, ha portato all’arresto di 24 persone.
Sintetizza bene il cronista del grande quotidiano: «“Dal traffico internazionale
di droga alla corruzione, dalla Calabria alla Lombardia, fino a una cittadina
della Brianza, quella di Seregno, dove nell’ultimo blitz contro le infiltrazioni
della ‘ ndrangheta al nord, finisce ai domiciliari anche il sindaco di Forza
Italia…». Che cosa siamo dunque indotti a pensare? Che il Comune di Seregno sia
stato sciolto per mafia, che tutte le persone coinvolte appartengano alla ’
ndrangheta. E il traffico di droga con tutti gli altri reati che caratterizzano
l’appartenenza alle cosche? Zero assoluto, non ci soni i reati e neanche i nomi
delle persone arrestate, tranne quelli del sindaco, di un consigliere,
dell’imprenditore e del senatore Mantovani. All’ex coordinatore lombardo di
Forza Italia viene dedicato un bel capitolo. Viene descritto come un politico
molto potente, cui molti si rivolgevano per impetrare favori e carriere. Spesso
si trattava di medici che si rivolgevano all’imprenditore Lugarà perché li
raccomandasse all’assessore regionale alla sanità per questioni di trasferimenti
o promozioni. Che regolarmente non erano andati a buon fine. In che cosa sarebbe
dunque consistita la corruzione? Lo sapremo alla data della chiusura delle
indagini. Ma intanto il circo mediatico ha già provveduto a fare il suo lavoro,
rovinare reputazioni, contribuire ai ricambi di governo. Non dimentichiamo il
caso di un’altra cittadina lombarda, Sedriano, assalita con lo stesso copione:
inchiesta di ‘ ndrangheta e corruzione, arrestato il sindaco Celeste del
centrodestra. L’inchiesta è finita nei mesi scorsi: il sindaco è stato assolto.
Nel frattempo, dopo il commissariamento e le fiaccolate del Pd (che si era molto
adoperato per far cadere la giunta), oggi a Sedriano governa il Movimento 5
stelle.
“Equivoci” e omissis: così hanno montato
il caso Seregno, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 25
Ottobre 2017 su "Il Dubbio". Il consiglio comunale del paese lombardo è stato
sciolto per “mafia” in base a delle intercettazioni trascritte in maniera
«erronea». Una consulenza tecnica che «non sta né in cielo e né in terra» e
alcune intercettazioni telefoniche trascritte in maniera “erronea” hanno portato
il mese scorso alle dimissioni dell’intero Consiglio comunale di Seregno e alla
nomina di un commissario prefettizio. Secondo il teorema accusatorio della
Direzione distrettuale antimafia di Milano, il sindaco della città brianzola
Edoardo Mazza (FI) e il consigliere comunale Stefano Gatti sarebbero stati
corrotti da Antonio Lugarà, un imprenditore di origini calabresi che in cambio
del via libera alla realizzazione di un centro commerciale avrebbe garantito ai
due un appoggio alle elezioni amministrative del 2015. Oltre a loro, erano state
arrestate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano 24 persone ritenute
a vario titolo responsabili di reati che andavano dallo spaccio di sostanze
stupefacenti, alla detenzione abusiva di armi, all’estorsione, il tutto con
l’aggravante dell’associazione mafiosa. Lugarà fin dal giorno del suo arresto
aveva però sostenuto la regolarità dell’iter amministrativo del progetto
edilizio e la mancanza del corrispettivo della corruzione contestato
nell’appoggio politico al sindaco Mazza. Gli avvocati Luca Ricci e Bruno
Brucoli, difensori di Lugarà, sono riusciti a dimostrare la correttezza da parte
del loro assistito, che è stato scarcerato senza l’applicazione di alcuna misura
la scorsa settimana, in quanto a suo carico, secondo il Tribunale del riesame,
non «sussistono i gravi indizi di colpevolezza». Come dichiarato
al Dubbio dall’avvocato Ricci, «l’intera indagine si basa su una consulenza
tecnica di un architetto nominato dalla Procura e sul massiccio ricorso alle
intercettazioni telefoniche». Grazie ad un «corretto» ascolto delle
intercettazioni telefoniche, durate anni, ed una «diversa» lettura del materiale
raccolto dal consulente della procura, gli avvocati di Lugarà hanno fatto
crollare il castello accusatorio. «Non esistendo intercettazioni fra Lugarà, il
sindaco Mazza e i funzionari comunali in cui emergano atti contrari ai doveri
d’ufficio finalizzati all’ottenimento delle autorizzazioni – afferma Ricci – gli
investigatori sono ricorsi ad una intercettazione fra due assessori». Per il gip
di Monza Pierangela Renda che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare
richiesta dal pm Ilda Boccassini è la pistola fumante in quanto evidenzia
«l’assoluta e condivisa consapevolezza della contrarietà degli atti relativi
alla vicenda (del permesso per costruire richiesto da Lugarà, ndr)». «In realtà
– prosegue Ricci – i due assessori discutono di un piano urbanistico in una zona
diversa, denominato “Pac1” che i carabinieri, invece di trascrivere
correttamente, riportano con un omissis, e cioè solo “Pa”. Sigla questa che
corrisponde effettivamente alla zona interessata dall’intervento edilizio da
parte di Lugarà». L’appoggio elettorale di Lugarà al sindaco, definito dagli
inquirenti «un vero e proprio “porta a porta” grazie alla sua fitta rete di
conoscenze», si esaurisce, sempre secondo l’avvocato Ricci, «in due telefonate».
In questa vicenda è stato tirato in ballo anche il consigliere regionale ed ex
vice presidente di Regione Lombardia Mario Mantovani che si era recato a Seregno
per sostenere la candidatura del sindaco Mazza. Secondo gli inquirenti,
Mantovani sarebbe stato il «referente» di Lugarà. «Dalla lettura dei risultati
elettorali del 2015 – aggiunge Ricci – i due candidati che Lugarà avrebbe
appoggiato, in un comune di 45.000 abitanti, hanno preso complessivamente 100
voti». In particolare, nel seggio dove per residenza votavano Antonino Lugarà ed
i suoi famigliari, «i voti riportati da entrambi sono stati 6, vale a dire
esattamente i componenti della sua famiglia». «Il peso elettorale di Lugarà,
dunque, tenuto conto che qualche amico e parente che li abbia votati i candidati
lo avranno pur avuto, è di poco più di una decina di voti», conclude Ricci. Il
mese prossimo le motivazioni complete da parte del Tribunale del riesame.
Nessuno ha il coraggio di dire a Bindi che è
razzista? Scrive Mimmo Gangemi il 22 Ottobre 2017 su "Il Dubbio". Per la
presidente dell’Antimafia è impossibile che in Valle d’Aosta non ci sia
’ndrangheta, stante che il 30% della popolazione è di origine calabrese. La
Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, on. le Rosy Bindi, dichiara
che è impossibile che in Valle d’Aosta non ci sia ’ndrangheta – «che ha
condizionato e continua a condizionare l’economia» – stante che il 30% della
popolazione è di origine calabrese. Qua e là annota punti di vista di matrice
abbastanza lombrosiana, che criminalizzano molto oltre i demeriti reali,
aggiungono pregiudizio al pregiudizio, alimentano la fantasia assurda che
quaggiù sia il Far West e una terra irredimibile, allontanano l’idea di una
patria comune, distruggono i sogni dei nostri giovani su un futuro possibile. Io
non sono in grado di escludere la presenza della ’ ndrangheta – essa va dove
fiuta i soldi o dove c’è, da parte di imprenditori locali, una richiesta sociale
di ’ ndrangheta, delle prestazioni in cui è altamente specializzata: i
subappalti da spremere, il lavoro nero, la fornitura di inerti di dubbia
provenienza, lo smaltimento dei rifiuti di cantiere, di quelli tossici o peggio,
l’abbattimento violento dei costi, la pace sindacale per sì o per forza, la
garanzia di controlli addomesticabili, e non con il sorriso. Ma, dopo aver
controllato la cronaca delittuosa, non mi pare che compaia granché o che sia
incisiva da dover indurre a tali spietate esternazioni. E non mi piace che tra
le righe si colga l’insinuazione che il calabrese è, in diverse misure,
colpevole di ’ ndrangheta – o di calabresità, che è l’identica cosa. Alludervi è
anche disprezzare il bisogno che ha spinto tanto lontano i passi della speranza
e gli immani sacrifici sopportati per tirarsi su. L’emigrazione in Valle d’Aosta
è stata tra le più faticose e disperate. I primi giunsero nel 1924. E giunsero
per fame. Lavorarono alla Cogne, nelle miniere di magnetite. E quelli di seconda
e terza generazione hanno dimenticato le origini, sono ben inseriti e valdostani
fino al midollo, pochi quelli che ricompaiono per una visita a San Giorgio
Morgeto, nel Reggino, da dove partirono in massa. Più che ai “nostri” tanto
discriminati, forse si dovrebbe guardare alle storie di ordinaria corruzione,
non calabrese e non ’ndranghetista, che nelle Procure di lì hanno fascicoli
robusti. Detto questo, la on. le Bindi Rosy da Sinalunga – civile Toscana, non
l’abbrutita Calabria – dovrebbe mettersi d’accordo con se stessa. Chiarisco:
alle ultime politiche, dopo che la sua candidatura traballò da ottavo grado
della scala Richter e non ci fu regione disposta ad accoglierla, per sottrarsi
alla rottamazione a costo zero ha dovuto riparare nell’abbrutita Calabria, che
sarà tutta mafiosa ma sa essere anche generosa e salvatrice per chi, come lei,
non intende rinunciare alla poltrona imbottita, con le molle ormai sbrindellate
stante i decenni che le stuzzica poggiando il nobile deretano. È prona come si
pretende da una colonia, la Calabria. In quell’occasione elettorale lo fu due
volte, con la on. le Bindi e con un altro personaggio di cui l’Italia va fiera,
tale Scilipoti Domenico, una bella accoppiata, entrambi eletti. La on. le fu
prima con migliaia di voti nelle primarie PD del Reggino e, da capolista,
ottenne l’entrata trionfale in Parlamento. Assecondando la sua ipotesi sulla
Valle d’Aosta e sulla presenza ’ ndranghetista, diventa legittimo estendere a
lei il suo stesso convincimento che, dove ci sono calabresi, per forza ci sono ’
ndranghetisti. Quindi, essendo la Calabria piena di calabresi – questa, una
perla di saggezza alla Max Catalano, in “Quelli della notte” – logica pretende
che tra le sue migliaia di voti ci siano stati quelli degli ’ndranghetisti, non
si scappa. Ne tragga le conseguenze. Oppure per lei, e per le Santa Maria
Goretti in circolazione, l’equazione non vale e i voti ’ndranghetisti non
puzzano e non infettano? Eh no, troppo comodo. Qua da noi persino il vago
sospetto d’aver preso certi voti conduce a una incriminazione per 416 bis e
spesso al carcere duro del 41 bis. Questo è. Forse però si è trattato di parole
in libera uscita, di un blackout momentaneo del cervello. Se così, dovrebbe
battersi il petto con una mazza ferrata, chiedere scusa ai calabresi onesti, che
sono la stragrande maggioranza della popolazione, e fare penitenza magari
davanti alla Madonna dagli occhi incerti nel Santuario di Polsi oltraggiato come
ritrovo di ’ ndrangheta e invece da decenni diventato solo luogo di preghiera e
di devozione. Ora mi aspetto l’indignazione dei calabresi. Temo che non ci sarà,
a parte quella di qualche spirito libero – e incosciente, vista l’aria che tira.
E stavolta dovrebbero invece, di più i nostri politici che, ahinoi, tacciono
sempre, mai una voce che si alzi possente e riesca ad oltrepassare il Pollino.
Coraggio, uno scatto d’orgoglio, tirate fuori la rabbia e gli attributi. Se non
ci riuscite, almeno il mea culpa per aver miracolato una parlamentare che ripaga
con acredine la terra che l’ha eletta e a cui, nell’euforia della rielezione
piovuta dal cielo, aveva promesso attenzioni amorevoli.
Il Csm: via i bambini ai mafiosi. Ma è un
provvedimento giusto? Scrive Giovanni M. Jacobazzi il 26 Ottobre 2017 su "Il
Dubbio". Fa discutere la proposta sulla decadenza della potestà genitoriale. I
nati in una famiglia di affiliati saranno equiparati ai figli di alcolisti e
tossicodipendenti. I figli nati in una famiglia mafiosa devono essere equiparati
a quelli nati in famiglie dove i genitori hanno problemi di alcolismo o
tossicodipendenza. Ed è pertanto necessario procedere con provvedimenti
giudiziari che comportino la decadenza della patria potestà e il successivo
allontanamento del minore dalla residenza familiare, con il suo affido ad una
struttura che consenta di crescere in un contesto idoneo per l’età. E’ questo il
contenuto della risoluzione che il Plenum del Consiglio superiore della
magistratura sta discutendo su iniziativa dei consiglieri Ercole Aprile e
Antonello Ardituro, in materia di “tutela dei minori nell’ambito del contrasto
alla criminalità organizzata”. Per prevenire e recuperare i minori è, dunque,
indispensabile intervenire sulla sfera familiare e/ o sociale di provenienza, in
quanto è una delle prime cause che incidono sul percorso di crescita. In
particolar modo nelle regioni meridionali si riscontra un frequente
coinvolgimento di minori in attività illecite legate ad associazioni criminali,
spesso di tipo mafioso (attività che consistono, ad esempio, nello spaccio di
stupefacenti, estorsioni, omicidi). Forse anche a causa del condizionamento
mediatico esercitato da alcune recenti fiction, il fenomeno si è accentuato e la
“cultura” mafiosa ha fatto presa sui giovani provenienti da contesti malavitosi.
La ricerca del potere, la facile ricchezza e realizzazione di sé, prevalgono
sulla pacifica convivenza e mettono le istituzioni sotto una luce negativa. La
soluzione è l’adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della potestà
genitoriale (fino ad arrivare alla dichiarazione di adottabilità) e di
collocamento del minore in strutture esterne al territorio di provenienza, per
eliminare il legame con i condizionamenti socio- ambientali. Pur costituendo
l’extrema ratio, la salvaguardia del superiore interesse del minore ad un
corretto sviluppo psico-fisico prevale sull’autonomia riconosciuta ai genitori
nell’adempimento del dovere educativo. La famiglia di origine, come nei casi in
cui i genitori siano dei tossicodipendenti o degli alcolisti, è «famiglia
maltrattante» che, per le modalità con cui «educa» i figli, ne compromette lo
sviluppo psicofisico. Per il Csm vanno, in primis, potenziati gli strumenti a
disposizione dei giudici minorili, con un’azione sinergica da parte dei servizi
minorili e dei servizi sociali, e una collaborazione, quando necessario, con gli
uffici giudiziari ordinari. Fondamentale, poi, un riassetto normativo che renda
più efficace ed effettiva l’applicazione di questi provvedimenti e che investa
anche il diritto penale (introducendo la pena accessoria della decadenza dalla
potestà genitoriale per i reati associativi di tipo mafioso) e processuale (dove
si prevede ora l’affidamento alla famiglia anche di minori che abbiano commesso
gravi reati). Un discorso a parte riguarda invece i figli minori di testimoni e
collaboratori di giustizia per i quali oltre ad una tutela psicologica bisogna
porre in essere le condizioni per un loro inserimento nelle località protette.
Caro Csm, Impastato era figlio di un boss
ma si ribellò al padre, scrive Mimmo Gangemi il 28
Ottobre 2017 su "Il Dubbio". Non c’è nessun automatismo tra il crescere in una
famiglia mafiosa e diventare mafiosi. È in discussione al Csm la proposta di
togliere la patria potestà alle famiglie mafiose e di affidare i figli a
strutture pubbliche. Si può disquisire a sazietà sulla questione, resta però che
i piccoli allontanati dal nido diventerebbero vittime sacrificate
all’inefficienza di uno Stato che non riesce a estirpare il fenomeno, che eleva
a logica incontestabile – offuscando così l’idea stessa di Giustizia – l’ipotesi
che chi cresce in un ambiente mafioso debba per forza sviluppare l’animo del
mafioso e che si arrabatta utilizzando i più deboli, dopo aver loro impresso a
caldo il marchio di mafiosi già solo decidendo che giocoforza condurranno la
stessa vita delittuosa dei padri. Dovesse esserci il sì del Csm, si stabilirebbe
a priori, e con l’imperizia cinica delle decisioni frettolose e arruffone, che
dove c’è un padre mafioso – latitante, carcerato – non ci sia possibilità di
orientarsi per un’educazione sana ai figli, di guidarli su strade di
rettitudine, di stare accorti a non porli davanti al bivio dove biforcano il
carcere e la morte per mano assassina, magari spinti a ciò dall’intento di non
incorrere nel destino amaro del genitore, tra sangue, galera, sofferenze
inflitte e patite. E si dà per scontato che la nuova situazione di bimbo o
ragazzo esiliato in strutture pubbliche – ed è tristemente noto come funzionano
le più – non produca i guasti che invece spesso capitano a chi è estirpato alle
origini e costretto, con buona pace dell’innocenza della giovane età, a mutare
la vita da così a così e a finire in quella condizione di abbandono e di
solitudine, senza l’affetto, le cure e le attenzioni di cui solo le mamme sono
capaci. Inoltre, viene difficile credere che l’allontanamento possa trasformarsi
in un affido a famiglie di buoni sentimenti: essendo note la pericolosità e la
ferocia della ’ ndrangheta, nessuno si arrischierebbe ad accoglierli, per il
timore di poter impattare nelle ritorsioni. La civiltà affossi quindi la
barbarie. E la proposta cada nel vuoto. Applicarla sarebbe una prepotenza da
Inquisizione, e una sconfitta delle Istituzioni, costrette a estremizzare con
azioni da regime totalitario l’incapacità di estirpare il cancro. Pure, sarebbe
un risultato pericoloso, con altri passi acciaccati verso la deriva autoritaria
della Giustizia, in atto da tempo in certe aree più a rischio del paese e che
avvolge di nebbia fitta lo Stato di diritto, incrina la libertà e la democrazia.
Nessuno dovrebbe pagare la colpa del cognome che porta. Di sicuro, non un
minore. Ho conoscenza diretta di famiglie di ’ ndrangheta che hanno deciso e
attuato un futuro diverso per i figli, tenendoli estranei, spingendoli allo
studio, alle buone frequentazioni, a forgiare pensieri positivi. Ma lo Stato
pare non accorgersi della loro esistenza. O non intende accettarlo, per troppa
rigidità, per troppe convinzioni che hanno messo crosta fino a deciderle
inconfutabili, verità assolute. Non riflette, lo Stato, che i comportamenti
repressivi applicati sul mucchio a prescindere, senza alcun distinguo tra chi
nella malavita s’immerge mani e piedi e chi invece tende a scansarla, parano
davanti a un muro cieco, diventano istigazione a delinquere, perché lasciare ai
figli della ’ ndrangheta soltanto lo sbocco ’ ndrangheta impedirà di spezzare il
circolo vizioso e perpetuerà la malapianta. Penso a Peppino Impastato, figlio di
un boss di Cosa Nostra. Ha scelto un percorso di onestà e di denuncia, pur
vivendo in un ambiente malsano. È in nome suo, e di tanti come lui di cui non
c’è memoria solo perché non si sono immolati eroi, che bisogna astenersi dal
sopruso amorale che si va profilando. Anche in nome e in ricordo di Maria Rita
Logiudice, la ragazza venticinquenne, bella e fresca di laurea con lode, che si
è uccisa gettandosi dal balcone per non aver più sopportato la discriminazione
per l’appartenenza a una potente cosca di ’ ndrangheta di Reggio. Allora
registrammo le parole di dolore e di contrizione del Procuratore Cafiero De
Raho: «Credo che debba toccare la coscienza di tutti… che siamo tutti
responsabili di fatti come questo… Persone così possono essere il cambiamento
della Calabria… Se noi perdiamo simili occasioni per recuperare la libertà,
l’onestà, l’etica, se diciamo ai ragazzi cambiate vita e poi, quando la
cambiano, li isoliamo, li emarginiamo, non diamo nessun sostegno, allora non
abbiamo più nessuna speranza per il nostro futuro… Dobbiamo fare tutto ciò che è
necessario perché tragedie di questo tipo non avvengano più». Peppino e Maria
Rita – e chissà quanti altri non noti alle cronache – sono la prova che non c’è
automatismo tra il crescere dentro una famiglia di mafia e il diventare mafiosi.
Comunque, pure a voler ammettere che i più di quegli innocenti di oggi da adulti
non condurranno vite da innocenti, valgono i pochi, è più importante che, pur di
colpire il resto, non si penalizzino i Peppino e i Maria Rita.
Chi va a decidere tenga nella giusta
considerazione i piccoli dal cognome scomodo che verrebbero a essere privati del
diritto alla famiglia. E non trascuri le esternazioni del Procuratore su una
figlia della ’ ndrangheta che inseguiva e coltivava civiltà. Non commetta
l’errore di lasciare che restino parole vuote. Non trasformi le lacrime di
allora in lacrime di coccodrillo.
«Lotta alla mafia? Non spetta alle toghe,
loro devono far rispettare la legge». La lezione di
Macaluso, scrive Davide Varì il 4 Marzo 2017 su "Il Dubbio". In un appassionante
intervento alla Scuola superiore della magistratura, lo storico dirigente e
intellettuale comunista illustra le trasformazione delle cosche e spiega: «Le
cose sono cambiate, i mafiosi non hanno più il potere e il ruolo del passato».
«Ho 92 anni suonati e nella mia vita ho visto di tutto. Eppure, parlare a dei
giovani magistrati mi emoziona, mi commuove». Se qualcuno avesse detto a
Emanuele Macaluso che un giorno sarebbe stato invitato dalla Scuola superiore
della magistratura per tenere una lezione sulla mafia, la politica e la
giustizia, lui, vecchio comunista siciliano, lo avrebbe fulminato con una
“taliata”, magari facendo spallucce e voltandosi dall’altra parte. E invece è
accaduto. E così il grande suggeritore di Giorgio Napolitano, si dice infatti
che i suoi saggi consigli abbiano accompagnato il settennato e mezzo del
presidente più “politico” degli ultimi anni, si è ritrovato, emozionato come un
ragazzino alla prime armi, a dover spiegare a un nugolo di imberbi magistrati il
complicatissimo rapporto tra politica e magistratura italiana. E allora conviene
partire dalla fine, dalle parole con cui Macaluso ha chiuso il suo lungo e
suggestivo intervento: «Eravamo all’inizio degli anni 80. Achille Occhetto era
il segretario regionale del Pci siciliano e nel corso del suo intervento per
l’inaugurazione dell’anno giudiziario invitò tutti, magistrati compresi, a
combattere contro la mafia. Poi prese la parola il presidente della Corte
d’Appello di Palermo che con grande serenità e chiarezza spiegò al giovane
Occhetto e a noi tutti, che la magistratura non doveva fare nessunissima lotta,
neanche contro la mafia: “La magistratura deve applicare le leggi e basta”,
disse». Ma questa è solo la conclusione dell’intervento di Macaluso. Per più di
un’ora il vecchio comunista ha raccontato episodi chiave della storia della
Sicilia e del nostro Paese. A cominciare dal fascismo e da Mussolini che «quando
presentò il Listone in Sicilia si affacciò con i mafiosi sui balconi delle
piazze, salvo poi inviare il prefetto Mori che perseguitò figli, moglie e
genitori dei latitanti o presunti tali». E poi la liberazione e lo sbarco
alleato, che divenne il momento in cui si saldò l’alleanza tra Stato, Chiesa,
latifondo e Cosa nostra. E l’avvento della Dc col ricordo di Giuseppe Alessi:
«Grande avvocato antifascista e primo presidente della regione Siciliana, che
rifiutò di iscrivere i mafiosi nella Dc e per questo fu “minacciato” dal vescovo
in persona». Poi Alessi si dimise, o fu fatto dimettere, e arrivò Arcangelo
Cammarata che con i mafiosi era decisamente più disponibile e malleabile. E quel
blocco di potere tra Chiesa, Stato, latifondo e mafia si rafforzò con le grandi
lotte contadine. E a quel punto Macaluso ha spiegato ai giovani magistrati chi
era Placido Rizzotto: «Un combattente che io conobbi e che fu ucciso dalla mafia
perché lottava al fianco dei contadini». E se è vero che Rizzotto fu ucciso
dalla mafia, è soprattutto vero che a tradirlo furono gli uomini dello Stato. A
cominciare da un giovane ufficiale di nome Carlo Alberto Dalla Chiesa, il futuro
generale Dalla Chiesa, il quale al processo sulla morte di Rizzotto dichiarò che
quel delitto non aveva nulla a che vedere con la politica e con la mafia. «Ma io
capisco quella sua posizione, allora c’era un unico grande nemico: il
comunismo». Ma anche i giudici ebbero un ruolo in quel sistema. Anche pezzi di
magistratura fecero parte di quel blocco di potere. «Il giudice Guido Lo Schiavo
teorizzò in un libro quel legame: “Dire che la mafia disprezza la polizia e la
magistratura è un’inesattezza – scrisse Lo Schiavo -, la mafia ha sempre
rispettato la giustizia e la magistratura, si è inchinata alle sue sentenza
collaborando anche alla cattura dei banditi”». Ma qualcosa iniziava a cambiare,
tanto che nel ‘ 78 la procura di Palermo fu affidata a Gaetano Costa: «Un uomo
rigoroso, colto, onestissimo. Un amico che pur avendo le sue idee non si
iscrisse mai a Magistratura democratica per mantenere la sua indipendenza. Ma
Costa fu isolato – ha raccontato Macaluso – tanto che quando preparava mandati
di arresto per i mafiosi nessun aggiunto li firmava con lui. E questa fu la sua
condanna». Poi arrivò la generazione che si era laureata nel ‘ 68 e allora la
magistratura cambiò davvero e quel patto osceno venne meno: «E fu proprio la
fine di quell’alleanza che determinò l’inizio del terrorismo mafioso che
raggiunse il culmine negli anni ‘ 90». Ma di lì in poi Cosa nostra inizia a
perdere. «Io credo che la mafia siciliana abbia perso – ha infatti ribadito alla
platea di giovani magistrati Macaluso-. Questo non vuol dire che la mafia non
c’è più. Io ritengo che le cose siano cambiate, che i mafiosi non hanno più il
potere e il ruolo che hanno avuto in passato». Poi la frase finale, il congedo
da quella platea così particolare: «I giudici non fanno battaglie, i giudici
devono far rispettare la legge. Non lasciate che la politica scarichi su di voi
questa responsabilità». E chissà se qualcuno ascolterà le parole di un vecchio
comunista.
Magistratura che deve applicare la legge e cercare
di non sbagliare.
Via la toga per un errore giudiziario.
Giudice reintegrato dopo 24 anni, scrive Viviana De Vita Venerdì 27 Ottobre 2017
su "Il Mattino". Fuori dalla magistratura per colpa di un errore giudiziario,
sotto processo da innocente, assolto con formula piena, è stato reintegrato a
distanza di quasi un quarto di secolo. Oggi ha 73 anni e, dopo aver dovuto
“reinventare” una professione indossando la toga di avvocato, può finalmente, e
nonostante l’età “pensionabile”, ritornare tra gli scranni dei magistrati. È una
sentenza del Consiglio di Stato a sancire il diritto dell’avvocato Antonio
Feleppa di essere reintegrato nella categoria dei magistrati nella quale entrò a
soli 23 anni e, all’interno della quale, potrà militare per altri 19 anni quelli
che, secondo il regolare iter lavorativo, lo avrebbero condotto alla pensione.
La sentenza chiude un “braccio di ferro” protrattosi per anni dichiarando
inammissibile l’appello dell’Avvocatura per il consiglio superiore della
magistratura, che aveva impugnato la pronuncia del Tar Lazio che accolse il
ricorso dell’avvocato Feleppa consentendogli di rientrare in magistratura in
base a quanto sancito dalla legge che prevede il reintegro dei magistrati e dei
funzionari dello Stato ingiustamente deposti. «La sentenza – afferma l’avvocato
Feleppa – mi restituisce, seppure a distanza di tanti anni, il mio onore di
magistrato. Se avessi avuto una carriera normale oggi, a 73 anni, sarei in
pensione: sicuramente ho perso delle chances, avrei avuto altre opportunità ma,
in cuor mio, non riesco ad odiare nessuno e non rimpiango nulla perché ritengo
che fare l’avvocato è molto più difficile che fare il magistrato. Sono stato
ingiustamente calunniato e, uno dei miei principali accusatori è stato
condannato; ci sono persone che, al mio posto si sono ammalate o, addirittura,
si sono suicidate: io mi sono solo adirato». Era il 1993 quando Antonio Feleppa,
sostituto procuratore presso la pretura circondariale di Salerno, finì nel
mirino degli inquirenti per presunti ritardi nell’ambito di un’inchiesta su
abusi edilizi. Era l’epoca di “mani pulite” e un vero e proprio terremoto si
abbatté sulla magistratura campana: l’allora pretore Antonio Feleppa aveva 49
anni e, davanti a sé, una carriera brillante.
Quegli assurdi processi
della giustizia militare fra brioche e risse ultrà.
Quarantotto giudici inutili e costosi. In aula trattano casi veri, che sembrano
barzellette, scrive Nino Materi, Venerdì 20/10/2017, su "Il Giornale". Sono casi
entrati nella giurisprudenza. Che Gino Bramieri avrebbe certo apprezzato.
Sentenze vere, ma così comiche da sembrare barzellette.
Condannati due carabinieri che
in «servizio d'ordine» allo stadio se le sono date di santa ragione perché
opposti tifosi delle squadre in campo.
Denunciato un sottufficiale
che aveva scritto con lo spray sul muro della caserma: «Tua moglie è una gran
p...».
Alla sbarra un caporale che
aveva sottratto dal bancone del bar una brioche e un commilitone che «con mossa
repentina ne ha mangiata una parte»: sotto processo entrambi, il primo per furto
e il secondo per ricettazione «perché traeva profitto dal furto precedente».
Tenente a giudizio perché
«rientrato in camerata entrando dalla finestra», il suo permesso d'uscita non
era stato autorizzato.
Sono solo alcune delle
sentenze emesse dai giudici militari, il cui «stupidario» dei verdetti che
sembrano barzellette risulta particolarmente ampio e variegato. Mantenere in
piedi il baraccone della magistratura con le stellette è come tenere aperto
un'industria di stufe nel Sahara. Scelte lecite, per carità, ma assolutamente
illogiche. Le toghe militari (competenti per i reati commessi da soldati e
carabinieri) rappresenta infatti una microcasta - superflua, ma tutelatissima -
all'interno della maxicasta delle toghe. Tecnicamente anche i magistrati
militari fanno parte di quel potere giudiziario che è, insieme a quello
esecutivo e legislativo, uno dei tre capisaldi fondamentali su cui si fonda lo
Stato. Ma se poi si va a comparare la magistratura ordinaria con quella
militare, la differenza balza subito agli occhi: nel primo caso migliaia di
processi all'anno, nel secondo a poche decine. Uno squilibrio evidente
conseguenza del fatto che per gli attuali 48 giudici militari (operativi fra tre
Procure di Verona, Roma e Napoli) la materia del contendere è scarsissima e
spesso relativa a illeciti «bagatellari» che potrebbero essere assorbiti dai
magistrati ordinari, o nei casi più irrilevanti addirittura dai giudici di pace.
Del resto con l'abolizione nel 2005 del servizio di leva obbligatoria, il crollo
dei contenziosi era inevitabile, ma la lobby ha tenuto duro. Riuscendo a
mantenere tutte le prebende che consentono di fare, con ottimi stipendi e una
vita di tutto riposo. Quasi di letargo, a rileggere oggi la coraggiosa
confessione del 2007 dell'allora giudice militare Benedetto Manlio Roberti che
sull'Espresso dell'8 febbraio scrisse testualmente: «Devo riconoscerlo, rubo
letteralmente lo stipendio all'amministrazione (...) È ora di finirla con questa
farsa. Qui non si lavora più e questa non è dignità». Coerentemente a quanto
denunciato il giudice Roberti ha chiesto e ottenuto il trasferimento nella
magistratura ordinaria diventando nella Procura di Padova uno dei pm più
impegnati soprattutto nel settore dei reati ambientali. Altri ex giudici
militari colleghi di Roberti hanno seguito il suo esempio, ma molti altri hanno
preferito continuare a godersi sonni tranquilli. Nel 2008 una riforma ha dato un
serio taglio all'intero comparto della magistratura militare che però ancora
oggi - se pur ridimensionata - continua ad avere un suo autonomo Csm (il Cmm),
una sua Anm (l'Anmm), tre Tribunali, un Tribunale di sorveglianza, un Corte di
Appello e una Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Insomma, un
perfetto - quanto pletorico - duplicato del già elefantiaco apparato della
magistratura ordinaria. L'attuale ministro della Difesa, Roberta Pinotti, già 9
anni fa, in un'intervista del 3 giugno al Secolo XIX andava giù duro: «Abbiamo i
processi più lenti d'Europa, mancano i giudici e ci permettiamo di mantenere
decine di fannulloni forzati(...) Ci sono alcuni magistrati che giudicano
indecoroso stare con le mani in mano e altri no. L'accorpamento dei tribunali
comporterebbe un risparmio di oltre un miliardo di euro». Oggi siamo nel 2017 e
la casta dei giudici con le stellette non lascia, anzi rilancia: «La giustizia
militare è storicamente uno degli orgogli del nostro Paese, nonostante la
politica stia facendo di tutto per farci sparire». Magari lo facesse davvero.
"Taccia lei è di Palermo", Ordine
avvocati contro un giudice di Trento, scrive il 20
settembre 2017 "Nuovo Sud". "Avvocato, lei taccia, perchè qua siamo in un posto
civile, non siamo a Palermo". La frase sarebbe stata pronunciata nel corso di
una udienza al Tribunale del Riesame di Trento dal presidente Carlo Ancona
all'avvocato palermitano Stefano Giordano (nella foto), figlio di Alfonso,
storico presidente del maxiprocesso. "Un fatto sicuramente gravissimo quello
accaduto al collega che me lo ha riferito. Domani pomeriggio informerò il
Consiglio e aprirò un fascicolo", commenta il presidente dell'ordine degli
Avvocati di Palermo Francesco Greco. "E' un fatto grave, oltre al riferimento
razzista ed offensivo. Ho in ogni caso prova di tutto quello che è accaduto", si
limita a confermare lo stesso Stefano Giordano che è riuscito, non senza
difficoltà, ad ottenere la verbalizzazione di quanto accaduto. Il presidente
dell'Ordine degli avvocati di Palermo precisa che, non appena ricevuta la nota
da parte di Giordano, verrà trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.
Mentre il verbale di udienza - richiesto ma non ancora inviato - sarà trasmesso
al procuratore generale della Corte di Cassazione.
«Siamo in un posto civile, mica a
Palermo». Frase «shock» del giudice Ancona in aula
durante un riesame. E l’avvocato siciliano è pronto a fare un esposto al Csm,
scrive il 21 settembre 2017 "Trentino". «Avvocato, lei taccia, perché qua siamo
in un posto civile, non siamo a Palermo». A pronunciare questa frase, come
racconta l'avvocato Stefano Giordano, del foro di Palermo, il presidente del
tribunale del riesame di Trento, Carlo Ancona, nel corso di una udienza che si è
celebrata martedì mattina proprio in una delle aule del palazzo di giustizia di
Trento. «È un fatto gravissimo oltre che una frase razzista - dice Giordano, che
figlio del presidente del Maxiprocesso di Palermo, Alfonso Giordano, - Mi
trovavo al tribunale di Trento per una udienza di rinvio al tribunale del
riesame, quando è avvenuto un fatto increscioso. Il presidente Carlo Ancona -
spiega Stefano Giordano - nel condurre l'udienza con un indagato palermitano e
con il sottoscritto come difensore, mi ha impedito di svolgere la mia arringa,
profferendo la seguente frase: “Avvocato, lei taccia, perché qua siamo in un
posto civile, non siamo a Palermo”. A questo punto, ho chiesto, e solo dopo
numerosi sforzi, ho ottenuto la verbalizzazione di quanto accaduto». Una frase
che, dopo il racconto dell’avvocato, è finita su siti di informazioni e sulle
agenzie di stampa avendo ampio risalto. Una frase che lo stesso giudice Ancona
non rinnega. «L’avvocato - spiega il giudice - aveva aggredito, verbalmente, una
pubblico ministero che neppure centrava con la causa che si stava discutendo. Un
atteggiamento non tollerabile al quale ho risposto. Per altro l’avvocato aveva
pacificamente ragione e non c’era molto da discutere, ma ha avuto un
atteggiamento scorretto». Una frase, che avrà delle conseguenze. Con un esposto
che sarà, infatti, portato all’attenzione del Consiglio Superiore della
Magistratura, che l’organo di autogoverno della magistratura. «Purtroppo -
aggiunge l’avvocato palermitano Stefano Giordano - nonostante numerose
richieste, non sono riuscito a ottenere dalla cancelleria del tribunale del
Riesame di Trento una copia del verbale dell’udienza. Manifesto, in relazione a
quanto accaduto, la mia preoccupazione per quanto accaduto, in quanto avvocato,
in quanto cittadino italiano e, soprattutto, in quanto palermitano - conclude
l’avvocato Stefano Giordano - Ho già concordato con il presidente dell'Ordine di
Palermo, l'avvocato Francesco Greco, di redigere insieme un esposto che sarà
prontamente comunicato al Csm e alle altre autorità istituzionali competenti».
«Quanto accaduto, per come appreso - commenta Andrea de Bertolini, presidente
dell’ordine degli avvocati di Trento - è un episodio infelice che, ritengo,
possa essere stato l’esito di tensioni quali quelle che a volte le udienze
penali possono generare; interessa un magistrato del quale, peraltro, il Foro ha
sempre riconosciuto la grande preparazione e la dedizione al lavoro».
Csm restituisce 20 milioni di euro
al bilancio dello Stato: ma i magistrati si occupano di finanza, edilizia o
giustizia? A Trento nel frattempo va in scena l’ennesimo abuso del giudice di
turno… La denuncia arrivata dell’avvocato Stefano
Giordano, peraltro figlio del giudice Alfonso Giordano che fu il presidente del
Maxiprocesso di Palermo: “Sono preoccupato per ciò che è accaduto, presenterò
esposto al Csm”. I membri togati Morosini, Aprile, Ardituro, Forteleoni e Spina
hanno immediatamente chiesto l’apertura di una pratica nei confronti del giudice
Carlo Ancona, una “vecchia conoscenza” della commissione disciplinare. Ecco di
cosa dovrebbe occuparsi il CSM…, scrive Antonello de Gennaro il 21 settembre
2017 su "Il Corriere del Giorno". Nella delibera del Comitato di Presidenza del
CSM, approvata ieri all’unanimità dal Plenum, ed annunciata con toni
trionfalistici da un comunicato stampa, si legge che secondo il
vicepresidente Giovanni Legnini la decisione di restituire 20 milioni “appare la
più opportuna nell’attuale contingenza economica, tanto più se la somma potrà
essere destinata al sostegno degli uffici giudiziari”. Il Consiglio Superiore
della Magistratura restituisce al Bilancio dello Stato 20 milioni di euro
risparmiati nel corso degli anni, con il fine di destinarli al sostegno degli
uffici giudiziari che si trovano nelle aree colpite d al terremoto e che versano
in un’eccezionale condizione di difficoltà. In particolare, il Consiglio
Superiore propone al Ministero dell’Economia di “prevedere presso il ministero
della Giustizia, l’istituzione di un apposito Fondo” i cui obiettivi dovrebbero
essere gli “aiuti agli uffici giudiziari delle aree colpite da eventi sismici e
di quelli che versano in un’eccezionale situazione di difficoltà“, nonchè un
“sostegno all’attività dei Consigli giudiziari, anche per rafforzare gli
strumenti di cooperazione tra il Csm e gli organi di governo autonomo di
prossimità“. “E’ un provvedimento storico – ha detto forse con troppa enfasi il
Vice Presidente Giovanni Legnini nel corso del Plenum – Per la prima volta il
Consiglio restituisce una somma consistente, auspicando che venga destinata
interamente per la giurisdizione”. “Mi farò carico personalmente – ha aggiunto
Legnini – di fare in modo che con la prossima legge di stabilità venga istituito
un Fondo sul Bilancio dello Stato, alimentato con questa somma, che abbia queste
finalità”. Restituire fondi inutilizzati allo Stato non è un gesto “esemplare”,
ma secondo noi giusto e corretto da parte di chi ha un senso dello Stato, e
quindi verso i cittadini, e quindi non ci sarebbe bisogno neanche di comunicarlo
con tutta questa enfasi. Probabilmente il Csm farebbe bene a pensare a
“lottizzare” di meno le sue nomine nei vari uffici giudiziari, e soprattutto
intervenire sull’operato dei giudici che indossando una toga a volte credono di
essere dei “supermen”, degli “intoccabili”, che possono tutto, e guai a chi li
tocca….
L’ultimo cattivo esempio dell’arroganza
manifestata da alcuni magistrati, è stato quello del Presidente del Tribunale
del Riesame di Trento, Carlo Ancona che nel corso di una udienza che si è
celebrata ieri proprio a Trento, rivolgendosi ad un avvocato ha detto “Avvocato,
lei taccia, perché qua siamo in un posto civile, non siamo a Palermo”. Lo ha
reso noto l ‘avvocato Stefano Giordano, che si dice “preoccupato per
l’accaduto. E’ un fatto gravissimo oltre che una frase razzista – commenta
l’avv, Giordano, che peraltro è il figlio di un giudice Alfonso Giordano che è
stato il Presidente del Maxiprocesso di Palermo – Ieri mi trovavo al Tribunale
di Trento per una udienza di rinvio al Tribunale del Riesame, quando è avvenuto
un fatto increscioso”. “Il presidente del Tribunale del Riesame di Trento, il
dottor Carlo Ancona – spiega Stefano Giordano, nel frattempo rientrato a Palermo
– nel condurre l’udienza con un indagato palermitano e con il sottoscritto come
difensore, mi ha impedito di svolgere la mia arringa, proferendo la seguente
frase: “Avvocato, lei taccia, perché qua siamo in un posto civile, non siamo a
Palermo”. A questo punto, ho chiesto, e solo dopo numerosi sforzi, ho ottenuto
la verbalizzazione di quanto accaduto. Purtroppo nonostante numerose richieste –
aggiunge l’avvocato Giordano – non sono riuscito a ottenere dalla cancelleria
del Tribunale del Riesame di Trento copia del suddetto verbale”. “Manifesto la
mia preoccupazione per quanto accaduto, in quanto avvocato, in quanto cittadino
italiano e, soprattutto, in quanto palermitano – aggiunge ancora Stefano
Giordano – Ho già concordato con il presidente dell’Ordine di Palermo,
l’avvocato Francesco Greco, di redigere insieme un esposto che sarà prontamente
comunicato al Csm e alle altre autorità istituzionali competenti”. A questo
punto c’è è da auspicare il Ministro di Giustizia Andrea Orlando mandi degli
ispettori anche presso il Tribunale di Trento ad accertare i comportamenti
arroganti non solo del giudice in questione ma anche della cancelleria.
La frase shock è approdata al Consiglio superiore
della magistratura, dove un componente togato del Csm Piergiorio Morosini ha
chiesto ieri pomeriggio l’apertura di una pratica disciplinare nei confronti del
giudice Ancona La richiesta sottoscritta anche da altri componenti togati
del Csm, tra i quali Antonello Ardituro, da Ercole Aprile, da Luca Forteleoni e
da Saro Spina, che ritengono “dai toni inaccettabili, di matrice razzista” la
frase espressa dal Presidente del Tribunale del Riesame di Trento, Carlo
Ancona . Quello che è sfuggito a molti è, che già in passato il giudice Carlo
Ancora è stato censurato dal Csm, insieme ai colleghi Claudia Miori e il
sostituto procuratore Pasquale Profiti tutti in servizio presso gli uffici
giudiziari del Tribunale di Trento. La vicenda ebbe inizio nell’estate del 2008
quando davanti al giudice Ancona arrivò a giudizio un immigrato clandestino
accusato di aver messo in atto una serie di danneggiamenti. Il giudice Ancona
convalidò l’arresto e si va andò patteggiamento a otto mesi di reclusione
sostituiti con l’espulsione dall’Italia per cinque anni. A questo punto
successe qualcosa di anomalo che poi portò al provvedimento disciplinare.
L’immigrato, infatti, non venne scarcerato ed è il suo avvocato
difensore, Filippo Fedrizzi, presentò istanza per la liberazione o, in
subordine, per gli arresti domiciliari. Si andò quindi al riesame (il giudice
era Claudia Miori) la quale acquisito anche il parere del pm Pasquale
Profiti rigettò il ricorso. I giorni così passarono e il clandestino restò in
cella in attesa dell’espulsione. Era il 14 agosto 2008 quando l’avvocato Filippo
Fedrizzi, presentò un esposto a vari enti fra i quali il Ministero di Giustizia.
Due giorni dopo, sia al 16 agosto, quindi a poco meno di un mese dal
patteggiamento, avvenne finalmente la scarcerazione dell’immigrato. Dell’esposto
se ne occupò il Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno
dei giudici. Si arrivò quindi alla “censura”, provvedimento contro il quale
presentano ricorso tutti e tre i magistrati trentini compreso il giudice Ancona
protagonista dell’ultima ennesima arroganza. Il fascicolo finì davanti
alla Suprema Corte Cassazione che rigettò le opposizioni dei tre magistrati di
Trento e quindi confermò la censura, in quanto il clandestino non doveva restare
in carcere quel mese in più. Questo fu all’epoca dei fatti il commento dal
giudice Carlo Ancona: “Siamo stati puniti solo per aver tentato di far
rispettare le leggi”.
La Legge non “è uguale per tutti”, ma bensì deve
essere uguale per tutti. Anche per i magistrati che la violano, calpestando
l’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, dimenticando che il pm
deve acquisire anche le prove a favore dell’indagato. Chissà se adesso il Csm
si deciderà ad applicare dei provvedimenti ben più incisivi e rigorosi di una
semplice “censura”.
La storia del giudice che decise di
morire da innocente, scrive il 13 Settembre 2017 "Il
Dubbio". Il procuratore di Catanzaro Pietro D’Amico fu coinvolto nell’inchiesta
“Why not?” di De Magistris. Ne uscì pulito ma qualcosa si ruppe. È una storia
sconcertante. Una di quelle storie che lasciano l’amaro in bocca; è la storia è
quella di un giudice, il Procuratore Generale di Catanzaro Pietro D’Amico.
Comincia quasi dieci anni fa, nel 2008. L’alto magistrato si trova coinvolto in
un’inchiesta che a suo tempo fece scalpore: quella “Why not?”, condotta
dall’allora procuratore Luigi De Magistris. Accuse che col tempo si rivelano
completamente infondate. La riabilitazione è netta, chiara; solo sospetti, tutto
viene archiviato; ma D’Amico esce da questa vicenda profondamente scosso: il
solo fatto che si sia potuto dubitare del suo corretto agire, lo getta in uno
stato di profondo sconforto. L’uomo, all’apparenza, è quello di sempre:
sorridente, solare. Ma evidentemente qualcosa “dentro” si è rotto. Congiunti,
amici, sanno di questo “disagio”, ma non ne sospettano la profondità, la gravità
di questa ferita che non riesce a rimarginarsi. Il 27 aprile 2010 D’Amico scrive
a un amico, Edoardo Anselmi: «C’è poco da capire: in una situazione come la mia,
io voglio morire perché aggredito da una malattia terribile in fase avanzata e
terminale». Già: perché al magistrato, nel frattempo, è stato diagnosticato un
tumore. D’Amico matura la convinzione che è meglio farla finita con “la dolce
morte” da praticare là dove è consentito: in Svizzera; meglio scegliere come e
quando, piuttosto di una lunga, lenta, dolorosa agonia senza scopo e speranza.
«Sto pensando», scrive, «a qualcosa di indicibile, e che nessuno può immaginare.
Vado in Svizzera poiché là é chi provvederà nel caso come il mio». Trascorrono
così quasi due anni: D’Amico sembra determinatissimo nel suo proposito. Alla
fine ottiene la documentazione necessaria: certificati che affermano l’esistenza
di patologie che rendono possibile, in base alla legge elvetica il cosiddetto
“suicidio assistito”. Nell’aprile del 2013, a Basilea, presso il centro “Life
Circle- Eternal Spirit”, la vicenda si conclude: D’Amico trova la sua pace.
L’inquietante storia, invece, comincia ora. Perché la famiglia, che nulla sa dei
propositi di D’Amico, viene freddamente avvertita con una telefonata
dell’avvenuto decesso; cerca di capire cosa è accaduto: chiede, e ottiene, che
sia effettuata l’autopsia. Colpo di scena: D’Amico non era affatto malato di
tumore, come forse credeva. Depresso, sì, per le ragioni che abbiamo detto. Ma
l’autopsia, e approfonditi esami di laboratorio escludono l’esistenza di quella
grave e patologia dichiarata da alcuni medici italiani, e asseverata da medici
svizzeri. Clamoroso errore, diagnosi errate, che spingono D’Amico, già
psicologicamente provato, a convincersi che l’unico modo per chiudere con
dignità la propria esistenza, è quello di ricorrere al suicidio assistito? O,
peggio: i documenti sono stati falsificati ad arte, per poter appunto accedere
alla clinica svizzera e suicidarsi? E’ quello che invano la famiglia di D’Amico
chiede da anni di sapere. La magistratura italiana, ripetutamente investita del
caso, al momento non ha intrapreso particolari iniziative per accertare i fatti;
e comunque la famiglia nulla sa. Come mai? Perché? Di questa sconcertante
abbiamo trattato ne “La Nuda Verità”, la trasmissione che conduco assieme a
Massimiliano Coccia, ogni domenica alle 19.30 su “Radio Radicale”. A “La Nuda
Verità” abbiamo ospitato Francesca, la figlia del magistrato. Ha ripercorso con
noi tutte le tappe della vicenda. Ha denunciato come al padre siano state
diagnosticate patologie inesistenti, redatti certificati medici falsi; e
rivendica il diritto di sapere come sono andate davvero le cose: «Mi chiamarono
dalla Svizzera e mi dissero che mio padre era morto. Io cadevo dalle nuvole: ero
convinta che fosse un errore, una omonimia… Invece era tutto tragicamente vero».
Francesca non contesta l’aspirazione alla dolce morte, dice di rispettare la
scelta di suo padre. Però ne fa un problema di deontologia: «Possibile che sia
arrivato in Svizzera con due documenti sulle sue condizioni di salute e che
nessuno abbia fatto accertamenti per capire, confermare, accertare? Quale medico
si può arrogare il diritto di disporre della vita altrui? Voglio andare fino in
fondo a questa faccenda, per capire come sono andate esattamente le cose e se
sono stati commessi errori». Sullo sfondo di questa inquietante vicenda, i
dilemmi e gli ineludibili interrogativi di sempre che lacerano le coscienze,
quelle laiche come quelle dei credenti: come e quando si ha diritto di
interrompere la propria vita? La depressione, pur nel suo stato profondo, va
compresa tra le patologie che possono rendere possibile la “dolce morte”? Chi
può stabilire quando il cosiddetto “mal di vivere” è incurabile? Fino a che
punto il volere del soggetto va assecondato, e non si deve invece cercare di
offrirgli alternative? Insomma: quali i limiti, e quali i diritti; come
esercitarli, e fino a che punto esercitare la propria autodeterminazione? Ecco,
al di là del caso specifico che abbiamo affrontato, l’essenza delle questioni.
Che non vanno negate, e che bisogna, al contrario, cercare di “governare”. *
Presidente Istituto Luca Coscioni
Che resta del pool di Mani pulite? Anche
Di Pietro si dissocia, scrive Valter Vecellio il 12
Settembre 2017 su "Il Dubbio". «Ho fatto l’inchiesta Mani Pulite con cui si è
distrutto tutto ciò che era la cosiddetta Prima Repubblica: il male, che era la
corruzione e ce n’era tanta, ma anche le idee». Aggiunge: «Ho fatto politica
basandola sulla paura e ne ho pagato le conseguenze». In principio, fu Diego
Marmo: il pubblico ministero del “venerdì nero della camorra”, la vicenda in cui
si vollero impigliare Enzo Tortora e Franco Califano (tra gli altri, che una
moltitudine di altri dimenticati furono, poi, gli assolti). Implacabile, e
impagabile, quel suo «ma lo sapete che più cercavamo le prove della sua
innocenza, e più emergevano quelle della sua colpevolezza?». Come poi è finita,
lo sappiamo bene. Con molti anni di ritardo, intervistato da Il Garantista e
ormai in pensione, Marmo riconosce il clamoroso abbaglio. Errore che non può
dirsi, propriamente, un errore; per dirla con Manzoni: era un’ingiustizia che
poteva essere veduta da quelli stessi che la commettevano. Senza l’intervento di
Marco Pannella, dei radicali, di Leonardo Sciascia e pochissimi altri, chissà
quando e come quell’errore/ orrore lo si sarebbe visto, riconosciuto. Chissà
quando e come si sarebbe visto e riconosciuto lo strame che si faceva di quelle
regole ammesse anche da coloro che le trasgredivano; sempre con Manzoni: «È un
sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo
sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è
una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può essere forzatamente vittime,
ma non autori». Aveva la vista lunga, il Grande Lombardo; e quanto sono
attuali I promessi sposi e La storia della colonna infame, a saperli leggere;
soprattutto a volerli leggere.
È poi la volta di Gherardo Colombo, uno dei
“moschettieri” del milanese pool di “Mani Pulite”. Con libri, interventi,
articoli, da qualche tempo ripensa la funzione della pena, l’amministrare la
giustizia, il potere che detiene chi si assume questo compito. Coltiva il
benefico tarlo del dubbio. Forse il Colombo di “oggi” albergava anche “ieri”,
nel Colombo che indossava la toga del magistrato: il Colombo uno e il Colombo
due convivevano. Confesso che allora non ho colto questa dualità. Chissà: forse
era una convivenza tormentata, tormentosa. Come nella pirandelliana “Signora
Morli una e due” Colombo era scisso: autentico il primo, sincero il secondo.
Solo che “ieri”, con la toga sulle spalle, il Colombo di “uno” sovrastava il
Colombo “due”; ora che quella toga è dismessa, i ruoli si sono invertiti.
La popolare saggezza ricorda che non è dato il due
senza il tre; puntuale ecco il terzo, più villico, ripensamento (ravvedimento
sarebbe dire troppo ardito). Nientemeno che Antonio Di Pietro, il dottor “che
c’azzecca? “. Si confida a L’aria che tira d’estate su La7: «Ho fatto
l’inchiesta Mani Pulite con cui si è distrutto tutto ciò che era la cosiddetta
Prima Repubblica: il male, che era la corruzione e ce n’era tanta, ma anche le
idee». Aggiunge: «Ho fatto politica basandola sulla paura e ne ho pagato le
conseguenze». Quali conseguenze magari un giorno ci verrà chiarito. Per ora
basta quello che ha sillabato: «Ho costruito la mia politica sulla paura delle
manette, sul concetto che erano tutti criminali». Frasi dal sen fuggite, nella
foga di un intervento? No. Con Paolo Vites de Il Sussidiario, Di Pietro integra
il ragionamento; dice di aver fatto il suo dovere di magistrato, «anche
l’inchiesta Mani Pulite non la rinnego, rifarei oggi tutto quanto feci allora».
Riconosce però che da «quell’inchiesta si è creato un vuoto, non solo un vuoto
di figure politiche, ma dell’idea stessa della ricostruzione della politica.
L’inchiesta era doverosa, ma chi voleva fare o restare in politica doveva
costruire una idea politica. Invece si è cercato il consenso sul piano
individuale, sul personalismo. Sono nati i Bossi, i Berlusconi, i Di Pietro, i
Salvini, i Renzi. Persone che basano il loro consenso su chi urla più forte. Io
sono stato uno di quelli. Ho peccato di personalismo, senza creare un’idea
politica».
A questo punto – lo si dice per celia – verrà un
giorno in cui anche un Piercamillo Davigo, un Nicola Gratteri, faranno analoghe
capriole? No. Tutto fa pensare che quel giorno non verrà; almeno loro
manterranno le ben note posizioni di sempre. Per tornare a Di Pietro: «Tra i
tanti effetti di Mani Pulite c’è stato anche l’effetto emulazione, sono nati i
magistrati dipietristi. È uno dei rischi che la magistratura deve evitare. La
magistratura fa lo stesso lavoro che fa il becchino. Il becchino interviene
quando c’è il morto, la magistratura deve intervenire quando c’è il reato, la
magistratura invece che vuole sapere se c’è il reato è una magistratura
pericolosa, perché con le indagini esplorative si crea il delinquente prima che
ci siano le prove». Si potrà ricavare, da queste parole, da questi
riconoscimenti, motivo per dire: meglio tardi che mai; e aggiungere che il tempo
si conferma galantuomo. No. Il detto in questo caso non può e non deve valere
quando galantuomini finiscono impigliati, e spesso stritolati, nelle tenaglie
della giustizia. Il problema, che non può essere eluso, il nodo che va sciolto,
è che le persone cui viene attribuito il potere di giudicare i propri simili non
possono e non devono vivere come potere questo potere. Può apparire paradossale;
ma come diceva Sciascia, «la scelta della professione di giudicare dovrebbe
avere radice nella repugnanza a giudicare, nel precetto di non giudicare;
dovrebbe cioè consistere nell’accedere al giudicare come ad una dolorosa
necessità, nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi
all’inquietudine, al dubbio». La crisi in cui versa l’amministrazione della
giustizia in Italia deriva «principalmente dal fatto che una parte della
magistratura non riesce a introvertire il potere che le è assegnato, ad
assumerlo come dramma, a dibatterlo ciascuno nella propria coscienza, ma tende
piuttosto a estrovertirlo, ad esteriorizzarlo, a darne manifestazioni che
sfiorano, o addirittura attuano, l’arbitrio». In mancanza di questo, anche il
riconoscimento più sincero e sofferto, è inutile, vano. Una consolazione che
nulla consola; un ripensamento che niente mette in discussione.
Dell’Utri, i Br e i bambini in carcere,
scrive Piero Sansonetti il 15 Agosto 2017 su "Il Dubbio". Quasi 57mila persone
passano il ferragosto in carcere, la cosa non interessa molti. Giornali,
intellettuali e politici son tutti presi dalla smania di buttar la chiave. Oggi
è ferragosto e gli italiani sono quasi tutti in vacanza. I ricchi in luoghi di
lusso, i mezzo- borghesi un po’ intruppati, i poveri a casa loro, alcuni
allegri, alcuni tristi. Poi ci sono 56 mila e 766 persone che non sono in
vacanza. Sono in carcere. Di loro, a parte gli addetti ai lavori e gli amici
radicali ( e qualche volta il papa), non si occupa nessuno. Loro passano un
ferragosto di dolore, come tutti gli altri giorni dell’anno, aggravato dalle
sofferenze a volte insopportabili del caldo. Pigiati nelle celle, perché le
celle sono piccole e ospitano molti detenuti, spesso molti di più di quelli che
possono contenere. Tra questi quasi 57 mila nostri fratelli disgraziati, ce ne
sono 730 che sono rinchiusi in regime di 41 bis. Cosa vuol dire? Semplicemente
vuol dire “carcere duro”, una espressione che dopo la caduta del fascismo era
stata cancellata dal nostro linguaggio, ed è tornata prepotentemente negli anni
90. Queste 730 persone, delle quali circa 100 sono in attesa di giudizio, non
possono ricever visite se non una al mese e da dietro una vetrata, vivono
isolati 24 ore su 24, senza tv, senza radio, non possono cucinare, non possono
lavorare, non hanno l’ora d’aria con gli altri detenuti. Dell’Utri, i
brigatisti, i bimbi in cella. Una cosa li unisce: sono persone…Una specie di
Cajenna. E siccome sono quasi tutti accusati di essere mafiosi, è quasi
impossibile immaginare che qualcuno, nel mondo per bene, abbia una parola
gentile, o persino un nascosto pensiero affettuoso nei loro confronti. Eppure
sono persone. Persone come tutti noi. La maggior parte di loro è colpevole di
vari e talvolta efferatissimi delitti, alcuni invece – forse pochi – sono
vittime di errori giudiziari, più frequenti di quel che si crede, in Italia.
Tutti, però, sono persone. Tra le altre persone che passeranno in carcere il
ferragosto ci sono anche 64 bambini. Per fortuna solo 64. Ma non sono pochissimi
64 bambini di meno di tre anni. In cella, con la loro mamma, qualcuno anche col
fratello o con la sorellina. La maggior parte di questi bambini è straniero: 40
stranieri contro 24 italiani. Eppure, sebbene la maggioranza sia straniera,
questa massa di bambini sicuramente riuscirà, più dei mafiosi, a strappare
qualche buon sentimento, forse un sorriso, forse una parola di pietà, anche nel
mondo perbene. Con i bambini ci sono 50 mamme. Più della metà straniere. Molte
rom, o senza fissa dimora. In genere non scontano pene lunghissime, pochi anni o
qualche mese. Ma sono recidive. Piccoli furti, borseggi, qualche truffa.
Recidive e dunque niente scarcerazione. Ci sono anche delle persone famose in
carcere. Generalmente le persone famose non suscitano nessuna simpatia. Spesso
stimolano i sentimenti della rivalsa e della vendetta. “Hai avuto una vita
agiata, sei stato potente? Ah ah: ora paghi, soffri maledetto”. E spesso questo
senso di rivalsa e di vendetta non è nemmeno un sentimento che si nasconde, del
quale ci si vergogna. Anzi lo si esterna con soddisfazione, si grida forte. Poi
magari si va anche a messa, dopo.
Tra le persone famose ne ricordo tre, perché
conosco bene la loro vicenda giudiziaria. Un medico, un senatore ed un ex
senatore. Il medico si chiama Pier Paolo Brega Massone, è in cella da nove anni.
Lo accusano di cose orribili, di avere operato pazienti che sapeva inoperabili,
e di averli uccisi, per prendere qualche rimborso. Lo hanno imputato per quattro
omicidi volontari e condannato all’ergastolo. Sebbene in sede civile fosse stato
assolto, e dunque qualche dubbio sulla sua colpevolezza fosse evidente. La Corte
d’appello, di fronte a una perizia del Pm che diceva “colpevole” e una perizia
della difesa che diceva “innocente”, si è rifiutata di nominare un perito
indipendente e ha creduto al Pm. Brega Massone chiedeva solo quello: un perito
indipendente. Lui si è sempre dichiarato del tutto innocente, e molti medici,
esperti, dicono che ha ragione. Ora la Cassazione ha stabilito che sulla base
delle prove raccolte non può certo trattarsi di omicidi volontari. Sono
eventualmente omicidi colposi. Niente ergastolo, bisogna ricalcolare la pena.
C’è tempo, c’è tempo, hanno risposto i magistrati. E lui sta i carcere. Tra poco
fa dieci anni. La moglie cerca di tirare avanti, lavoricchiando, con una bambina
di 13 anni, perché il marito non produce più reddito, bisogna assisterlo in
prigione, pagare gli avvocati…
Il secondo caso è quello che conoscete tutti. L’ex
senatore Marcello dell’Utri. E’ in prigione da quasi tre anni. E’ accusato di un
reato che non è scritto nel codice penale: concorso esterno in associazione
mafiosa. Una specie di offesa al vocabolario e alla sintassi. La Corte europea
ha stabilito che quel reato, seppure esiste, esiste dal 1994. I fatti imputati a
dell’Utri sono degli anni 80. E’ chiaro che deve uscire. Perché non esce? La
“compagnia dell’antimafia” non vuole, e talvolta i magistrati subiscono la
pressione della “compagnia antimafia”. E poi dell’Utri è molto amico di
Berlusconi, e se non si può mettere dentro Berlusconi si tiene in prigione,
finché si può, un suo amico. Siccome non c’è il reato, tecnicamente Dell’Utri è
un prigioniero politico.
Poi c’è il giovane senatore Caridi, del quale
abbiamo parlato nei giorni scorsi. E accusato di associazione mafiosa. Prove? No
non ce n’è. Ci sono alcune dichiarazioni dei pentiti di una decina d’anni fa.
Dichiarazioni già considerate non attendibili dai giudici di allora, ma poi, si
sa, i tempi cambiano. Uno di questi pentiti ha dichiarato di aver assistito a un
incontro segreto tra Caridi e un certo boss mafioso nel 2007. Sarebbe la prova
regina della colpa del senatore. Poi si è saputo che nel 2007 ‘ sto boss mafioso
era al 41 bis. Non poteva incontrare proprio nessuno, tantomeno di nascosto.
Però non è stato cancellato il pentito è stata corretta la data…
Cosa c’entra quel cuore di pietra di Dell’Utri coi
bambini di tre anni? C’entra, perchè sono persone: nello stessissimo modo sono
persone. E dovrebbero interessarci. Invece all’opinione pubblica sembra
interessare solo che le carceri siano piene. Sempre più spesso si sente dire,
anche da persone responsabili, importanti: «Buttate la chiave!» Recentemente due
giornali nazionali di grande prestigio hanno protestato. Una volta perché un
boss era stato portato a casa per 12 ore a vedere la mamma ammalata. E poi si è
saputo che non era neanche vero. Un’altra volta, pochi giorni fa, perché
Carminati (che non è più al 41 bis perché è stato assolto dal reato mafioso),
adesso può spassarsela all’ora d’aria, può cucinare in cella, incontrare i
parenti una volta a settimana per un’ora filata…C’è un verso famoso di una
canzone di Fabrizio de André che dice così: «tante le grinte, le ghigne i musi,
vagli a spiegare che è primavera… e poi lo sanno ma preferiscono vederla
togliere a chi va in galera». Già, proprio così. Se vengono a sapere che ora
Carminati può cucinarsi un uovo sodo fremono come bestie. E siccome abbiamo
citato De André torniamo agli anni d’oro di De André, tra i settanta e i
novanta. In quegli anni in Italia il tasso di criminalità era molto, molto più
alto di ora. C’era il terrorismo, la mafia uccideva quasi tutti i giorni. Erano
di più i furti, le rapine, le aggressioni. Le città non erano molto sicure,
perché la violenza era alta. Beh, sapete quanti erano i detenuti, in quegli
anni? Ho dato un’occhiata agli annuari Istat. Nel 1976, che è l’anno nel quale
esplode il terrorismo, i detenuti erano 53,2 ogni 100.000 abitanti. Oggi invece
sono 107, 4 ogni centomila abitanti. Un po’ più del doppio. Nel 1992, dopo più
di un decennio di terrorismo scatenato e mentre era in pieno svolgimento la
durissima iniziativa mafiosa, e cioè l’attacco frontale allo Stato deciso dai
corleonesi, i detenuti erano 35.000, più o meno a parità di popolazione. 21 mila
meno di oggi. Se volete qualche altra cifra dell’Istat posso dirvi che della
attuale popolazione carceraria circa il 35 per cento è in prigione senza
condanna definiva e circa il 20 per cento è in prigione senza aver ricevuto
nessuna condanna, neanche di primo grado.
Qualunque manuale di sociologia ci spiega che con
l’avanzare della civiltà le carceri si svuotano, piano piano. Le pene diventano
sempre meno severe, crescono le misure alternative. Da noi no: è una corsa a far
diventare le pene sempre più pesanti. Il numero dei carcerati è tornato quello
degli anni trenta, durante il fascismo. I trattamenti si sono inferociti. Il 41
bis è un obbrobrio giuridico. Ed è un obbrobrio anche l’ergastolo ostativo, cioè
la prigione a vita senza possibilità di una scarcerazione anticipata, senza un
permesso premio, niente. E a me sembra un obbrobrio anche la situazione di circa
30 ex brigatisti rossi che sono stati dimenticati in carcere, chi da
trentacinque chi da quarant’anni. Non usciranno mai. Serve a qualcuno?
In questi giorni stiamo pubblicando, a puntate, il
trattato di Cesare Beccaria sui delitti e le pene. Nelle prime righe spiega come
ogni pena non necessaria sia espressione della tirannia. Diceva proprio così,
nel settecento, Beccaria: tirannia. Sono passati due secoli e mezzo, ma mica lo
abbiamo capito…
Valentina Angela Stella, giornalista de "Il
Dubbio": "Della attuale popolazione carceraria circa il 35 per cento è in
prigione senza condanna definiva e circa il 20 per cento è in prigione senza
aver ricevuto nessuna condanna, neanche di primo grado".
L’INCIVILTA’ GIURIDICA. LA CRUDELTA’.
Il Procuratore contro la gogna: «Basta
foto degli arrestati», scrive il 16 gennaio 2018 "Il
Dubbio". Il commento di Edmondo Bruti Liberati contro polizia e stampa.
L’articolo che segue, scritto dall’ex Procuratore di Milano Edmondo Bruti
Liberati, è tratto da “Questione giustizia”, la rivista on- line di Magistratura
democratica, ed è stato pubblicato l’8 gennaio 2018. Chi avesse scorso i
quotidiani del 6 gennaio 2018 avrebbe trovato due notizie, di segno molto
diverso, sul tema della diffusione di foto e riprese di persone arrestate. Il
quotidiano Libero in prima pagina, con grande evidenza titola: «Il comandante
dei carabinieri infuriato: “Questi signori ladri tornano liberi e riprenderanno
a rubare”. I volti degli otto clandestini albanesi segnalati pubblicamente dai
carabinieri di Padova»; nel riquadrato le otto fotografie segnaletiche a colori.
L’articolo prosegue a pagina 13 con il titolo. «L’avvertimento del comandante
dell’Arma di Padova. “Occhio a questi ladri, stanno per uscire di cella”. I
carabinieri segnalano otto pregiudicati albanesi. “Tenete a mente queste facce,
potrebbero riprendere a rubare nelle case”». Nel testo dell’articolo si
riferisce che, nel corso di una conferenza stampa, il comandante provinciale dei
Carabinieri di Padova «ha mostrato le foto segnaletiche perché le telecamere
delle televisioni locali riprendessero bene i volti di questi malviventi e li
diffondessero nelle case della gente. Sono tutti pregiudicati, hanno precedenti
specifici, sono albanesi di famiglia zingara e sono sprovvisti del permesso di
soggiorno. Vivono grazie ai proventi dei loro furti. (…) Il colpo più datato è
di tre mesi fa, sono stati ammanettati da poco, ma il comandante dei Carabinieri
si sente in dovere di dire alla popolazione di stare attenta, di guardarsi
attorno dieci volte prima di lasciare la propria casa incustodita perché questi
ceffi quando a breve avranno saldato il loro conto con la legge potrebbero
tornare in azione. (…) Nel corso della conferenza stampa il comandante ha anche
illustrato una sorta di vademecum per difendersi dai ladri». Segue, sempre a
pagina 13, un commento dal titolo: «A questo porta l’inefficienza della nostra
giustizia». La notizia viene riportata anche dai quotidiani della catena La
Nazione- Il Resto del Carlino- Il Giorno con toni analoghi e pubblicazione delle
otto foto; segue un commento dal titolo «Onore all’Arma». Non sappiamo quanto di
enfasi sia dovuto alla penna dei cronisti rispetto alle dichiarazioni
effettivamente rese dal comandante provinciale dei Carabinieri, ma il dato di
fatto pacifico è l’iniziativa di diffondere alla stampa le foto segnaletiche
degli arrestati. Sarà interessante vedere se vi saranno reazioni da chi
ricorrentemente denuncia (e giustamente) episodi di “gogna mediatica” ovvero se
l’indignazione si confermi selettiva in base alla personalità dei soggetti
offerti alla gogna. Il Corriere del mezzogiorno (Napoli e Campania) sempre il 6
gennaio 2018 a pagina 6 titola: «Melillo: stop alla diffusione delle foto di
persone indagate oppure arrestate. Circolare del procuratore alle forze
dell’ordine, ad avvocati e giornalisti: va tutelata la dignità. Soprattutto se
il soggetto coinvolto sia vulnerabile, come nel caso di chi ha perso la
libertà».
LA CIRCOLARE. Merita subito una segnalazione il
fatto che la circolare diretta alle autorità di polizia sia, molto
opportunamente, indirizzata, per conoscenza, oltre che al procuratore generale e
ai magistrati dell’ufficio, anche al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati e al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti. La circolare
muove dalla premessa: «La doverosa cura delle condizioni di efficace tutela
della dignità delle persone sottoposte ad indagini ovvero comunque coinvolte in
un procedimento penale appare, infatti, maggiormente meritevole di attenzione
qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel
caso in cui sia privata della libertà personale». E prosegue: «Come
costantemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema normativo
vigente impone il raggiungimento di un ponderato equilibrio tra valori diversi
contrapposti, tutti di rilievo costituzionale, stante l’esigenza di un
necessario contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, il diritto
dei cittadini all’informazione e l’esercizio della libertà di stampa». Vengono
quindi richiamate le disposizioni dell’art. 25 del Codice per la protezione dei
dati personali, l’art. 8 del Codice di deontologia dei giornalisti, il
provvedimento n. 179 del 5 giugno 2012 dell’Autorità di garanzia dei dati
personali, nonché la sentenza Cedu 11 gennaio 2005 (Sciacca contro Italia), che
ha ravvisato una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo nella diffusione della foto segnaletica di una persona arrestata. La
circolare dopo aver rammentato che: «Del resto, tali principi sono espressamente
richiamati anche nella circolare 123/ A183. B320 del 26.2.1999, con la quale il
Ministero dell’Interno ha sottolineato l’esigenza che, anche nell’ipotesi di
indiscutibile “necessità di giustizia e di polizia” alla diffusione di immagini,
“il diritto alla riservatezza della tutela della dignità personale va sempre
tenuto nella massima considerazione”» conclude disponendo: «In conformità alle
precise indicazioni normative appena ricordate, pertanto, le SS. LL. vorranno
assicurare – impartendo ogni opportuna disposizione agli uffici e ai comandi
dipendenti – la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita diffusione di
fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell’ambito
di procedimenti la cura dei quali competa a questo Ufficio, segnalando
preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di prevenzione
ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra
richiamato». La diffusione e la pubblicazione di riprese filmate e foto di
persone al momento dell’arresto o della traduzione in carcere o delle foto
segnaletiche, a dispetto dei principi e della normativa vigente, è purtroppo un
costume diffuso. La comprensibile e pur legittima esigenza di visibilità delle
autorità di polizia che hanno proceduto alle indagini può trovare uno sbocco nel
modulo comunicativo che si realizza con la partecipazione alla conferenza stampa
tenuta negli uffici della Procura della Repubblica. Il tema è controverso e le
prassi sono difformi. Non sono mancate iniziative dirette a contrastare le
prassi distorte. Nel Bilancio di Responsabilità sociale 2014/ 2015 della Procura
della Repubblica di Milano, reperibile nel sito internet della procura, in un
passaggio della Introduzione dedicato alla “Comunicazione della Procura” si
segnala: «Per i casi di significativo interesse pubblico, è stata privilegiata
la comunicazione con lo strumento del comunicato stampa emesso dal Procuratore e
diffuso con la massima tempestività possibile consentita dal livello di
discovery raggiunto, anche al fine di garantire parità di accesso a tutti i
media. Nel periodo in esame sono stati diffusi numerosi comunicati stampa. In
occasione di indagini di particolare rilievo al comunicato stampa è seguita una
conferenza stampa, tenuta negli uffici della Procura della Repubblica, con la
partecipazione dei responsabili della o delle forze di PG interessate.
L’obiettivo è di fornire all’opinione pubblica una informazione il più possibile
completa su quegli aspetti della indagine che non sono più coperti da segreto e
sempre nel rispetto della presunzione di non colpevolezza. Il rispetto della
dignità delle persone ha comportato, d’intesa con le forze di polizia, la
adozione di precise prassi operative per evitare la ripresa fotografica o
televisiva di persone al momento dell’arresto. Nel quinquennio, nonostante siano
stati eseguiti numerosi arresti in tema di criminalità mafiosa, terrorismo,
corruzione e criminalità economica suscettibili di grande risonanza mediatica,
in nessuna occasione vi è stata la diffusione di immagini delle persone». Ma è
sufficiente una rapida ricerca sul web per trovare diverse riprese filmate degli
arrestati. Altrettanto frequente è la diffusione delle foto segnaletiche degli
arrestati sia da parte delle autorità di polizia, sia anche nel corso di
conferenze stampa tenute con la presenza del procuratore della Repubblica. Tre
esempi recenti sul web: l’Operazione Gorgòni, Catania 28 novembre 2017;
l’Operazione Metauros, Reggio Calabria 5 ottobre 2017; il Blitz Contatto, Lecce
5 settembre 2017. In questo contesto è tanto più apprezzabile la iniziativa del
procuratore di Napoli, sia per la puntuale motivazione sia per le precise
disposizioni impartite.
NORME E PRASSI. Può essere utile una rassegna
della normativa per evidenziarne la inosservanza nella prassi. Con l’art. 14,
comma 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 è stato introdotto un nuovo comma 6
bis all’art. 114 cpp: «È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona
privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta
all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo
che la persona vi consenta». Per la risposta sanzionatoria rimane operante
l’art. 115 cpp: «Violazione del divieto di pubblicazione. Salve le sanzioni
previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto
dagli artt. 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare
esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle
persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del
potere disciplinare». Non risultano segnalazioni del pubblico ministero e
tantomeno iniziative disciplinari a fronte della non infrequente pubblicazioni
di foto e riprese di arrestati in manette, talora, ma non sempre, con l’ipocrita
accorgimento delle manette “pixelate” e dunque paradossalmente ancor più
sottolineate. Eppure vige da tempo il Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica
(Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio
1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179) che prevede: «Art. 8. Tutela
della dignità delle persone. Salva l’essenzialità dell’informazione, il
giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma
su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell’immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di
giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto
di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. Le persone
non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia
necessario per segnalare abusi». È interessante segnalare che in Francia la
legge n. 2000- 516 del 15 giugno 2000, intitolata al rafforzamento della
presunzione di innocenza e dei diritti delle vittime, all’art. 92 ha introdotto
un nuovo articolo 35- ter alla legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa:
«Salvo che sia realizzata con il consenso dell’interessato, la diffusione, con
qualunque mezzo o supporto, dell’immagine di una persona identificata o
identificabile soggetta ad una procedura penale, ma non ancora condannata, che
la mostri sottoposta all’uso di manette ovvero ad altro mezzo di coercizione
fisica, ovvero mentre viene posta in detenzione provvisoria, è punita con
l’ammenda di 100.000 F». La stessa legge del 2000 ha modificato l’art. 803 del
codice di procedura penale nei termini seguenti: «Nessuno può essere sottoposto
all’uso di manette ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che sia
considerato pericoloso per sé o per gli altri o suscettibile di tentare la fuga.
In queste ipotesi devono esser adottate tutte le misure utili, compatibilmente
con le esigenze di sicurezza, ad evitare che la persona sottoposta all’uso di
manette ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, sia fotografata o soggetta
a ripresa audiovisiva». Una rapida ricerca sui siti web francesi non fa emergere
casi di diffusione di foto segnaletiche o di persone ammanettate; è pubblicata
una ripresa video di violenze da parte della polizia in servizio di ordine
pubblico nei confronti di persone arrestate e ammanettate nel corso di una
manifestazione in Place de la Republique il 28 aprile 2016. Il tema è stato
riproposto con particolare evidenza nel 2011 quando il Consiglio superiore
dell’audiovisivo (CSA) ha ritenuto che non fossero pubblicabili in Francia le
foto diffuse negli Stati Uniti in occasione dell’arresto di Dominique Strauss
Kahn. Le foto e le riprese televisive, largamente diffuse, in Italia hanno
mostrato Dominique Strauss Kahn in manette deliberatamente e ripetutamente
offerto alle riprese giornalistiche dalle autorità di polizia secondo la pratica
cosiddetta del “perp walk”, controversa ma largamente diffusa. Il termine “perp”
è una abbreviazione di “perpetrator”, con buona pace della presunzione di
innocenza, trattandosi di persona arrestata dalla polizia e messa in pasto al
pubblico prima ancora di essere presentata davanti al giudice. Gli esempi di
“perp walk” sono numerosi: forse il più celebre è quello in cui Jack Ruby viene
ripreso in diretta dalle Tv mentre spara ed uccide Lee Harvey Oswald, arrestato
come sospetto assassino di J. F. Kennedy. A partire dagli anni ‘ 80 alla pratica
del “perp walk” sono stati sottoposti anche “colletti bianchi”, soprattutto per
iniziativa di Rudolph Giuliani.
LA SENTENZA CEDU. Se in Italia siamo ben distanti
dalla barbarie del “perp walk” americano, il confronto con la Francia mostra
quanto si debba operare ancora nel nostro Paese per eliminare prassi distorte.
Eppure un monito forte ci è stato offerto oltre un decennio addietro dalla
sentenza Cedu dell’11 gennaio 2005 Sciacca contro Italia, opportunamente citata
nella circolare del procuratore di Napoli. La Corte ha ritenuto la violazione
dell’art. 8 della Convenzione nella divulgazione alla stampa da parte della
autorità di polizia della foto di una persona arrestata, in quanto ingerenza non
giustificata nel diritto al rispetto della vita privata, non essendo necessaria
per lo sviluppo delle indagini. Vi è da augurarsi che la meritoria iniziativa
del procuratore Giovanni Melillo riesca ad innescare un circolo virtuoso tra
magistratura, polizia e stampa.
“Il giornalista non è nè giudice nè
poliziotto. Dia le notizie senza suggestionare e non anticipi i possibili
sviluppi”. “A ciascuno il suo: agli inquirenti il
compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la
fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del
diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività”. Ma questa
sentenza della Corte Cassazione deve essere rimasta ignota ad alcuni giornalisti
troppo spesso al servizio effettivo del pm “protagonista” di turno. Ah quanti ne
conosciamo…!!! Scrive "Il Corriere del Giorno" il 16 gennaio, 2018. “A ciascuno
il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il
compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne
notizia, nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la
collettività”. È il monito della Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare un
caso di diffamazione. Secondo la Suprema corte, in particolare, “rientra
nell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e
atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito
effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e
precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di
tale attività”. “È quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di
narrare fatti già accaduti (…) l’opera del giornalista che confonda cronaca su
eventi accaduti e prognosi su eventi a venire”, perchè “in tal modo – aggiunge
la Cassazione, facendo riferimento al caso in esame – egli, in maniera autonoma,
prospetta e anticipa l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista,
a fronte di indagini ufficiali nè iniziate nè concluse“. Il caso su cui si è
pronunciata la Quinta Sezione Penale riguardava un procedimento per diffamazione
nei confronti del giornalista Peter Gomez (attuale direttore del
sito ilfattoquotidiano.it ai danni del presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi. La Corte di Appello di Roma, nel 2009, pur dichiarando l’estinzione
per prescrizione del reato per diffamazione aveva ritenuto fondata la tesi
secondo cui il giornalista in un articolo sui presunti finanziamenti della mafia
al gruppo Fininvest, oltre a riportare le dichiarazioni di un collaboratore di
giustizia contenute nelle indagini, aveva aggiunto “ulteriori considerazioni
tratte da altre dichiarazioni di altri soggetti, che apparivano dirette ad
avvalorare la credibilità del collaboratore di giustizia realizzando così una
funzione di riscontro» che però non può fare il giornalista ma solo l’autorità
giudiziaria”. Nel ricorso in Cassazione il giornalista ha chiesto che nonostante
la prescrizione venisse lo stesso riconosciuto l’esercizio del diritto di
cronaca, ma i supremi giudici con sentenza 3674 hanno respinto la richiesta.
Scrivono infatti i giudici che “è interesse dei cittadini essere informati su
eventuali violazioni di norme penali e civili, conoscere e controllare
l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello Stato davanti
all’illegalità per poter effettuare valutazioni sullo stato delle istituzioni e
il livello di legalità di governanti e governati“; ugualmente, “è diritto della
collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento
penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilevo
nella vita sociale, politica o giudiziaria“. Ma, precisa la Cassazione, è “in
stridente contrasto con il diritto-dovere” di cronaca l’azione del giornalista
che “confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire”. Nel
caso specifico, “il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte
conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e
valutativa rimessa all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria”. E
l’articolo pubblicato, sostiene la Suprema Corte, “non può ritenersi un’asettica
riproduzione di dichiarazioni (…) ma un articolato discorso che, comprendendo
altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verità del contenuto
di queste” dichiarazioni, “a fronte di indagini in corso proprio per
l’accertamento di questa verità”. “La cronaca giudiziaria è quel particolare
ramo della cronaca che riguarda l’esposizione di avvenimenti criminosi e delle
vicende giudiziarie ad essi conseguenti, al fine di consentire alla collettività
di avere una retta opinione su vicende penalmente rilevanti, sull’operato degli
organi giudiziari e, più in generale, sul sistema giudiziario e legislativo del
Paese. Difatti come ricordato dalla Cassazione (Cass. pen., 1 febbraio 2011, n.
3674, Pres. Calabrese, Rel. Bevere) nella sentenza che qui si pubblica
l’esimente delle cronaca giudiziaria riguarda il “diritto di informare i
cittadini sull’andamento degli andamenti giudiziaria a cario degli altri
consociati”, dato che “è interesse dei cittadini essere informati su eventuali
violazioni di norme penali e civili, conoscere e controllare l’andamento degli
accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde
potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul
livello i legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato
momento storico”. Continua sempre la Corte osservando come il “diritto di
cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta
categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e
al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte
consapevoli nell’ambito della vita associata. E’ diritto della collettività
ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o
civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita
sociale, politica o giudiziaria”. Ne segue che “in pendenza di indagini di
polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziari nei confronti di un cittadino,
non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria
reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione
perde il suo carattere di antigiuridicità”. Ciò posto, nell’ambito della cronaca
giudiziaria si ritiene che sia certamente legittima l’esposizione di fatti
recanti discredito all’onore ed alla reputazione altrui, purché i “fatti in
questione trovino rispondenza in quanto espresso dalle autorità inquirenti
ovvero nel contenuto degli atti processuali, dovendosi altresì considerare che
per il cronista giudiziario il limite della verità delle notizie si atteggia
come corrispondenza della notizia al contenuto degli atti e degli accertamenti
processuali compiuti dalla magistratura, con la conseguenza che il fatto da
dimostrarsi vero, al fine dell’accertamento della scriminante, è unicamente la
corrispondenza della notizia agli atti processuali a prescindere dalla verità
dei fatti da questi desumibili” (Tribunale di. Roma, 09.05.2003, in RCP, 2005,
232). Nella narrazione di tali atti è tuttavia necessario che venga rispettato
il diritto dei soggetti coinvolti in tali fatti, cosicché l’opinione del
consesso dei cittadini, si formi su notizie aderenti a quelle che sono le
effettive risultanze processuali a loro carico. E’ dunque di tutta evidenza che
la cronaca giudiziaria può collidere con il contrapposto interesse di tutela
della riservatezza del soggetto coinvolto negli accadimenti giudiziari oggetto
della cronaca. Altresì (e soprattutto) la cronaca giudiziaria si colloca in
potenziale conflitto anche con i principi espressi dall’art. 27 della
Costituzione, ai sensi del quale sono vietate affermazioni anticipatorie della
condanna o, comunque, pregiudizievoli della posizione dell’indagato e
dell’imputato: la ratio della norma è volta a tutelare detti soggetti contro
ogni indicazione che li accrediti come colpevoli prima di un accertamento
processuale definitivo che effettivamente li riconosca come tali (cfr. Cass.
pen., 21.03.1991, in RPen, 1991, 912; Trib. Roma, 06.04.1988, in DInf, 1988, p.
837). Tanto premesso, d’altro canto, è parimenti ovvio che il diritto di
cronaca (e, più in generale, di manifestazione del pensiero) non può venire del
tutto sacrificato neppure nei confronti del principio di presunzione di
innocenza; ciò sul presupposto che a favore dell’imputato o dell’indagato non
militi alcuna ragione volta a riconoscere loro una tutela della reputazione
maggiore di quanto non spetti ad altri soggetti. Date queste premesse, vediamo
che la cronaca giudiziaria incontra i medesimi limiti delle altre forme di
cronaca (verità della notizia, pubblico interesse alla conoscenza dei fatti
narrati, e continenza), sui quali però sono state svolte doverose
specificazioni. E difatti, quanto al limite della verità, esso viene inteso in
senso restrittivo, poiché il sacrificio della presunzione di innocenza non deve
spingersi oltre quanto strettamente necessario ai fini informativi. Ciò comporta
che il giornalista non deve narrare il fatto in modo da generare un
convincimento su una colpevolezza non solo non ancora accertata, ma che poi
potrà rivelarsi anche inesistente (cfr. App. Roma, 20.01.1989, in GPen., 1991,
II, c. 519); inoltre, se la notizia viene mutuata da un provvedimento
giudiziario, occorre che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso,
senza illazioni, allusioni, alterazioni o travisamenti (cfr. Cass. pen.,
10.11.2000, Scalfari, in CPen, 2001, p. 3045) e senza ricostruzioni, o ipotesi
giornalistiche, autonomamente offensive (cfr. Cass. pen., 20.09.2000, in CPen,
2001, p. 3405). Altresì si richiede che non venga omessa la narrazione di
aspetti idonei a scagionare l’imputato: i fatti vanno, dunque, riferiti in
termini di problematicità (Trib. Roma, 5.11.1991, in DInf, 1992, p. 478),
chiarendo le opposte tesi dell’accusa e della difesa (c.d. principio
dell’equilibrio), dando voce in ugual misura alle parti contrapposte senza
tacere aspetti salienti delle tesi difensive, al fine di inculcare nel lettore
la convinzione di una inevitabile pronunzia di condanna. Inoltre, nel dare la
parola agli indagati, agli imputati ed ai loro difensori, il cronista
giudiziario non deve raccogliere sfoghi ed invettive, ma elementi concreti di
difesa o di accusa, atti a mettere il lettore di farsi una propria opinione sui
fatti, sui criteri di gestione dei processi, sul ruolo della magistratura così
da consentire il controllo diretto della collettività sull’operato delle
istituzioni (L. BONESCHI, Etica e deontologia del giornalista nella cronaca
giudiziaria: qualche regola da rispettare, in DInf., 1999, p. 569, ss). In
questo contesto la Cassazione nella sentenza qui pubblicata ha precisato che i
giudizi critici manifestati su una persona coinvolta in indagini devono porsi in
correlazione con l’andamento del processo, perché “rientra nell’esercizio del
diritto di cronaca giudiziaria riferire atti giudiziari e atti censori,
provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare
ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività
di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività”.
Secondo la Corte quindi è in contrasto con il “diritto / dovere di narrare fatti
già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni «a futura memoria»,
l’opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su
eventi a venire. In tal modo egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa
l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini
ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la
affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del
loro esito. Si propone ai cittadini un processo garantista. Dinanzi al quale il
cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per
diffamazione”. Conclude così la Corte: “a ciascuno il suo: agli inquirenti il
compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la
fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del
diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività”.
Minzolini: «Ora s’indignano per Cioffi E
quando un giudice del Pd mi condannò?» Scrive Paola
Sacchi il 4 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". «La Repubblica che ha protestato per
la presunta partecipazione di un giudice a una convention non disse nulla sulla
mia situazione ben più grave». «È un elefante in un occhio». Così commenta
con Il Dubbio Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia ed ex direttore del
Tg1, con un curriculum da maestro dei cronisti parlamentari, il diverso
atteggiamento dei media, in particolare del quotidiano La Repubblica, che ha
messo nel mirino la presunta partecipazione del giudice dei fratelli di Luigi
Cesaro, candidato campano di Fi, a una convention azzurra; e invece, ha
denunciato Minzolini in un tweet, «ha ritenuto lecito che un giudice già
parlamentare e membro di governi di centrosinistra condannasse il sottoscritto».
Ex senatore Minzolini, il giudice dei Cesaro,
che ha smentito la sua partecipazione all’iniziativa di Forza Italia, si è
dimesso da presidente del collegio giudicante. A lei, condannato in Cassazione
per peculato, che ha abbandonato il parlamento per sua scelta, nonostante un
fronte trasversale abbia bocciato le sue dimissioni, è stato usato quindi una
trattamento diametralmente opposto?
«Io non sto a
guardare il trattamento usato nei miei confronti. Ne faccio una questione di
informazione che riguarda l’atteggiamento di “La Repubblica”. Quel quotidiano ha
imbastito una campagna sulla vicenda campana per la presunta partecipazione di
un giudice a una convention. E’ evidente che rispetto a questo la mia vicenda
diventa un elefante in un occhio».
Ci spieghi.
«C’è stato un
giudice che in Cassazione ha ribaltato una sentenza di assoluzione in primo
grado, che se ne è infischiato del fatto che il giudice del Lavoro mi avesse
dato ragione, facendomi addirittura risarcire dalla Rai. Questo giudice non ha
neppure dato tanto peso alle richieste della pubblica accusa aumentando la pena
di sei mesi. Quelli però necessari a far scattare la legge Severino. Ecco,
questo magistrato non è uno che aveva partecipato semplicemente a una convention
del Pd, ma ha fatto il deputato, il senatore, il sottosegretario più volte con
governi del centrosinistra. Per La Repubblica questo invece non ha fatto
scandalo. Non ho trovato lo stesso atteggiamento critico sull’imparzialità che
invece ho trovato sulla vicenda campana. Il mio processo è stato caratterizzato
da personaggi che hanno avuto a che fare con la politica: il relatore in
Cassazione del mio processo era anche stato capo di Gabinetto del ministero di
Grazia e Giustizia del governo Prodi. Credo che qui ci sia anche un problema di
sensibilità istituzionale degli stessi giudici. Nella Prima Repubblica mi
ricordo che un senatore Dc si astenne, senza che nessuno glielo avesse chiesto,
perché si trovò a giudicare Arnaldo Forlani, colui che era stato il suo
segretario».
Due pesi e due misure?
«Piuttosto mi
sembra che ci sia un grammo da un lato e una tonnellata dall’altro».
Intanto, il giudice dei Cesaro si è dimesso dal
collegio giudicante.
«Ha fatto un
passo indietro evidentemente per impedire che qualsiasi sua decisione venisse
analizzata rispetto alla sua presunta partecipazione a un evento politico. I
miei giudici, invece, a quanto pare se ne sono assolutamente infischiati. Ma
quel che è peggio è che se ne è infischiato il resto del Paese. L’unica a non
infischiarsene è stata proprio la politica, e lo posso dire perché non ne faccio
più parte. Per la prima volta dopo cinquant’anni il parlamento ha rigettato una
sentenza definitiva. Uno schieramento trasversale, in cui c’erano molti
esponenti del Pd, a voto palese, ha respinto la richiesta della mia decadenza.
Io di fronte a persone che hanno avuto il coraggio di queste scelte a maggior
ragione ho mantenuto per coerenza il mio impegno già preso da tempo di
dimettermi. Ho rinunciato al mio stipendio di 140.000 euro netti e alla
pensione. Da anni i grillini invitano a rinunciare alla pensione, ecco io l’ho
fatto. Sono l’unico. Inoltre, si è creata una situazione particolare a livello
istituzionale».
Perché?
«Il potere
legislativo, cioè il parlamento, ha individuato nella mia sentenza fumus
persecutionis. Il potere esecutivo, cioè il governo, attraverso l’avvocato dello
Stato, ha recepito quel giudizio, a Strasburgo rispondendo ai giudici della
Grande Chambre per spiegare la differenza di trattamento tra me e Berlusconi ha
ricordato che su di me c’è stato fumus persecutionis. Il potere giudiziario, i
magistrati, mi hanno condannato. C’è quindi una contraddizione evidente. Ma
nessuno è intervenuto, neppure chi per ruolo istituzionale dovrebbe mediare tra
questi poteri. C’è quindi una strana situazione, come se esistessero tre Stati
paralleli. Tanto meno se ne è occupata l’informazione, lasciando le nostre
istituzioni in una situazione singolare per non dire patetica».
Tutto si può dire tranne che per lei non sia
stato usato un trattamento speciale. Ora cosa fa?
«Faccio lo
stringher, mettiamola così (risatina ndr), ovvero quello che passa le notizie a
“Yoda” per Il Giornale e a “Keiser Soze” per Panorama».
"Scrivono male di lei". E le banche
scaricano l'imprenditore modello. Finito sotto
inchiesta, gli istituti azzerano tutti i crediti sulla base degli articoli di
giornale, scrive Cristina Bassi, Lunedì 05/02/2018, su "Il Giornale".
Trasformato da un giorno all'altro da rispettabile imprenditore brianzolo a
truffatore di bassa lega. Capita - si dirà - a chi incappa in guai giudiziari.
Ma la storia di Marco Castoldi, 59 anni, al di là della sua colpevolezza o meno
ancora da stabilire, è l'emblema del meccanismo perverso che a volte incrocia
realtà e rappresentazione mediatica. Tutti a Monza sanno chi è Marco Castoldi. È
il titolare della Castoldi srl, azienda con oltre 60 anni di storia fondata dal
padre, leader nella distribuzione di elettrodomestici, articoli elettronici e
informatici. I suoi negozi fanno parte del network Euronics. Gli affari sono
sempre andati bene, finché il presidente del Cda è finito in un'inchiesta della
Guardia di finanza di Como su una rete di frodi fiscali. Ora la ditta ha chiesto
e ottenuto dal Tribunale il concordato preventivo, perché banche e assicurazioni
hanno chiuso i rubinetti mettendola in grave difficoltà. Il motivo? Non ciò che
è scritto negli atti d'indagine né tanto meno una condanna. Bensì le «notizie di
stampa». Per i creditori insomma, Castoldi è un truffatore, la sua società
merita di andare a gambe all'aria e i 150 dipendenti a casa sulla base degli
articoli di giornale che hanno dato conto, nel settembre scorso, degli arresti e
dell'inchiesta. Anche se due settimane dopo i provvedimenti cautelari, i
domiciliari a carico di Castoldi sono stati revocati. Un passo indietro. A metà
settembre scatta la retata con un centinaio di finanzieri, dopo l'indagine
coordinata dalla Procura di Como. Gli indagati sono 39, gli arrestati 17. Tra
loro, appunto, anche Castoldi e un consigliere dell'azienda. L'accusa è che
abbiano partecipato a una associazione per delinquere finalizzata a una serie di
reati fiscali e tributari. Le ipotesi degli inquirenti riguardano
l'organizzazione a livello internazionale di cosiddette «frodi carosello» per
totali 300 milioni di euro. Si tratta in sostanza di operazioni di compravendita
fittizie, con relative false fatture emesse da società create ad hoc (le
«cartiere»), finalizzate a ottenere crediti Iva non dovuti. Castoldi avrebbe
«consapevolmente» partecipato al traffico di merci, definite «scadenti»,
mettendo a disposizione la propria società come anello della catena fraudolenta.
E guadagnandoci circa 3 milioni di euro di illeciti crediti Iva. «Accuse
cervellotiche - dice il suo difensore, l'avvocato Ivano Chiesa -. Il mio
assistito non ha nulla a che vedere con tutti gli altri indagati e non aveva
idea di cosa facessero. Ha semplicemente comprato e venduto merce, come ha
sempre fatto. Comunque si è dimesso dalle cariche societarie e ha fornito a
garanzia 6 milioni di immobili personali, il doppio di quanto contestato». A
ottobre il Tribunale del riesame di Milano ha revocato i domiciliari a Castoldi,
ritenendo che non sussistano gli indizi del reato associativo. Il processo farà
il proprio corso, l'udienza preliminare è fissata per il 20 febbraio davanti al
gup Laura De Gregorio. Intanto però l'azienda comunica l'apertura del concordato
preventivo che ha lo scopo di tutelare i dipendenti e i fornitori e di provare
ad assicurarsi un futuro. La Castoldi, si legge in una nota, «negli ultimi anni
non ha riscontrato criticità dal punto di vista economico, patrimoniale o
finanziario, come dimostrano i suoi bilanci. A partire dal mese di ottobre 2017,
la società si è trovata nell'impossibilità di adempiere regolarmente alle
proprie obbligazioni a causa dell'irrigidimento del sistema bancario e
dell'azzeramento dei fidi da parte delle società di assicurazione del credito
dei fornitori, determinati dalla propagazione della notizia dell'indagine». Da
qui le difficoltà ad approvvigionarsi, proprio nel periodo a ridosso del Natale,
il migliore per gli affari. Nei primi nove mesi del 2017, «la società aveva
registrato un fatturato di oltre 66 milioni di euro con un risultato economico
positivo. Nel 2016 il fatturato era stato pari a oltre 86 milioni di euro, con
un utile di circa 400mila euro».
Storia del boss Navarra e del suo sangue
che oggi ricade sul nipote, scrive Salvo Toscano l'1
Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Il discendente del “medico” corleonese si candida
e Crocetta s’infuria. Da quando è stata resa nota la sua epurazione dalle liste
del nuovo Pd renziano, Rosario Crocetta lo ripete quotidianamente, come un
mantra. «Renzi ha preferito schierare il rettore Navarra, nipote del capomafia
di Corleone. Quelli ormai sono i riferimenti del Pd». Con il collaudato stile
dell’antimafia politica doc, l’ex governatore siciliano scaricato dal Pd non ha
perso tempo per “mascariare” (imbrattare, così si dice a queste latitudini)
l’avversario. Ripescando la parentela del rettore di Messina, Pietro Navarra,
schierato dai dem in un posto blindato nelle liste proporzionali per la Camera.
«Navarra non si è avvicinato al Pd, ma è stato avvicinato dal Pd per sostituire
il potere di Genovese (ex segretario regionale Pd, poi passato a Forza Italia,
condannato in primo grado per lo scandalo dei “corsi d’oro della formazione
professionale, ndr). L’Università di Messina ha sempre avuto un potere enorme,
lo sanno tutti». Così ancora ieri l’altro Crocetta nella sua conferenza stampa
indetta in un hotel palermitano per sparare a zero su Renzi, definito «primo
uomo politico medievale d’Italia». Non molti sono andati appresso al campione
deposto dell’antimafia politica nel tiro al Navarra. Un po’ di post al vetriolo
in giro per i social, qualche articolo sul Fatto quotidiano, poco altro. Il
rettore, dal canto suo, non ha fatto attendere la sua reazione. Con tanto di
minaccia di querela preventiva ai giornali: «Noto con rammarico che, addirittura
prima ancora dell’inizio della campagna elettorale, personaggi protagonisti del
recente passato politico hanno rilasciato dichiarazioni infamanti nei miei
confronti, con riferimento alla vicenda che vide coinvolto mio zio. Affermazioni
ingiuriose, rilanciate da alcuni organi di stampa – ha detto Navarra – Premetto
che la mia posizione su questo argomento è ben nota da tempo: si parla di
persone morte prima della mia nascita e ogni collegamento non può che
rappresentare una volgare strumentalizzazione». Con un post scriptum in cui
annunciava querele «nei confronti delle testate che daranno spazio a simili
considerazioni». Classe 1968, il messinese Navarra diventò poco meno di sei anni
fa il più giovane rettore d’Italia. Eletto ai vertici di quell’ateneo definito
“verminaio” una ventina d’anni fa, per l’influenza che secondo varie inchieste
avrebbero avuto al suo interno i boss della ‘ ndrangheta, ma anche per un certo
nepotismo esasperato. Nella Città dello Stretto, l’Università è sempre stata uno
dei capisaldi del potere. E a Navarra si guardò proprio come il possibile volto
nuovo della svolta, dopo gli scandali. Ma l’intemerata, a puntate, di Crocetta
guarda a fatti ben più antichi. E cioè alle vicende di don Michele Navarra,
medico, zio del rettore (fratello di suo padre) e boss corleonese del
dopoguerra. La sua cosca è ritenuta responsabile dell’omicidio, avvenuto nel
1948, del sindacalista Placido Rizzotto, i cui resti vennero ritrovati
sessant’anni dopo, infoibati in un precipizio. Un pastorello di tredici anni,
probabilmente testimone oculare di quel delitto, morì l’indomani nell’ospedale
di Corleone, dove lavorava il medico- boss, dopo un’iniezione, ufficialmente per
una “tossicosi” da farmaci. Michele Navarra fu ammazzato il 2 agosto del 1958,
crivellato di colpi – 94 proiettili furono trovati nel corpo – mentre tor- nava
al paese a bordo di una Fiat 1100 nera. Con lui rimase ucciso un giovane medico,
del tutto estraneo a vicende mafiose, che gli aveva dato un passaggio. Un
delitto rimasto nella storia della mafia, che segnò l’avanzata del campiere
Luciano Liggio nelle gerarchie di Cosa nostra e l’ascesa della mafia dei
“viddani” corleonesi che vent’anni dopo con Totò Riina avrebbero dettato legge
liquidando i vecchi boss palermitani. Sessant’anni sono passati dalla morte di
don Michele. Sessant’anni che in Sicilia sembrano non essere sufficienti per
ritenersi al riparo degli strali di una parte dell’antimafia in una terra dove
non solo le colpe dei padri, ma pure quelle degli zii si vorrebbero imputare ai
consanguinei. Anche se il bersaglio delle bordate, il giovane rettore, è nato
solo dieci anni dopo l’omicidio del famoso boss, percorrendo in vita una strada
ben diversa, anzi del tutto lontana, da quella dello scomodo parente. Professore
di Economia del Settore Pubblico nell’Università di Messina, Navarra ha maturato
un lungo elenco di esperienze internazionali tra la Gran Bretagna, l’Australia e
soprattutto gli Stati Uniti, tenendo lezione in molte delle più prestigiose
università americane. Il rettore era da tempo considerato vicino a Matteo Renzi.
Alle elezioni regionali di tre mesi fa buona parte della nomenclatura
universitaria messinese sostenne la candidatura del direttore generale
dell’Ateneo Francesco De Domenico, che è stato eletto nel Partito democratico
con una buona messe di voti. Ora, il salto nella politica tocca a Navarra,
secondo in lista dietro l’onnipresente Maria Elena Boschi, che è candidata
altrove e lascerà quasi certamente spazio. Con buona pace del Crocetta furioso e
delle evocazioni di spettri di sessant’anni addietro.
Restituire alla Storia i cognomi
infangati dalle mafie, scrive Valentina Tatti Tonni il
3 gennaio 2018 su "Articolo 21" e 20 Gennaio 2018 su "Antimafia duemila". Un
corto circuito. Parliamo di mafia come se fosse un soggetto e un linguaggio.
Riprendendo il libro Io non taccio scritto a più mani da giornalisti di
inchiesta, ho notato che la presenza dei nomi che associamo alle famiglie dei
clan hanno nel tempo disonorato e macchiato quei nomi stessi. L’etimologia di
mafia come di ‘ndrangheta, ha connotati regionali e si riferisce a balordi
presuntuosi travestiti da uomini che, usando metodi illeciti, interferiscono
nelle attività economiche, commerciali e sociali del luogo in cui transitano,
mettendo a repentaglio senza scrupolo la vita di chiunque si metta tra loro e
gli affari. E’ il caso di innocenti, giornalisti, magistrati, forze dell’ordine
e loro stessi a causa di guerre per il territorio, come cani che marcano il
suolo oltre ad abbaiare sparano. Il quadro italiano, secondo la mappa
interattiva consultabile grazie a “Il Fatto Quotidiano” e al Parlamento Europeo,
vede quattro principali organizzazioni criminali muoversi sullo stivale: abbiamo
la mafia, intesa come Cosa nostra in Sicilia, la camorra prevalente nelle zone
campane di Napoli e Caserta, l’ndrangheta che dalla Calabria si è spostata
anche al Nord in Lombardia, la pugliese Sacra Corona Unita. Tutte queste si
occupano principalmente di spaccio di droga, riciclaggio, estorsione e
infiltrazioni nell’economia, soprattutto tramite appalti pubblici e nel campo
dell’edilizia privata. Inoltre ad operare con i clan principali abbiamo anche
criminalità nigeriana, cinese e albanese. Il fatto che siano nate in certe
regioni non li esenta dal trafficare anche in altri luoghi, grazie anche al
sostegno con alcuni membri della politica. Non sembra essere un caso allora se
il Bel Paese sia l’unico in Europa a dotarsi di una normativa ad hoc contro
l’associazione di stampo mafioso, l’articolo 416 bis.
Rendere silenti le famiglie dei clan. Torniamo al
linguaggio della mafia per riabilitare quei nomi. Dal libro di cui sopra, inizio
dai Barbaro, facente parte all’ndrangheta calabrese molto presente in Lombardia,
Piemonte, Germania e Australia. I Barbaro ben più importanti furono però
quelli dell’alta aristocrazia veneziana che dal 1390 vantavano nel loro
entourage vescovi, commercianti ed esploratori, come quel Nicolò che scrisse
una cronaca sull’assedio di Costantinopoli nel 1453 al pari di Giosafat che ne
scrisse sull’Asia. Che dire dei Papalia, ai Barbaro collegati per ‘ndrangheta,
ma ben lontani nella Storia essendo stati estratti dalla nobiltà calabrese in
principio legata, sembrerebbe, al marchesato di Saluzzo in Piemonte. Andando
avanti troviamo i Brandimarte di Gioia Tauro e la faida aperta con i Priolo in
quel di Vittoria in Sicilia, famiglie nella storia remota ben conosciute: i
primi di origine medievale furono resi famosi dalle battaglie epiche francesi
della Chanson de Roland e dal nostrano Ariosto nonché più di recente simbolo
dell’artigianato e dell’argento a Firenze, la seconda dei Priolo invece abitante
del Rinascimento veneto trovandosi un capo, un Doge, della Repubblica. In
Sicilia, nel presente, vi è anche il clan mafioso dei Carbonaro-Dominante,
appartenente alla Stidda una quinta organizzazione criminale operante
soprattutto nelle province di Ragusa, Caltanissetta, Enna e Agrigento. Sì, ma i
Carbonaro, come suggerisce il nome potrebbero derivare sia dalla Carboneria,
quale società rivoluzionaria e liberale ottocentesca nata nel Regno di Napoli,
sia dal carbonaio come mestiere di trasformazione della legna in carbone
vegetale, Carbonaro-Dominante legato a Ventura, come il suo boss, cognome
risalente al medioevo cristiano. Li conosciamo con questi cognomi che sembrano
fare la Storia, ma la nostra Storia è un’altra. Grazie a "la Spia" sappiamo
che: “Stidda e Cosa Nostra si dividono gli affari locali, la ‘Ndrangheta
gestisce la cocaina e la Camorra (sarebbe più giusto parlare dei Casalesi)
gestiscono i trasporti”. Casalesi, un altro nome balzato alle cronache a causa
dei fatti e dei misfatti ad essi collegati e a Schiavone anche, il boss,
derivante dagli slavi che seguita la rotta dei longobardi arrivarono dal fiume
Natisone nel Friuli Venezia Giulia. Un’altra famiglia che ha infranto i valori
della società civile è senz’altro la Bottaro-Attanasio, forte della sua prima
origine di “fabbricante di botti” e della seconda dell’immortale che si è
illuso di dare il nome a tutta la Sicilia greca che conta - tolte le persone
perbene -, quella di Siracusa. Nonché i Corleonesi, sui quali ha avuto
interesse persino l’industria del cinema producendo pellicole narranti di
padrini più eroi che padroni. Una cosca formata all’interno di Cosa nostra
negli anni Settanta e appoggiata dalle famiglie Liggio, Riina e Provenzano, il
superficiale per origine, la mancata Regina e un Provenzano Salvani di Siena che
un giorno rinvenne in una casa della Contrada della Giraffa e lì, meta di
pellegrinaggio, una Madonna ancora porta il suo nome. Poi ci sono gli
imprenditori Cavallotti che cercano invano di minare il radicalismo del primo
Felice. Ai Corleonesi alleati i Cuntrera-Caruana, di Siculiana nella provincia
di Agrigento e in principio campieri, ovvero guardie private al controllo di una
tenuta agricola, nel 2013 seguendo le orme della Banda della Magliana si
impadronirono, insieme ai fratelli Triassi, del litorale di Ostia. Triassi,
d’origine una nobile famiglia spagnola che avrebbe guidato la conquista di
Mallora, secondo le ultime cronache, avrebbe una certa comunanza (di complicità
e rivalità) con i Fasciani e gli Spada. E a loro volta gli Spada e i Casalesi
con i Casamonica, una famiglia dall’Abruzzo da tempo operante nella zona dei
Castelli Romani, castelli senza più neanche un cavaliere. Dall’ndrangheta di
Morabito, Logiudice e Musitano alla Sacra Corona Unita dei Giannelli-Scarlino:
sconsolata la prima e più antica famiglia latina, la seconda di magistrati, la
terza di predicatori e l’ultima non piena di virtù, ormai negate da famiglie
con più facile collusione alla realtà. Infine, sempre in riferimento al libro
di cui sopra, da Napoli i Mazzarella e i Giuliano, i primi una casata nobile del
Cilento all’interno di cui si ricordano le gesta di valorosi uomini come quel
Michele che difese Malta dai Turchi nel 1565, i secondi invece dalla Spagna
trapiantati in Sicilia dal Re Federico III da Baldassarre, tale la potenza che
lo stemma della famiglia ritraeva un leone con due rose a dimostrar forza e
delicatezza, oggi anch’essa ormai sopita. Appare mitigata la bellezza in cambio
dell’omertà, ma forse no, il faro è ora acceso.
I giornalisti e la politica,
scrive Augusto Bassi il 3 febbraio 2018 su "Il Giornale". Gianluigi Paragone,
Tommaso Cerno, Giorgio Mulè, Emilio Carelli, Francesca Barra, Primo Di Nicola
sono i più illustri giornalisti che saranno candidati alle elezione del 4 marzo
prossimo, trasversalmente, fra partiti e movimenti, fra forze conservatrici e
riformiste. Una presenza in quantità e di qualità che non rappresenta tuttavia
una rottura con il passato, quanto piuttosto la conferma di una
interscambiabilità naturale fra l’impresa giornalistica e quella politica. Prima
di loro c’erano stati, fra gli altri, Eugenio Scalfari, Michele Santoro,
Dietlinde Gruber, Antonio Polito. E su questo tema mi era capitato di ascoltare
una tavola rotonda del Parlamento Europeo dove intervenivano Antonio Tajani,
David Maria Sassoli e Silvia Costa, anch’essi autorevoli ex giornalisti in
seguito protagonisti ai più alti livelli di istituzioni sovranazionali. In
questi giorni ho seguito con attenzione le testimonianze degli ex colleghi
pronti al governo della comunità, invitati nei salotti televisivi a raccontare
le ragioni di questa scelta. Così come ho letto le opinioni dei futuri elettori,
ondeggianti fra convinto supporto e accuse di servilismo premiato. Ora, premetto
che non ritengo deprecabile che un giornalista scenda, o salga, in politica.
L’esercizio dell’obiettività, della neutralità, dell’imparzialità… è già di per
sè ideologia. Ne abbiamo avuto manifesta testimonianza nell’ultima puntata di
Piazza Pulita, dove Corrado Formigli – campione di quel giornalismo che pretende
di raccontare i fatti, la realtà, senza filtri – ha mostrato una volta di più
faziosità subdola quanto palmare. Vittorio Sgarbi gli ha levato la pelle con
nevrosi chirurgica, lasciando all’osservatore il macabro spettacolo della
crudité di un filisteo. Ma se è facile togliere la maschera al sedicente super
partes, più difficile è prendere coscienza dell’inevitabilità di una
dichiarazione, anche nel momento in cui la si rifiuta. Il giornalista non è un
aruspice che legge le interiora degli animali, ma neppure un reporter. Il suo
compito, in particolare nel tempo dell’immediatezza universale, non è quello di
scattare l’istantanea del reale, che è comunque irriducibilmente parziale e
soggettiva anche in un reportage. Non serve impegnarsi nel vano sforzo della
terzietà. Deve piuttosto essere in grado di abdurre: ovvero di osservare i fatti
come qualcosa di correlato, ipotizzandone le cause al fine di prevedere altri
fatti, di scommettere sulle conseguenze, di condurre chi legge da ciò che è a
ciò che sarà. Di pensare in maniera non lineare e post-convenzionale allargando
l’orizzonte critico. Mentre il mondo è pieno di giornalisti che dopo sapevano
tutto prima. Quando si parla un poco pretenziosamente di “ricerca della verità”,
si intercetta la volontà buona di chi intende abdurre solo dopo essersi ripulito
da incrostazioni ideologiche, farisaiche, opportunistiche. Questo è il massimo
della professionalità che ci è concesso. Da lì in avanti si procede rendendo
sempre maggiormente manifesta la propria idea di buona vita, chiarendo che cosa
si ritiene auspicabile e che cosa nocivo. E in quel momento si fa politica,
ovvero si interviene sulla realtà nella speranza di modificarla. I lettori
rappresentano gli elettori e si conquistano con la lealtà e la lucidità.
Escludendo i solipsismi, ogni pubblica rivendicazione morale è un’affermazione
politica. Se un editorialista racconta i mali dell’Italia, dolendosene, fa
politica, perché esprime implicitamente la sua idea di come l’Italia dovrebbe
essere. Se in buona fede intercetta i responsabili, fa politica, perché
costringe la politica stessa a correggersi. Per questo esiste un continuum
naturale fra le due funzioni, fra le due dimensioni, e un equilibrio necessario.
Ciò che si evince, per converso, è la buffoneria di quei colleghi che ostentano
neutralità, obiettività, quasi come se le loro opinioni cadessero direttamente
dalla navicella spaziale di John Rawls, per poi ritrovarli anni dopo schierati
in una lista a sventolare bandierine. Paragone ha dichiarato: «Sono sempre stato
un giornalista di parte, quindi non credo di presentarmi in una veste diversa.
Ero già un attore politico. Non escludo dunque neppure di tornare a fare il
giornalista. Mi considero come una sorta di inviato speciale nel Palazzo…».
Vero. Anche se la parte è cambiata. Ma qui è possibile osservare il percorso di
ciascuno e pesarne l’integrità. Nulla vieta di rimanere delusi da un partito e
trovare comunanza di vedute con un altro, magari nuovo. Cerno confessa: «Ero
stanco di fischiare dalle tribune, volevo scendere in campo e provare a
segnare». Poi aggiunge: «L’imparzialità nasce dal pluralismo delle voci, non da
una singola voce. Mi piace la parola partito perché significa prendere parte».
Tutto legittimo. Anche quando si sceglie tragicamente di prendere parte al
Partito Democratico. Cionondimeno, vorrei chiarire che cosa mi ha spinto a
commentare. Nella totalità di questi interventi, testimonianze, confessioni, di
oggi e di ieri, da ex colleghi e possibili riferimenti istituzionali, non ho
sentito una sola parola sul futuro dell’informazione. Non una riflessione sulla
professione che lasciano. Sull’epocale transizione digitale, fra i media intesi
come medium circoscritto e regolamentato e il riconoscimento di ogni smartphone
come strumento di comunicazione di massa. Sul delirante dibattito relativo alle
fake news. Su come garantire l’indipendenza dell’informazione dalla politica
proprio in virtù di una così stretta affinità di inclinazioni e intenti. E
dall’economia sovranazionale, verso cui la politica nazionale stessa è in
posizione sempre più ancillare. Silenzio. Compito del giornalismo oggi, urgente
come mai prima, è la negazione dell’automatismo. La negazione di una verità
immediatamente alienata. La negazione di una verità immediatamente manipolata.
La negazione di ogni superstizione ideologica e del pensiero mercantile di
dominio. La negazione dell’inevitabilità del reale. Il giornalista fa politica
sorvegliando la politica. Vigilando sulla politica. Pungolando la politica.
Potendo avvalersi di quella distanza dal potere rivendicata da Montanelli. Ma se
i migliori giornalisti abbandonano la propria funzione per diventare politici
stricto sensu, quis custodiet ispos custodes?
Giornalisti contro avvocati: «Vietato
criticarci», scrive Giulia Merlo il 23 gennaio 2018 su
"Il Dubbio". Fnsi, il sindacato dei giornalisti, attacca l’Osservatorio
sull’informazione giudiziaria della Camera penale di Modena che replica:
«Travisamento della notizia che offende la classe forense». Accetta di definirlo
un «fraintendimento». Da penalista, però, specifica che il fraintendimento da
parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana «si colloca tra la colpa
grave e il dolo eventuale». La Camera Penale di Modena, per voce del suo
presidente, Guido Sola, è al centro di una polemica al vetriolo proprio con la
Fnsi e l’Ordine dei Giornalisti, ragione del contendere: la creazione
dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria (iniziativa già in atto da due
anni a livello nazionale, promossa dall’Unione Camere Penali italiane con la
pubblicazione del Libro Bianco sull’informazione giudiziaria). Il
“fraintendimento” è nato dopo l’annuncio della Camera Penale di Modena della
costituzione dell’Osservatorio: «La cronaca giudiziaria ed i temi della
giustizia hanno assunto negli ultimi tempi un interesse sempre maggiore da parte
dell’opinione pubblica, tanto che da alcuni anni gli addetti ai lavori ed anche
esperti di psicologia e sociologia si stanno interrogando sugli effetti
distorsivi dei cosiddetti “processi mediatici”», si legge nel comunicato. E
ancora, «l’informazione spesso diventa strumento dell’accusa per ottenere
consensi e così inevitabilmente condizionare l’opinione pubblica e di
conseguenza il giudicante: pensiamo ad esempio a quanto accaduto nel processo
“Aemilia” allorché, pochi giorni dopo gli arresti, prima ancora delle decisioni
del tribunale del riesame, è stato pubblicato e diffuso un libro che riportava
fedelmente, quasi integralmente, il contenuto della misura cautelare con atti
che dovevano rimanere segretati». Proprio questo passaggio ha scatenato la
reazione del sindacato nazionale del giornalisti e dell’Ordine dei giornalisti
nazionale e locale, che definiscono l’iniziativa dei penalisti «inquietante» e
attaccano: «La Camera Penale di Modena fa esplicitamente riferimento al processo
“Aemilia”, in corso da oltre un anno a Reggio Emilia, che per la prima volta ha
alzato il velo sulle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna, per decenni
sottovalutate. E lo fa proprio in concomitanza con un’udienza dello stesso
processo in cui un pentito ha rivelato che, tra i progetti degli ‘ ndranghetisti
in Emilia, c’era anche quello di uccidere un giornalista scomodo. Notizia che
pare non aver toccato in maniera altrettanto significati- va la sensibilità
degli avvocati. Del resto, non è la prima volta che sindacato e Ordine dei
giornalisti sono costretti a occuparsi di intimidazioni, esplicite o velate,
fatte a chi si occupa di informare i cittadini sul processo “Aemilia”.
Ricordiamo le minacce in aula ai cronisti reggiani, le richieste dei legali
degli imputati di celebrare il processo a porte chiuse, le proteste contro i
giornalisti già manifestate da alcuni difensori alle Camere Penali di
competenza». Insomma, quella degli avvocati è un’iniziativa «dal sapore
intimidatorio» ed è «grave e inquietante che i media debbano essere messi sotto
osservazione da un organismo composto solo da avvocati». Allusioni che indignano
il presidente delle Camere Penali modenesi. «Siamo davanti ad un esempio
lampante di travisamento della notizia», ha commentato il presidente Sola, «che
offende gravemente chi ha deciso di costituire l’Osservatorio e tutta la classe
forense». Che quello tra avvocati e giornalisti sia stato o meno di un equivoco,
il fatto più grave è che «alla nostra iniziativa è stata associata una difesa
ideologica da noi mai espressa alla criminalità organizzata, identificando il
difensore con l’imputato». Come se gli avvocati “fossero” i clienti che
difendono (nel caso Aemilia, indagati per ‘ndrangheta). Al contrario, ha
spiegato Sola, l’obiettivo dell’Osservatorio è di «aprire un percorso culturale
a più livelli sul tema del bilanciamento del diritto di cronaca con il diritto
alla difesa. In particolare, il monitoraggio sull’informazione giudiziaria e
sulla politica giudiziaria verranno svolti con la finalità di organizzare un
convegno e discuterne con tutte le parti in causa». Quanto al citato processo
“Aemilia”, Sola ribadisce che «è stato citato come esempio di patologia, ma è
scontato che l’Osservatorio non nasce certo per monitorare singoli processi, per
di più ancora in corso. Aggiungo che, dal mio punto di vista, le fughe di
notizie sono una patologia che non è certo da imputare ai giornalisti ma a chi
permette che informazioni coperte da segreto trapelino illecitamente». La
polemica non è ancora chiusa e se Sola ribadisce che «sarebbe importante avere
un confronto con il mondo del giornalismo, cosa che del resto già è avvenuta
proficuamente in molte sedi», la Camera Penale sottolinea come l’accaduto
«rafforzi la convinzione che la decisione di costituire l’Osservatorio sia
quanto mai più opportuna».
Polemica penalisti-giornalisti, chi
critica diventa amico dei boss, scrive Giulia Merlo il
26 gennaio 2018 su "Il Dubbio". La polemica tra avvocati e giornalisti prosegue,
oltre quello che la Camera Penale di Modena aveva definito un «fraintendimento
della notizia, che si colloca tra la colpa grave e il dolo eventuale». La
ragione rimane la stessa, il processo Aemilia (un’inchiesta sulle infiltrazioni
mafiose in Emilia Romagna). La vicenda, già raccontata su questo giornale, è
della settimana scorsa: la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e
l’Ordine dei Giornalisti nazionale e locale hanno attaccato pesantemente
l’istituzione, presso la Camera Penale di Modena, di un Osservatorio
sull’informazione giudiziaria (sulla scia di un’iniziativa tra l’altro giù
esistente a livello nazionale da parte dell’Unione Camere Penali, che ogni anno
pubblica il Libro Bianco sull’informazione giudiziaria). I penalisti modenesi,
nell’annuncio dell’istituzione dell’Osservatorio, avevano spiegato che
«l’informazione spesso diventa strumento dell’accusa per ottenere consensi e
così inevitabilmente condizionare l’opinione pubblica e di conseguenza il
giudicante: pensiamo ad esempio a quanto accaduto nel processo “Aemilia”
allorché, pochi giorni dopo gli arresti, prima ancora delle decisioni del
tribunale del riesame, è stato pubblicato e diffuso un libro che riportava
fedelmente, quasi integralmente, il contenuto della misura cautelare con atti
che dovevano rimanere segretati». proprio questo passaggio, definito dal
presidente dei penalisti modenesi Guido Sola «esemplificativo di una patologia,
ma è scontato che l’Osservatorio non nasce certo per monitorare singoli
processi, per di più se ancora in corso», aveva mandato su tutte le furie i
giornalisti, che hanno definito «inquietante» e «dal sapore intimidatorio»
l’iniziativa, perchè annunciata «in concomitanza con un’udienza dello stesso
processo in cui un pentito ha rivelato che, tra i progetti degli ‘ndranghetisti
in Emilia, c’era anche quello di uccidere un giornalista scomodo. Del resto, non
è la prima volta che sindacato e Ordine dei giornalisti sono costretti a
occuparsi di intimidazioni, esplicite o velate, fatte a chi si occupa di
informare i cittadini sul processo “Aemilia”». La Camera Penale modenese, che ha
incassato il sostegno dell’Unione Camere Penali, dell’ordine degli avvocati di
Modena e della Camera Penale di Reggio Emilia, ha risposto sul punto,
sottolineando come «alla nostra iniziativa è stata associata una difesa
ideologica da noi mai espressa alla criminalità organizzata, identificando il
difensore con l’imputato». Il presidente della Camera Penale di Reggio Emilia,
Nicola Tria, ha inoltre fatto sapere che anche il suo direttivo istituirà un
Osservatorio locale sull’informazione giudiziaria, «non per intimidire
chicchessia, ma semplicemente per monitorare i meccanismi della comunicazione e
misurarli alla luce dei principi costituzionali» e ha offerto di organizzare a
Reggio Emilia un convegno con avvocati, magistrati e giornalisti, per «ragionare
insieme sulle criticità».
La polemica ha infiammato la discussione per
alcuni giorni e si è arricchita di un ulteriore tassello proprio ieri, quando è
andato in onda sul Tg3 locale un servizio sul processo Aemilia. Nel servizio, è
stata data notizia del fermo di un indagato e, dalle pagine del decreto di fermo
della Dda di Bologna è emerso che, attraverso un avvocato, l’uomo avrebbe
introdotto in carcere due chiavette usb a fini intimidatori. Nella chiosa, però,
è stato fatto chiaro riferimento all’Osservatorio delle Camere Penali: «Proprio
in questi giorni la Camera Penale di Modena e quella di Reggio Emilia hanno
annunciato di voler monitorare l’informazione giudiziaria, in particolare sul
processo Aemilia e, alla luce di quando indicato nel decreto della procura di
Bologna, ci sarebbe quasi da sorridere, ma a far riflettere è il fatto che con
le informazioni ricevute in cella gli imputati siano poi riusciti a condizionare
alcune testimonianze». Immediata la reazione degli avvocati. «Fare giornalismo
non significa approfittarsi del potere mediatico per travisare le notizie.
Ironizzare sull’iniziativa dell’avvocatura significa gratuitamente offendere
l’intera categoria», hanno dichiarato Sola, Tria e il responsabile
dell’Osservatorio, Alessandro Sivelli. I tre hanno ribadito come l’Osservatorio
sull’informazione giudiziaria non nasca affatto in relazione all’inchiesta
Aemilia ma, soprattutto, come sia assurdo collegare l’iniziativa con un fatto di
reato («e gli avvocati, ammesso che siano indagati, sarebbero comunque presunti
innocenti») che nulla ha a che vedere con l’attività delle Camere Penali. In
effetti, questo lascerebbero intuire le parole del giornalista. Come se
l’Osservatorio nascesse per intimidire i giornalisti, in concomitanza con
l’ipotesi di reato di un avvocato. Tuttavia, gli avvocati hanno deciso di non
sporgere querela per diffamazione nè di chiedere rettifiche, «perchè anni di
professione hanno insegnato che chiedere la rettifica di notizie diffamatorie
non provoca altro che ulteriore diffamazione». «Non abbiamo alcuna intenzione di
rinfocolare una polemica», ha commentato Sola, il quale ha anticipato di aver
già invitato, in accordo con la Camera Penale di Reggio Emilia, il presidente
dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, Giovanni Rossi, ad un confronto
pubblico su quanto sta accadendo, «per urlare con forza che l’informazione va
difesa, ma che la stessa non consente di ingiuriare chiunque e di svolgere
processi mediatici senza contraddittorio».
Avvocati contro giornalisti? Una falsità
Il nostro obiettivo è il processo mediatico, scrive il
31 gennaio 2018 "Il Dubbio". Dopo lo scontro tra penalisti modenesi e ordine dei
giornalisti, un nuovo attacco da parte del Fatto Quotidiano e di Articolo 21.
Nei giorni scorsi il direttore Sansonetti si è già occupato della polemica
sollevata dall’Ordine dei giornalisti sulla istituzione degli Osservatori sulla
informazione giudiziaria degli avvocati penalisti modenesi, accusati di voler
esercitare una forma di censura sulla stampa e di volersi asseritamente occupare
di “screditare” il processo “Aemilia”. La polemica, tuttavia, non si è
stemperata, e con un articolo on line del 30 gennaio, Il Fatto Quotidiano e un
intervento sul blog di “Articolo 21”, si torna alla carica con titoli che già
dicono tutto: “Gli avvocati controllano i giornalisti”. Nei brani, ancora una
volta, previa la identificazione tra avvocati e loro assistiti propria di
concezioni culturali autoritarie, si tornano ad accusare i legali di voler
intimidire la stampa, di voler limitare il diritto di cronaca e di denunciare
solo i casi di processi relativi a imputati ricchi, o potenti, o legati alla
criminalità. E, stavolta, viene chiamato in causa anche l’Osservatorio nazionale
sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali italiane ed il libro
bianco sull’informazione giudiziaria italiana, pubblicato con il controllo
scientifico dell’Università di Bologna. Si reiterano poi le accuse ai legali di
Modena e Reggio Emilia di voler usare strumentalmente gli osservatori per
condizionare il processo Aemilia. Ferme restando le puntuali risposte già date
dai colleghi emiliani e dal presidente Ucpi Migliucci e pubblicate
dal Dubbio, quello che è davvero preoccupante (per chi dovrebbe fornire una
informazione imparziale anche se riguarda la propria categoria) è la
strumentalizzazione ed il travisamento delle altrui posizioni e la lettura
distorta del libro bianco. Questa pubblicazione ha esaminato, su 25 quotidiani
italiani, circa 8000 articoli di cronaca giudiziaria in sei mesi: articoli che
riguardavano ogni tipologia di processo (per intenderci, anche quelli ai “poveri
cristi”), raccogliendo dati che – seppure opinabili e discutibili come tutti –
hanno consentito una lettura di politica giudiziaria sulla quale si è chiesto un
confronto leale con i giornalisti. Confronto che in questi ultimi anni vi è
stato (il libro è stato presentato in numerose città, presso diverse Università
ed in altre sedi pubbliche: sempre invitando giornalisti e dando luogo a un
dibattito anche acceso ma sempre civile). Il libro bianco propone certamente una
tesi polemica: le risultanze della ricerca hanno dato conferma che, con le
dovute e rispettabili eccezioni, l’impostazione delle cronache giudiziarie è
quasi totalmente appiattita sulle tesi dell’accusa e sulla fase delle indagini
preliminari e di polizia; lo spazio dato alla difesa è percentualmente
irrisorio; le notizie pubblicate provengono in percentuale bulgara dall’accusa;
le pubblicazioni avvengono molto spesso in violazione del disposto di due norme
del codice ( 114 II co. e 329 c. p. p.) che vietano di riprodurre la testualità
di atti processuali anche quando è venuto meno il segreto; le “fughe” di notizie
comportano che spesso i legali apprendano notizie ed atti prima dalla stampa che
nelle sedi processuali; l’immagine di chi è sottoposto al processo è
“mascariata” prima ed a prescindere dal processo. E il tratto più preoccupante
ed evidente è lo stabilirsi di un asse tra investigatori e informatori
destinato, volontariamente o meno, a condizionare o a rischiare di condizionare
gli sviluppi del processo (si pensi a testimoni che depongono dopo mesi di
bombardamento mediatico e agli stessi giudici: proprio ieri, sul Dubbio, il
presidente del Tribunale di Torino, non un avvocato “prezzolato”, ha denunciato
il pericolo di un giudice preoccupato di assumere decisioni “impopolari”). Detto
questo, non si pretende ovviamente che questa analisi sia accolta con
entusiasmo, ma che almeno non sia stravolta: è falso, gravemente falso, che i
penalisti vogliano limitare il diritto di cronaca ed è preoccupante che si
assuma essere impossibile criticare il mondo dell’informazione giudiziaria: se
“Articolo 21” ha letto il libro bianco troverà, contrariamente a quanto afferma,
più volte richiamata la sacertà della libera manifestazione della critica
giornalistica; se ha letto i documenti dell’Osservatorio, troverà anche quelli a
difesa del segreto professionale dei giornalisti ( mentre questi ultimi appaiono
indifferenti alle violazioni di quello degli avvocati). E troverà anche spunti
fortemente critici verso quegli avvocati che fanno strame del loro ruolo
partecipando ai “processi mediatici” televisivi. Ed allora, posto che un
confronto si impone senza toni ( quelli sì) intimidatori, per una volta
l’informazione giudiziaria – o almeno quella che assume queste posizioni – si
interroghi anche su sé stessa, al di là delle norme di legge: sul rapporto con
le proprie fonti investigative; sull’assenza di spirito critico verso le
prospettazioni accusatorie; sulla necessità di rispettare la presunzione di
innocenza; sulla impostazione che viene data alle notizie, ai titoli, alle
decisioni assolutorie che vengono considerate “spreco di indagini”. E quanto
all’accusa che ci viene rivolta di occuparci solo dei potenti, per una volta,
completi il proprio compito informativo: si vada a documentare sulle battaglie
storiche dell’Unione delle camere penali sui diritti dei migranti, sui processi
agli stranieri, sulle denunce sui Cie, sul rispetto delle regole in ogni
processo, chiunque sia accusato. Chè solo in Italia ricorre l’equivoco che “il
potere” sia solo la politica, e che la magistratura sia il “contropotere”.
L’intimidazione di Repubblica agli
avvocati: «Dovete tacere», scrive Piero Sansonetti l'1
Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Il processo mediatico. Il titolo, a tutta pagina,
dice così: «I legali dei boss processano i cronisti ». Non è il titolo di un
fogliaccio di propaganda populista ma del più importante giornale della
borghesia moderna, progressista e illuminata, e cioè Repubblica. Il giornale
erede del grande pensiero liberale, della grande tradizione giornalistica laica
e democratica, di Mario Pannunzio, di Arrigo Benedetti, di Scalfari. Il titolo
si riferisce a una iniziativa della Camera penale di Modena, che ha istituito un
osservatorio sull’informazione giudiziaria. Questo osservatorio nasce dopo la
pubblicazione di un libro bianco, realizzato a livello nazionale dall’Unione
Camere penali con la collaborazione dell’Università di Bologna. Da questo libro
bianco risulta, sulla base di dati statistici, che l’informazione giudiziaria
italiana è assolutamente dipendente dall’accusa e dalle procure, e trascura,
quasi nega, l’esistenza della difesa e delle sue argomentazioni. Il titolo
di Repubblica denuncia la nascita di questo osservatorio che considera una
intimidazione alla libertà di stampa. Analizziamo prima bene il titolo, poi
parliamo dell’intimidazione. Il titolo poteva essere fatto in vari modi. Ad
esempio: «Gli avvocati mettono sotto osservazione i giornali». Sarebbe stato un
titolo molto oggettivo. Oppure si poteva fare un titolo malizioso: «Gli avvocati
processano i giornali». Malizioso – per l’uso della parola “processano” – ma non
arrogante. Invece, nel titolo che si è scelto, i giornali sono diventati “i
cronisti”, con una evidente forzatura della realtà (la critica delle Camere
penali è ai giornali, non ai singoli cronisti). E soprattutto gli avvocati sono
diventati, nel titolo, «i legali dei boss». Scompare la parola avvocato, che ha
un sapore nobile, alto, e compare la parola boss. “Legali dei boss”, in
sostanza, allude a una dipendenza del legale dal boss. E dunque, oggettivamente,
a una mafiosità dell’avvocato. Il quale, oltretutto, paradossalmente vorrebbe
ribaltare lo stato di diritto e, invece di accettare di sottoporsi al processo,
pretende di essere lui l’accusatore. Ora forse sarebbe necessario spiegare bene
cos’è questo libro bianco e cos’è questo osservatorio, e come né l’uno né
l’altro hanno nessun intento “accusatorio”, ma solo di analisi. Questa
spiegazione però, molto dettagliata, l’ha fornita sul Dubbio di ieri l’avvocato
Renato Borzone. A me invece interessa qui ragionare un momento su questa
sbandata giustizialista di uno dei più importanti giornali italiani. E
sull’accusa di intimidazione rivolta agli avvocati. Conosco il direttore
di Repubblica e molti suoi giornalisti. Conosco la loro cultura, e in
particolare la cultura di Mario Calabresi, il suo pensiero ispirato ai valori
della democrazia, della libertà e dello Stato di diritto. Perciò mi rivolgo
proprio a lui per porre questa domanda: se anche Repubblica finisce travolta
dalla tendenza di trasformare la giustizia in giustizia sommaria, l’accusa in
giudizio, l’imputato in colpevole e l’avvocato in sodale dei delinquenti, e cioè
di trasformare il diritto in autoritarismo e lo stato di diritto in stato
autoritario, o stato etico, o stato dei “migliori”, non credi che la democrazia
corra un rischio grandissimo? Io sono convinto che oggi sia aperta una battaglia
decisiva per il futuro della modernità, e della stessa civiltà, e che questa
battaglia sia tra chi vuole mettere al centro di tutto il diritto e chi invece
pensa che il diritto sia antimoderno, e francamente non capisco come si possa
combattere questa battaglia senza l’aiuto delle roccaforti della cultura
liberale, e quindi senza l’aiuto di un grande giornale come Repubblica.
L’attacco agli avvocati di Modena, descritti come dei “mantenuti” dai boss
veramente è preoccupante. È una vera e propria intimidazione, insopportabile, un
attacco costruito su una cultura della giustizia nella quale il diritto di
difesa è visto come un lusso. Nell’articolo si parla, testualmente di «avvocati
retribuiti per difendere clienti del giro della cosca della ‘ndrangheta
d’Emilia». Capite che questo è un linguaggio inaccettabile, che tradisce una
cultura giuridica davvero rasoterra, e che assomiglia al lessico che si usava
tra i questurini della Repubblica di Salò? A nessuno può venire seriamente in
mente che l’iniziativa pubblica di una organizzazione di avvocati, che tende a
ristabilire la cultura del diritto, possa essere una intimidazione. Gli
avvocati, sì, con questa iniziativa hanno indicato il rischio del processo
mediatico. Ma non c’è bisogno di immaginare che lo abbiano fatto perchè sono
venduti ai mafiosi. Questo rischio è stato indicato, prima che dagli avvocati,
nell’ordine (per fare pochissimi esempi) dal Presidente della Repubblica, dal
procuratore generale della Cassazione Canzio, dal suo successore Mammone, da
almeno una decina di Procuratori delle grandi città, a partire da Roma
(Pignatone) e ancora l’altro giorno, sul Dubbio, dal presidente del Tribunale di
Torino. C’è una parte molto grande della magistratura che ha chiarissimo il
rischio che il processo mediatico travolga la nostra giurisdizione. Con enormi
danni. Pericolo molto chiaro anche all’avvocatura. Possibile che il giornalismo
italiano sia così indietro, sul piano culturale, rispetto alle altre
professioni? Possibile che non si renda conto che il suo compito non è quello di
ricopiare le informative dei carabinieri o le requisitorie dei Pm, ma quello di
criticare, dubitare, indagare, ricercare? E anche quello di discutere, insieme
ai protagonisti della giurisdizione, su come si possa ristabilire il diritto e
fermare l’obbrobrio dei processi mediatici? Se i giornalisti riusciranno o no a
risollevarsi, a rientrare nella dignità della loro professione, ovviamente non
può dipendere solamente dal coraggio, o dalla cultura, o dell’anticonformismo
dei singoli cronisti. Dipende dalle proprietà e dalle direzioni dei giornali,
dalla Fnsi, dall’Ordine. Tutti soggetti che fin qui hanno preferito mettere il
mercato, o il corporativismo, o la subordinazione a qualche Procura, al di sopra
della propria dignità culturale. Sarà ora di invertire la tendenza? È
immaginabile una inversione di tendenza senza l’impegno di “colossi” come
Repubblica?
Ma insomma, Errani è un farabutto o no?
Scrive Piero Sansonetti il 2 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Travaglio ci ripensa,
ritira il fango e diventa garantista. Non c’è niente da fare: se volete trovare
un forcaiolo vero, a 24 carati, coerente, ferreo, dovete per forza rivolgervi a
Davigo. Lui sì che è stato mandato da Dio, e non vacilla mai, ed è
incorruttibile. Lui e lui solo. Tutti gli altri nascondono un lato perverso,
garantista o addirittura perdoni- sta. Compreso il capo dei capi dei
giustizialisti, il Savonarola per eccellenza, l’accusatore, il colpevolista, il
Viscinski del terzo millennio: Marco Travaglio. Ieri ha scritto sul “Fatto” un
editoriale quasi tutto molto travagliano. Nel quale, come è sua abitudine, dà
dello stragista a Berlusconi, dell’imbecille a Prodi, dello stalinista a Renzi,
dell’ipocrita a quasi tutti i corrispondenti dei giornali esteri. Stragista a
Berlusconi è testuale, le altre qualifiche sono solo sottintese. E però poi
prende una paurosa sbandata. Scrive così: «Il professore (Prodi, ndr) a Bologna
dovrà votare Casini… contro una figura storica del centrosinistra bolognese come
Vasco Errani». Stupore del lettore. Vasco Errani?? Vasco Errani sarebbe una
icona della grande politica e della sinistra, di fronte alla quale un elettore
non può fare altro che inchinarsi? Ma, ma, ma… Andiamo a vedere cosa scriveva
Marco Travaglio, meno di due anni fa, di questo Vasco Errani. C’è un articolo
dell’agosto del 2017 che è intitolato così: «Errani humanum est, perseverare
diaboliucum». E porta la firma di Travaglio. Ne trascrivo solo qualche riga:
«Vasco Errani commissario alla ricostruzione. É stato assolto, ma è proprio
il caso di nominare un ex governatore che finanziò la coop di suo fratello?». Un
paio di mesi prima invece era uscito un articolo intitolato «La combriccola del
Vasco». Anche qui trascrivo qualche riga: «Nel 2006 la giunta di Vasco Errani
regala 1 milione di euro alla coop rossa Terremerse presieduta da suo fratello
Giovanni per un nuovo stabilimento enologico a Imola che risulta già costruito.
Un bel conflitto d’interessi, direbbe la combriccola del Vasco se al posto suo
ci fosse Berlusconi o qualcuno dei suoi. Invece tutti zitti. Anche quando si
scopre che la cantina finanziata dalla Regione non è stata costruita, dunque a
quei fondi pubblici non aveva diritto». Voi direte: d’accordo, però dopo quegli
articoli Errani fu assolto, e ora Travaglio ne prende atto e lo riabilita.
Nient’affatto: quegli articoli sono stati scritti dopo l’assoluzione. E
Travaglio riuscì a spiegare come l’assoluzione non valeva niente, perché
comunque Errani forse era colpevole. Scriveva così: « Non solo un pm, ma tre
giudici di primo appello e cinque di Cassazione, oltre a tre procuratori
generali, hanno attestato che il processo andava fatto… Resta da capire se i
fatti addebitati a Errani, giudicati delittuosi da alcuni giudici e penalmente
irrilevanti da altri ( che, avendo l’ultima parola, hanno ragione per
convenzione, non per scienza infusa) siano compatibili con la santificazione, o
se invece siano almeno politicamente disdicevoli» Ora, come per miracolo, Errani
diventa un gigante della sinistra. E Casini invotabile, sebbene Casini, in
realtà, sia uno dei pochissimi esponenti della prima Repubblica a non aver mai
avuto guai con la giustizia. Tanto che se si dovessero rispettare le idee del
partito di Travaglio – onestà, onestà! – uno non potrebbe fare altro che
votarlo. Detto questo vorrei spiegare bene una cosa. Errani è innocente, è stato
dichiarato innocente, è una persona rispettabilissima, un dirigente politico di
grande valore e con alle spalle una storia robusta. Caso abbastanza raro,
peraltro, nella classe politica di oggi, dominata dai 5 Stelle e da vari cloni o
imitatori. Sono convinto che chi lo voterà non si pentirà. Il problema non è
Errani, è la fragilità del giustizialismo. La mia su Davigo non era una battuta.
Le sue idee mi terrorizzano, penso che siano lontanissime dalle idee di un
liberale, che siano incompatibili con una società basata sul diritto e sulla
democrazia. Però provo un sentimento di grande rispetto per Davigo, perché non
posso non riconoscere la sua coerenza. Il giustizialismo di Davigo è un
principio formidabile, ferreo, non è lo strumento, agile e pieghevole, per una
battaglia politica. È un caso unico. Lo stesso Travaglio vive il giustizialismo
solo come una occasione per scagliarsi contro gli avversari. Lo sospende,
naturalmente, se le vittime del giustizialismo sono i 5 Stelle, ma lo sospende
persino con Errani, dopo aver rovesciato fango su di lui, se esaltare Errani può
essere utile per polemizzare con Prodi o con Renzi. Devo dire, per onestà, anche
un’altra cosa. Purtroppo, molto spesso, anche il garantismo è oscillante. E
proprio per questo è debole, non riesce ad assumere la posizione che gli
spetterebbe nel dibattito politico. Troppe volte viene usato solo come scudo per
i propri amici. E poi viene smentito immediatamente se smentirlo può servire a
colpire gli avversari. Quante volte ho sentito esaltare il garantismo e poi
dire: «Buttate la chiave…». Mi viene in mente Salvini, per esempio, ma mica solo
lui.
«I processi in tv ormai rischiano di
sostituire noi giudici», scrive Errico Novi il 30
gennaio 2018 su "Il Dubbio". Inizia tutto con Tangentopoli? «No, guardi, io
credo che siamo di fronte a un salto degenerativo: durante Tangentopoli sulle
prime pagine c’erano i pm, ora a essere oggetto di una vera e propria gogna, e
altre volte di eccessivo plauso, è la decisione del giudice. Pericolosissimo.
Anche perché si corre il rischio di un paradossale slittamento della giustizia
dal luogo propriamente assegnatole a quello improprio dei mass media». Massimo
Terzi, presidente del Tribunale di Torino, è uno dei magistrati che
all’inaugurazione dell’anno giudiziario non hanno scelto un terreno di gioco
facile. Il suo discorso alla cerimonia in Corte d’appello ha puntato dritto sul
rischio che «la decisione del magistrato giudicante venga ridotta a opinione
personale». E invece, ricorda al Dubbio, «l’esercizio della giurisdizione è
tutt’altra cosa da una delle tante opinioni espresse nel circuito mediatico».
I pericoli riguardano soprattutto le
assoluzioni?
«Il punto è
capire che la decisione del giudice non è un’operazione matematica. Altrimenti
potremmo tranquillamente essere sostituiti da un computer. Si tratta di un
percorso che spesso comporta un travaglio e, soprattutto quando questo travaglio
conduce a un’assoluzione, bisogna rispettarlo, nell’interesse e a garanzia di
tutti. Oltre che da questo, all’inaugurazione dell’anno giudiziario ho cercato
di mettere in guardia da un’altra deriva».
Ovvero?
«Dal rischio di
ridurre, appunto, la decisione del giudice a una delle tante opinioni della
dialettica massmediale. Dovrebbe essere chiaro che solo nel caso del magistrato
la decisone si accompagna a un’assunzione di responsabilità. E invece a volte il
rispetto di tale principio può venir meno anche tra di noi».
I magistrati a volte eccedono nel contestare la
decisione di un collega?
«Nei mezzi di
impugnazione c’è tutto lo spazio per le contestazioni di merito anche più aspre.
Io mi riferisco alle esternazioni gratuite che riguardano l’intero circuito
massmediatico e che spesso si basano su una scarsissima conoscenza degli atti.
Dopodiché, anche quando le critiche arrivano sulla base degli atti ci si
dovrebbe ricordare che l’opinione è cosa ben diversa da una decisione che cambia
la vita di qualcuno».
Il tribunale televisivo ha esautorato i
Tribunali veri e propri?
«Senta, è
chiaro che non tutte le decisioni sono inappuntabili dal punto di vista tecnico.
Ma mi pare che adesso davvero si esageri: nel circuito massmediatico tutti
diventano giudici. E ci si dimentica che il giudice vero assume una decisione
non in quanto persona fisica ma in nome del popolo italiano, e come espressione
di un determinato ufficio giudiziario, di cui è solo, per così dire,
ambasciatore».
Lei ha parlato di magistrati a rischio gogna.
«Certo,
nell’ultimo anno mi pare si sia verificato in più di un’occasione. E se è
terribile che un magistrato venga messo alla gogna è potenzialmente persino più
pericoloso il plauso, che rischia di avere effetti ancora più distorcenti».
Verso le toghe c’è la stessa sfiducia che
investe le istituzioni in generale?
«Non credo si
tratti di sfiducia ma di interessi mossi deliberatamente da qualcuno o di una
inarrestabile logica massmediale in cui esasperare i toni è conveniente. Il
meccanismo del consenso o del dissenso massmediale può essere devastante. Sembra
davvero che l’ultima parola non spetti più all’ambito processuale ma sia
devoluta all’opinione pubblica. Dio ci scampi e liberi da una giustizia che
ricerca il consenso».
Nei confronti di un gip di Reggio Emilia che ha
“osato” emanare un’ordinanza cautelare meno severa di quanto richiesto sono
state indette manifestazioni di piazza. Gli avvocati di Reggio sono stati gli
unici a difendere quel magistrato.
«Non conosco il
caso specifico ma l’esempio, da come lo riferisce, mi pare molto pertinente: le
manifestazioni costituiscono un prezioso strumento per influenzare le scelte
della politica, ma se rivolte alla funzione giurisdizionale assumono un tratto
inquietante. Anche perché il contrasto tra quanto l’opinione pubblica vorrebbe e
la decisione resa possibile dalle norme è spesso assai vistoso. Certe decisioni
possono non piacere alla gente, magari non piacciono neanche a me come persona
fisica: ma se le norme ci sono vanno rispettate. Ci sono reati in cui anche in
caso di flagranza non puoi tenere una persona in carcere. Prendersela con il
giudice in quanto persona fisica crea anche un problema di sicurezza».
C’è la medicina difensiva: avremo giudici che
per non essere linciati prenderanno le decisioni attese dalla gente?
«Le influenze
possono anche essere inconsce. D’altra parte chiunque comprende come sia
impossibile non modificare per nulla il proprio atteggiamento mentale con
cinquanta telecamere puntate addosso».
La degenerazione si supera anche con una
collaborazione sempre più intensa tra magistratura e avvocatura?
«Penso di sì.
Credo che le storture di cui parliamo richiedano senz’altro un faticoso, forse
utopistico dibattito culturale che porti a un codice deontologico massmediale.
Ma sicuramente può essere molto preziosa una comunanza di intenti tra
magistratura e avvocatura. È comprensibile come il difensore possa ritenere
utile, nell’ambito del suo mandato, rimarcare una valutazione critica sulla
decisione di un giudice, ma si tratta di un’utilità solo immediata. Alla lunga
il meccanismo che si innesca è corrosivo per l’intero sistema».
Inizia tutto con Tangentopoli, presidente
Terzi?
«Sicuramente
Tangentopoli ha impresso un’enorme accelerazione al processo che ha visto
intrecciarsi giustizia e mass media. Ma c’è una differenza sostanziale rispetto
a quanto avviene oggi: all’epoca le prime pagine erano presidiate da pubblici
ministeri. Vista la diversità dei ruoli, portare l’attenzione sulla magistratura
giudicante è un grande salto degenerativo, che si arrivi al plauso o alla gogna.
Dobbiamo trovare il modo di alzare un argine: la decisione del giudice è diversa
da un’opinione, anche da quella pur qualificata del pm, e non è accettabile che
la persona fisica che l’assume finisca sotto i riflettori».
In carcere da innocenti: ne entrano tre
ogni giorno, scrive Damiano Aliprandi il 31 gennaio
2018 su "Il Dubbio". Mille persone ogni anno ricevono un indennizzo perché sono
stati ingiustamente detenuti. È quanto emerge da uno studio elaborato dai
curatori del sito errorigiudiziari.com. Lo scorso anno si è chiuso con un
aumento dei casi di ingiusta detenzione e, di conseguenza, lo Stato ha sborsato
più soldi in indennizzi. Questo è il dato relativo al 2017 elaborato da
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, giornalisti che curano il
sito errorigiudiziari.com. Andando sullo specifico, gli autori dello studio,
elaborando gli ultimi dati disponibili del ministero dell’Economia, sono
riusciti a fare un raffronto con l’anno precedente. Il 2017 si è chiuso con un
dato in aumento sia per quanto riguarda i casi di ingiusta detenzione che hanno
toccato quota 1013, contro i 989 registrati nell’anno precedente, sia per
l’ammontare complessivo dei relativi risarcimenti che superano i 34 milioni di
euro. La città con il maggior numero di casi indennizzati è stata Catanzaro, con
158. Subito alle sue spalle c’è Roma (137) e a seguire Napoli (113), che per il
sesto anno consecutivo si conferma nei primi tre posti. Gli autori fanno notare
come nella top 10 dei centri dove è più frequente il fenomeno della ingiusta
detenzione prevalgano le città del Sud: sono infatti otto su dieci, con le sole
Roma e Milano a invertire la tendenza. Catanzaro e Roma sono anche le città in
cui lo Stato ha speso di più in risarcimenti liquidati alle vittime di ingiusta
detenzione: nel capoluogo calabrese lo scorso anno si è fatta registrare la
cifra enorme di circa 8 milioni e 900 mila euro, ben più del doppio di quanto si
è speso per i casi della Capitale (poco più di 3 milioni e 900 mila euro). Al
terzo posto Bari con indennizzi versati per oltre 3 milioni e 500 mila euro, che
scavalca Napoli, quarta in classifica con più di 2 milioni e 870 mila euro. Il
tema delle ingiuste detenzioni e degli errori giudiziari è scottante, eppure in
occasione dell’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario, il 26 gennaio in
Cassazione, non è stato nemmeno sfiorato. Come mai? Provano a rispondere
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone di errorigiudiziari.com, spiegando che le
1000 persone che finiscono in carcere ingiustamente ogni anno, e che per questo
ricevono un risarcimento, secondo giudici e procuratori costituiscono un “dato
fisiologico”, una sorta di “effetto collaterale” inevitabile di fronte alla mole
di processi penali che si celebrano ogni anno nelle aule dei tribunali italiani.
Prendendo in esame gli ultimi 25 anni, i dati complessivi risultano una
ecatombe. Dal 1992 a oggi, 26.412 persone hanno subito una ingiusta detenzione.
Per risarcirli, lo Stato ha versato complessivamente poco meno di 656 milioni di
euro. Se poi si includono anche gli errori giudiziari, il numero delle vittime
sale a 26.550, per una somma totale di 768.361.091 euro in risarcimenti versati
dal 1992 a oggi. Parliamo dunque di una media annuale di oltre 1000 casi, per
una spesa superiore ai 29 milioni di euro l’anno. I dati dei soldi sborsati
dallo Stato sono anche poco indicativi. Prendiamo ad esempio l’anno 2016: c’è
stato un brusco calo di indennizzi per ingiusta detenzione rispetto agli anni
precedenti. Quindi meno innocenti in carcere? No, il vero motivo è un altro. Lo
spiegano gli stessi esperti del ministero dell’Economia e delle Finanze: le
diminuzioni degli importi corrisposti a titolo di R. I. D. (Riparazione per
Ingiusta Detenzione) soprattutto negli ultimi anni non sono conseguenza di una
riduzione delle ordinanze, bensì della disponibilità finanziaria sui capitoli di
bilancio non adeguata. È necessario distinguere l’ingiusta detenzione dagli
errori giudiziari. Nel primo caso si fa riferimento alla detenzione subita in
via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della
condanna eventuale, mentre nel secondo si presuppone invece una condanna a cui
sia stata data esecuzione e un successivo giudizio di revisione del processo in
base a nuove prove o alla dimostrazione che la condanna è stata pronunciata in
conseguenza della falsità in atti. Nel caso di ingiusta detenzione, l’indennizzo
consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l’importo di
516.456 euro. La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo. Nel
caso dell’errore giudiziario, invece, c’è un vero e proprio risarcimento. Il
caso più eclatante di risarcimento è avvenuto esattamente un anno fa. Si tratta
del più alto risarcimento per un errore giudiziario riconosciuto in Italia. Sei
milioni e mezzo per ripagare 22 anni di carcere da innocente e circa 40 anni
vissuti con una spada di Damocle sulla propria esistenza, tra galera e attesa
delle decisioni dei giudici da Giuseppe Gullotta.
Lasciato morire in carcere per una
condanna a un anno, scrive Damiano Aliprandi il 20
Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Si chiamava Angelo Di Marco, aveva 58 anni. L’11
febbraio si è sentito male, vomitava sangue ed è stato ricoverato d’urgenza ed è
morto. Gravemente malato, da novembre scorso era detenuto nel carcere romano di
Rebibbia per scontare una pena di poco meno di un anno, ma il tribunale di
sorveglianza non solo ha vietato la concessione dell’affidamento in prova (visto
che parliamo di una condanna inferiore ai 3 anni), ha anche ritenuto che fosse
compatibile con la carcerazione. L’ 11 febbraio si è sentito male, vomitava
tantissimo sangue e solo a quel punto è stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale
Sandro Pertini. In codice rosso, operato di urgenza, l’hanno salvato in
extremis, ma poi giovedì scorso il cuore ha smesso di battere ed è morto. Si
chiamava Angelo Di Marco, aveva 58 anni, ma ne dimostrava molti di più. Un
romano che faceva una vita ai margini, dedito a piccoli reati e soffriva di
diverse patologie epatiche, compresa la cirrosi, che gli avevano compromesso
anche il cuore. Era talmente grave che, secondo una relazione medica del Sert di
Rebibbia datata 8/ 3/ 2016, le sue condizioni risultavano «mediocri,
suscettibili di peggioramento e non compatibili con il regime carcerario». La
sua è una storia emblematica che riguarda tante altre persone come lui. Secondo
quanto riferito dai volontari che l’hanno seguito sia dentro che fuori dal
carcere, Angelo era una persona che ha vissuto in un contesto ambientale
degradato, da giovanissimo era entrato nel tunnel della droga e per procurarsela
commetteva alcuni reati, da piccoli furti a spaccio. La tossicodipendenza, unito
all’alcolismo, l’ha portato in un vicolo senza uscita, sia mentale che fisico.
Eppure, negli ultimi anni, aveva chiesto aiuto. È stato seguito sia dal Sert che
dal dipartimento sanitario mentale, ma non si trovavano strutture socio
sanitarie disposte ad ospitarlo. Troppo vecchio per una comunità di recupero,
troppo giovane per una casa famiglia con persone fragili. Un continuo
rimpallarsi tra il Sert e l’azienda sanitaria locale, e se non fosse stato per
la disponibilità di alcuni volontari, sarebbe rimasto completamente da solo. Ed
effettivamente lo era, in balia dell’inconsistente gestione socio sanitaria
esterna e l’assistenza sanitaria carceraria che presenta tuttora numerose
criticità. Parliamo di un caso che Marcello Dell’Utri – stavano nello stesso
reparto G 14 di Rebibbia – ha segnalato al suo legale di Antigone Simona
Filippi. Che è stata nominata dal detenuto sua avvocata venti giorni prima che
morisse. «Quando facevo i colloqui con lui – spiega l’avvocato a Il Dubbio – si
vedeva che stava malissimo, il viso era giallo e non si reggeva più in piedi».
Stava male Angelo, ma già prima di essere condannato. Per questo, tramite un
avvocato d’ufficio, aveva richiesto l’incompatibilità, oltre alla sospensione
della pena visto la piccola entità della condanna. «Nel fascicolo di rigetto che
poi ho avuto modo di visionare – spiega sempre l’avvocata Filippi –, su due
paginette e mezzo, non c’è uno straccio di documento medico. Lo mandano in
carcere de- dicando solo due righe sul discorso della presunta compatibilità con
il carcere».
In sostanza, il tribunale di sorveglianza non ha
ritenuto di acquisire documenti che certificavano il suo stato di salute. Per i
magistrati, Angelo Di Marco poteva senza dubbio essere curato in carcere. La
mattina di domenica 11 febbraio, Angelo si sente male e gli esce dalla bocca un
po’ di sangue, ma – secondo quanto ricostruito dai sui compagni di sezione – per
i medici che l’hanno visitato la cosa non desta allarme. Il pomeriggio, però,
comincia a peggiorare vomitando nuovamente sangue, ma così tanto da riempire un
secchio. Gli stessi detenuti dell’infermeria hanno cominciato a protestare per
chiedere soccorsi. Solo a quel punto viene trasportato di urgenza all’ospedale e
lo operano. Uscito dalla camera operatoria, lo hanno allettato nel reparto
ospedaliero civile, con tanto di piantoni. L’avvocato Simona Filippi, nel
frattempo, alla luce di quello che era successo, è riuscita a fissare un’udienza
urgente con il tribunale di sorveglianza. Ma oramai era troppo tardi. Dopo pochi
giorni Angelo muore, in solitudine, in un letto di ospedale.
Il procuratore scopre la gogna: «Io,
sbattuto in prima pagina…», scrive Davide Varì l'8
Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Lo sfogo del magistrato di Brescia Tommaso
Buonanno dopo l’arresto del figlio Gianmarco per rapina a mano armata. «Viviamo
in uno stato di diritto dove la responsabilità penale è personale. Mio figlio
risponderà dei fatti che gli sono contestati, ma io sono stato sbattuto in prima
pagina anche se non ho fatto nulla». Sono giorni difficili per il procuratore
capo di Brescia Tommaso Buonanno. Chi lo ha incontrato parla di un uomo provato,
schiacciato tra la professione di magistrato e il ruolo di padre. La mazzata è
arrivata lunedì scorso, giorno in cui il Gip di Bergamo ha chiesto l’arresto di
suo figlio Gianmarco, accusato di rapina a mano armata. E contro Tommaso
Buonanno si è subito messa in moto la macchina della gogna che ha convinto il
procuratore a prendere un periodo “riposo” perché, dice: «Voglio stare vicino a
mio figlio». Chi lo ha incontrato parla di un uomo provato, schiacciato tra la
professione di magistrato e il suo ruolo di padre. Sono giorni molto difficili
per il procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno. La mazzata è arrivata
lunedì scorso, giorno in cui il Gip di Bergamo ha chiesto l’arresto di suo
figlio Gianmarco, accusato niente meno che di rapina a mano armata. Il figlio
del procuratore avrebbe infatti assaltato un supermercato Conad armato di mitra.
Valore del colpo: 12mila euro. Ma le videocamere avrebbero fotografato la targa
della sua auto, peraltro intestata al padre. Di lì al momento dell’arresto sono
passate poche ore. E poco dopo il procuratore ha fatto sapere di voler lasciare
il suo lavoro per un lungo periodo. «Mi metto in ferie per stare vicino a mio
figlio» avrebbe confessato. E poi lo sfogo, raccolto dal Corriere di
Brescia: «Sono stato sbattuto in prima pagina, anche se non ho fatto nulla». E
in effetti la stampa di mezza Italia si è sbizzarrita: “Figlio del procuratore
con problemi di droga rapinava con il mitra”, era il titolo che campeggiava sui
Tutti molto attenti a mettere in relazione la professione del padre e quella
decisamente “meno nobile”, ma ancora tutta da provare, del figlio. «Un
trattamento che ha penalizzato anche mio figlio – ha continuato il procuratore –
si è parlato solo di lui. Un trattamento che rischia di metterlo anche in
condizioni di pericolo in carcere, lì non ci sono persone per bene, quando
sapranno che è figlio di un magistrato potrebbe anche correre dei pericoli.
Anche l’uso di un’auto intestata a me da parte di mio figlio è stato
enfatizzato: si tratta di una vettura che mio figlio usa da una vita, abbiamo
discusso più volte perché è talmente vecchia che volevo la rottamasse». «Fino a
prova contraria – dice il procuratore – viviamo in uno stato di diritto dove la
responsabilità penale è personale. Mio figlio risponderà personalmente dei fatti
che gli sono contestati, io posso continuare a guardare gli altri in faccia
senza dovermi vergognare. Da 41 anni faccio il magistrato con dignità e anche
con qualche risultato, come è stato dimostrato più volte. Posso continuare a
fare il mio lavoro, come ho fatto finora. Gli sbagli di mio figlio sono una
cosa, il mio lavoro è un’altra: lui ha sbagliato a Bergamo, io sono il
procuratore a Brescia. Non c’è nessun profilo di incompatibilità, le indagini
sono della procura di Bergamo». «In procura precisa Buonanno – non c’è alcuna
situazione di tensione. Ma a questo punto preferisco prendere un periodo di
pausa per stare con la mia famiglia». Buonanno aveva già passato qualche guaio
anche con l’altro figlio, Francesco, quattro anni più giovane di Gianmarco, che
un anno fa era finito in un’inchiesta sullo spaccio di droga nel mondo degli
ultras dell’Atalanta. Ma in Italia c’è lo stato di diritto e la responsabilità
penale è sempre personale, come ripete in questi giorni il procuratore Buonanno.
Albamonte: «Pm e giornalisti, ora basta
con le notizie a mercato nero», scrive Giulia Merlo il
28 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". L’allarme del presidente dell’Associazione
nazionale magistrati: «C’è il rischio di effetti distorsivi e di cortocircuiti
nell’informazione giudiziaria». Lo ha definito «il mercato nero delle fonti», il
presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte. Un
“mercato nero” in cui «l’informazione è costretta a stabilire un rapporto
preferenziale con una o con l’altra parte del processo per avere notizie e
documenti» è sintomo di un giornalismo che «potrebbe essere forzato verso una
posizione piuttosto che sull’altra, mentre deve essere neutrale». Mai il
sindacato delle toghe si era espresso in maniera tanto esplicita, prendendo
posizione nella battaglia contro la spettacolarizzazione delle inchieste anche a
spregio dei limiti di legge, che da tempo viene portata avanti anche
dall’avvocatura. «Con il giornalismo spettacolo c’è il rischio di effetti
distorsivi e di cortocircuiti nell’informazione giudiziaria», ha continuato il
leader di Anm, che ha parlato davanti a una platea più che interessata: i
giornalisti che hanno preso parte al seminario sulla libertà di stampa,
organizzato dall’Associazione Stampa Romana. Il magistrato ha poi evidenziato i
rischi della mediatizzazione dei processi nei talk show: «può provocare effetti
distorsivi, producendo un’opinione sfalsata rispetto al procedimento giudiziario
in corso». Albamonte non ha risparmiato critiche a un giornalismo «borderline»,
dove «si fa credere di fare informazione e invece si fa intrattenimento, che è
cosa ben diversa dal giornalismo “orientato”, che invece fa parte della
tradizione italiana». E, siccome la giustizia non deve essere in alcun modo
confondibile con l’intrattenimento, la cronaca giudiziaria avrebbe bisogno di un
maggiore approfondimento. Sul fronte della magistratura, il leader di Anm ha
rilevato come serva una «migliore comunicazione» tra toghe e giornalisti, perchè
la distorsione delle notizie nasce da una mancata comprensione: «La giustizia
italiana si dovrebbe dotare di uffici stampa, composti da professionisti
dell’informazione e da magistrati, per diramare note esplicative sulle decisioni
adottate e far capire il percorso seguito nel processo». E, a prescindere da
questo intervento sugli uffici, «i magistrati devono lavorare sul linguaggio da
utilizzare nei loro atti, che non deve essere criptico». Capitolo dolente in
materia di giustizia, Albamonte ha affrontato anche la questione delle
intercettazioni, riconoscendo alla riforma Orlando di essersi mossa nella giusta
direzione: «Le intercettazioni strumenti molto forti sia dal punto di vista
dell’indagine giudiziaria sia dal punto di vista dell’informazione all’opinione
pubblica. Negli anni abbiamo assistito al tentativo di ridurre le
intercettazioni o la loro pubblicazione, ora la legge cerca di raggiungere un
punto di equilibrio». Infine, il presidente dell’Anm non ha risparmiato
un’ulteriore critica alla stampa italiana: la mancanza di vero giornalismo
d’inchiesta. «Siamo un Paese con una forte tradizione e una volta i capi delle
Procure avevano fin troppi articoli di giornale sulla loro scrivania, oggi è il
contrario». Forse anche questo un effetto del rapporto privilegiato della stampa
con una sola parte del processo, rinunciando alla neutralità e dunque
all’autonoma ricerca di notizie. L’intervento si è chiuso con un monito, rivolto
non solo ai giornalisti: «L’informazione sulla giustizia è una scelta
strategica: è indispensabile per la giustizia e per spiegarne le dinamiche ai
cittadini».
Il giustizialismo? Una questione di
classe…, scrive il 25 febbraio 2018 Iuri Maria Prado
su "Il Dubbio". Il Paese è mantenuto in condizioni avvilenti e di inciviltà. Ma
la responsabilità oltre che della politica è delle persone socialmente dominanti
e influenti. "Caro direttore, è certamente colpa delle schiatte politiche e di
governo se il sistema carcerario nel nostro Paese è mantenuto in condizioni
avvilenti e di inciviltà. Ma a mantenerlo in quelle condizioni è anche
l’atteggiamento delle classi socialmente dominanti e influenti: la gente che sta
bene, per capirsi. Non che la fascia povera e disagiata dimostri più attenzione
e umanità davanti alla rassegna di ingiustizia e illegalità quotidianamente
offerta dalla cronaca carceraria, anzi: e semmai è proprio dal ventre plebeo del
Paese che viene la reazione più violenta all’idea che ci si debba preoccupare di
far vivere appena decentemente i detenuti. Ma almeno quel vasto settore di
popolo reazionario ha una scusante: non ha avuto a disposizione gli strumenti
per farsi un’idea diversa e, soprattutto, non ha nessuna capacità di influenza.
E’ soltanto la materia passiva degli esperimenti elettorali e delle inerzie dei
deputati a cambiare le cose: accomodati a non cambiarle in faccia a un popolo al
quale va benissimo che non cambino. Le classi agiate e culturalmente più
attrezzate non hanno analoghe scusanti. E la loro colpa è dunque più grave. E a
contrassegnare questa colpa, a ben guardare, è un profilo particolarmente
odioso: la sistemazione di classe, appunto. Il censo. La posizione di privilegio
sociale. L’idea, immonda, che dopotutto un “delinquente” il carcere non lo
soffre poi tanto: ché è il suo ambiente. Ricordo con un certo schifo una
cerimonia di presentazione di un libro di non so più quale giornalista sopra i
tanti casi di cosiddetta ( e giustamente detta) malagiustizia al tempo del
terrore giudiziario degli anni Novanta, a Milano. Accanto a me stava un avvocato
il quale, commentando quel reportage effettivamente agghiacciante, mi spiegava:
“Sai, io sono garantista. Perché per un balordo, per un delinquente, finire in
galera non è nulla: ma per una persona come noi, una persona perbene, è un
dramma”. Ero allora piuttosto giovane e molto sprovveduto, ma non abbastanza per
non capire di quale pasta fosse davvero fatto il “garantismo” di certi presunti
liberali; sui quali doveva purtroppo aver ragione ancora dopo tanto tempo
Corrado Alvaro: il loro, scriveva, “non è un partito, ma l’atteggiamento di chi
non ha gravi ragioni di sofferenza”. A quella creatura seduta accanto a me,
nemmeno remotamente si presentava il sospetto che il suo fervore garantista
fosse magari male orientato, e determinato non dal senso di ribellione davanti
all’ingiustizia del carcere incivile ma dal timore di poterci finire lui, un
“galantuomo”. Che è già qualcosa, per carità, nel senso che un garantismo in
prospettiva egoistica può in ogni caso contribuire a diffondere qualche
sensibilità riformatrice: ma resta il segno di un rapporto abbastanza disturbato
con le esigenze di amministrazione di un Paese che fino a prova contraria
dovrebbe offrire la stessa giustizia a tutti, possibilmente decente e senza
distinzioni di rango. C’è dunque anche questo, disgraziatamente, a restringere
la via già accidentata verso un miglioramento possibile del sistema carcerario
nel nostro Paese: una pulsione garantista semmai autoprotettiva, oltretutto
dannosa perché offre alla reazione giustizialista l’argomento ottimo secondo cui
la militanza per lo Stato di diritto ammanta in realtà l’interesse bieco di chi
vuole “farla franca”. Se i “galantuomini” si occupassero in primo luogo dei
“balordi”, proteggerebbero infine anche se stessi. Ma dovrebbero capire che non
meritano un carcere così incivile perché sono persone: non perché sono persone
“per bene”".
Squadrismo giudiziario: attenti, così ci
abituiamo, scrive Mauro Mellini il 21 Febbraio 2018 su
"Il Dubbio". La politica dei perseguitati è quella di cercare che si parli del
torto da loro subìto meno possibile, di farlo passare per un “incidente”,
attribuendo la responsabilità a qualche disgraziato “equivoco”. C’è uno
“squadrismo giudiziario”, una serie di operazioni di plateale giustizialismo con
finalità soprattutto mediatiche (ma con danni d’ogni genere) che si susseguono e
si confondono con la normale (e, come tale non certo esemplare) attività
giudiziaria. Si confondono anche perché diversamente da quanto avveniva in altri
episodi, colpiscono in direzioni diverse e, almeno apparentemente opposte. Ma
ciò è determinato dal fatto che c’è ora uno schieramento politico più
frastagliato e, poi, la tendenza ad abbandonarsi ad una attività che meglio non
potrebbe definirsi come, appunto, “squadrismo giudiziario” e più ampia e
diffusa. C’è indisciplina anche nel Partito dei Magistrati ed il potere e la
mancanza di una correlativa responsabilità finisce per de- terminare uno stile,
una “normalità dell’anormale” che ha preoccupanti connotazioni di un vero
“anarchismo giudiziario”. La tendenza della magistratura ordinaria ad operare in
modo da sostituirsi agli altri poteri dello Stato, a “sconfinare” in giudizi che
sono e debbono essere riservati al potere esecutivo o, al più, alla magistratura
amministrativa, crea questa situazione che ha, poi, nella pubblica opinione,
l’effetto, da una parte, di ingigantire la convinzione, che già si fonda su dati
assai rilevanti di indubbia gravità, di fenomeni corruttivi e di illegalità e
dall’altra sta creando assuefazione e convinzione di ineluttabilità
dell’arbitrarietà e della strumentalità politica della magistratura. Quello però
che è più grave è che, come già le forze politiche fatte specifico e particolare
oggetto della persecuzione giudiziaria, prima con “Mani Pulite”, poi con la
caccia a Berlusconi ed ai suoi, continuano a non reagire, a non denunziare al
Paese la gravità ed il carattere di gravissimo problema politico
dell’atteggiamento della magistratura. La politica dei perseguitati è quella di
cercare che si parli del torto da loro subìto meno possibile, di farlo passare
per un “incidente”, attribuendo la responsabilità a qualche disgraziato
“equivoco”. Si arriva a lamentare la facilità degli “avvisi di garanzia”, dei
provvedimenti cautelari, si riduce a qualche ipocrita e cretina espressione di
“ho fiducia nella giustizia”, espressione che varrebbe da sola a far cadere ogni
fiducia in chi questo afferma. Ma lì ci si ferma. Si comincia a criticare
qualche “eccesso” dell’Antimafia, ma non si denunzia la mafiosità intrinseca
dell’Antimafia. Molti oramai credono che io non sia fuori di testa perché da
anni parlo di “Partito di Magistrati”. Ma assai pochi ammettono che tale partito
esiste e che negarlo significa non voler capire nulla della politica italiana.
Il Centrodestra, bersaglio per anni di una sfrenata campagna di aggressione
politicogiudiziaria, in nome della “moderazione” e di un presunto rispetto delle
opinioni dei “moderati”, protesta meno di tutti, lasciando credere, con ciò, che
nei suoi confronti la prevaricazione giudiziaria sia meno ingiustificata. Ho già
avuto modo di esprimere la mia opinione che queste elezioni colgono a metà
traiettoria una serie di movimenti che hanno cominciato a manifestarsi nel
Paese. E’ certo così. Ma è pur vero che sono mezzi uomini quelli che non osano
fare di certe convinzioni oggetto di battaglie politiche. Il pensiero “a metà”,
l’” agire a metà”, non è espressione di cautela e di prudenza. Avremo, questo è
quello che molti ammettono, risultati elettorali “a metà”. Si dovrebbe dire che,
però, è questo il risultato che in fondo, rappresenta con dolente esattezza la
realtà di un Paese, in cui non si ha il coraggio e la capacità di fare le cose
per intero.
Così Woodcock “prometteva” vacanze a
Poggioreale…, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 20
Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Come iniziare in un ufficio giudiziario
l’interrogatorio di un testimone? Facendolo prima avvicinare alla finestra da
dove si vede la facciata del vicino carcere e domandandogli se, per caso, non
abbia voglia di trascorrervi una vacanza. Oppure, altro modo, mostrare dei fili
spacciandoli per delle microspie e dicendo al testimone che è stato
intercettato, anche se ciò non è vero. Sarebbe questo, in sintesi, il “metodo”
Woodcock di condurre alla Procura di Napoli gli interrogatori. Tali tecniche
investigative alquanto particolari, sono emerse ieri al Consiglio superiore
della magistratura durante l’udienza disciplinare a carico dei pm napoletani
Henry John Woodcock e Celestina Carrano, titolari di uno dei filoni
dell’inchiesta Consip. Ai due magistrati è stato contestato l’interrogatorio di
Filippo Vannoni, il presidente della municipalizzata fiorentina Publiacqua, già
consigliere dell’allora Premier Matteo Renzi. Indicato dall’ex ad di Consip,
Luigi Marroni, come uno dei soggetti che lo informarono di una indagine in
corso, Vannoni, che chiamò in causa l’allora sottosegretario Luca Lotti e i
vertici dell’Arma dei carabinieri, i generali Tullio Del Sette ed Emanuele
Saltalamacchia, venne ascoltato dai pm napoletani come persona informata dei
fatti, cioè come testimone, senza l’assistenza di un difensore. Secondo la
Procura generale della Cassazione che ha esercitato l’azione disciplinare
c’erano, però, già allora gli elementi per iscrivere Vannoni nel registro degli
indagati, cosa che poi fecero i pm romani quando il fascicolo venne trasmesso
nella Capitale per competenza territoriale. Averlo sentito come testimone senza
il legale di fiducia e, soprattutto, con quelle “irrituali” modalità avrebbe
leso la sua dignità. Al termine dell’interrogatorio Vannoni, come riportato nel
capo di incolpazione del Pg della Cassazione Mario Fresa che ha svolto
l’istruttoria, si sarebbe sentito “sconvolto”, “frastornato” e “scioccato”. Il
metodo Woodcook prevederebbe, poi, anche carta bianca alla polizia giudiziaria,
in questo caso i carabinieri del Noe comandati allora dal capitano, poi promosso
maggiore, Gianpaolo Scafarto. Sempre secondo il Pg della Cassazione Vannoni
doveva “confessare” con molteplici domande confuse che gli venivano rivolte dai
carabinieri. Woodcock deve rispondere anche di un’altra accusa. Si riferisce ad
un articolo pubblicato il 13 aprile scorso dal quotidiano La Repubblica nel
quale, in un colloquio con la giornalista Liana Milella, il magistrato si
sarebbe lasciato andare a giudizi di valore sui colleghi romani. In particolare,
dopo la notizia che Scafarto era stato indagato per falso dai pm romani per aver
attribuito ad Alfredo Romeo, l’imprenditore al centro dell’inchiesta,
un’affermazione su un incontro con il padre di Matteo Renzi, Tiziano, in realtà
pronunciata da Italo Bocchino, Woodcock dichiarò che quel falso doveva essere
considerato come frutto di un mero errore e non come un depistaggio
intenzionale. Dopo una relazione al Csm dell’allora procuratore reggente di
Napoli Nunzio Fragliasso, l’allora Pg della Cassazione Pasquale Ciccolo avviò
l’azione disciplinare, accusando il pm di un comportamento “gravemente
scorretto”: sia nei confronti di Fragliasso per non aver rispettato il suo
invito a mantenere il riserbo con gli organi di informazione, sia nei confronti
dei colleghi della Procura di Roma per aver pubblicamente “contraddetto e
svalutato l’impostazione dei magistrati della Capitale”. Il prossimo 15 marzo
l’udienza disciplinare entrerà nel vivo con l’audizione dei testimoni. I pm
napoletani sono difesi dal’ex procuratore generale di Torino Marcello Maddalena
e da Antonio Patrono, attuale procuratore di La Spezia. I due magistrati sono
fra gli esponenti di punta di Autonomia& Indipendenza, la corrente fondata
dall’ex Pm di Mani pulite Piercamillo Davigo.
La ferocia al posto della legge,
scrive Piero Sansonetti il 20 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". L’incredibile storia
di Angelo Di Marco, morto a 58 anni e tenuto in carcere a Rebibbia in modo
assolutamente illegale. Angelo Di Marco aveva 58 anni ed era tenuto in prigione
in modo assolutamente illegale. Le sue condizioni di salute erano incompatibili
con il carcere. La sua situazione giudiziaria permetteva largamente la
concessione dell’affidamento ai servizi sociali. Tenerlo in prigione è stato un
atto in violazione aperta ed evidente degli articoli 27 e 32 della Costituzione.
Una sfida arrogante a quegli articoli. Se non li conoscete li copiamo qui (anche
ad uso di qualche magistrato che magari li ha scordati): «Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato». Così è scritto all’articolo 27. Invece l’articolo
32 precisa che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo».
Angelo Di Marco è morto solo, da detenuto,
vomitando sangue. Perché stava in prigione, per un reato che la giurisprudenza
definisce bagatellare, sebbene avesse il fegato a pezzi? Perché è stato lasciato
morire in modo atroce, solo e abbandonato nell’infermeria di Rebibbia, sebbene
esistessero tutte le documentazioni necessarie che provavano la gravità della
sua malattia? State tranquilli. Non solo nessuno pagherà per quello che è
successo, ma non ci saranno né giornali né partiti politici che chiederanno
conto. Se c’è il sospetto di una caso di malasanità, l’informazione scatta
subito. Della malagiustizia non frega nulla a nessuno. State tranquilli, oggi
sui giornali questa notizia non la troverete, o la troverete piccola piccola.
State tranquilli, quello di Angelo Di Marco non è un caso clamoroso. È successo
tante altre volte, e tante altre volte è passato sotto silenzio. No, non ho
nessuna voglia di chiedere punizioni esemplari per i responsabili. Non mi piace
chiedere punizioni per nessuno, e poi so che la legge non permette di punire i
magistrati. Vorrei solo che qualche magistrato serio, come ce ne sono tanti,
esprimesse solidarietà ai familiari di Angelo Di Marco. Mi piacerebbe se lo
facesse anche il Csm, e magari anche il ministro. E soprattutto mi piacerebbe se
il sacrificio del signor Di Marco valesse almeno come spinta per affrettare la
riforma carceraria. La riforma è lì, sul tavolo del governo. Attende solo un
atto formale. Cinque minuti. Bisogna approvarla senza modifiche. Rita Bernardini
e quasi altre mille persone da un mese stanno facendo lo sciopero della fame per
sollecitare questo provvedimento. Non è una riforma pericolosa, è solo un atto
di civiltà. Come spiega molto bene Simona Giannetti a pagina 14, non è una
riforma che libera i mafiosi né tantomeno che riduce il potere dei magistrati.
Al contrario: allarga la possibilità per i magistrati di decidere sulla
liberazione e sulle pene alternative per chi ne ha diritto. E noi speriamo che
molti magistrati possano usare con saggezza questi nuovi poteri. Il grado di
civiltà di un paese non si calcola sul numero delle persone che riesce a
sbattere in prigione. Si calcola sulla capacità dello Stato di difendere la
legalità e anche di rispettare la legalità. Nel caso di Angelo Di Marco la
legalità non è stata rispettata. E questa è una ferita profonda per la dignità
nazionale.
La Cassazione: «Toto Riina è malato, ha
diritto a morire con dignità», scrive il 5 giugno 2017
"Il Dubbio". Apertura dei giudici del Palazzaccio alla scarcerazione del “boss
dei boss”: ha 86 anni, è in carcere dal 1993. Valutare nuovamente se sussistano
o meno i presupposti per concedere a Totò Riina il differimento della pena o gli
arresti domiciliari per motivi di salute. È quanto ha disposto la Cassazione,
che, accogliendo il ricorso presentato dalla difesa del boss di Cosa nostra, ha
annullato con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza di Bologna che
aveva detto “no” alla concessione di tali benefici penitenziari, nonostante le
gravissime condizioni di salute in cui Riina versa da tempo. Il giudice
bolognese aveva ritenuto che le “pur gravi condizioni di salute del detenuto”
non fossero tali da “rendere inefficace qualunque tipo di cure” anche con
ricoveri in ospedale a Parma (nel cui penitenziario Riina è recluso al 41 bis) e
osservato che non erano stati superati “i limiti inerenti il rispetto del senso
di umanità di cui deve essere connotata la pena e il diritto alla salute”. Il
tribunale di sorveglianza di Bologna, invece, metteva in evidenza la “notevole
pericolosità” di Riina, in relazione alla quale sussistevano “circostanze
eccezionali tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione della pena nella
forma della detenzione inframuraria”. Oltre all'”altissimo tasso di pericolosità
del detenuto”, il giudice ricordava “la posizione di vertice assoluto
dell’organizzazione criminale Cosa nostra, ancora pienamente operante e rispetto
alla quale Riina non ha mai manifestato volontà di dissociazione”: per questo,
osservava il tribunale bolognese, era “impossibile effettuare una prognosi di
assenza di pericolo di recidiva” del boss, nonostante “l’attuale stato di
salute, non essendo necessaria, dato il ruolo apicale rivestito dal detenuto,
una prestanza fisica per la commissione di ulteriori gravissimi delitti nel
ruolo di mandante”. La prima sezione penale della Suprema Corte, con una
sentenza depositata oggi, ha ritenuto fondato il ricorso, definendo “carente” e
“contraddittoria” la decisione del tribunale di sorveglianza, che ha omesso di
considerare “il complessivo stato morboso del detenuto e le sue generali
condizioni di scadimento fisico”: affinchè la pena non si risolva in un
“trattamento inumano e degradante”, ricordano i giudici di piazza Cavour, lo
“stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare
il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione
della detenzione domiciliare non deve ritenersi limitato alla patologia
implicante un pericolo per la vita della persona, dovendosi piuttosto – si legge
nella sentenza – avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace
di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere
rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria”. I giudici di
Palazzaccio, inoltre, osservano che “ferma restando l’altissima pericolosità” di
Riina e “del suo indiscusso spessore criminale”, il tribunale di sorveglianza
non “chiarisce come tale pericolosità possa e debba considerarsi attuale” data
la “sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e, del più generale stato
di decadimento fisico” del boss. La decisione del giudice bolognese, secondo la
Cassazione, non spiega come “si è giunti a ritenere compatibile con le
molteplici funzioni della pena e con il senso di umanità” imposte dalla
Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti umani “il
mantenimento in carcere” di Riina, viste le sue condizioni di salute: la Corte
afferma quindi “l’esistenza di un diritto di morire dignitosamente, che deve
essere assicurato al detenuto e in relazione al quale il provvedimento di
rigetto del differimento dell’esecuzione della pena e della detenzione
domiciliare deve espressamente motivare”, anche tenuto conto delle “deficienze
strutturali della casa di reclusione di Parma”. Il giudice di merito, dunque,
deve “verificare, motivando adeguatamente in proposito, se lo stato di
detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un’afflizione di tali intensità
da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione
di una pena”. Infatti, le “eccezionali condizioni di pericolosità” per cui
negare il differimento pena devono “essere basate su precisi argomenti di fatto
– conclude la Cassazione – rapportati all’attuale capacità del soggetto di
compiere, nonostante lo stato di decozione in cui versa, azioni idonee in
concreto ad integrare il pericolo di recidivanza”. Sulla base delle indicazioni
e dei principi espressi della Suprema Corte nella sentenza di oggi, il tribunale
di sorveglianza di Bologna dovrà riesaminare le istanze delle difesa di Riina.
La sentenza della Corte:
«Ormai Riina è vecchio e malato. Non è più pericoloso».
Secondo i giudici la
giustificazione secondo la quale Riina può essere seguito e trattato anche in
carcere è del tutto «parziale», scrive il 6 giugno 2017 "Il Dubbio". La sentenza
che ha dato il via libera alla scarcerazione di Totò Riina è una vera e propria
proclamazione del diritto e dei diritti della persona. Tra le pagine firmate da
Mariastefania Di Tomassi presidente della prima sezione penale della Cassazione,
si legge chiaramente che la permanenza in carcere del vecchio boss nega il
diritto alla salute e il senso di umanità della pena. In particolare gli
ermellini “contestano” la decisione di respingere la prima richiesta di
scarcerazione, avanzata dal legale del boss lo scorso anno, spiegando che nel
motivare il diniego, il tribunale di sorveglianza di Bologna aveva omesso di
considerare il «complessivo stato morboso del detenuto e le sue condizioni
generali di scadimento fisico». «II provvedimento impugnato – spiega infatti
oggi la Cassazione – pur affermando le gravissime condizioni di salute in cui
versa l’istante – soggetto di età avanzata, affetto da plurime patologie che
interessano vari organi vitali, in particolare cuore e reni, con sindrome
parkinsoniana in vasculopatia cerebrale cronica – nega la sussistenza dei
presupposti normativi richiesti dall’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. per il
rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, in particolare escludendo, da un
lato, l’incompatibilità della detenzione con le condizioni cliniche dell’istante
e, dall’altro, il superamento dei limiti imposti dal rispetto dei principi
costituzionali del senso di umanità della pena e del diritto alla salute». Il
Collegio spiega che la decisione di negare la libertà a Riina «è carente e, in
alcuni tratti, contraddittoria». Secondo la Cassazione, infatti, «il
provvedimento in esame sostiene l’assenza di un’ incompatibilità dell’infermità
fisica del ricorrente con la detenzione in carcere, esclusivamente in ragione
della trattabilità delle patologie del detenuto anche in ambiente carcerario, in
considerazione del continuo monitoraggio della patologia cardiaca di cui
quest’ultimo è affetto e dell’ adeguatezza degli interventi, anche d’urgenza,
operati, al fine di prevenire danni maggiori, a mezzo di tempestivi ricoveri del
detenuto presso l’Azienda ospedaliera Universitaria di Parma, ex art. 11 legge
n. 354 del 1975» Insomma, secondo gli ermellini la giustificazione secondo la
quale Riina può essere seguito e trattato anche in carcere è del tutto
«parziale». «Tale prospettiva di valutazione è parziale e, pertanto, inadeguata
a sostenere la ritenuta compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente
con il regime carcerario. In particolare, il Tribunale omette, nella motivazione
adottata, di considerare il complessivo stato morboso del detenuto e le sue
generali condizioni di scadimento fisico, pure descritte nel provvedimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, affinchè la pena non si
risolva in un trattamento inumano e degradante, nel rispetto dei principi di cui
agli artt. 27, terzo comma Cost. e 3 Convenzione EDU, lo stato di salute
incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento
dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della
detenzione domiciliare non deve ritenersi limitato alla patologia implicante un
pericolo per la vita della persona, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni
stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto
della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di
restrizione carceraria».
I mafiosi ed una morte
dignitosa. Cassazione: per Riina il diritto alla morte dignitosa.
Rischio ricorsi per il 41bis, scrive Roberto Galullo il 5 giugno 2017 su
"Il Sole 24 ore". Due boss di Cosa nostra, due valutazioni della Cassazione che
rischiano di aprire strade opposte alla carcerazione dura.
Per l’uno, Bernardo
Provenzano, morto il 13 luglio 2016 nel reparto adibito ai detenuti
dell'ospedale San Paolo di Milano, il carcere duro non era incompatibile con la
sua situazione di salute, ma al contrario era «fondamentale» per farlo
sopravvivere.
L'altro, Totò Riina, alla pari
di ogni altro detenuto, deve avere il diritto «a morire dignitosamente», a
maggior ragione alla luce del fatto che le sue condizioni di salute sono a dir
poco precarie. Ragion per cui il Tribunale di sorveglianza competente
territorialmente, ha deciso la Cassazione, sarà chiamato a rivalutare la
compatibilità o la sussistenza dei presupposti per il differimento della pena,
lasciando il 41 bis.
Come se non bastasse si apre
ora un varco per decine di reclusi al 41 bis (il carcere duro) che per questioni
legate allo stato di salute possono appellarsi al fresco precedente di Riina.
Il 9 giugno 2015 la suprema
Corte di Cassazione aveva bocciato il ricorso di “zu Binnu” - nell'ultimo
periodo affetto, oltre che da tumore alla prostata, da decadimento cognitivo
grave, ipertensione arteriosa, infezione cronica del fegato - perché il carcere
duro è «fondamentalmente incentrato sulla necessità di tutelare in modo adeguato
il diritto alla salute del detenuto». Se avesse lasciato il reparto ospedaliero
del San Paolo di Milano per raggiungere un reparto comune, sarebbe stato a
«rischio sopravvivenza», per la «promiscuità» e le cure che venivano invece
dedicate. Gli avvocati del boss avevano fatto ricorso alla Suprema Corte contro
il ricovero nella camera ospedaliera di massima sicurezza chiedendo che fosse
spostato ai domiciliari in un reparto di lungodegenza dell'ospedale San Paolo.
L'11 luglio 2016, due giorni
prima della morte, il giudice di sorveglianza di Milano 2 aveva respinto una
nuova istanza di differimento pena per Provenzano (vale a dire che la pena va
scontata ai domiciliari o in altro luogo di degenza al fine di garantire le cure
o consentire una morte dignitosa) dell'avvocato Rosalba Di Gregorio che chiedeva
la scarcerazione del boss o la revoca del carcere duro. I «trascorsi criminali e
il valore simbolico del suo percorso criminale» avrebbero potuto esporlo
«qualora non adeguatamente protetto nella persona» e «trovandosi in condizioni
di assoluta debolezza fisica» ad «eventuali rappresaglie connesse al suo
percorso criminale, ai moltissimi omicidi volontari dei quali è stato
riconosciuto colpevole, al sodalizio malavitoso» di cui è stato «capo fino al
suo arresto». In altre parole non era più lui ad essere un pericolo per gli
altri ma lui ad essere potenziale vittima per scopi dichiarati o meno.
Sul profilo malavitoso torna
la Cassazione nella decisione che coinvolge Riina, boss ottantaseienne. «Fermo
restando lo spessore criminale», afferma infatti, «va verificato se Totò Riina
possa ancora considerarsi pericoloso vista l'età avanzata e le gravi condizioni
di salute». Si ripropone dunque il quesito che riguardò Provenzano e la
contestuale necessità di garantirne la sicurezza pur in una situazione di grave
salute fisica. La richiesta, recita la sentenza 27.766 relativa all'udienza del
22 marzo 2017 per Riina, era stata respinta lo scorso anno dal Tribunale di
sorveglianza di Bologna, che però, secondo la Cassazione, nel motivare il
diniego aveva omesso «di considerare il complessivo stato morboso del detenuto e
le sue condizioni generali di scadimento fisico». Il Tribunale non aveva
ritenuto che vi fosse incompatibilità tra l'infermità fisica di Riina e la
detenzione in carcere, visto che le sue patologie venivano monitorate e quando
necessario si era ricorso al ricovero in ospedale a Parma. La stessa che accade
per Provenzano. Né più né meno. La Cassazione sottolinea, a tale proposito, che
il giudice deve verificare e motivare «se lo stato di detenzione carceraria
comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità» da andare oltre la
«legittima esecuzione di una pena». Il collegio ha ritenuto che non emerga dalla
decisione del giudice il modo in cui si è giunti a ritenere compatibile con il
senso di umanità della pena «il mantenimento in carcere, in luogo della
detenzione domiciliare, di un soggetto ultraottantenne affetto da duplice
neoplasia renale, con una situazione neurologica altamente compromessa», che non
riesce a stare seduto ed è esposto «in ragione di una grave cardiopatia ad
eventi cardiovascolari infausti e non prevedibili». Questa decisione apre la
strada ad altri ricorsi, anche in ragione della visibilità e del potere di
Riina. Ricorsi che non si limiteranno soltanto ai boss in regime di 41 bis ma
anche di detenuti comuni, reclusi pur in gravi condizioni di salute psichica o
fisica. Molti Tribunali di sorveglianza infatti non concedono frequentemente
differimenti pena legati a ragioni di salute anche gravi.
No, non è vero che la
Cassazione ha detto di liberare Riina.
Cosa c'è dietro la sentenza dei giudici che hanno accolto (in parte) le
richieste della difesa del boss mafioso, malato, scrive Massimo Bordin il 5
Giugno 2017 su "Il Foglio". Se martedì mattina qualche giornale dovesse titolare
“Vogliono liberare Riina” è bene sapere che ci sarebbe dell’esagerazione.
Lunedì è stata resa pubblica una sentenza della prima sezione penale della
Cassazione sulle condizioni di detenzione del “capo dei capi”. La trafila è
questa: Riina, che ha 86 anni, gli ultimi 24 dei quali trascorsi in carcere, sta
male e il suo avvocato ha presentato un’istanza al tribunale di sorveglianza di
Bologna (Riina è detenuto a Parma) in cui si chiede la sospensione della pena o
almeno i domiciliari. I giudici bolognesi hanno risposto di no, motivando con la
intatta pericolosità del personaggio. La Cassazione ha annullato la decisione ma
– ecco il punto – rinviandola ai giudici bolognesi per “difetto di motivazione”.
Vuol dire che dovranno scriverla meglio. La Cassazione spiega che la
pericolosità da sola non basta come argomento, scrive che esiste per tutti,
anche per i peggiori dunque, il “diritto a una morte dignitosa”. Non si esclude
che possa avvenire in carcere ma si chiede di argomentare più analiticamente. Ci
sono dei precedenti, l’ultimo è il caso di Provenzano che obiettivamente stava
ancora peggio di Riina ma fu lasciato morire in carcere. Prima ancora analoga
sorte ebbe Michele Greco detto “il Papa” e ancora prima toccò a quello che di
Riina e Provenzano era stato il capo, Luciano Liggio. Erano tutti
pluriergastolani e grandi capi. Per i boss di medio calibro il trattamento è
stato talvolta diverso. Gaetano Fidanzati e Gerlando Alberti furono mandati a
morire a casa loro. Difficilmente sarà così per Riina. La Cassazione ha chiesto
solo di rispettare le forme. In fondo esiste per questo.
Un uomo è un uomo…,
scrive Piero Sansonetti il 6 giugno 2017 su "Il Dubbio". La coraggiosa sentenza
della Cassazione che attribuisce a Toto Riina il diritto a «morire con dignità»
è un colpo al populismo giudiziario e a chi pensa che la legge non sia uguale
per tutti. È una sentenza che provocherà molte polemiche. Un colpo secco a
quell’ideologia giustizialista – e a quella retorica giustizialista – che da
molti anni prevale in Italia. Nel senso comune, nel modo di pensare delle classi
dirigenti, negli automatismi dell’informazione e anche della politica. Dire che
Totò Riina va liberato – perché è vecchio, perché è malato, perché le sue
condizioni fisiche non sono compatibili con la vita in carcere, perché non è più
pericoloso – equivale a toccare il tabù dei tabù, e cioè a mettere in
discussione, contemporaneamente, alcuni dei pregiudizi più diffusi nell’opinione
pubblica e nell’intellettualità (espressioni che ormai, largamente, coincidono).
Il primo pregiudizio è quello che riguarda la legge. Che spesso non è concepita
come la regola che assicura i diritti e la difesa della civiltà, ma piuttosto
come uno strumento per punire e per assicurare la giusta vendetta, privata o
sociale. Non è vista come bilancia: è vista come clava. Il secondo pregiudizio
riguarda l’essere umano, che sempre più raramente viene considerato come tale –
e dunque come titolare di tutti i diritti che spettano a qualunque essere umano
– e sempre più frequentemente viene invece inserito in una graduatoria di tipo
“etico”. Cioè si suddivide l’umanità in innocenti e colpevoli. E poi i
colpevoli, a loro volta, in colpevoli perdonabili, semiperdonabili o
imperdonabili. E i diritti vengono considerati una esclusiva dei giusti. Il
diritto di negare i diritti ai colpevoli, o anche solo ai sospetti, diventa il
nocciolo duro del diritto stesso. Salvatore Riina, capo della mafia siciliana
per circa un ventennio tra gli anni settanta e i novanta, è concordemente
considerato come il vertice dell’umanità indegna, e dunque meritevole solo di
punizione. Chiaro che per lui il diritto non esiste e qualunque ingiustizia, se
applicata a Riina (o all’umanità indegna) inverte il suo segno e diventa
giustizia. E, dunque, viceversa, qualunque atto di giustizia verso di lui è il
massimo dell’ingiustizia. La Corte di Cassazione, con una sentenza
coraggiosissima, inverte questo modo di pensare. E ci spiega un concetto
semplice, semplice, semplice: che la legge è uguale per tutti. Come è scritto
sulle porte di tutti i tribunali e sui frontoni di ogni aula. Il magistrato la
studia, la capisce, la applica: non la adatta sulla base di suoi giudizi morali
o dei giudizi morali della maggioranza. La legge vale per Riina come per papa
Francesco, per il marchese del Grillo come per il Rom arrestato l’altro giorno
col sospetto di essere l’assassino delle tre sorelline di Centocelle. E poi la
Corte di Cassazione ci spiega un altro concetto, che fa parte da almeno due
secoli e mezzo, della cultura del diritto: e cioè che la pena non può essere
crudele, perché la crudeltà è essa stessa un sopruso e un delitto, e in nessun
modo, mai, un delitto può servire a punire un altro delitto. Un delitto non
estingue un altro delitto, ma lo raddoppia. La Cassazione fa riferimento
esplicito all’articolo 27 della nostra Costituzione (generalmente del tutto
ignorato dai giornali e da molti tribunali) e stabilisce che non è legale tenere
un prigioniero in condizioni al di sotto del limite del rispetto della dignità
personale e del superamento del senso di umanità nel trattamento punitivo. La
Cassazione non dice che è ingiusto, o incivile, o inopportuno: dice che è
illegale. E cioè stabilisce il principio secondo il quale, talvolta, scarcerare
è legale e non scarcerare è illegale. Idea molto rara e di difficilissima
comprensione. La prima sezione penale della Cassazione, che ha emesso questa
sentenza respingendo una precedente sentenza del tribunale di sorveglianza di
Bologna, e dichiarandola “errata”, ha avuto molto coraggio. Ha deciso senza
tener conto delle prevedibili reazioni (e infatti già ieri sono piovute reazioni
furiose. Dai partiti politici, dai giornalisti, dai maestri di pensiero). Usando
come propria bussola i codici e la Costituzione e non il populismo giudiziario.
È la prova, per chi non fosse convinto, che dentro la magistratura esistono
professionalità, forze intellettuali e morali grandiose, in grado di garantire
la tenuta dello stato di diritto, che ogni giorno la grande maggioranza della
stampa e dell’informazione tentano di demolire. La magistratura è un luogo molto
complesso, dove vive una notevole pluralità di idee in lotta tra loro. Non c’è
solo Davigo e il suo spirito di inquisizione.
L’ascesa di Riina, così “u
Curtu” prese il posto di Liggio,
scrive Paolo Delgado il 6 giugno 2017 su "Il Dubbio". È stato un’anomalia feroce
e distruttiva. Durante il suo impero, amici e nemici sono morti a migliaia. Per
trovare un altro nome capace di evocare al solo pronunciarlo l’ombra di Cosa
nostra bisogna saltare nello spazio e nel tempo, al di là dell’Atlantico e negli
anni ‘ 30, nel regno di Lucky Luciano, oppure sconfinare nell’immaginario, sino
a quel don Vito che si chiamava come il suo paese, Corleone. Eppure nella storia
di Cosa nostra Salvatore Riina, Totò “u curtu”, è stato un’anomalia assoluta,
feroce, devastante e distruttiva. Perché Cosa nostra, a modo suo, è sempre stata
una democrazia. Così l’aveva voluta Salvatore Lucania, detto Charlie “Lucky”
Luciano, dopo aver stroncato nel sangue le ambizioni imperiali di Salvatore
Maranzana. Nessun capo dei capi per Cosa nostra, al massimo un primus inter
pares, un presidente con intorno una commissione a fare da governo. E così era
sempre stata la mafia siciliana. Fino al golpe di don Totò e dei suoi corleonesi
nel 1981, e all’instaurazione di una dittatura tra le più sanguinarie, con oltre
tremila esecuzioni, finita solo quando “u Curtu”, dopo 24 anni di latitanza, fu
arrestato il 15 gennaio 1993. Eppure nessuno sembrava meno destinato al ruolo di
capo assoluto della più potente associazione criminale del “viddano” nato il 16
novembre 1930 a Corleone, poco distante da Palermo in termini di chilometri ma
all’altro capo dell’universo nelle gerarchie mafiose. Di famiglia poverissima,
orfano a 13 anni, col padre e un fratello saltati in aria mentre scrostavano una
bomba inesplosa, condannato per omicidio a 19 anni e scarcerato 6 anni dopo,
Riina era uno dei picciotti di fiducia di Luciano Leggio, braccio destro del
capomafia locale, rispettato e temutissimo, il dottor Michele Navarra. Piccolo,
baffuto, silenzioso e sempre serio Riina e i suoi amici d’infanzia e compagni
della vita, Bernardo “Binnu” Provenzano e Calogero Bagarella, fratello di
Ninetta, futura signora Riina, erano l’esercito privato di Leggio, i suoi uomini
di mano e di fiducia. Guardando a ritroso, la differenza tra i corleonesi e il
resto di Cosa nostra era già chiara sin dagli esordi, da quando senza curarsi di
niente, rispetto, regole o gerarchie, lasciarono il potente Navarra steso in
mezzo a una strada di campagna, il 2 agosto 1958, sorpreso col suo autista e
fucilato senza esitazioni. Qualche giorno prima il medico aveva tentato di
eliminare il suo ex campiere e braccio destro diventato troppo ambizioso,
Leggio. Dopo l’omicidio eccellente fu proprio Riina a guidare la delegazione che
doveva cercare la pace con gli uomini di Navarra. Accordo raggiunto con
reciproca soddisfazione, se non fosse che proprio all’ultimo minuto, tra una
pacca e l’altra, Riina aggiunse una condizione imprevista: la consegna «di quei
cornuti che hanno sparato a Leggio». Un attimo dopo Provenzano e Bagarella
cominciarono a sparare e la mattanza a Corleone finì solo quando tutti gli
uomini di Navarra furono eliminati uno a uno. Quando approdarono a Palermo i
corleonesi non avevano amicizie politiche, non avevano le mani in pasta negli
affari grossi, che allora erano soprattutto gli appalti, non avevano eserciti a
disposizione come i boss di prima grandezza come i Bontate, sovrani della
famiglia palermitana di Santa Maria del Gesù o Salvatore Inzerillo, con le sue
parentele altolocate, cugino del potente padrino di Brooklyn Carlo Gambino, o
come don Tano Badalamenti di Cinisi. I corleonesi avevano dalla loro parte solo
la fame, la determinazione e la disposizione alla violenza che avevano già
dimostrato a casa loro. A Palermo salirono piano piano parecchi gradini. Riina
si fece altri anni di carcere prima di essere assolto nel giugno 1969. Uscito di
galera scomparve per 24 anni ma senza andare troppo lontano e continuando a
scalare i vertici di Cosa nostra. Organizzò la strage di viale Lazio a Milano,
che il 10 dicembre 1969 mise fine alla prima guerra di mafia. Furono ammazzati
il boss Michele Cavataio e tre suoi uomini, ma ci rimise la pelle anche
Bagarella, e Provenzano si guadagnò il soprannome di “u Tratturi”, il trattore,
finendo Cavataio a colpi di calcio di pistola sul cranio. Quando Leggio,
latitante nel Nord, entrò a far parte della Commissione, Riina fu delegato a
rappresentarlo e quando il boss finì in carcere ne prese il posto, nel ‘ 74, lo
stesso anno in cui coronava con le nozze il lungo fidanzamento con Ninetta
Bagarella. Ma i “viddani” restavano la plebe di Cosa nostra. Il giro grosso ora
erano gli stupefacenti, e a loro arrivavano le briciole, concesse con sprezzo e
sufficienza da Stefano Bontate, “il principe di Villagrazia”. Ma Don Totò non
era solo deciso e crudele. Era anche astuto. Lavorò nell’ombra conquistando
quinte colonne in tutte le famiglie, incluso il fratello di Bontate. Nell’estate
‘ 81 passò all’azione con i metodi brevettati a Corelone: ammazzò Bontate,
ammazzò Inzerillo, sterminò uno per uno tutti i fedeli dei boss nemici, poi,
come capita spesso nelle dittature diventò diffidente, iniziò a vedere
tradimenti ovunque e a sospettarli anche prima che si verificassero come quando
fece ammazzare il suo killer di fiducia, Pino Greco “Scarpuzzedda” perché stava
diventando troppo popolare tra gli uomini d’onore. Negli anni del suo impero di
terrore amici e nemici sono morti a migliaia. Riina conosceva solo la guerra.
Nel suo regno l’eliminazione di giudici e poliziotti scomodi diventò norma
comune e dopo la sentenza definitiva nel maxiprocesso istruito da Falcone e
Borsellino dichiarò guerra allo Stato: Lima, Falcone, Borsellino, poi la
pianificazione delle stragi. Per la stessa Cosa nostra la sua dittatura è stata
devastante: all’origine delle collaborazioni, dei pentimenti, c’è la sua
ferocia, quella che lo spingeva a far ammazzare i nemici, e se non li trovava
tutti i familiari. È stato il primo e l’ultimo imperatore di Cosa nostra, e
forse, senza neppure rendersene conto, anche il suo più temibile nemico.
Nel carcere di Riina sono
reclusi altri tre novantenni. Non c’è solo Totò “u’ curtu” nel carcere di Parma,
scrive Damiano Aliprandi il 6 giugno 2017 su "Il Dubbio". Proprio nel carcere di
massima sicurezza di Parma dove è detenuto Toto Riina, ci sono altri casi di
detenuti al 41 bis affetti di gravi patologie dovuti soprattutto alla loro età
avanzata. Almeno tre di loro hanno raggiunto il novantesimo anno di età. Il caso
più eclatante riguarda Francesco Barbaro – 90 anni compiuti il mese scorso –
che, come si legge nella cartella clinica, soffre di disturbi cognitivi, deficit
della memoria e altre patologie legate all’età. Una situazione che dal momento
all’altro potrebbe ulteriormente peggiorare, tant’è vero che gli stessi
operatori sanitari del penitenziario hanno espresso parere favorevole per un
trasferimento presso una struttura più adeguata. Questa notizia – pubblicata nei
giorni scorsi da Il Dubbio – è emersa grazie alla segnalazione di Rita
Bernardini, esponente del Partito Radicale, giunta al tredicesimo giorno dello
sciopero della fame per la riforma dell’ordinamento penitenziario, per non
vanificare il lavoro degli stati generali sull’esecuzione penale: non solo per
porre rimedio all’impennata di sovraffollamento, ma anche per umanizzare
l’intero sistema penitenziario comprensivo dello stesso 41 bis. Secondo gli
ultimi dati, del 24/ 01/ 2017, ci sono 729 detenuti al 41 bis. Nel carcere di
Parma vi sono recluse 65 persone al regime di carcerazione dura. Alcuni sono
giovani, ma la media si alza a causa dell’invecchiamento dei detenuti. A questo
va aggiunto il discorso sanitario, perché oltre ai tre novantenni, ci sono anche
diversi ultra 80enni che necessitano di cure. Il 41 bis ha come finalità
l’evitare eventuali rapporti all’esterno con la criminalità organizzata, ma come
si evince dalla relazione della commissione del Senato, guidata dal senatore
Luigi Manconi, esistono regole restrittive che non avrebbero nessun legame con
questa esigenza. Ad esempio c’è un isolamento di 22 ore al giorno, è vietato di
attaccare fotografie al muro, c’è una limitazione dei capi di biancheria, l’uso
del computer per chi studia è consentito a patto che quell’ora venga sottratta
dall’ora d’aria. Sempre nel carcere di Parma, il garante locale dei detenuti
Roberto Cavalieri ci aveva segnalato che ai detenuti reclusi al 41 bis viene
puntata la telecamera direttamente sul water. Una privacy completamente
annientata.
I Pm chiedono garantismo
(ma soltanto per loro),
scrive Giovanni M. Jacobazzi il 5 giugno 2017 su "Il Dubbio". Pronta la delibera
che “scagiona” le (poche) toghe che hanno subito provvedimenti disciplinari. Il
99,7% dei magistrati ha una valutazione positiva, un “unicum” nelle democrazie
occidentali. Mercoledì scorso il Plenum del Consiglio superiore della
magistratura ha approvato, su proposta della Sesta commissione, competente
sull’ordinamento giudiziario, una delibera destinata sicuramente a far
discutere. In estrema sintesi, i consiglieri chiedono al Ministro della
Giustizia di adottare «ogni iniziativa nell’ambito delle proprie attribuzioni al
fine di introdurre un’apposita disciplina legislativa che permetta l’estensione
anche alle toghe dell’istituto della riabilitazione». Attualmente non è
previsto, infatti, nessun meccanismo per eliminare dal curriculum della toga la
‘ macchia” disciplinare. Nella sostanza questo determina, ad esempio, un
handicap nei giudizi comparativi per accedere ai posti direttivi. In primis di
procuratore o di presidente di tribunale. «Dopo un congruo periodo di
ineccepibile esercizio delle funzioni e buona condotta», si legge nella delibera
indirizzata al Ministro Andrea Orlando, si potranno dunque eliminare gli effetti
della sanzione, senza lasciare traccia alcuna. L’Assemblea del Palazzo dei
Marescialli chiede, al momento, di limitare la riabilitazione ai casi di
condanne alle sanzioni meno gravi (cioè censura e ammonimento), e di porre quale
condizione ostativa la pendenza di procedimenti penali o disciplinari per fatti
tali da pregiudicare la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine
giudiziario. Censura e ammonimento, in specie, colpiscono i casi di ritardo nel
deposito di una sentenza. Va ricordato che ben il 99.7% dei magistrati italiani
ha attualmente una valutazione positiva. Un “unicum” fra le democrazie
occidentali come spesso ricorda il primo presidente della Corte di Cassazione
Giovanni Canzio che pone interrogativi su come vengono effettuate le valutazioni
di professionalità. Con questo “colpo di spugna” si aumenterà verosimilmente
tale numero. “L’ineccepibilità” della con- dotta richiesta, poi, dovrebbe essere
la norma, un prerequisito, per chi esercita la giurisdizione e lo differenzia
dalla platea dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Forse sarebbe stato
il caso, per ottenere la riabilitazione, di richiedere un qualcosa che vada
oltre. E c’è da chiedersi, infine, cosa penseranno i magistrati che si sono
sempre comportati in maniera corretta, soprattutto quando vengono comparati i
loro profili nell’assegnazione delle tanto ambite carriere direttive.
Totò Riina, scandalo italiano: vive in un
centro di eccellenza medico, scrive "Libero
Quotidiano" il 7 Giugno 2017. Da circa due anni Totò Riina non di fatto
rinchiuso in carcere, ma ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma. Il dettaglio
non da poco era stato chiarito dal suo avvocato, Luca Cianferoni, durante la
trasmissione L'aria che tira su La7, nel pieno del dibattito scatenato dalla
sentenza della Cassazione sul diritto a "una morte dignitosa" per i detenuti. In
attesa che il tribunale di sorveglianza di Bologna si esprima sull'eventuale
scarcerazione, Riina resta in una sorta di stanza segreta della clinica
universitaria di Parma, dove è ricoverato dal 5 novembre. Come riportato
da Repubblica, la stanza di Totò 'u Curtu è sostanzialmente una cella blindata,
dove l'accesso è consentito solo a medici, infermieri e guardie. Ampia solo
cinque metri per cinque, la stanza gode di un affaccio sulla città di Parma.
Negli ultimi tempi il bosso avrebbe chiesto una radiolina e un calendario. Una
richiesta che non potrà vedere soddisfatta, perché nella cella sono ammesse solo
apparecchiature mediche. Il capo di Cosa Nostra è tenuto sotto stretta
osservazione dai medici, a causa di diverse patologie che si sono aggravate nel
corso degli anni. Al di là della "morte dignitosa" e del diritto a curarsi e
non peggiorare le condizioni in carcere, che è un sacrosanto diritto
costituzionale, stona un po' che il boss sia così "coccolato", mentre spesso e
volentieri per un cittadino libero qualunque le liste di attesa negli ospedali
pubblici sono lunghissime, spesso in edifici fatiscenti. Così come stona un po'
che un paziente le cui condizioni "sono ormai gravissime", prenda parte ad ogni
tappa processuale (in collegamento video in barella) e sia l'unico degli
imputati o teste a non assentarsi mai, a non fermarsi per pranzare o bere. In
ogni caso la permanenza di Riina nell'ospedale di Parma non ha turbato la vita
della struttura. L'ordine è quello di passare inosservati. Niente militari in
divisa, niente mitragliette in vista. Gli spostamenti senza sirene. Adesso il
Capo dei capi è in attesa del colloquio con i familiari, previsto una volta al
mese. Ma il regime del 41bis vale anche in ospedale. La visita avverrà a un
metro di distanza e non saranno permessi contatti fisici. Sarà tutto
videoregistrato. Per i magistrati, Totò Riina è ancora in grado di mandare
messaggi, è ancora riconosciuto come capo di Cosa Nostra.
Filippo Facci su "Libero Quotidiano" del 6 giugno
2017. Ha 86 anni, è in isolamento dal ’93, ne ha per poco. La Cassazione chiede
i domiciliari, il tribunale si oppone in nome del carattere punitivo del
carcere. Domanda: anche a Totò Riina va assicurato un «diritto a morire
dignitosamente» che equivale a metterlo agli arresti domiliciari? Oppure,
nonostante abbia 86 anni e la sua salute sia decisamente malmessa, deve restare
in regime di carcere duro per ragioni di pericolosità o di principio? La
questione è attuale, perché la Cassazione, a quanto pare, è della prima idea,
mentre il tribunale di sorveglianza di Bologna è decisamente della seconda.
Cercheremo si spiegare le ragioni di entrambe le parti, magari senza ammorbarvi
troppo con le nostre valutazioni in merito. Allora. Riina è in galera
dall’inizio del 1993 e dapprima c’era il problema di isolarlo per fargli perdere
contatto con le sue truppe in rovina, perciò fu messo in regime di carcere duro
41 bis (la prima versione, la più implacabile e decisamente anticostituzionale)
che tra varie vessazioni funzionò alla grande: soprattutto quando restarono
operative Pianosa e l’Asinara, carceri talmente orrende da indurre alla
collaborazione anche i peggiori mafiosi. Riina era monitorato notte e giorno da
una telecamera (anche in bagno) e non distingueva il giorno dalla notte. In
pratica vedeva solo la moglie che gli portava notizie dei figli. Poi, allentato
giocoforza il 41bis anche su pressione di vari organismi internazionali, Riina
potè presenziare a qualche processo dove cercò di fare quello che ha sempre
cercato di fare: accreditarsi come capo di una mafia che intanto non esisteva
più, svuotata di ogni struttura gerarchico-militare, coi capi e i sottoposti
progressivamente tutti in galera, con armi e droga e patrimoni sequestrati, la
presa sul territorio allentata, i traffici ceduti a mafie non siciliane. Dì lì
in poi, Riina si è progressivamente acquietato e dalle intercettazioni (di cui
era consapevole) è emerso una sorta di padre di famiglia con uscite
paternalistiche che molti tuttavia si preoccupavano di interpretare o
sovrainterpretare. Il processoectoplasma sulla “trattativa” è stata l’ultima
occasione di Riina di inventarsi un contatto con la realtà degli ultimi 15 anni,
coadiuvato da una preistorica “antimafia” (anche giornalistica) molto impegnata
a inseguire fantasmi del passato e improbabili link col presente, tipo la
panzana che Riina volesse far uccidere il pm Nino Di Matteo (che Riina
probabilmente non sapeva neanche chi fosse). L’ultima fase è più o meno
l’attuale: Riina è in carcere a Opera, ha 86 anni ed è affetto da duplice
neoplasia renale, neurologicamente è discretamente rincoglionito (o «altamente
compromesso», se preferite) e non riesce neppure a stare seduto per via di una
grave cardiopatia. Insomma, non ne ha per molto. Il suo isolamento è peggiorato
dal fatto che nessuno vuole condividere la cella con lui: troppi controlli e
cimici, essendo lui ipersorvegliato. Ma Riina, secondo altri, resta sempre
Riina. La Direzione antimafia lo considera a tutt’oggi il Capo di Cosa Nostra,
benché non esista più Cosa nostra: ma si teme che i corleonesi non è chiaro
quali dopo 25 anni possano riorganizzarsi. Per questa ragione il Tribunale di
sorveglianza di Bologna, ancora l’anno scorso, respinse ogni richiesta di
differimento o concessione degli arresti domiciliari, ed evidenziò «l’altissima
pericolosità» e «l’indiscusso spessore criminale», dopodiché osservò pure che
non vedeva incompatibilità tra le sue infermità e la detenzione in carcere:
tutte le patologie risultavano monitorate, al punto che, quando necessario, era
stato ricoverato in ospedale a Parma. Invece la Cassazione, a cui hanno ricorso
i legali, è stata di diverso avviso, e ha invitato il Tribunale a ripensarci: ha
accolto il ricorso nel marzo scorso, anche se l’abbiamo saputo solo ora. La
Suprema corte ha detto che il Tribunale non aveva considerato «il complessivo
stato morboso del detenuto e le sue condizioni generali di scadimento fisico»,
poi che un giudice dovrebbe (doveva) motivare «se lo stato di detenzione
carceraria comporti una sofferenza ed un’afflizione di tale intensità» da
oltrepassare la «legittima esecuzione di una pena», e che non si capisce come
possano essere compatibili la condizione di Riina e la stretta detenzione
riservata a un vecchio. Perciò va affermato il suo «diritto di morire
dignitosamente», anche perché non si vede che cosa potrebbe comandare, ridotto
com’è. Chi ha ragione? In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ci
tornerà sopra il 7 luglio prossimo. Dovessimo scommettere, premetteremmo
anzitutto che non c’è giurisprudenza che non tenga conto dell’umore del Paese:
ed è una fase, questa, in cui molti italiani e parlamentari continuano a pensare
che la repressione penale debba avere un carattere punitivo e non rieducativo,
come pure prevederebbe l’articolo 27 della Costituzione. In carcere si deve
andare a star male, questo il sentire comune. Non fu diverso, del resto, per
Bernardo Provenzano: la stessa Cassazione riconobbe che fosse affetto da
patologie «plurime e gravi di tipo invalidante» ma disse pure che era
compatibile con la galera. Il boss morì agli arresti ospedalieri nel luglio
dell’anno scorso, sempre al 41 bis.
Vittorio Sgarbi su "Il Giorno" il 7 Giugno 2017:
"Totò Riina a casa non è pietà umana, ma giustizia". "se il criminale compie il
crimine, lo Stato non può imitarlo, Lo Stato non si vendica, non cerca una
corrispondenza tra violenza patita e pena, che non deve andare oltre quei limiti
che il criminale ha calpestato". Così, Vittorio Sgarbi oggi nella rubrica
quotidiana "Sgarbi Vs Capre" che ha sul quotidiano Il Giorno. Scrive, Sgarbi, a
proposito della pronuncia della Cassazione sulla carcerazione del boss
mafioso Totò Riina, che ha scatenato reazioni indignate pressochè ovunque, tanto
da parte dei cittadini che da parte della politica. "Chi cerca la vendetta -
prosegue - è come lui. Lo Stato, come non uccide, non umilia. E non è pietà
cristiana. E' giustizia".
Vittorio Feltri su “Libero Quotidiano” il 7 Giugno
2017: Riina in carcere, i brigatisti rossi a spasso da anni. La polemica del
giorno esalta la faziosità che serpeggia in Italia. Secondo la Cassazione, Totò
Riina, condannato all'ergastolo per una serie di omicidi mafiosi, potrebbe
uscire dal carcere di Opera dove è blindato in regime di 41 bis e sottoposto a
torture quotidiane, come ha dimostrato Melania Rizzoli nell' articolo pubblicato
ieri su Libero. Il boss è dietro le sbarre da oltre due decenni, ha 86 anni, non
ha molto da vivere perché soffre di svariate malattie, cardiache e tumorali.
Tenerlo in galera non è un atto di giustizia, bensì di gratuita crudeltà dato
che egli non è in grado di fare male a una mosca, essendo ridotto a uno
straccio. I soliti cattivoni (politici e commentatori di pronto intervento) sono
indignati all' idea che il detenuto venga spedito a casa sua in barella,
preferiscono che costui patisca in cella pur essendo in stato preagonico. Sono
duri e puri? Nossignori, sono ignoranti, non conoscono in che cosa consista il
41 bis e non hanno letto nemmeno una pagina di Cesare Beccaria (consigliamo a
tutti di ripassarne il testo famoso, Dei delitti e delle pene). Altrimenti
saprebbero che la prigione riservata ai criminali organizzati è una vergogna
nazionale, per eliminare la quale nessuno muove un dito. Trattasi di isolamento
perenne, un'ora di aria al dì, telecamere e luci sempre accese inquadrano anche
il water e chi lo usa. La sorveglianza spietata è prevista 24 ore. Guantanamo,
al confronto delle nostre strutture dedicate ai farabutti incalliti, è un ameno
villaggio turistico. Fantastico. Il Parlamento è in procinto di approvare il
reato di tortura da contestare ai poliziotti che eventualmente ricorrano ai
muscoli per arrestare un delinquente. Però i deputati e i senatori consentono
alle istituzioni di sottoporre a supplizi gli "ospiti" del succitato 41 bis. Non
solo, non pensano neanche ad abolire le cosiddette pene accessorie. Esempio.
Bossetti si è beccato l'ergastolo, che tuttavia non bastava: gli hanno aggiunto
per sovrammercato un paio d' anni di isolamento. Mancavano due calci quotidiani
nel didietro. Altro che culla del diritto, siamo la tomba della civiltà.
Torniamo a Riina. Lo hanno spacciato per capo dell'onorata società, lui
analfabeta tenne in scacco per venti anni e passa carabinieri e agenti, i quali
lo cercarono dovunque, in qualsiasi angolo della Sicilia tranne che nella sua
abitazione nel centro di Palermo, e qui fu poi scovato. Vengono dei sospetti: o
fingevano di dargli la caccia, oppure erano un po' storditi. Altra spiegazione
non esiste. Se il comandante supremo della mafia era davvero Totò, un nano
capace a malapena di firmare, ci domandiamo con inquietudine per quale motivo
gli intelligentoni della sicurezza non lo acchiapparono prima che ne combinasse
di cotte e di crude. Un mistero ancora da svelare. Adesso che il nano è uno
zombi, gli inflessibili giustizialisti insistono: fatelo marcire nella tomba di
cemento che lo rinchiude. Deve patire. Essi agirono diversamente con i bastardi
delle Brigate rosse che fecero più vittime del morbillo. Non ne è rimasto uno
sotto chiave. Tutti liberi e belli, uno è entrato a Montecitorio, alcuni
insegnano (quali materie si ignora) addirittura all' università, scrivono brutti
libri, concionano in centinaia di conferenze pubbliche. Pluriassassini come
Viscardi di Prima linea sono stati scarcerati subito, restituiti al consorzio
umano quasi che fossero dei ladruncoli di ortaggi. In effetti ci sono assassini
e assassini, quelli politici, via dalle pazze carceri medievali: meritano la
riabilitazione di fatto; quelli mafiosi, Riina docet, benché la vecchiaia e la
malattia li abbiano stritolati, rimangano all' inferno a tribolare finché non
avranno tirato le cuoia. Se questa è giustizia, ci sputiamo sopra.
"Lucido, determinato e non pentito. Il
mio incontro con Totò Riina nel carcere di massima sicurezza".
Melania Rizzoli, medico e scrittrice, ha visto e visitato il capo di Cosa
Nostra. "Mandarlo a casa? Esistono centri medici carcerari che possono curare i
suoi problemi di salute". Intervista di Cristiano Sanna del 6 giugno 2017 su
"Tiscali notizie". Il capo dei capi sta male. Molto: neoplasia ad entrambi i
reni. Ha 87 anni, è sottoposto al regime di isolamento carcerario più duro, il
41bis, dal 1993. Nelle ultime ore non si discute che di lui, dopo la decisione
della Cassazione di accogliere la richiesta di mandarlo ai domiciliari per
permettergli di affrontare la morte in mezzo ai familiari. Una morte dignitosa,
si direbbe. Ma cosa si intende per morte dignitosa quando il protagonista della
richiesta è l'uomo che ha insanguinato e terrorizzato l'Italia, quello delle
bombe, dei giudici fatti saltare per aria, delle crudeli esecuzioni, della
strage di Capaci, dei bambini fatti sciogliere nell'acido, delle minacce di
morte violenta all'attuale pm Antimafia, Di Matteo? Dove si ferma il concetto di
giustizia e comincia quello di vendetta e di accanimento nei confronti di un
super criminale? Melania Rizzoli, giornalista, scrittrice, medico e politico,
sei anni fa ha incontrato Totò Riina nel braccio di massima sicurezza del
carcere di Opera.
Melania, tu hai raccolto le storie dei
carcerati celebri e delle loro condizioni di salute in un libro.
"Sì, tra gli altri raccontai anche di Provenzano,
morto in carcere, in regime di isolamento, lo scorso luglio. Quando lo incontrai
era incapace di intendere e di volere. Ho visitato i centri di detenzione perché
facevo parte della Commissione sanità, occupandomi dei casi di malati
incompatibili con il regime detentivo: come quelli affetti da sclerosi multipla,
ad esempio".
Nel 2011 ad Opera incontri Totò un Riina
lucido, integro, cosciente della sua condizione di carcerato.
"Rimasi colpita: dopo tanti anni di detenzione al
41bis, che è un regime spaventoso, perché sei sempre sotto terra, isolato, non
hai giornali, aveva perfino il telecomando della tv bloccato, poteva solo
cambiare canale e il televisore si accendeva a orari prestabiliti, trovai un
uomo fiero. Orgoglioso, di spirito elevato, Riina pareva detenuto da massimo tre
mesi. Sapeva di avere una storia di potere alle sue spalle e probabilmente nel
suo presente. L'ho visitato come medico, l'ho stimolato a scrivere ma si
rifiutò. Nun sacciu scrivere, rispose, mai lo farei. Io volevo che lasciasse una
testimonianza della sua storia criminale. Lui disse: se casomai finissi in un
libro di storia mai lascerei una testimonianza di me".
Perché? Riina si percepisce più grande di
quanto possano raccontare gli altri?
"Io ho avuto l'impressione che non volesse
condividere la sua storia con quella della reclusione".
Dunque una specie di scissione fra l'uomo
siciliano privato e il capo dei capi che ha commesso stragi e violenze di ogni
genere.
"Esatto, ho avuto l'impressione che fosse tornato
in libertà avrebbe ricominciato la sua storia criminale senza problema".
Quindi la posizione dell'Antimafia che continua
a considerarlo il perno di tutta la storia mafiosa ancora in movimento nel
nostro Paese, non è semplice allarmismo.
"Riina è in regime 41bis aggravato, se la
magistratura ha deciso di tenerlo in queste condizioni ne ha tutte le ragioni.
Io sono un medico, ho seguito tanti terminali, ritengo che quando una persona
affronta il momento più fragile e terribile della sua vita, la morte, abbia
diritto di farlo in modo dignitoso. Riina è stato trasferito nel centro medico
di Parma, un'eccellenza italiana, dove sono perfettamente in grado di
seguirlo".
Un'assistenza che gli si può dare tenendolo al
41bis o anche spostandolo altrove?
"In questi centri medici ci sono strutture di
massima sicurezza, per permettere di assistere malati gravi in isolamento. Non è
necessaria la scarcerazione".
Torniamo all'incontro con Riina ad Opera del
2011. In un braccio di massima sicurezza con quattro celle per lato, vuoto.
Dentro c'era solo lui.
"Man mano che mi avvicinavo vedevo l'ombra del
cancello riflessa sul pavimento del carcere, e si sentiva una musica, l'Ave
Maria di Schubert che lui stava seguendo alla tv. Incontravo il personaggio che
ha firmato la storia più orribile del nostro Paese. Ancora oggi Sicilia e mafia
sono sinonime. L'ex premier Renzi, di fronte all'idea di tenere il G7 in
Sicilia, fu sconsigliato di farlo, perché ancora oggi all'estero la Sicilia
significa mafia. Riina è responsabile della fama negativa di quella regione".
Lo vedi, gli stringi la mano, lo visiti: a
parte i problemi alla tiroide, c'erano già evidenze delle neoplasie ai reni?
"Aveva già problemi renali, prima che io andassi
via mi sollecitò perché accelerassi le visite specialistiche. E' un uomo molto
intelligente, ci teneva ad essere curato e alla sua salute".
Il rapporto dei boss, pervertito, con la
religiosità: Riina disse che leggeva regolarmente la Bibbia. Come adesione alle
tradizioni religiose o come passatempo?
"Sia come passatempo sia come conforto. Quando sei
in quella condizione di isolamento, solo con te stesso, rinchiuso e impedito
in qualsiasi forma di comunicazione, ti resta da pensare. Avrà riflettuto
probabilmente sulle sue azione e responsabilità. Mi disse che non pregava ma che
la Bibbia la leggeva tutte le sere. Non ha mai voluto dare un'immagine di
cambiamento".
Quindi: no scarcerazione, se c'è bisogno di
curarlo lo si può fare tenendolo in isolamento carcerario.
"Se non ci fosse la possibilità di curarlo in modo
dignitoso direi che bisognerebbe spostarlo da li. Non come è stato fatto per
Provenzano. Ma in Italia ci sono centri di eccellenza nelle case circondariali
italiane in grado di assistere un detenuto anche condannato al 41bis. Certo non
avrà ciò a cui tiene di più, la vicinanza della famiglia. Chi sta in isolamento
ha diritto ad una sola visita al mese, per una sola ora. Ma ribadisco: Totò
Riina si trova nel centro medico del carcere di Parma, in grado di affrontare
qualsiasi emergenza medica e chirurgica".
«Il mio incontro con Totò Riina in carcere». L’ho
conosciuto in cella nel 2011. Era ancora vitale, per niente depresso Parlava in
siciliano, faceva il galante. «Qui divento un monachello...», scrive su "Libero
Quotidiano" il 6 giugno 2017 Melania Rizzoli. Ho incontrato Totò Riina nel
carcere di Opera (Mi) nel 2011, durante una delle mie visite ispettive nei
centri di reclusione italiani, che svolgevo in qualità (...) (...) di
parlamentare della Commissione Sanitaria della Camera dei Deputati. Il “Capo dei
capi” di Cosa Nostra era recluso in regime di 41bis, in isolamento assoluto, dal
giorno del suo arresto, il 15 gennaio del 1993, ma quando me lo sono trovato di
fronte ho visto un uomo forte e vitale, per niente depresso, anzi ancora fiero
ed orgoglioso, come fosse incarcerato da appena pochi mesi. Avevo chiesto di
vederlo per verificare il suo stato di salute, poiché, oltre alle varie
patologie dalle quali era affetto, pochi mesi prima era stato colpito da un
infarto, era stato curato ed era ancora convalescente. Sapevo che Riina non
gradiva le visite di estranei, né tantomeno di parlamentari, che aveva sempre
rifiutato di incontrare, per cui io chiesi aiuto al direttore del carcere di
Opera, che mi accompagnò da lui nei sotterranei dell’isolamento. E per me fu
un’esperienza indimenticabile. Totò “u’ curtu” era rinchiuso da solo in un
intero reparto interrato, senza finestre e luce naturale, nel quale c’erano otto
celle, quattro per lato, separate da un ampio corridoio, all’ingresso del quale
era stato posizionato un metal detector con due agenti di polizia penitenziaria
armati, alloggiati in un gabbiotto con quattro monitor, tutti collegati con la
cella dell’unico detenuto di quel settore. Avanzando verso quel reparto
calcolavo che quello spazio, seppur ampio, non sarebbe stato sufficiente a
contenere in piedi tutte le vittime di mafia collegate a lui ed ai suoi sicari.
Dopo i controlli di routine ai quali siamo stati sottoposti, io, il collega
Renato Farina che si era offerto di accompagnarmi, e lo stesso direttore, questi
andò avanti da solo, per informare Riina della nostra visita, avanzando verso la
sua ferrata, dalla quale usciva una musica celestiale, l’Ave Maria di Schubert.
Riina, senza spegnere il televisore od abbassare il volume, chiese chi volesse
incontrarlo, rispose che lui non gradiva vedere nessuno e che non era
interessato, esprimendosi in stretto dialetto siciliano, che però io conoscevo
bene, avendolo appreso dai miei nonni materni, siciliani anche loro, per cui
avanzai d’impeto di fronte a lui presentandomi, ed informandolo sullo scopo
della mia visita inaspettata. Naturalmente mi rivolsi a lui nel suo stesso
dialetto, cosa che lo colpì molto, e che lo fece sorridere, oltre che
autorizzare gli agenti ad aprire il cancello per farmi entrare. «Allora lei mi
capisce, s’accomodasse, prego trasisse» furono le sue prime parole, mentre
allungava il braccio per porgermi la mano. Io ebbi un attimo di esitazione, ma
poi quella stretta inevitabile mi diede un brivido, perché stavo ricambiando il
saluto e stringendo la mano di un criminale assassino. Riina era vestito con una
camicia bianca, pantaloni e scarpe nere senza stringhe, era sbarbato, e
nonostante fosse quasi ottantenne, era brizzolato, pettinato ed ordinato,
diritto come una spada, e non aveva l’aria sofferente. Notai subito un suo
grosso gozzo tiroideo evidente e sporgente, e quando gli chiesi di visitarlo lui
acconsentì, aprendo il collo della camicia, che era stirato, lindo e pulito,
fresco di lavanderia. Il direttore si era raccomandato di non accennare nella
maniera più assoluta con il detenuto alle sue vicende giudiziarie, per cui
parlammo soprattutto del suo stato di salute, della sua situazione cardiaca e
degli altri problemi che si evidenziavano dalla sua cartella clinica. Lui si
lamentava della difficoltà e della lentezza per ottenere le visite
specialistiche che gli spettavano, ma quello che mi colpiva di più era il suo
stato d’animo. Riina era spiritoso, a tratti addirittura ironico, e ci teneva a
dimostrare che la detenzione non gli pesava, non lo piegava, che la accettava ma
non la subiva. «Qui mi stanno facendo diventare un monachello sa, ma io ero
tutt’altro...». La sua cella era spoglia come quella dei frati, con un letto a
branda, un solo cuscino, un comodino ed uno sgabello tondo di legno scuro vicino
ad un piccolo tavolo. Sulle pareti nemmeno un crocifisso o una foto, ma un
piccolo armadio senza sportelli con camicie, magliette e biancheria riposte in
ordine, con una sola stampella con appesa una giacca blu. «Quando la indosso?
Quando vengono gli avvocati, o quando, una volta al mese per un’ora sale su mia
moglie. Io la aspetto e la vedo sempre volentieri, e mi faccio trovare ordinato.
Perché io ho una buona mugliera lo sa? Le viene sempre da me, tutti i mesi
prende la corriera, poi il treno e viene a trovarmi». In regime di 41bis si ha
diritto ad una sola visita al mese con un solo familiare a volta e ad una sola
telefonata mensile. «Se ho nostalgia della Sicilia? Ma quando mai, non sento
nostalgia io, mai. Qui sto bene, mi trattano bene, mangio bene, sempre le stesse
cose, ma non mi posso lamentare. E poi ho questi miei due angeli custodi (gli
agenti di guardia) con i quali ogni tanto scambio qualche parola.
Il populismo giudiziario stavolta ha
perso, scrive Sergio D'Elia il 6 giugno 2017 su "Il
Dubbio". Il commento del segretario di Nessuno tocchi Caino. La sentenza della
corte di Cassazione sul caso di Totò Riina è ineccepibile sotto il profilo
giuridico, ed è un raro esempio di indipendenza del giudizio di una suprema
corte da considerazioni di tipo moralistico, populistico o, peggio, politico che
non dovrebbero mai albergare in un’aula di giustizia, anche di rango inferiore a
quella della Cassazione. Principi e norme come «umanità della pena», «diritto a
morire dignitosamente», «attualità della pericolosità sociale», sono raramente
rispettati da un giudice quando si tratta di persona che per il suo passato
criminale ha rappresentato l’emblema della mostruosità che non può mai svanire,
che va alimentato per tutta la vita. In tempi di populismo giudiziario e, ancor
più, penale non è accettabile che tali simboli del male assoluto si sciolgano
come neve al sole. Totò Riina non può essere un pupazzo di neve con la coppola e
la lupara di plastica in un giardino d’inverno che dura solo fino a primavera.
Deve rimanere un monumento granitico e indistruttibile in servizio permanente
effettivo, insieme a tutti gli altri armamentari speciali ed emergenziali della
lotta alla mafia, dal 41 bis al ‘ fine pena mai’ dell’ergastolo ostativo da cui
si può uscire in un solo modo: da collaboratori di giustizia o, come si dice,
coi piedi davanti. La forza di uno Stato non risiede nella sua ‘ terribilità’,
come diceva Leonardo Sciascia, ma nel diritto, cioè nel limite insuperabile che
lo Stato pone a sé stesso proprio nel momento in cui deve affrontare il male
assoluto. Se quel limite viene superato a morire non è solo Totó Rina, così come
è stato lasciato morire Bernardo Provenzano, come rischiano di morire alcuni
ultra novantenni ancora in 41 bis nel carcere di Parma o come Vincenzo Stranieri
ancora in misura di sicurezza in regime di 41 bis nonostante abbia scontato la
sua pena e sia gravemente malato. A morire e lo stato di diritto, la legge
suprema che vieta trattamenti disumani e degradanti, a morire è anche la nostra
Costituzione, il senso stesso della pena, che non può essere quello della
vendetta nei confronti del più malvagio dei nemici dello Stato.
Vincenzo Stranieri è grave e la figlia fa
lo sciopero della fame, scrive Damiano Aliprandi il 31
Maggio 2017 su "Il Dubbio". Anna, la figlia di Vincenzo Stranieri in carcere dal
1984 e in regime del 41 bis dal 1992, è in sciopero della fame dopo che il
tribunale de L’Aquila ha respinto l’ennesima richiesta di scarcerazione per
incompatibilità con il regime detentivo perché malato di tumore. Una vicenda
paradossale che Il Dubbio ha seguito fin dall’inizio. Stranieri ha un tumore
alla laringe e i 24 anni di 41 bis gli hanno causato gravi problemi di tipo
psichiatrico. La sua pena teoricamente sarebbe dovuta finire il 16 maggio del
2016, ma gli restano ancora da espiare due anni di misura di sicurezza in una
colonia penale agricola. Secondo la Direzione nazionale antimafia, però, risulta
ancora pericoloso. Quindi il ministro della Giustizia, seguendo le indicazioni
della Dna, gli ha prorogato di fatto il 41 bis trasformando la colonia penale in
“casa lavoro” nella sezione del regime duro del carcere de L’Aquila. Però
nell’Istituto abruzzese il lavoro non c’è per gli internati. A denunciarlo era
stata la radicale Rita Bernardini quando lo scorso luglio si rivolse al capo
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, proprio per
porre rimedio alla situazione: durante la visita di Pasqua dell’anno scorso,
l’esponente del Partito Radicale, aveva ritrovato internati cinque detenuti al
41 bis che dovevano scontare la cosiddetta “casa lavoro”; aveva chiesto a uno di
loro quale fosse il suo lavoro attraverso il quale avrebbe dovuto “rieducarsi” e
la risposta fu: «Lo scopino per 5 minuti al giorno». Un altro che faceva il
porta- vitto, le chiese: «Come faccio a dimostrare che non sono più
pericoloso?». E ancora un altro detenuto le fece presente che l’ora d’aria si
svolgeva in un passeggio coperto senza mai poter ricevere la luce diretta del
sole. «Qui non possiamo fare una revisione critica del nostro percorso; uno di
noi che si vuole salvare che deve fare?». Rita Bernardini fece presente che a
Vincenzo Stranieri, gravemente malato e quasi impazzito per i disumani e
degradanti trattamenti subiti, era riservato questo trattamento assolutamente
non compatibile con i diritti e la dignità di una persona. Nel frattempo però le
condizioni fisiche di Stranieri si erano aggravate, trasferito nella struttura
protetta di Milano “Santi Paolo e Carlo” per ricevere le cure adeguate, ha
subìto un secondo intervento chirurgico. Ora si trova nel carcere milanese di
Opera in completo isolamento con un sondino direttamente collegato allo stomaco
per farlo nutrire. Aveva 24 anni quando venne arrestato nel lontano giugno del
1984 per aver fatto parte del sequestro di Annamaria Fusco, la giovane maestra
figlia dell’imprenditore del vino Antonio Fusco rimasta per sei mesi nelle mani
della Sacra corona unita prima di essere liberata dopo un lauto riscatto.
Stranieri infatti era stato il numero due della cosiddetta quarta mafia. «Me lo
hanno tenuto lontano per 32 anni – dice Anna Stranieri che non ha mai smesso di
lottare per suo padre – ed ora che ha pagato i suoi errori lo Stato si accanisce
e non si ferma neanche davanti al tudel more; ormai è chiaro che gli vogliono
far fare la fine di Provenzano». Nel frattempo l’ultima batosta: per il
Tribunale di sorveglianza, Stranieri può restare in carcere. Una decisione che
va in controtendenza con le disposizioni dello stesso perito del giudice che
consigliava il ricovero del detenuto in una proprietà della fondazione Don
Gnocchi di Milano a causa del suo tumore che andrebbe monitorato presso
strutture adeguate. Non può deglutire, né parlare. Si alimenta tramite un
sondino e respira grazie alla tracheotomia. È dimagrito e non può camminare da
solo. Ricordiamo che per il rapimento di Anna Maria Fusco, Vincenzo Stranieri fu
condannato a 27 anni di carcere ridotti in appello a 18 e 10 mesi. Ma nel
frattempo gli anni sono diventati 32 per delle condanne inflitte quando era in
carcere per reati di associazione mafiosa. Al momento della condanna era
giovanissimo e non sta pagando nessuna condanna per omicidio: è giusto avergli
prorogato gli anni di carcerazione presso la sezione dedicata al 41 bis,
nonostante il sopraggiungere di questa grave malattia e abbia scontato tutti gli
anni inflitti?
L’avvocata di Provenzano: «Quanti
sconosciuti lasciati morire al 41 bis». Intervista di
Valentina Stella su "Il Dubbio" del 12 luglio 2017 alla legale Rosalba Di
Gregorio che difese il vecchio boss: «Ci sono centinaia di persone in condizioni
gravemente malate solo che si chiamano Mario Rossi e Pinco Pallino e di loro
quasi nessuno si occupa». Riina, il cosiddetto carcere duro, alla presunta
trattativa Stato- mafia. Di questi temi parla l’avvocata Rosalba Di Gregorio,
legale di numerosi boss come Bernardo Provenzano. «Molti si scandalizzano per la
sentenza della Cassazione su Riina, che invece non è affatto scandalosa perché
afferma principi di diritto. L’informazione è stata disinformante perché si è
concentrata solo sul nome dell’imputato. La popolazione carceraria non si
compone solo di Provenzano e Riina, ci sono centinaia di persone in condizioni
disastrose, solo che si chiamano Mario Rossi e Pinco Pallino e di loro quasi
nessuno si occupa».
Continua a tenere banco la condizione di salute
di Riina rispetto ai suoi status di detenuto e imputato. Dello stato di salute
di Provenzano non si discusse con lo stesso approfondimento.
«Molti si
scandalizzano per la sentenza della Cassazione su Riina, che invece non è
affatto scandalosa perché afferma principi di diritto. L’informazione è stata
disinformante perché si è concentrata solo sul nome dell’imputato: quando la
Suprema corte afferma che bisogna motivare sull’attualità della pericolosità.
Sostiene cose talmente ovvie, scontate e conformi al diritto che non ci sarebbe
proprio da discuterne, se non per dire che andrebbe applicata a chiunque. La
popolazione carceraria non si compone solo di Provenzano e Riina, ci sono
centinaia di persone in condizioni disastrose dal punto di vista sanitario, solo
che si chiamano Mario Rossi e Pinco Pallino e di loro quasi nessuno si occupa.
Vorrei chiedere all’onorevole Bindi perché non è andata a verificare anche le
condizioni di salute di Provenzano, quando all’epoca la stampa se ne occupò dopo
che sollevammo l’incompatibilità con il 41bis per una persona che era un
vegetale. Perché non sono andati a visitarlo quando anche lui era a Parma? Io ho
documentato che quando si ritiravano le magliette intime di Provenzano erano
intrise di urina perché lì gli cambiavano il pannolone solo due volte al giorno
e quindi poi l’urina arrivava dappertutto, fino al collo. Ho fatto fare persino
il test del Dna sull’urina perché non si dicesse che non era la sua. Tutto è
stato denunciato alla Procura di Parma che naturalmente ha archiviato. Ora
l’onorevole Fava della commissione Antimafia dice che le condizioni di Riina non
sono paragonabili a quelle di Provenzano: allora deduco che all’epoca la
Commissione era in ferie».
L’Antimafia all’epoca era senza dubbio attiva:
quale altra spiegazione si può trovare?
«Si scelse di
dare una risposta ai familiari delle vittime lasciandolo al 41bis. Ai quali va
tutta la mia comprensione, ma i problemi giuridici andrebbero affrontati in
quanto tali».
Rita Dalla Chiesa, dice "mio padre non ha avuto
una morte dignitosa": perché concederla a Riina?
«Il dolore è
comprensibile, la solidarietà è massima, ma ciò non significa che uno Stato di
diritto possa abrogare o non applicare le norme perché esiste la sofferenza
delle vittime».
La presidente della commissione Antimafia Rosy
Bindi, al termine della visita a Parma dove ha verificato le condizioni di
Riina, ha dato l’impressione di voler anticipare la sentenza del Tribunale di
Bologna sul differimento pena.
«È bene
precisare che la Commissione è andata nel reparto detenuti 41 bis dell’ospedale
Maggiore di Parma. Io invito tutti invece ad andare al carcere per rendersi
conto se quello al suo interno è un centro clinico e se non ci dobbiamo
vergognare dei nostri cosiddetti centri clinici nei penitenziari. Ma per tornare
alla domanda, a me hanno insegnato che siamo in una Nazione in cui il potere
giudiziario è indipendente da quello politico. Non credo che i parlamentari
dell’Antimafia abbiamo acquisito capacità medico diagnostiche e possano
stabilire, con uno sguardo, al posto dei Tribunali, cosa sia giusto per un
detenuto. Io non ne faccio un problema per Riina ma per tutti i reclusi. Il 41
bis si lascia ai soggetti pericolosi».
Bindi è certa che Riina sia "ancora il capo di
Cosa nostra, è così per le regole interne alla mafia".
«Per principio
lo dice. E così si disse di Provenzano. Bisogna che si mettano d’accordo su chi
era il capo dei capi. Se muore anche Riina avremo allora una organizzazione
acefala».
Lei ha lanciato un appello ai politici affinché
visitino i reparti del 41 bis.
«Più che un
appello era una sfida che credo nessuno raccoglierà mai. Per fare una cosa del
genere bisogna recarsi lì all’improvviso e visitare tutte le sezioni, non solo
quelle che vogliono farti vedere i direttori delle carceri».
Sul 41 bis si sono espresse riserve sia nella
relazione di Luigi Manconi sia negli Stati generali dell’esecuzione penale.
«Il problema è
la modalità di attuazione del 41 bis, ovvero la vivibilità in termini umani. E
che si tratta di un provvedimento emergenziale diventato la norma. Non ci può
essere una presunzione della presenza del contatto del detenuto con
l’organizzazione criminale. Ci devono essere segnali precisi, per ipotizzare che
il recluso stia veicolando ordini all’esterno. I pareri sulla permanenza al 41
bis vengono elaborati dal profilo criminale, dalle vecchie schede, ma c’è gente
nel carcere che dopo anni ha fatto percorsi di ravvedimento, di cui nessuno
prende atto».
In realtà come ha documentato Ambrogio Crespi
nel docufilm Spes contra Spem, prodotto da Nessuno Tocchi Caino, anche persone
che hanno commesso 40 omicidi dopo decenni possono riabilitarsi.
«Il problema
oggi, e lo ha detto il presidente del Senato Grasso, è che o accedi alla
collaborazione oppure si deduce che non vi è stata rivisitazione critica del
proprio vissuto. Teoricamente si dovrebbero trasformare tutti in collaboratori
di giustizia».
C’è il rischio che non si abbia nulla da dire e
che si offrano false informazioni su cui poi però si imbastiscono processi.
«Il problema è
a monte: lo Stato non può pretendere di usare il 41 bis per farti pentire».
Al processo Borsellino bis, Vincenzo Scarantino
ha mandato al 41 bis per 20 anni degli innocenti.
«Il Borsellino
quater ha stabilito che Scarantino è stato indotto a "collaborare". Si può
presupporre un mancato vaglio da parte dei magistrati, prima inquirenti poi
giudicanti, sul lavoro degli investigatori. Che cosa c’è stata a fare tutta la
Procura in questi anni?»
Del processo Borsellino quater si è parlato
pochissimo.
«L’agenda rossa
di Borsellino non l’ha presa Toto Riina e neppure Graviano, non se ne facevano
niente. Se Borsellino avesse annotato “la Mafia mi fa schifo” era una notizia
già nota ai mafiosi. Dal processo è emerso l’intervento di terzi un po’ più in
alto rispetto a quelli che io considero esecutori del depistaggio, a partire da
dirigenti della Polizia, e a qualcuno non fa comodo che si sappia».
Capitolo "trattativa": Mori è stato assolto
dall’accusa di favoreggiamento aggravato alla mafia per non aver catturato
Provenzano quando si poteva.
«Non ho letto
le carte processuali, ma qualcosa si può dedurre dal fatto che c’è una triplice
conformità sull’assoluzione. O buttiamo via i processi o dobbiamo prendere atto
di queste sentenze».
Il Fatto Quotidiano ha pubblicato come inedita
la dichiarazione di Graviano secondo cui Pannella nell’ 87 andò in carcere a
raccogliere iscrizioni tra i detenuti.
«Da sempre in
carcere si trova sostegno per le battaglie garantiste. Non mi pare una notizia
che possa scalfire l’immagine del Partito radicale».
Ilaria D'Amico imprigionata in tribunale
per 5 ore, lo sfogo contro la giustizia italiana: "Scusate, ora devo andare",
scrive il 2 Giugno 2017 “Libero Quotidiano”. Contro i tempi biblici della
giustizia italiana, in un'aula di tribunale, tuona anche Ilaria D'Amico. Già,
perché la signora del calcio su Sky è rimasta "imprigionata" per quasi 5 ore in
tribunale soltanto per confermare le accuse contro il suo ex
commercialista, Davide Censi, che l'avrebbe truffata sottraendole 1,2 milioni di
euro, destinati al pagamento delle tasse. Cinque ore d'attesa per dire poche
parole: "Confermo quanto ho già dichiarato nel luglio 2016". Dunque, la D'Amico
ha aggiunto con tono polemico: "Devo tornare a Milano, ho due figli". Ilaria,
compagna di Gianluigi Buffon, ha atteso cinque ore senza mai incrociare lo
sguardo dell'ex commercialista, che da par suo si è poi sfogato con i
giornalisti presenti: "Non ho fatto nulla, voi dovete sentire tutte le campane".
Durissima la replica della D'Amico: "Dico solo che la mia querela è del dicembre
del 2013 - polemizza ancora contro i tempi della giustizia -. Ma questo è il
paese delle sòle. Lunga vita alle sòle. Rimango a bocca aperta, ma non è che lo
scopra oggi".
I giudici la zavorra dell'Italia:
piangono e intanto ci fottono, scrive Filippo Facci su
“Libero Quotidiano" il 3 Giugno 2017. La Giustizia è il problema di questo
Paese. Non è uno dei problemi: è «il» problema che li racchiude tutti, perché è
un freno allo sviluppo imprenditoriale e all’attrazione di capitali esteri. È
questa la Giustizia che interessa agli indicatori internazionali, non quella
intrisa di malanimo sociale di cui vedete cianciare nei talkshow; è questa la
zavorra che blocca un Paese in cui, negli ultimi venticinque anni, è cambiato
semplicemente tutto tranne la Giustizia e la corresponsabilità della
magistratura in questo sfascio: toghe che si atteggiano a vittime del problema e
invece ne sono parte. I dati di Bankitalia, che oggi rilanciamo, sono noti a
tutti gli osservatori internazionali, ma il parolaio italiano tende ormai a
liquidarli come «ritardi della giustizia» quasi che fossero un destino
fisiologico, un rumore ambientale, e non un carico che pesa - anche - sulle
spalle di esseri umani che rappresentano l’ultima vera casta della Prima
Repubblica. I dati dicono che la produttività dei tribunali nei procedimenti
civili è calata dal 2014 al 2016 in tutto il territorio nazionale (la
produttività è data dal rapporto tra il numero di procedimenti definiti e i
giudici che se ne occupano) e spiegano che, tanto per cambiare, al Sud va
nettamente peggio che al Centro Nord. Non solo: dicono che «i divari non
dipendono da carenze di organico dei giudici e del personale amministrativo»
(non fosse chiaro) e che questo «potrebbe dipendere da aspetti organizzativi»,
che è un modo gentile per dire che qualcuno lavora poco. Ma guai a dirlo.
Ricorderete tutta la lagna perché il governo Renzi cercò di limitare l’unico
primato occidentale della nostra magistratura: quello delle ferie. Beh, alla
fine ci sono riusciti con complicati magheggi procedurali: le ferie sono più o
meno quelle di prima. Anche perché molti lavorano semplicemente quanto vogliono:
nessuno li controlla, non timbrano un cartellino, possono lavorare anche da
casa. Poi ci sono dei fatti notori a tutti gli addetti ai lavori: tipo i
corridoi dei tribunali già deserti il venerdì, le pause dopopranzo alla
messicana, le assenze che coincidono spesso con le feste scolastiche,
l’avvertenza che il dottore «oggi non c’è» oppure appunto «lavora a casa» o
ancora «non è venuto», punto. Senza contare la chiusura estiva dei tribunali
(che è una chiusura, non prendiamoci in giro: e infatti la maggioranza degli
avvocati è costretta a prendere le ferie nello stesso periodo) che non esiste in
nessun altro Paese serio al mondo. Sono problemi, questi? Non sia mai: la solita
Associazione magistrati (che in pratica è la Cgil delle toghe) ogni volta
provvede a puntualizzare che tutto quel che riguarda i magistrati è sempre
sbagliato, anzi è sempre un problema di «risorse» e di «organici», poi certo, di
«leggi» e loro interpretazione. La Fondazione Einaudi aveva già evidenziato che
non solo l’Italia, sulla giustizia, si classifica in una posizione nettamente
inferiore rispetto a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito: ma pure che -
rispetto agli altri Paesi - non è nemmeno riuscita a difendere la sua posizione,
passando dal 39° posto del 2012 al 42° del 2015. Altri dati (The European
House-Ambrosetti) hanno spiegato che ogni anno perdiamo l’1,3% del Pil a causa
della malagiustizia: fanno 22 miliardi di euro. Anche Mario Draghi ha
riconosciuto che il Paese ha smesso di crescere anche per la lentezza della
giustizia civile: «La durata dei processi ordinari di primo grado supera i mille
giorni e colloca l’Italia al 157esimo posto su 183 nelle graduatorie stilate
dalla Banca Mondiale», disse da governatore della Banca d’Italia. Traduzione: è
arduo che una banca possa finanziare una piccola azienda - magari poco
conosciuta, come tutte le piccole aziende - senza una un sistema giudiziario che
dia affidamento e che garantisca sentenze in tempi ragionevoli. Del resto negli
anni Ottanta, secondo l’Istat, una procedura fallimentare durava in media
quattro anni, ora dura più di nove. Problema di risorse, dicono i magistrati,
come no: ma a parte che le toghe italiane hanno stipendi tra i più alti del
mondo (qualcuno dice i i più alti), lo Stato italiano per la giustizia spende
circa 70 euro per abitante (dati del Consiglio d’Europa) quando la Francia ne
spende 58 a parità di giudici e cancellieri. Gli addetti ai lavori queste cose
le sanno tutte, politici compresi: ma non c’è governo - anche perché i governi
sono sempre d’emergenza, per definizione - che non giudichi la questione
strutturale della giustizia come troppo rognosa per affrontarla come
meriterebbe. E poi porta male: la giustizia i governi li fa cadere, altroché.
Per il resto ci siamo abituati a considerare la giustizia come una variante del
palinsesto mediatico: si è adeguata ai tempi che corrono, spettacolarizzata, la
celebrità di un caso aumenta gli sforzi per risolverlo (a discapito di altri) e
le indagini con rilevanza mediatica sfociano spesso in pene sproporzionate. Da
qualche mese le Cemere Penali raccolgono firme per introdurre una vera
separazione delle carriere dei magistrati: ci fosse un giornale che lo scrive.
Anche il centrodestra ormai è fermo: Silvio Berlusconi ha cercato di cambiare le
cose, ma l’ha fatto male - sicuramente - e l’ha fatto per ragioni prima
personali e solo dopo pubbliche, ma almeno ci ha provato. Mentre il Pd, per
lustri interi, ha finto che i problemi della giustizia fossero il falso in
bilancio e il conflitto d’interessi di Berlusconi: difendendo anche la
magistratura più indifendibile pur di non regalare vittorie all’avversario. I
governi Renzi e Gentiloni sull’intoccabile Giustizia non hanno voluto grane (al
solito) e il fiato su collo dei pitecantropi grillini, a oggi, contribuisce a
una politica che sulla giustizia fa il pesce in barile: come se la definitiva
affermazione del populismo penale, in Italia, fosse un mero accidente
atmosferico, anzi, una colpa della «casta» che peraltro ha nella magistratura la
sua vera e fossilizzata regina. Ma non l’hanno capito, i grillini. Trent’anni
che ne parliamo, e ora vogliono candidare Davigo. Filippo Facci
Cittadini e magistrati. Di
chi sono i tribunali?
Scrive il 20 maggio 2017 Francesco Petrelli, Segretario Unione Camere Penali
Italiane. Non tutti sanno che ne suo progetto originario, risalente agli anni
’60, la pavimentazione del Tribunale di Roma, uffici, aule e corridoi, era
interamente costituita da “sampietrini”, i cubetti di porfido caratteristici
delle strade e piazze romane. Una scelta questa, discutibile sotto il profilo
pratico ed estetico, ma dotata di una straordinaria potenza evocativa: il luogo
della giustizia, non è un luogo separato dalla città, ma ne rappresenta
l’inevitabile continuazione. Le strade della città entrano all’interno del
tribunale che appartiene dunque a tutti i cittadini e non è dominio
incontrastato di una magistratura separata ed autocratica. Nel tempo la ragion
pratica ha prevalso sulla bella metafora del “foro” aperto alla città ed anonimi
pavimenti hanno sostituito i sampietrini. Da allora la distanza fra
la Giustizia ed il Paese si è fatta sempre più grande, procedendo di pari passo
con l’idea che i tribunali fossero dei “giudici”, che i palazzi di giustizia
fossero i luoghi nei quali i pubblici ministeri esercitavano il loro potere.
Difficile non pensare a questo percorso, non solo simbolico, che l’idea stessa
di giustizia ha disegnato negli ultimi decenni, quando apprendiamo dal diniego
apposto da alcuni importanti magistrati di poter raccogliere firme per la
proposta di legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere tra
magistratura inquirente e giudicante. A Firenze in particolare, la presidente
della corte d’appello ed il procuratore generale hanno giustificato la mancata
autorizzazione con non meglio precisate ragioni di sicurezza. Ed è difficile
immaginare quale pericolo possano costituire un cancelliere dello stesso
Tribunale, intento ad effettuare l’autentica delle firme di pacifici cittadini,
considerato che questi esercitano i loro più naturali diritti politici e quelli
la più tipica delle loro funzioni. Nei nostri Tribunali vi sono banche, uffici
postali, cartolerie, edicole e librerie, si raggiungono accordi e si firmano
contratti, ma non si sottoscrivono leggi che vogliono distinguere le carriere di
quel giudice e di quel procuratore generale. E’ bizzarro riflettere sulla
circostanza che l’iter di raccolta delle firme ha inizio con il deposito formale
del testo di legge di riforma di iniziativa popolare proprio all’interno del
“Tribunale Supremo”, in un aula della Corte di Cassazione, raccogliendo le firme
dei promotori, mentre ai cittadini dovrebbe essere preclusa la possibilità di
promuovere tale iniziativa in una normale aula di Tribunale. In ogni altro luogo
ma non lì. Resta la sensazione che questa proposta di legge che non fa altro che
realizzare un articolo della Costituzione rimasto inattuato, e avvicina il
sistema giudiziario italiano a quello degli altri paesi europei cui è del tutto
ignota quella “colleganza” tra giudici e pubblici ministeri, in fondo scopra un
nervo sensibile dell’organo giudiziario di questo Paese, da troppo tempo
adagiato sull’idea che la giustizia sia una cosa propria della magistratura, una
cosa da somministrare paternalisticamente ad ignari cittadini , fissata
su cardini di potere inamovibili, fondata su principi che le leggi umane non
devono e non possono mutare.
«Quella madre era malata: non doveva
stare in cella». Parla l’avvocato della donna detenuta
a Rebibbia che ha ucciso i due figli, scrive Simona Musco, il 23 Settembre 2018
su "Il Dubbio". Non avrebbe dovuto stare in carcere, Alice Sebesta, la 33enne di
origini tedesche che martedì, a Rebibbia, ha scaraventato violentemente i figli
giù per le scale del nido del carcere, uccidendo sul colpo la più piccola,
Faith, di 4 mesi, e ferendo in modo gravissimo Divine, di 19 mesi, per il quale
è stata decretata la morte cerebrale. La madre, attualmente sottoposta a
trattamento sanitario obbligatorio e piantonata nel reparto di psichiatria
dell’ospedale Pertini, non ha potuto dare l’ok all’intervento per l’espianto
degli organi. La donna, dicono oggi le cronache, «era stata più volte segnalata
per alcuni comportamenti, sintomatici di una preoccupante intolleranza nei
confronti dei due piccoli», tanto che il personale del carcere aveva segnalato
«la necessità di accertamenti anche di tipo psichiatrico», secondo quanto
contenuto in un documento firmato dal capo del Dipartimento di amministrazione
penitenziaria, Francesco Basentini, visionato dall’Ansa. Informazioni che al suo
legale, Andrea Palmiero, non sono state, però, mai comunicate. «L’istanza per
farle avere i domiciliari spiega al Dubbio l’avvocato, che ieri ha parlato di
nuovo con la donna in ospedale – è stata rigettata dal giudice per le indagini
preliminari come fosse acqua fresca. Se il ministro della Giustizia vuole capire
davvero come sono andate le cose allora lo invito a leggere questi documenti».
Avvocato, cosa sapeva dello stato di salute di
Alice prima che avvenisse la tragedia?
«No, in questi
20 giorni nessuno mi ha mai segnalato nulla. Non mi sono stati comunicati
episodi che lasciassero anche solo immaginare un epilogo del genere e non ho mai
letto la nota del Dap di cui si parla in queste ore. Se queste informazioni
dovessero rivelarsi vere, la cosa sarebbe davvero molto grave: avrei dovuto
certamente essere informato di certe circostanze. Invece non ho mai saputo nulla».
Lei aveva presentato istanza affinché la donna
andasse ai domiciliari. Come sono andate le cose?
«La mia
richiesta è stata rigettata per ben due volte. Nel primo caso si poneva un
problema effettivo: la donna, che non si trovava nel proprio paese, non aveva
una casa in cui poter eleggere domicilio, così la prima volta la mia istanza è
stata respinta. Mi sono impegnato per trovare una casa in cui potesse passare
questo periodo di custodia cautelare ai domiciliari e alla fine ci sono
riuscito. Così ho presentato per la seconda volta istanza, ad un nuovo giudice,
in quanto nel frattempo era cambiato. Ma, inspiegabilmente, è stata rigettata
una seconda volta, senza alcuna giustificazione a mio avviso plausibile: secondo
il gip, la difesa non aveva portato alcun elemento nuovo. In realtà, però,
l’elemento nuovo c’era: la casa, appunto. Non so davvero spiegarmelo».
Parliamo di com’è finita in carcere il 26
agosto scorso, quando è stata arrestata in flagranza. È possibile che per
spaccio di marijuana, con due figli piccolissimi dietro, si trovasse lì?
«Sicuramente
non possiamo parlare di un reato minore, per via dell’ingente quantitativo di
sostanza stupefacente che aveva con sé (10 chili nascosti in macchina tra i
pannolini dei bambini, ndr). Ma comunque parliamo di marijuana, in un periodo
storico in cui si sta andando verso la liberalizzazione… Non si tratta certo di
droghe pesanti, di cocaina o eroina. Ritengo che non potesse stare in carcere.
Io il domicilio alternativo l’avevo proposto, ma non è comunque servito. Ma al
di là di questo, nel caso in cui si fosse arrivati ad una condanna definitiva,
per questo reato la scarcerazione sarebbe stata obbligatoria. In ogni caso,
dunque, non avrebbe dovuto trovarsi lì».
Aveva già commesso altri reati?
«No, questo era
il suo primo arresto. Non stiamo parlando, quindi, di una persona recidiva, ma
di una persona che affrontava questa esperienza per la prima volta, in un paese
straniero, che non le apparteneva, per giunta. L’ho vista molto spaesata, com’è
comprensibile. Ma nulla poteva farmi pensare che le cose sarebbero andate a
finire in questo modo».
E dopo la tragedia come l’ha vista?
«L’ho vista
insofferente, depressa. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono andata a trovarla in
ospedale, ma di quanto ci siamo detti preferisco non dire nulla, perché domani (
oggi, ndr) ci sarà l’udienza di convalida e riferirò tutto al giudice. Di
sicuro, prima che si verificassero questi eventi non mi era stato fatto presente
nulla circa il suo stato di salute».
Durante i vostri colloqui non era emerso nessun
elemento che potesse anche solo lasciare immaginare, dunque?
«Lei non mi ha
mai detto nulla. Ero io a vederla sempre un po’ sofferente, ma in un colloquio
di dieci minuti sono poche le cose di cui si può parlare. Avevo notato che si
presentava sempre un po’ più trascurata, ma da qui a pensare che potesse
accadere una cosa del genere…»
Il ministro della giustizia ha sospeso i
vertici del carcere…
«Non so chi
abbia responsabilità, non tocca a me dirlo. So soltanto che questi bambini li
abbiamo pianti soltanto noi. Chi lavora in carcere vive gomito a gomito con
queste persone, con i detenuti, e non credo che le responsabilità si debbano
cercare lì o che non avessero a cuore queste persone. Invito, piuttosto, il
ministro ad andare a visionare il fascicolo con il rigetto dell’istanza di
carcerazione domiciliare. Vada a vedere lì se c’è qualcosa che non quadra».
Carcere e bambini: perché quello che si
fa non basta. Il caso della detenuta che ha ucciso i 2
figli a Rebibbia getta sale sulla ferita dei bimbi in prigione, scrive Barbara
Massaro il 20 settembre 2018 su "Panorama". "Ora almeno loro sono finalmente
liberi". Lo ha detto Alice S., 33 anni, di nazionalità tedesca, detenuta da
agosto presso il carcere di Rebibbia per essere stata colta in flagranza di
reato con 14 chili di marijuana. Lo ha detto a proposito della morte dei suoi
due figli, un bimbo di meno di due anni e una neonata. A ucciderli è stata lei,
la madre Medea di questa tragedia greca drammaticamente contemporanea. La donna,
interrogata dagli psichiatri del carcere, con fredda lucidità ha dichiarato:
"Sapevo che era in programma l'udienza davanti ai giudici del Riesame che
dovevano discutere della mia posizione. I miei figli intanto li ho liberati,
adesso sono in Paradiso". "Ora sono liberi". Per questa donna donare la vita è
stato meno importante che concedere la morte e piuttosto che trattenere i suoi
figli, nati liberi, in prigione ha preferito ucciderli gettandoli dalle scale
del nido carcerario in cui vivevano. Per il gravissimo episodio il Ministro per
la Giustizia Alfonso Bonafede ha sospeso la direttrice della sezione femminile
del penitenziario e la sua vice responsabili di non aver fatto abbastanza per
prevedere la tragedia. La donna - si legge in un documento firmato dal capo del
Dap, Francesco Basentini e riportato da Ansa "Era stata più volte segnalata per
alcuni comportamenti sintomatici di una preoccupante intolleranza nei confronti
dei due piccoli" e il personale in servizio presso il carcere aveva segnalato
"La necessità di accertamenti anche di tipo psichiatrico". Ad appurare
responsabilità ed eventuali omissioni ci penserà l'inchiesta giudiziaria già
avviata, quel che resta alla fine di questa storia è il dramma sempre attuale
dei bambini tra gli zero e i tre anni che, pur nati liberi, vivono i propri
primi mille giorni da detenuti.
Bambini in carcere. I bimbi uccisi dalla madre,
meno di due anni in due, dal 28 agosto alloggiavano all'interno del nido di
Rebibbia, uno dei 15 asili nido che si trovano nelle sezioni femminili
delle carceri italiane. A Rebibbia il nido si trova in una sezione distaccata.
Ogni cella ha una culla in legno per i bambini e in reparto ci sono una ludoteca
e una piccola cucina. I bambini sono assistiti da pediatri e terapeuti e anche
le madri sono sostenute dal supporto psicologico, o per lo meno dovrebbero
esserlo, ma comunque sempre di carcere si parla. In Italia al momento dietro le
sbarre ci sono 62 bambini figli di 52 madri detenute. La legge prevede che una
donna madre di bimbi molto piccoli venga tutelata nel suo diritto a mantenere la
genitorialità e per questo in Italia esistono 15 nidi all'interno delle
strutture carcerarie.
Gli Icam. Molto meglio delle ludoteche dietro le
sbarre, però, sarebbero di ICAM, istituti a custodia attenuata per madri. Il
problema è che in tutto il territorio nazionale sono solo 5. Si tratta di luoghi
che assomigliano più a una casa che a un carcere (pur essendolo a tutti gli
effetti) dove le madri sono sottoposte a una sorta di custodia domiciliare sotto
tutela dell'istituzione carceraria. Pur non potendo uscire dagli ICAM e pur
essendoci sbarre alle finestre e guardie fino a fine pena le madri possono
condurre un'esistenza tutto sommato normale e i bambini vivono in maniera meno
intensa il trauma del carcere. Il problema è che per gestire questi istituti
servono fondi che non ci sono e quindi restano nel ridicolo numero di 5 su
territorio nazionale. Ci sarebbe anche l'opzione delle case famiglia protette,
ma in questo caso va anche peggio visto che in Italia ce ne sono solo
due. Mancano strutture, investimenti e soprattutto volontà politico
istituzionale di costruirle.
Cosa dice la legge. Va precisato che una madre non
ha l'obbligo di portare il figlio in carcere con sé, ma spesso coloro che
scelgono questa opzione è perché sono sole al mondo e non saprebbero dove
lasciare le proprie creature. Si tratta di un problema non solo logistico, ma
anche etico ed educativo a proposito del quale esiste un'ampia giurisprudenza e
che coinvolge un intero nucleo famigliare che il carcere avrebbe il compito di
rieducare alla vita. Il problema è capire come. L'episodio di Rebibbia pone
l'accento, tra l'altro, sul dramma della depressione tra le neo-madri già
violenta per donne libere e ancora più drammatica con l'aggravante della
prigione. Perché si tratta di donne che hanno problemi con la giustizia penale,
ma che non perdono le prerogative genitoriali e lo Stato ha l'obbligo di
preservare il diritto del minore a vivere con la propria madre.
Un bimbo muore a Rebibbia. Che civiltà è
questa? Scrive Damiano Aliprandi il 19 Settembre 2018
su "Il Dubbio". Dramma nella sezione nido del carcere di Rebibbia. Una detenuta
tedesca ha tentato di uccidere i suoi figli: la neonata di 4 mesi è morta sul
colpo, per l’altro è in programma l’accertamento di morte cerebrale. Dramma
nella sezione nido del carcere di Rebibbia. Una detenuta tedesca ha tentato di
uccidere i suoi figli, di fatto, ristretti nel carcere: la neonata di 4 mesi è
morta sul colpo, l’altro, di due anni, ha lottato tra la vita e la morte
all’ospedale del Bambin Gesù ed ora è in programma l’avvio della procedura di
accertamento di morte cerebrale. Il ministro ha sospeso la direttrice e la
vicedirettrice della sezione femminile del carcere e inoltre il vicecomandante
del reparto di Polizia Penitenziaria. Prima di compiere il terribile gesto, la
donna ha atteso che le altre detenute sfilassero prima di lei per poi rimanere
in disparte e sbattere ripetutamente, con forza, il corpo dei suoi due bimbi per
terra. Una volta compreso quanto stava accadendo, sono intervenute alcune agenti
della polizia penitenziaria e diverse detenute rom per cercare di fermare la
furia della donna. La donna, 33 anni, nata in Germania ma di cittadinanza
Georgiana, era stata arrestata in flagranza di reato il 26 agosto scorso a Roma
per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi avrebbe
manifestato segnali di disagio nel ritrovarsi in carcere con una bimba di pochi
mesi e uno di appena due anni. Ma non solo, qualche giorno fa, la donna aveva
parlato con l’avvocato a cui aveva fatto presente di soffrire di depressione e
di non reggere la situazione carceraria. Appena giunta la notizia, il ministro
della giustizia Alfonso Bonafede si è dapprima recato al carcere per avere
chiarezza della situazione, dopodiché ha raggiunto l’ospedale per constatare le
condizioni di salute del bambino ricoverato in codice rosso. Il guardasigilli ha
subito avviato un’inchiesta interna volta a ricostruire l’esatta dinamica dei
fatti e ad accertare eventuali profili di responsabilità. A Rebibbia si è recata
anche il procuratore aggiunto Maria Monteleone, coordinatrice del pool dei
magistrati che si occupa dei reati sui minori. Avvierà una indagine per omicidio
e tentato omicidio. Sono in corso anche i rilievi tecnici dei carabinieri del
nucleo investigativo di via In Selci per ricostruire con esattezza la dinamica
dei fatti. A dare per prima la tragica notizia è Lillo Di Mauro, presidente
della Consulta penitenziaria e responsabile della struttura romana protetta per
le detenute madri “Casa di Leda”. «Ho appreso la notizia direttamente dai
volontari e operatori che operano nella struttura – spiega a Il Dubbio Di Mauro
-, e tutto il personale è sconvolto visto la loro attenzione alle questioni che
riguardano i bambini». Lillo Di Mauro ha colto anche l’occasione per dire a Il
Dubbio che questa tragedia si poteva evitare visto che i bambini – per legge –
non ci devono proprio stare in carcere. Si riferisce alla legge del 2011 la
quale prevede che le detenute madri devono scontare la pena con i loro figli
fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, non più solo fino al
terzo, ma non in carcere. L’intento della norma è di facilitare l’accesso delle
madri alle misure cautelari alternative. La pena deve essere quindi scontata in
istituti a custodia attenuata (ICAM), luoghi colorati, senza sbarre, a misura di
bambino. Sono però in media circa 60, in Italia, i bambini al di sotto dei tre
anni che ogni anno entrano in carcere con le mamme. In alcuni casi sono ospitati
in asili nido colorati, ma non tutte le strutture femminili riescono a garantire
questi spazi. E così capita anche che un bambino o una bambina debba crescere
dietro le sbarre, scontando la pena per una colpa che non ha commesso. Oltre
all’ICAM, sempre secondo la legge del 2011 si dovrebbe privilegiare la casa
famiglia protetta dove le donne che non hanno un posto possono trascorrere la
detenzione domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni. Sono dei veri e
propri appartamenti, le madri possono portare a scuola i figli, assisterli in
ospedale se sono malati. Niente sbarre, niente cancelli. Sono strutture inserite
nel tessuto urbano, possono ospitare un massimo di sei nuclei familiari e devono
rispecchiare le caratteristiche di una casa: spazi personali, servizi, luoghi
per giocare. Ad oggi ne esiste solo una, ed è proprio “Casa di Leda” inaugurata
un anno fa. La casa non a caso è intitolata a Leda Colombini, figura di
primissimo piano del Pci e, negli ultimi anni, strenuo difensore dei diritti
delle mamme detenute. Morì nel 2011, all’età di 82 anni, in seguito a un malore
che l’ha colpita nel carcere di Regina Coeli, dove stava svolgendo la sua
quotidiana opera di volontariato. Nel volontariato in carcere, come presidente
dell’associazione – tuttora attiva – “A Roma Insieme” aveva promosso numerosi
progetti a favore delle mamme detenute e, soprattutto, per i bambini fino a tre
anni reclusi nel carcere romano di Rebibbia con le loro madri. Il responsabile
della “casa di Leda” ha spiegato a Il Dubbio che la struttura è nata per
ospitare sei madri con bambini fino al decimo anno di età. «Ma da tempo –
denuncia Lillo Di Mauro – ne ospitiamo solo quattro, ci sono due posti liberi:
come mai alcune di quelle madri ristrette a Rebibbia non sono state fatte
giungere qui?». Il responsabile conclude con un auspicio: «Questa tragedia deve
sollecitare il parlamento a trovare la soluzione definitiva di questo problema
relativo ai bambini in carcere!».
Mai più bimbi in galera. Ma in Italia
sono almeno 60. È lunga la lista dei minori costretti
a vivere dietro le sbarre, scrive Simona Musco il 19 Settembre 2018 su "Il
Dubbio". Sessantadue bambini dietro le sbarre. Anzi 60 da ieri, dopo la morte
del bimbo di quattro mesi e il ferimento grave del fratellino di due anni, che i
medici stanno tentando di strappare alla morte. Numeri in crescita: a dicembre
2017 erano infatti 56 i minori costretti a vivere in carcere assieme alle
proprie madri, 37 a fine 2016. I dati, pubblicati sul sito del ministero
dell’Interno, fotografano la situazione in tutta Italia al 31 agosto. Nel nostro
paese si contano 2551 detenute, 52 delle quali vivono in compagnia dei propri
figli, troppo piccoli per allontanarsi dalle madri. Sono 15 gli istituti che
ospitano madri e figli: 27 sono italiane, in cella assieme a 33 bambini.
Venticinque le madri straniere, che si prendono cura in stato di detenzione di
29 bambini, in una condizione lontana anni luce da una normale infanzia. I
numeri più alti sono quelli di Rebibbia, dove ieri si è consumata la tragedia:
al “Germana Stefanini” sono presenti 16 bambini a seguito di 13 madri. Un
carcere sovraffollato, dove sono presenti 353 donne su 276 posti disponibili. A
seguire c’è il Lauro Icam – istituto a custodia attenuata per detenute madri -,
in Campania, con 12 bambini e 10 madri. Un istituto che rientra nelle strategie
stabilite dalla legge 62/ 2011, pensata per valorizzare il rapporto tra le madri
e i loro figli all’interno del penitenziario, in ambienti pensati come una casa-
famiglia, per tenere i bambini il più possibile lontani dal clima carcerario.
Anni dopo quella legge, però, sono soltanto cinque gli Icam attivati: Milano San
Vittore, da dove è partito il primo progetto e dove vivono quattro bambini con
le loro madri, Venezia Giudecca (dove sono presenti sei minori e cinque madri),
Torino “Lorusso e Cutugno” ( dove si trovano 10 bambini e sette madri), Cagliari
e, appunto, Avellino Lauro. E dove gli Icam non esistono, come nel caso di
Rebibbia, i bambini finiscono “reclusi”, fino ai 3 anni, nelle sezioni nido nei
penitenziari femminili. La legge rimane dunque attuata a metà, facendo, di
fatto, ricadere le colpe delle madri sui figli. Come nel “Giuseppe Panzera” di
Reggio Calabria, dove è presente una madre straniera assieme ai suoi due
bambini, il “Rocco D’Amato” di Bologna, con due madri straniere e due bambini,
il “Bollate” di Milano, con tre madri e tre bambini, e una madre con un bambino
a seguito negli istituti di Brescia, Foggia, Lecce, Sassari, Messina, Firenze e
Perugia. «La tragedia di Rebibbia ci ricorda il dramma dei tanti troppi –
bambini che crescono e vivono dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato,
da innocenti», ha commentato Mara Carfagna, vice presidente della Camera e
deputato di Forza Italia. Sette anni dopo la legge sull’istituzione degli Icam,
«sono solo cinque le strutture dedicate e insufficienti le case protette: troppi
bambini sono oggi condannati a crescere dietro le sbarre. È inaccettabile, oltre
che pericoloso. Forza Italia chiederà conto del ritardo accumulato negli anni –
ha concluso – e pretenderà che nella legge di Bilancio vengano stanziate le
risorse necessarie», conclude. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la collega di
partito e deputata Renata Polverini. «I bambini non devono pagare le colpe dei
genitori e non è giusto che vivano in certe realtà – ha commentato -. Esistono
case protette ma non sempre vengono utilizzate. Bisogna riflettere davanti a
certe tragedie e se il caso cambiare qualcosa nella legge». Sul caso, la
consigliera regionale del Lazio del Pd, Michela De Biase, ha chiesto di
ascoltare il VII Commissione welfare il garante dei detenuti e il garante
dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio. «Mi auguro si apra presto un
dibattito serio sulla presenza dei minori nelle carceri – ha dichiarato -. Le
istituzioni hanno il dovere di difendere e tutelare la vita dei minori».
La morte di Cucchi ha lasciato il segno
sulla nostra pelle. Successo e polemiche per il film
che racconta gli ultimi giorni del giovane ucciso in carcere, scrive Boris
Sollazzo il 19 Settembre 2018 su "Il Dubbio". «Quando smetterete di cadere per
le scale?». A chiederlo è un secondino, un agente di polizia penitenziaria.
«Quando smetteranno di picchiarci». A rispondere è Stefano Cucchi. Questo
dialogo è diventato una sorta di parola d’ordine sui social, copiato e incollato
ovunque, nelle discussioni fuori sui cinema o sui prati e nei centri sociali.
Sulla mia pelle, come non succedeva da anni – neanche per La grande
bellezza, che pure era entrato prepotentemente nel dibattito pubblico – ha
riportato un film all’interno della dialettica di un paese. Non si parla
d’altro, tutti vogliono vederlo. Un miracolo per una realtà marginale,
commercialmente e purtroppo culturalmente, come il cinema italiano. Ora tutti
sembrano darlo per scontato, eppure la storia di Stefano Cucchi poteva essere
respingente e quindi fallimentare. Tanti, troppi di fronte alle prime recensioni
positive, hanno reagito istintivamente con un “non so se ce la farò a vederlo”.
Lo stesso accadde per lo splendido Diaz di Daniele Vicari con cui Sulla mia
pelle di Alessio Cremonini condivide una fedeltà e un’onestà intellettuale verso
il materiale processuale e verso la ricerca della verità quasi insopportabile.
Ma rispetto a Diaz, che pure ebbe successo in Italia ( 2 milioni di incasso) e
fu venduto all’estero, ora c’è Netflix. Ovvero 130 milioni di utenti per 190
paesi e la novità di un’uscita contemporanea in streaming legale e in sala. Il
luddismo conservatore tipico di un’Italia pigra e corporativa ha reagito
violentemente: in particolare l’Anec e l’Anica, che l’hanno visto come un
attacco alla sacralità della sala. Senza capire, purtroppo, che l’enorme
visibilità e l’incredibile successo di questo film, anche in sala (seconda media
per sala delle ultime uscite), nasce proprio da quel pubblico raggiunto in poche
ore. Più che un passaparola, uno tsunami, sottolineato da quella commovente
seppur ambigua ondata di proiezioni gratuite pirata che non fanno altro che
aumentare il “mito” del film. Commovente, perché costituita da giovani avidi di
una storia dura, dolorosa, terribile, di farsi parte di un’indignazione civile.
Ambigua perché chi ha “approfittato” del film – che pure era stato messo a
disposizione di queste iniziative sociali dal 12 ottobre dai produttori con
l’avallo della famiglia Cucchi, che in proposito ha fatto un appello esplicito –
ha deciso di agire contro quel produttore, Lucky Red, che ha rischiato di suo
per raccontare quella storia che, “piratata”, potrebbe non convenire narrare ad
altri. Lo hanno fatto alla luce del sole (spesso troppa, tanto da non riuscire a
vedere le immagini sui lenzuoli appesi in questi immensi consessi) perché
sapevano che mai, visto il tema di quel film, avrebbe chiamato le forze
dell’ordine per impedirlo. E hanno fatto vedere un bellissimo film nelle
condizioni peggiori. Una storia italiana, fin troppo. Perché mentre Stefano
faceva tanti miracoli, dal far diventare di massa una storia che aveva trovato
l’attenzione mediatica solo grazie all’eroismo di Ilaria Cucchi, al far tornare
il cinema al centro di tutto, mostrandoci un pubblico avido di storie difficili
e impegnate, ci si dedicava al tafazzismo. Gli esercenti, per dire, hanno
pensato bene, in gran parte, di boicottare il film. E giustamente il loro
rappresentante, guarda un po’ quell’Andrea Occhipinti di Lucky Red che ha messo
parecchio di suo per costruire il film e poi ha puntato su questa doppia
distribuzione contemporanea, ha mollato. «Ho deciso di dimettermi perché la
nostra scelta di distribuire Sulla mia pelle di Alessio Cremonini in
contemporanea nelle sale e su Netflix ha creato molte tensioni tra gli esercenti
che lo hanno programmato (pochi) e quelli che hanno scelto di non farlo (
molti). II successo del film ha aumentato queste tensioni. Nonostante
esistessero dei precedenti in Italia e ci sia un acceso dibattito a livello
internazionale, non voglio che una scelta puramente aziendale venga considerata
come una posizione della sezione distributori dell’Anica, visto il mio ruolo.
Per non creare ombre o imbarazzo ai miei colleghi, ritengo quindi opportuno
lasciare la carica di Presidente». Una dichiarazione dura nella parte iniziale e
solo apparentemente conciliante nella seconda che fa capire quanto sia lontano
il mondo dell’industria cinematografica non solo dalle esigenze del pubblico
(altrimenti quelle sale indegne le terrebbero meglio) ma addirittura dalla
propria stessa convenienza. Senza Netflix, senza i pirati sociali, senza la fame
di questa storia alimentata di ora in ora, non ci sarebbe stato questo clamoroso
successo di pubblico (non economico, ed essendo il cinema anche un’industria, è
un problema) e questa penetrazione nell’immaginario collettivo. Merito di
Alessandro Borghi, che ha il talento cristallino dei migliori interpreti
americani degli anni ’ 70 e una modernità di sguardo e recitazione straordinari,
della scrittura limpida e tesa di Lisa Nur Sultan, della regia impietosa di
Alessio Cremonini, di un Max Tortora sontuoso e di una Jasmine Trinca come
sempre perfetta. Ma soprattutto di Stefano Cucchi. Che ha lasciato abbastanza
semi per far germogliare una storia tragicamente vera, spudoratamente onesta,
raccolta da chi non ne ha voluto fare un santo, pur essendo morto da martire.
Questo non è solo un film. Stefano Cucchi siamo noi, per questo lo sentiamo
tanto sulla nostra pelle. Stefano, e quindi Alessandro, è tutti noi che le
abbiamo prese da chi avrebbe dovuto proteggerci, tutti voi che potreste ogni
giorno inciampare in scale che non smettono di picchiarvi. Quest’omicidio di
stato ci rimane tatuato addosso nella sua verità, nella disperazione di un
ragazzo indifeso che sbaglia troppe scelte e muore perché non trova rami a cui
aggrapparsi. Non smettiamo di andarlo a vedere. Sosteniamo il film, sosteniamo
la famiglia Cucchi che rimane uno dei pochi motivi per essere fieri di essere
italiani. Continuiamo a sentire questa ingiustizia, questa infamia sulla nostra
pelle. Ogni giorno, ogni volta che avremo la tentazione di voltare lo sguardo
dall’altra parte. Perché Stefano ha cominciato a morire per le botte di quei
carabinieri, ma il colpo di grazia l’ha ricevuto dall’indifferenza complice di
tutti coloro, con camici e divise e toghe, che non lo hanno aiutato e difeso.
Solo facendo valere i suoi diritti. Abbiamo il dovere di non rimanere
indifferenti. E di andare in sala, perché non si smetta di raccontare le storie
che non vorremmo vedere. Ma dobbiamo.
E Grillo pubblica la lettera di Musumeci
al Guardasigilli. Beppe Grillo ha pubblicato sul suo
blog una lettera dell’ergastolano Carmelo Musumeci rivolta al ministro della
giustizia Alfonso Bonafede, scrive Damiano Aliprandi il 4 Agosto 2018 su "Il
Dubbio". Mentre il governo legastellato svuota il pilastro principale della
riforma dell’ordinamento penitenziario che punta all’allargamento delle pene
alternative, Beppe Grillo – il padre del Movimento Cinque Stelle – ha pubblicato
sul suo blog, per la seconda volta, un contenuto critico al sistema
carcerocentrico. Questa volta apre alla messa in discussione dell’ergastolo e
dell’utilità del 41 bis. Lo fa pubblicando una lettera dell’ergastolano Carmelo
Musumeci rivolta al ministro della giustizia Alfonso Bonafede. «Qualche giorno
fa ho ricevuto questa mail da Carmelo Musumeci, un ergastolano attualmente in
semilibertà. Ha indirizzato la sua lettera al ministro della Giustizia, Alfonso
Bonafede, e in copia a me. Voglio condividerla con voi perchè so che sarà
sicuramente fonte di grande dibattito», così introduce la lettera
dell’ergastolano. «Continuo comunque a lottare scrive Musumeci nella lettera
contro la pena dell’ergastolo, perché io sono l’eccezione che con- ferma la
regola e, purtroppo, stando così le cose, molti miei compagni usciranno solo
cadaveri dalle loro celle». Per eccezione, Carmelo, intende che dopo più di un
quarto di secolo di carcere duro, sono ormai 20 mesi che è sottoposto al regime
di semilibertà, anche se il suo fine pena rimane, come per tutti gli
ergastolani, il 31 dicembre 9999. Si rivolge al ministro chiedendo cosa ne pensa
della pena dell’ergastolo. «Non crede – scrive l’ergastolano – che pretendere di
migliorare una persona per poi farla marcire dentro sia una pura cattiveria?
Anche perché in carcere se uno rimane cattivo soffre di meno». Sottolinea al
ministro che una persona in carcere «dovrebbe perdere solo la libertà e non la
dignità, la speranza, la salute, l’amore e, a volte, anche la vita». Musumeci
spiega che «quasi sempre si finisce in questi posti per avere commesso dei
reati, ma poi nella maggioranza dei casi si va, di fatto, in un luogo che nega
la legalità e dove la legge infrange la sua stessa legge». L’ergastolano
denuncia le condizioni del carcere che «in Italia sembra di stare in un
cimitero, con molti detenuti nelle brande sotto le coperte a guardare i
soffitti, imbottiti di psicofarmaci». Aggiunge che molti di loro «non sono
ancora morti, anche se a volte ci comportiamo come se lo fossimo. Il carcere ti
lascia la vita, ma ti divora la mente, il cuore, l’anima e gli affetti che fuori
ti sono rimasti». E quelli che riescono a sopravvivere? Musumeci scrive nella
lettera rivolta a Bonafede che «una volta fuori, saranno peggio di quando sono
entrati». L’ergastolano insiste sull’inutilità delle carceri e di come
incattiviscono le persone. Un pensiero che rispecchia esattamente quello di
Grillo quando pubblicò l’articolo contro l’istituzione carceraria. Poi denuncia
il carcere duro. «Cosa c’entra la sicurezza sociale con tutte le privazioni
previste dal regime di tortura del 41 bis?», scrive sempre Musumeci. «Io credo
che alla lunga – sottolinea l’ergastolano – il regime di tortura del 41bis, e
una pena realmente senza fine come l’ergastolo ostativo, abbiano rafforzato la
cultura mafiosa, perché hanno innescato odio e rancore verso le Istituzioni
anche nei familiari dei detenuti. Penso che sia davvero difficile cambiare
quando sei murato vivo in una cella e non puoi più toccare le persone che ami,
neppure in quell’unica ora al mese di colloquio che ti spetta. Con il passare
degli anni i tuoi stessi familiari incominciano a vedere lo Stato come un nemico
da odiare e c’è il rischio che i tuoi figli, che si potrebbero invece salvare,
diventino loro stessi dei mafiosi» . Parla della funzione rieducativa espressa
dalla nostra Costituzione, che si oppone alla vendetta. «E la pena – scrive
l’ergastolano non deve essere certa, ma ci dev’essere la certezza del recupero,
per cui in carcere un condannato dovrebbe stare né un giorno in più, né uno in
meno di quanto serva. Io aggiungo che ci dovrebbe stare il meno possibile, per
non rischiare di farlo uscire peggiore di quando è entrato». L’intento di
Musumeci è far venire qualche dubbio al ministro. Così come, pubblicando la
lettera, vuole farlo venire anche Beppe Grillo.
Carmelo Musumeci scarcerato, era
all’ergastolo ostativo. Per i giudici che gli hanno
concesso la liberazione condizionale, Carmelo Musumeci è un'uomo “nuovo”, scrive
il 17 Agosto 2018 "Il Dubbio". Con un provvedimento “storico”, il Tribunale di
Sorveglianza di Perugia ha concesso la liberazione condizionale a Carmelo
Musumeci, condannato all’ergastolo ostativo per reati di criminalità organizzata
e in carcere dall’ottobre del 1991. A dare notizia della scarcerazione è lo
stesso Musumeci ieri sul suo profilo Facebook: ‘ L’altro ieri ho ricevuto una di
quelle telefonate che ti cambiano la vita. Il numero era quello del carcere di
Perugia. Mi avvisano di rientrare in carcere perchè devo essere scarcerato’. Per
i giudici che gli hanno concesso la liberazione condizionale, Carmelo Musumeci è
un ‘ uomo nuovo’, com’è testimoniato anche dal fatto che persegue il suo ‘
riscatto dal passato impegnandosi quotidianamente ad assistere la disabilità’ in
una casa famiglia. Nella decisione, il Tribunale della Sorveglianza di Perugia
argomenta il provvedimento col quale viene concessa la liberazione condizionale
a un ergastolano ostativo evidenziando pure "il percorso di grande crescita
personale che ha portato Musumeci a leggere e studiare in carcere con granitica
volontà, così da lasciarsi alle spalle la mera licenza elementare posseduta
all’avvio della detenzione per fregiarsi di tre lauree". Musumeci, si legge
ancora nel provvedimento, ‘ è inoltre divenuto scrittore e conferenziere,
principalmente sulle tematiche dell’ergastolo ostativo e in tale veste collabora
con studenti universitari delle facoltà giuridiche che a lui si rivolgono’.
Maria Brucale, avvocato ed esponente dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”
spiega all’Agi la portata del provvedimento firmato dai giudici umbri: "Non mi
risultano altre casi di liberazione condizionale concessi a ergastolani
ostativi. Musumeci godeva già della semilibertà da due anni, dopo che i giudici
avevano riconosciuto l'inesigibilità della collaborazione”. È una notizia
meravigliosa, un grido di speranza nel buio. Gli ergastolano ostativi, a
differenza di quelli comuni, non hanno diritto a benefici penitenziari in
assenza di una condotta collaborante con la giustizia, salvo i casi, rari, in
cui venga riconosciuta l’inesigibilità della collaborazione. Musumeci durante il
periodo di semilibertà lavorava di giorno in una casa famiglia di don Oreste
Benzi e di notte faceva rientro in carcere. Ora, con la decisione dei giudici
non dovrà invece far rientro dietro le sbarre, ovviamente rispettando le
prescrizioni imposte. L’ex boss della Versilia, 63 anni, entrato in carcere con
la licenza elementare ne esce con due lauree, una in Legge e l’altra in
Sociologia. Tra le sue opere anche “L’urlo di un uomo ombra”. Nei giorni scorsi,
ha scritto una lettera sul tema del carcere al ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede, pubblicata anche dal blog di Beppe Grillo. ‘ Non si può educare una
persona tenendola all’inferno per decenni – le parole di Musumeci – senza dirle
quando finirà la sua pena. Lasciandola in questa situazione di sospensione e
d’inerzia la si distrugge e dopo un simile trattamento anche il peggior
assassino si sentirà innocente’’.
Con il suo blog dalla prigione (i testi erano
affidati a persone a lui vicine che provvedevano a pubblicarli in rete) e alcuni
libri, uno scritto col costituzionalista Andrea Pugiotto, Musumeci è diventato
la voce degli “uomini ombra”, cioè i reclusi la cui pena detentiva coincide con
la durate della vita e una data che non lascia speranze: 31/12/99999.
Musumeci: «All’ergastolo il carcere da
medicina diventa malattia», scrive Damiano Aliprandi
il 19 Agosto 2018 su "Il Dubbio". «Mi sono sentito l’uomo più felice
dell’universo il giorno che mi è arrivata la telefonata dal carcere di Perugia
per dirmi che devo essere scarcerato». È Carmelo Musumeci a spiegare a Il
Dubbio quei momenti inaspettati visto che aveva perso ogni speranza per ottenete
la liberazione condizionale attraverso l’accertamento della cosiddetta
“collaborazione impossibile”. Ha varcato la soglia del carcere fin dal 1991 con
una condanna all’ergastolo ostativo. La scadenza della pena è fissata al 31
dicembre 9999, mentre anni fa si scriveva: fine pena mai. Il che vuol dire la
stessa cosa. Musumeci ha attraversato dure prove durante gli anni di prigionia.
Il 41 bis, le celle di isolamento a causa della sua ribellione al sistema
carcerario, si è trovato a combattere non solo contro l’istituzione
penitenziaria, ma anche contro diversi detenuti che, appartenendo alla cultura
mafiosa, mantenevano l’ordine, quello di subire e basta, senza rivendicare i
diritti. Un percorso che l’ha portato a creare relazioni con il mondo esterno,
quello della cultura e della politica. È riuscito a creare un ponte con
l’esterno, ha scritto diversi libri con prefazioni autorevoli della comunità
scientifica come Margherita Hack o Umberto Veronesi. Ha intrapreso dialoghi con
Agnese, la figlia di Aldo Moro. È entrato con la licenza elementare ed è uscito
con tre lauree. Ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti dell’inutilità della pena come l’ergastolo, in particolare quello
ostativo che non permette l’accesso ai benefici o alla libertà salvo rare
eccezioni e dove si può cambiare la sua condizione solo diventando collaboratore
di giustizia. Carmelo ha sempre rifiutato quest’ultima opzione. Ma perché? Nel
1990 fu vittima di un agguato teso dal clan rivale. Fu raggiunto da sei colpi di
arma da fuoco, riuscì miracolosamente a salvarsi. Dopo essersi rimesso in sesto,
assieme ad altri componenti della banda, organizzò la vendetta e la portò a
compimento. Viene arrestato nel ‘ 91 e condannato all’ergastolo ostativo. Se
solo avesse voluto, ne avrebbe fatti meno di anni. «Ma avrei messo un altro al
mio posto e non me lo sarei mai perdonato», spiega Musumeci. Due anni fa aveva
ottenuto la “collaborazione impossibile”: i reati per cui è stato arrestato,
infatti, erano finiti in prescrizione. Fare i nomi non sarebbe comunque più
servito. Così era riuscito ad ottenere la semilibertà. Oggi, finalmente, è in
libertà condizionale grazie alla tenacia del suo avvocato Carlo Fiorio, un
professore straordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli
Studi di Perugia che fu anche relatore della tesi di laurea di Musumeci proprio
sull’ergastolo ostativo che non a caso era intitolata “la pena di morte viva”.
La scarcerazione è stata una notizia
inaspettata?
«Il passo
successivo alla semilibertà, ottenuta due anni fa, è l’ottenimento della libertà
condizionale. Ho provato a fare l’istanza già due volte, e tutte e due è stata
rinviata soprattutto per un ostacolo».
Quale?
«Il
risarcimento. È uno dei requisiti per ottenere la liberazione anticipata. Per
rimuovere quell’ostacolo ho dovuto rinunciare al risarcimento di 28mila euro che
avevo ottenuto per le condizioni disumane e degradanti che ho subito negli anni
90 nel famigerato carcere dell’Asinara. Sì, lo so, è paradossale che da una
parte il ministero della Giustizia ti risarcisce, ma dall’altra si riprende i
soldi. Però l’ho fatto ben volentieri pur di ottenere la libertà e dimostrare,
con un comportamento concreto, il ravvedimento anche lasciando allo Stato i
soldi che mi spettavano».
Ora lei vivrà in libertà, ma per cinque anni a
determinate condizioni. Come si vede proiettato nel futuro?
«Sì, ovviamente
in questi cinque anni dovrò firmare un giorno a settimana alla caserma dei
carabinieri di Bevagna (comune della provincia di Perugia ndr.), non mi posso
ovviamente allontanare dalla provincia, posso uscire al mattino alle 6 e
rientrare alle 10. Non è una libertà piena, ma finalmente vivo fuori dal carcere
e dimoro presso la comunità Papa Giovanni XIII di don Benzi. In questi cinque
anni continuerò a fare il volontariato presso la comunità e lo faccio ben
volentieri perché è un modo anche per rimediare al male causato facendo del
bene. Finiti i cinque anni, l’ergastolo sarà estinto e in quel momento chiederò
la riabilitazione per poi – è il mio sogno – aprire uno studio legale che si
occupi dell’esecuzione penale. Il mio scopo è quello di continuare ad aiutare –
questa volta fuori dalle mura – soprattutto gli ergastolani che sono dentro fin
da quando erano giovanissimi».
Facciamo un enorme passo indietro. Lei è
entrato in carcere nel ‘91. Come ha acquisito la coscienza che l’ha portata a
intraprendere la battaglia contro l’ergastolo?
«Deve sapere
che ero un delinquente anomalo. Fin da giovane ero un ribelle, simpatizzavo per
la sinistra ed ero molto vicino agli ideali anarchici. Ma a causa di certe
condizioni ambientali ero finito per fare il delinquente. Dal momento che mi
hanno dato l’ergastolo è scattato un meccanismo mentale paradossale. “Finalmente
posso essere me stesso perché non ho nulla da perdere visto che la società mi ha
condannato ad essere colpevole per sempre”, mi dicevo. Da lì che è cominciata
una mia crescita interiore. Ma essere se stessi, in carcere la paghi cara».
Perché?
«Se studi, ti
arricchisci, cominci ad acquisire strumenti che ti permettono di riconoscere i
propri diritti, ti scontri inevitabilmente con l’istituzione carceraria. Anche
per questo motivo, per me, furono anni duri, difficili, venivo spesso punito
perché facevo istanze, reclami, chiedevo ai parlamentari di entrare in carcere
per fargli comprendere quello che accadeva, soprattutto all’Asinara. Ma mi sono
dovuto scontrare anche con i miei compagni».
Quindi lei si scontrava anche con i detenuti?
«Sì. Molti di
loro entravano in carcere già “istituzionalizzati”. Non dallo Stato, ma dalla
cultura mafiosa che è volta all’ubbidienza e all’ordine. Mi ritrovai a
scontrarmi con alcuni boss mafiosi, perché io pretendevo che ci ribellassimo
tutti insieme alle torture che subivamo all’Asinara. Loro invece no,
rispondevano che avrebbero subito le umiliazioni e torture a testa alta. Io pur
essendo stato un delinquente, avevo acquisito una coscienza ribelle durante le
sommosse degli anni 70 che avvenivano anche negli istituti penali minorili. Deve
sapere che a 15 anni mi sono fatto il primo carcere: il minorile di Marassi per
una rapina in un ufficio postale. Noi stavamo al piano terra, i maggiorenni al
primo piano. Uscii peggio di prima. A 16 anni rapinai una bisca clandestina con
due amici. Poi ne sono diventato socio. E da lì è iniziata la mia carriera
criminale. Ritornando al discorso del mio scontro contro tutti all’interno del
carcere, erano momenti che mi ritrovai solo: sia contro la ferocia di quel tipo
di Stato, sia contro quelli che rappresentavano “l’antistato”. L’atteggiamento
dei boss mafiosi, paradossalmente, convenivano alla direzione del carcere.
Quando venivano i parlamentari a far visita ispettiva, le uniche denunce
arrivavano da me e pochi altri».
A proposito di solitudine, quando è nato il
primo ponte con l’esterno, soprattutto per rendere visibili le sue battaglie
contro l’ergastolo ostativo?
«I primi furono
gli anarchici che dimostravano solidarietà fuori dal carcere di Spoleto o di
Nuoro. Attraverso volantini e comunicati pubblicati tramite internet davano voce
agli scioperi della fame degli ergastolani che organizzavo. Ero isolato da tutti
e da tutto. Quindi gli devo molto. E poi pian piano sono riuscito a crearmi
delle relazioni con altre personalità del mondo libero».
La svolta è stata il suo contatto con
un’associazione cattolica.
«Sì, la
comunità Papa Giovanni XIII di don Oreste Benzi. Parliamo del 2007 e tutto
nacque con un incontro. Pensi che io ero – e lo sono tuttora – un ateo convinto
e avevo dei pregiudizi nei confronti dei cattolici. Li consideravo dei “buoni”
che andavano a messa e prendevano la comunione. Tutto lì. Era il periodo che
provocatoriamente avevamo raccolto petizioni per chiedere di tramutare
l’ergastolo ostativo in pena di morte. Quel giorno, al carcere di Spoleto,
organizzammo un convegno e si presentò don Oreste Benzi. Lo sfidai ad appoggiare
lo sciopero della fame promosso da ergastolani mafiosi. Io, che dei preti non mi
fidavo, pensavo che avrebbe risposto di no, invece mi spiazzò perché,
sorridendo, accettò immediatamente. Assieme a lui c’erano altri membri della
comunità come Nadia Bizzotto, e don Benzi disse loro di appoggiarci e seguirci.
Fu lì che si realizzò un grande ponte verso la società esterna e nello stesso
tempo, per la prima volta, mi sentii davvero un “colpevole”. Questo accade
quando una parte della società ti prende in considerazione e vuole aiutarti
nonostante il danno che hai causato».
Lei dice che l’ergastolo è inutile perché è
“pena di morte viva”, però lei alla fine ce l’ha fatta a liberarsi.
«L’ergastolo
non serve a nulla. Se non hai la speranza di uscire prima o poi, ti dimentichi
di essere colpevole e ti ritieni una vittima. Il carcere all’inizio dovrebbe
essere una medicina ma a lungo andare diventa una malattia. Io sono un caso
eccezionale, ma che conferma la regola. Voglio dire agli ergastolani che sono
entrati a 19 anni e sono invecchiati dentro quelle mura che devono lottare, non
devono delegare, ma combattere in prima persona partendo dall’istruzione, la
lettura dei libri, acquisire una coscienza e liberarsi anche da quell’idea che
loro si sentono meno colpevoli di tanti altri detenuti che magari hanno commesso
altre atrocità. Ci vuole un cambiamento culturale anche tra i detenuti, non solo
dall’alto».
Durante tutti questi anni di prigione, ha mai
pensato al suicidio?
«È inevitabile
pensarci, soprattutto in quei momenti di sconforto, oppure quando sei in
isolamento e ti tolgono tutto. Quando non vedi nessuna via di uscita, pensi di
farla finita. Questa sofferenza aumenta ancora di più quando acquisisci una
coscienza, ti istruisci, ti alimenti di cultura. In quel momento ti senti
diverso dagli altri. Farsi la galera dopo aver acquisito una certa sensibilità,
non solo soffri per te stesso, ma anche per gli altri. A volte reagivo io per
loro e questo mi portava scontri con le direzioni delle carceri. Io ci ho
pensato al suicidio e ricordo di averlo fatto capire alla mia compagna. Lei me
lo vietò, perché mi fece capire che avrei fatto del male a lei e ai miei figli.
Non sarebbe stato giusto».
In cella 7 anni dopo il reato: la
prescrizione è davvero inutile? Il caso di uno chef e
di una accusa controversa di violenza sessuale, con la condanna definitiva
l’uomo ha perso tutto, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 19 Agosto 2018 su "Il
Dubbio". La certezza della pena: la storia di S. B. dovrebbe far riflettere
tutti quelli che la invocano come panacea dei mali che affliggono il sistema
giudiziario italiano. S. B è uno chef che ha appena compiuto 50 anni. Nato a
Venezia, fin da giovane ha avuto una grande passione per la cucina, e ha
lavorato in molti ristoranti in Italia e all’estero. Trasferitosi a Parma agli
inizi del 2000, decide di fare il grande passo e di mettersi in proprio aprendo
un ristorante di pesce nella patria del prosciutto e del parmigiano. Il successo
è immediato. Nonostante il locale sempre pieno, come tutti gli chef, anche S. B.
dopo qualche tempo sente il bisogno di rimettersi in gioco e di tentare
l’avventura altrove. Nella primavera del 2011 la scelta dunque di vendere il
locale di Parma per aprirne uno alle Cinque Terre. La trattativa si rivela
alquanto complicata. L’acquirente, una donna della città emiliana, tergiversa,
tratta sul prezzo, allunga i tempi. S. B ha invece fretta, avendo già versato un
importante acconto per il nuovo ristorante in Liguria. Quei soldi sono quindi
indispensabili. Una sera di giugno di quell’anno, quando sembra che finalmente
tutto si è sistemato, la donna ci ripensa e si presenta nel ristorante per
comunicarglielo. La discussione è molto accesa. Volano parole grosse. S. B. alza
anche le mani. La donna esce dal locale e corre subito dai carabinieri. «S. B.
l’ha violentata», scrivono i militari, allegando il referto del pronto soccorso
che parla di «abrasione ad un braccio». Passano solo pochi giorni e S. B. si
ritrova nel carcere di massima sicurezza di Parma. «Tentata violenza sessuale»,
l’accusa riportata sull’ordine di custodia cautelare. Inutili i tentativi di
difendersi. La parola della donna contro quella di S. B. E poi quel referto
medico. Dopo alcuni mesi trascorsi in carcere, i domiciliari. Poi l’obbligo di
dimora. Finché agli inizi del 2012 S. B. è completamente libero. Il progetto di
trasferirsi alle Cinque Terre è rimasto nella testa di S. B. ed è difficile
rimanere a Parma dopo quanto successo. Il sogno di avere un locale nel frattempo
è sfumato e i soldi dell’anticipo definitivamente persi. Arriva l’estate e S. B.
riparte dalla cucina di un ristorante vicino al porto di La Spezia come aiuto
cuoco con un contratto a chiamata. Le indagini si chiudono nel 2014. Il processo
inizia l’anno dopo. Arriva la condanna in primo ed in secondo grado: 4 anni e
mezzo. Nel frattempo S. B. si è sposato, ha comprato casa con un mutuo, ed è
tornato a fare lo chef in un importante ristorante delle Cinque Terre. Ma agli
inizi di quest’estate la Cassazione conferma la sentenza di condanna. Nonostante
il “presofferto”, S. B. deve andare in carcere: i reati di violenza sessuale non
ammettono la sospensione dell’ordine di esecuzione. I carabinieri lo vengono a
prendere all’alba della scorsa settimana. Secondo la legge deve effettuare un
percorso di rieducazione, dietro le sbarre. Anche se S. B. il percorso di
rieducazione in questi anni l’ha già fatto da solo: si è sposato, ha rifatto la
gavetta fino a guadagnarsi un lavoro a tempo indeterminato (un miraggio di
questi tempi), ha comprato casa. Ieri S. B. è stato licenziato: la moglie, a
carico, sta cercando urgentemente lavoro. La richiesta alla banca di sospensione
del mutuo verrà presentata oggi. Ultima nota. Il ristorante in cui S. B.
lavorava è rimasto senza chef proprio nel periodo clou della stagione. La
certezza della pena.
Benedetto, recluso a
Rebibbia ma lui non sa neanche il perché.
Si trova detenuto nel poliambulatorio di Rebibbia, condannato a quattro anni in
contumacia, ha un problema cognitivo, scrive Damiano Aliprandi il 30 giugno 2018
su "Il Dubbio". «Ho visitato numerose carceri in tutti questi anni, ma non ho
mai visto un caso del genere». Così denuncia a Il Dubbio Irene Testa, membro
della presidenza del Partito Radicale, a proposito della visita al carcere di
Rebibbia effettuata assieme a Maria Antonietta Farina Coscioni. Una visita
particolare perché indirizzata ad una sezione specifica del carcere, il
poliambulatorio. Un reparto, quello del G14, nel quale vi sono reclusi detenuti
malati, disabili, anche con sofferenze psichiche evidenti. Tra loro c’è l’ex
senatore Marcello Dell’Utri che è gravemente malato, così come tanti altri
ristretti che potrebbero scontare una pena alternativa al carcere. Ma è anche
emerso un caso di uno che non sa nemmeno perché si trova in carcere ed ha 4 anni
da scontare. «A differenza degli altri detenuti che hanno sempre qualcosa da
chiedere e segnalare – spiega Irene Testa –, non diceva nulla. I suoi compagni
di cella hanno insistito perché ci parlassi». L’esponente radicale sottolinea
che si era resa conto da sola che qualcosa non andava in lui, perché aveva lo
sguardo assente. È un ragazzo e si chiama Benedetto. «Mi sono trovata davanti
non un tossico – continua Irene Testa -, non un malato con problemi
psichiatrici, non un delinquente, ma un ragazzo, orfano e senza altri familiari
che si occupino di lui, che a seguito di un incidente occorsogli in giovane età
ha un grave ritardo mentale con invalidità annessa». Ovviamente è tutto da
verificare visto che non hanno potuto accedere alla sua documentazione, ma la
storia che emerge, se confermata, ha dell’incredibile. Benedetto forse era stato
raggirato, una firma a sua insaputa e denunciato per questo. Al processo non si
sarebbe presentato, perché neanche sapeva dove si sarebbe dovuto recare.
«Secondo il suo racconto – spiega l’esponente radicale Irene Testa – è stato
quindi condannato a quattro anni in contumacia». Quindi senza che il giudice lo
abbia visto. «Credo che se l’avesse visto -, il magistrato avrebbe capito che
qualcosa in lui non andava, un evidente ritardo mentale e che quindi non sarebbe
stato in grado di firmare coscientemente».
Benedetto è solo, non ha
nessuno. La madre, unico familiare rimasto, sarebbe morta qualche anno fa.
Sembrerebbe che sia stato difeso da un avvocato d’ufficio, ma che non avrebbe
mai visto di persona. Una storia, ripetiamo se confermata, parla di un buco
nero, la scomparsa del mondo esterno e lui, rinchiuso là dentro, in carcere,
senza saperne il motivo e senza sapere che cosa gli aspetta. Irene Testa, che
tra l’altro è candidata a Garante dei Detenuti della Regione Sardegna, ha
denunciato questa storia prendendo spunto da un post su Facebook pubblicato dal
grillino Alessandro Di Battista dove si legge che al primo posto vengono i
diritti economici, prima ancora di quelli umani e civili. «Una vicenda come
questa – denuncia l’esponente radicale – fa capire l’importanza dello Stato di
Diritto e che i diritti in generale non diventino di serie A e di serie B». Ora
del caso di Benedetto, anche per verificarne la veridicità della sua narrazione,
se ne sta occupando il garante dei detenuti della regione Lazio Stefano
Anastasìa. Un intervento autorevole che servirà per attivare tutte le garanzie
del caso. Può finire in prigione, 4 anni di carcere da scontare, una persona che
probabilmente presenta dei problemi cognitivi?
DENUNCE A PERDERE.
«Mio figlio curò zu Binnu per questo fu
ucciso», scrive Errico Novi il 18 Agosto 2017 su "Il
Dubbio". La madre di Attilio Manca contro la pronuncia che afferma la morte per
overdose dell’urologo. Lunedì scorso la giudice del Tribunale di Viterbo Silvia
Mattei ha depositato la sentenza con cui si stabilisce che la morte del dottor
Attilio Manca fu procurata da Monica “Monique” Mileti, la donna che gli procurò
due dosi fatali di eroina. Una sentenza che esclude la pista che legherebbe il
suo destino a un’assistenza medica segretamente assicurata a Provenzano. Ma la
madre del medico non si arrende: «Un pentito attendibile ha detto che Attilio è
stato ucciso per aver assistito Provenzano». Certo qualche iperbole scoraggia.
Ad esempio le parole con cui Antonio Ingroia grida la sua verità: “Attilio Manca
è una vittima di Stato e di mafia, ma lo Stato non può e non vuole ammetterlo”.
Eppure la storia di questo giovane e brillante medico trovato morto, per
overdose secondo i giudici, a 34 anni il 12 febbraio 2004, lascia ancora qualche
zona d’ombra. Lunedì scorso, alla vigilia di Ferragosto, la giudice del
Tribunale di Viterbo Silvia Mattei ha depositato la sentenza con cui si
stabilisce che Monica “Monique” Mileti procurò a Manca le due dosi fatali di
eroina. La 58enne è stata dunque condannata a 5 anni e 4 mesi di reclusione in
primo grado. Con la verità giudiziaria affermata dal magistrato, per l’urologo
di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, verrebbe esclusa la pista
che legherebbe il suo destino a un’assistenza medica segretamente assicurata a
Bernardo Provenzano. Ma oltre a Ingroia, avvocato della famiglia Manca insieme
con il collega Fabio Repici, è la madre del medico, Angela, a non arrendersi:
“Il pentito barcellonese Carmelo D’ Amico”, ha scritto la donna su facebook, “ha
detto che Attilio è stato ucciso per aver assistito Provenzano: è molto
attendibile e tutto quello che ha detto fino ad oggi è stato regolarmente
verificato. Che motivo avrebbe a mentire sull’omicidio di Attilio? ”. Secondo la
famiglia, l’urologo sarebbe stato ucciso, e la sua morte mascherata da overdose,
pochi mesi dopo aver visitato, e forse operato alla prostata, il boss mafioso a
Marsiglia. Ipotesi che sarebbe suffragata da una telefonata fatta a casa dal
figlio proprio nell’autunno del 2003, in cui spiegò di trovarsi in Costa azzurra
per ragioni professionali. Poi, la dichiarazione di D’Amico. E ancora, il fatto
che mai in famiglia si era potuto solo sospettare della tossicodipendenza di
Attilio. Diverse anomalie nella stanza della casa di Manca a Viterbo in cui il
corpo fu ritrovato: per esempio il fatto che i buchi attraverso i quali sarebbe
stata iniettata la droga erano nel braccio sinistro, nonostante Attilio fosse
mancino. Le tumefazioni al labbro, il fatto che nel bagno fossero state trovate
impronte di Ugo Manca, cugino e teste chiave sia rispetto al fatto che l’urologo
fosse da anni un “consumatore anomalo” di eroina (non ne veniva intralciato
nella sua attività clinica, che svolgeva all’ospedale Belcolle di Viterbo) sia
dei rapporti ormai ultradecennali tra lo stesso medico e la spacciatrice da poco
condannata. Nelle motivazioni, la giudice Mattei nota come “l’istruttoria non si
è limitata a esaminare le prove a carico dell’imputata in relazione al reato di
spaccio, ma ha avuto a oggetto una serie di elementi apparentemente non
direttamente riferibili al reato contestato che, tuttavia, si è ritenuto
opportuno prendere in esame per valutare, infine escludendola, la possibilità di
individuare cause alternative alla morte di Manca”. La giudice scrive anche che
“altre ipotesi sono estranee all’attuale vicenda processuale”. Come pure che
“non esiste una prova diretta della cessione dello stupefacente da Mileti a
Manca nei giorni immediatamente precedenti il decesso”. C’è però “una serie di
elementi” che “inducono a ritenere” come “l’autrice della cessione fatale sia
stata l’imputata”. Soprattutto i “plurimi contatti (telefonici, nda) nei giorni
immediatamente precedenti” la morte del medico. Ingroia parla di “ingiustizia”.
La pronuncia con cui il Tribunale accoglie la tesi della morte da eroina e
dunque nega quella dell’omicidio mascherato da overdose si basa sulle “stesse
ricostruzioni lacunose e le stesse considerazioni infondate sostenute dalla
Procura, lo stesso incredibile capovolgimento della realtà, la stessa ignobile
calunnia verso una persona perbene, un giovane e stimato chirurgo spacciato come
un tossicodipendente”. E poi c’è quel grido di dolore della madre Angela.
Sull’ipotesi mafiosa la Procura di Roma è prossima all’archiviazione. Difficile
che l’esposto alla Procura nazionale antimafia possa modificare le scelte di
Piazzale Clodio. Ma un interrogativo continua ad agitarsi: le due verità in
conflitto, tragedia personale e manipolazione criminale, potrebbero essere
intrecciate? Possibile che proprio averle considerate alternative tra loro
impedisca di cercare ancora la verità?
Torino, cade dalla moto per una buca. Il
pm vuole archiviare: "Se piove lo scooter si lascia a casa".
Una buca nell'asfalto: in caso di pioggia ancora più insidiosa. Secondo il
magistrato non c'è nesso causale tra il fondo stradale sconnesso e la caduta, ma
soprattutto meglio la prudenza se le condizioni meteo non sono favorevoli,
scrive "La Repubblica" l'8 aprile 2017. La pioggia da sola avrebbe dovuto
convince lo scooterista a lasciare in garage la moto. Tra la buca in strada e le
lesioni provocate dalla caduta rovinosa di un uomo di 37 anni, il 16 giugno del
2015 nel quartiere Vanchiglietta a Torino, non c'è "un nesso causale". E' quanto
scrive il pm Vincenzo Pacileo nella richiesta di archiviazione alla denuncia
presentata da un motociclista di Giaveno che era finito con la ruota anteriore
del suo scooter in una buca tra via Nievo e via Ravina nel mezzo di un
temporale. Il motociclista "ha ugualmente voluto proseguire", nonostante la
pioggia battente "condizioni di tempo che già di per sé avrebbero sconsigliato
di viaggiare in scooter", scrive ancora il magistrato che ha chiesto di
archiviare la pratica senza farla arrivare in un'aula di tribunale. La prudenza,
insomma - sembra dire la procura - comincia ancora prima di mettersi in
strada, guardando le previsioni del tempo e se il clima sembra brutto è meglio
scegliere un mezzo più adeguato alle circostanze. O comunque andate pure in
moto, se vi pare, ma ve ne assumete la piena responsabilità e se le strade sono
piene di buche il problema è solo vostro che sfidate il maltempo. E soprattutto
poi non lamentatevi pretendendo ragioni e risarcimenti in nome della legge. Per
giunta, prosegue il pm, la denuncia dello scooterista è sempre rimasta a carico
di ignoti "non essendo stato possibile identificare l'eventuale responsabile".
Ma per il legale del motociclista il responsabile c'è ed è da cercare tra chi
aveva la responsabilità della manutenzione di quella strada. Ora l'avvocato
dello scooterista ha depositato l'opposizione alla richiesta di archiviazione
chiedendo nuove indagini.
Si fa la piega nel suo salone:
parrucchiera multata. Accusata di evasione, sanzione di 500 euro.
L'ultima follia di uno Stato forte solo coi deboli, scrive Riccardo
Pelliccetti, Lunedì 10/04/2017, su "Il Giornale". Ormai si sfiora il ridicolo. È
vero che l'Italia sia la patria del melodramma, ma certi episodi di rigidità
mentale e di pedissequa osservanza delle norme, peraltro assurde, hanno i
contorni grotteschi. Stiamo parlando del Stato, naturalmente, e dei blitz della
Guardia di Finanza, che è costretta a fare cassa su mandato del fisco. Oramai
abbiamo perduto il conto di tutte le multe scaturite dalla fantasia della
burocrazia e comminate con zelo dagli agenti che devono compiacere un moloch
vorace. Si potrebbe scriverne un libro. Ma ci limitiamo a raccontare l'ultimo
caso in ordine di tempo, accaduto a Lecco a una parrucchiera. La signora Mara
Lucci, titolare di un salone, è stata sanzionata dalla Guardia di Finanza per
essersi fatta la piega nel proprio esercizio senza emettere lo scontrino. Non
stiamo scherzando. Se voi avete un'attività commerciale, per esempio un bar, una
pasticceria, una salumeria eccetera non potete assolutamente permettervi di bere
un caffè, mangiare una pastina oppure un panino col prosciutto anche se
appartengono a voi. Il motivo? La normativa sull'autoconsumo che impone, anche
al titolare dell'attività, di emettere la fattura o lo scontrino fiscale. Non
sappiamo cosa passasse per la testa del creativo legislatore quando ha avuto la
brillante ideona, ma sta di fatto che questa è la sconsolante realtà. A questo
punto, pensiamo che per qualsiasi pubblico esercente sia più conveniente andare
a prendere un caffè, una pasta o un panino dalla concorrenza e non nel proprio
esercizio perché, a conti fatti, gli costerebbe meno che autoemettere lo
scontrino. La parrucchiera di Lecco, probabilmente ignara di questa vessazione
di Stato, ha pensato di farsi la piega nei tempi morti dell'attività, fra una
cliente e l'altra. E, senza rendersene conto, è diventata un pericoloso evasore
fiscale, tanto da ricevere dai solerti finanzieri una multa di 500 euro. Quando
le hanno contestato la violazione, ha pensato a uno scherzo, ma i toni degli
agenti l'hanno subito stroncata, facendola sentire una disonesta. La signora
Lucci è scoppiata in lacrime e ha invocato inutilmente il buon senso. Il buon
senso? È un termine bandito nei dizionari dello Stato italiano, la cui voracità
ha ormai raggiunto livelli insostenibili. Quello che sembra un caso di cronaca
locale è invece il paradigma di un Paese intero, dove il cittadino è un suddito
che deve piegarsi ogni qualvolta un burocrate, da Roma o Bruxelles, imponga
norme incomprensibili, contradditorie, in antitesi con il buon senso. Una
tirannia subdola e vendicativa. Sembra di vivere in un romanzo di Orwell. E così
lo Stato despota, che ci impone di giustificare come spendiamo i nostri soldi
quando dovrebbe essere lui a spiegare come spende i nostri, invece di andare a
caccia di grandi evasori, di coloro che sfruttano il lavoro nero minacciando la
previdenza pubblica, dei possessori di grandi patrimoni al di là dei confini,
spreme i cittadini-sudditi. E se la prende con una parrucchiera di Lecco o con
un barista di Albisola Superiore, che si è bevuto un caffè nel proprio bar,
costatogli 500 euro; perseguita un cafè restaurant di Carpi perché il titolare
ha evaso 95 centesimi non emettendo scontrini e lo bastona con una multa di
2.400 euro; sanziona pesantemente un imprenditore di San Donà di Piave perché ha
scaricato con il carrello elevatore, che non ha la targa, un camion a un metro
dall'azienda e non dentro la sua proprietà. Insomma, smettiamola di definire
ipocritamente questi episodi come «lotta all'evasione», questa si chiama
semplicemente persecuzione fiscale.
Alle mamme che spalmano marmellata 1.032
euro di multa. Scatta la colletta. Accade a Lallio
(Bergamo), dove l’Associazione Genitori ha organizzato una marcia non
competitiva. Solo il gestore di un chiosco poteva distribuire cibo, ma l’hanno
fatto anche le mamme: «Una leggerezza». E un consigliere di minoranza le ha
segnalate al Comune, scrive Armando Di Landro l'8 aprile 2017 su "Il Corriere
della Sera". Nell’Italia dei parcheggi in doppia fila troppo spesso tollerati e
dei favori oltre le regole su cui troppe volte si chiude un occhio, accade anche
questo: una multa da 1.032 euro a un gruppo di mamme colpevoli di aver spalmato
marmellata sulle fette biscottate per i bambini, durante una marcia non
competitiva. Colte con le mani nella marmellata, già, le battute potrebbero
sprecarsi, ma stavolta è la sanzione a suonare assurda. Oltre che vera. A
settembre l’Associazione Genitori di Lallio, paese alle porte di Bergamo,
organizza la «Funny A.Ge. Run», attorno al paese. Per poter somministrare
bevande il gruppo chiede un aiuto al gestore del chiosco di un parco del paese,
il parco dei Gelsi, che ha già le sue licenze. Sulla carta solo lui potrebbe
distribuire bibite e cibo per chi partecipa alla marcia. «Poi però quella
mattina, quando abbiamo visto che la partecipazione era alta, ci siamo
rimboccate le maniche e abbiamo iniziato anche noi mamme a spalmare marmellata
sulle fette biscottate, soprattutto per i più piccoli, senza verificare che lo
facesse solo la persona preposta — racconta Marzia Cugini, presidente dell’A.Ge.
—. È stata solo una leggerezza, non avremmo mai immaginato quel che è accaduto
dopo». Manifestazione ben riuscita, tutto a posto? Solo in apparenza. A novembre
l’associazione riceve una comunicazione dagli uffici comunali in merito a
«un’indagine amministrativa». E a fine marzo arriva una multa che sembra uno
scherzo, ma non lo è, come ha segnalato il settimanale Bergamopost: 1.032 euro,
è la sanzione amministrativa che l’Associazione deve pagare. Il tutto dopo una
serie di controlli e accertamenti dell’ufficio tecnico iniziati su segnalazione
di un consigliere comunale di minoranza, Giacomo Lodovici, della lista «Un paese
in Comune Lai-Lallio». Di «comune» c’è ben poco, in questa storia: un gruppo di
mamme arrabbiate da una parte, un consigliere d’opposizione dall’altra, che
ritiene di aver fatto il suo dovere. Il paese bergamasco si indigna: alla festa
degli Alpini sono state messe in vendita, nemmeno troppo provocatoriamente,
fette biscottate con marmellata, per aiutare l’Age a pagare la multa. Lo stesso
ha fatto la pasticceria caffetteria del paese «Peccati di gola», mettendo a
disposizione per l’associazione un salvadanaio dove lasciare le offerte. Esempio
seguito da un altro locale pubblico, che preferisce non comparire. Mentre
un’azienda del paese ha promesso un contributo di 25 euro per coprire la multa a
ogni coppia che sponsorizzerà i suoi prodotti. «Io ho segnalato qualcosa e
qualcuno è stato multato, sono io ad aver sbagliato? — chiede il consigliere
d’opposizione Lodovici —. Io gradirei che la presidente dell’associazione e il
Comune rendessero pubblica la contestazione degli uffici, per far capire meglio
quanto accaduto». «La manifestazione aveva tutte le autorizzazioni del caso ed è
stata anche molto partecipata — replica il sindaco Massimo Mastromattei —.
L’unico difetto dei volontari, e lo dico ironicamente ma anche con amarezza, è
che si danno un gran da fare. Dopodiché c’è un certo divario tra il buon senso e
le norme. Il caso si è cristallizzato nel momento in cui in Comune è arrivata la
segnalazione del consigliere di minoranza: gli uffici hanno dovuto accertare e
agire, non potevano fare altrimenti». Il sindaco non lo dice chiaramente ma il
messaggio è piuttosto semplice: senza esposto si sarebbe potuto chiudere un
occhio. E le mamme? Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 aprile, la presidente
dell’associazione ha dato l’annuncio soddisfatta, dopo l’amarezza: «Posso dire
finalmente che il grande cuore di Lallio ci ha permesso di coprire la cifra
della sanzione, ce l’abbiamo fatta. Ci hanno aiutato più associazioni, tra cui
gli Alpini, più bar del paese, semplici cittadini che ci hanno portato i soldi
in contanti o hanno fatto un bonifico. Com’è accaduto in altri casi, ad esempio
quando ci avevano rubato un defibrillatore, anche in questo caso la catena di
solidarietà ha funzionato. È bastata una settimana, o poco più».
«La moglie è posseduta»:
per i giudici la colpa del divorzio è del demonio.
Sentenza a Milano in una causa di separazione: «Eventi inspiegabili anche per i
medici e gli esorcisti». E il Tribunale scrive «La signora non agisce
consapevolmente, è agìta», scrive Luigi Ferrarella il 6 aprile 2017 su "Il
Corriere della Sera". Il Diavolo esiste davvero. Parola del Tribunale civile di
Milano. Che in una causa di separazione, pur riconoscendo che il marito avesse
ragione nel lamentare l’insostenibilità di un matrimonio sconvolto dagli
inspiegabili comportamenti ossessivi della moglie da lui ascritti a possessione
demoniaca, in sentenza non ha ritenuto di poter addebitare la colpa della
separazione alla moglie: perché costei, a detta dei medici priva di patologie
che possano giustificare quei fenomeni, «non agisce consapevolmente» ma
«altrettanto chiaramente è “agita”». Se viene voglia di sorridere, passa subito
a leggere la motivazione della sentenza depositata dai giudici della IX sezione
civile. In partenza sembra una causa di separazione come tante, moglie e marito
al capolinea con due figli. Il marito domanda che l’addebito della separazione
sia posto a carico della moglie per l’«ossessione religiosa» scatenatale dal
2007 da «devastanti comportamenti compulsivi» ascrivibili «a possessione
demoniaca».
E l’istruttoria raccoglie
prove che in effetti «hanno sostanzialmente confermato la veridicità materiale»
dei «fenomeni inspiegabili» narrati dal marito (anch’egli «fervente fedele» in
chiesa) e confermati da molti fedeli, dal parroco, da un frate cappuccino: ecco
la signora che cade vittima di improvvisi irrigidimenti o convulsioni corporee
«che richiedono l’intervento di terze persone in funzione contenitiva», striscia
e si scuote sul pavimento della chiesa, pur essendo di esile corporatura solleva
con una sola mano una pesante panca e la scaglia contro l’altare, appare
sollevarsi in aria per poi ricadere con «proiezioni paraboliche» a notevole
distanza. Lei stessa, ascoltata dai giudici, sussurra solo di «non gradire
parlare» di questi eventi sottoposti anche a «un monsignore esorcista della
Diocesi di Milano». Anche sua sorella «conferma pudicamente che dal 2007» la
familiare «aveva cominciato a stare male, un male che generava “fenomeni esterni
e non dipendenti dalla sua volontà”, di cui» nessuno «sapeva dire la natura». E
un frate cappuccino si dice «impressionato dai fenomeni “poltergeist”» che «si
verificavano sotto i suoi occhi» nella signora, «seguita per diversi anni da
sacerdoti investiti ufficialmente della funzione di esorcista».
Il Tribunale - lo si
percepisce nell’imbarazzo della motivazione - non sa come uscirne. Negli atti
trova «tutte testimonianze che convergono nel confermare comportamenti
parossistici della signora», «eventi singolari», «fenomeni inspiegabili» anche
«da un clinico medico» che ha sottoposto la donna a «una accurata valutazione
psichiatrica», sottoponendola ai vari test scientifici per poi concludere che
«la signora non risulta affetta da alcuna conclamata patologia tale da poter
spiegare i fenomeni». E tuttavia i giudici scrivono che «la separazione non può
essere addebitata alla moglie perché difetta il requisito della imputabilità
soggettiva di questi comportamenti» nei quali non esprime una volontà, ma
nemmeno simula, e neppure è pazza: «Non agisce consapevolmente», ma «altrettanto
chiaramente ella è “agìta”». E «i tormenti» e gli «inspiegabili fenomeni subìti
dalla signora sono la causa e non la conseguenza del suo atteggiamento di
esasperata spiritualizzazione», attraverso il quale «fa quello che può per
guarire». La separazione è così dichiarata dai giudici in via ordinaria, senza
«addebito» per alcuno dei coniugi: al marito andrà la casa, alla moglie un
assegno di mantenimento.
Giudici, un italiano su due non si fida.
Dati ribaltati rispetto a Mani Pulite. Nel ‘94, secondo l’Ispo, la fiducia nei
confronti dei magistrati arriva a toccare il 70 per cento. Venticinque anni dopo
la realtà è capovolta: secondo il sondaggio Swg, il 69 per cento degli italiani
pensa che «settori della magistratura perseguano obiettivi politici», scrive
Goffredo Buccini il 21 marzo 2017 su "Il Corriere della Sera". Forse la caduta
comincia con un colpo di teatro: la mossa a effetto con cui Antonio Di Pietro,
il 6 dicembre 1994, si sfila la toga dopo la requisitoria Enimont, iniziando
un’inarrestabile marcia d’avvicinamento alla politica. Nei due anni precedenti
il pm simbolo di Mani Pulite arriva, secondo la Doxa, a guadagnarsi la fiducia
dell’83 per cento degli italiani. E ancora quell’anno, il ’94, sette italiani su
dieci, secondo l’Ispo, si fidano dei magistrati, convinti che non abbiano fini
politici. La realtà che un quarto di secolo dopo fotografa l’ultimo sondaggio
Swg (fra il 13 e il 15 marzo, su un campione di 1.500 cittadini) è assai
diversa. Due italiani su tre non credono nel sistema giudiziario, uno su due ha
poca o nessuna fiducia nei giudici. E, soprattutto, la stragrande maggioranza
(il 69 per cento, percentuale quasi identica ma rovesciata rispetto al ’94)
pensa che «settori della magistratura perseguano obiettivi politici». Il 72 per
cento trova «inopportuno» che un magistrato si candidi e il 62 per cento è
contrario alle «porte girevoli», ovvero al rientro nei ranghi togati dopo un
mandato elettorale. Mondi distanti. Il sondaggio, commissionato
dall’associazione «Fino a prova contraria», è stato presentato ieri con
l’introduzione dell’ex ministro Paola Severino e l’intervento di Giovanni
Legnini. Il vicepresidente del Csm da sempre teorizza distanza tra i due mondi:
per evitare «sia in fase di accesso che di reingresso che l’indipendenza della
magistratura possa essere messa in discussione dalla militanza a qualunque
titolo», spiegò nell’illustrare la stretta in materia del plenum del Csm più
d’un anno fa. Naturalmente non c’è solo questo nel grande freddo che pare calato
tra gli italiani e i loro giudici. Come è improprio imputarlo al cambio di
casacca — da arbitro a giocatore — di un singolo, si chiami pure Di Pietro. Ma
la percezione muta. E non pare possa attribuirsi a una svolta garantista
dell’opinione pubblica se l’80 per cento continua, sia pur con diversi gradi di
convinzione, a ritenere utile la carcerazione preventiva e il 74 per cento
invoca mano libera per i magistrati nelle intercettazioni (uno su due è però
contrario a pubblicarle sui giornali). Dubbi sul processo. La sfiducia sta,
insomma, nell’istituzione, non più percepita come «altro» dalla politica.
S’annida tra infelici esperienze quotidiane e distorsioni mediatiche. Quei sei
italiani su dieci con poca o nessuna fiducia nel sistema si lagnano soprattutto
dell’iter processuale: insomma di quel meccanismo farraginoso che, specie nel
campo del civile, trasforma in una vera lotteria ogni causa. Ne deriva,
fortissima, l’esigenza di una riforma del sistema, urgente per il 43, importante
per il 41 per cento. Quasi sette su dieci invocano un «cambio radicale», a
rammentarci pure quanto la riforma Vassalli del 1989 abbia lasciato, in fondo, a
metà del guado il processo penale con rito accusatorio: un processo di parti,
dunque, in cui il pm resta tuttavia ben al di sopra delle altre parti. Lo
scoppio di Tangentopoli, tre anni dopo, non è forse del tutto estraneo a
quest’impasse. È un Paese sconcertato. Dai troppi epigoni di Di Pietro, forse, e
certo dalle tante invasioni di campo: come si coglie nei sondaggi degli ultimi
vent’anni, con la fiducia nei magistrati che cala a picco tra gli elettori del
centrodestra per effetto dei processi a Berlusconi, flette poi tra i supporter
dell’Unione di Prodi quando i pm si concentrano sul fronte progressista, torna a
salire nel centrosinistra tra il 2009 e il 2010, coi berlusconiani di nuovo al
governo e nel mirino. Pm come goleador. Questo moto pendolare del consenso, da
uno schieramento all’altro, disegna l’incrinarsi di un rapporto. Ora gli
italiani non si fidano ma tifano, si sceglie un pm come un goleador della
propria squadra. Il tempo del consenso bipartisan è passato, il patrimonio di
credibilità che accompagnò i pm di Milano nella primavera del ’92 è dissipato
per sempre. E la campana suona anche per noi giornalisti. Quasi un italiano su
due ci chiede «più cautela» nel rivelare notizie riguardo persone sulle quali le
indagini non sono ancora concluse. Il 48 per cento vorrebbe che se ne
«valutassero le conseguenze». Una massima pericolosa se si fa filtro di
convenienza politica, ineccepibile se diventa garanzia di umanità.
Lo stato della gogna giudiziaria nel
2016. Uno studio dell'Unione delle camere penali: dopo
avere esaltato arresti e indagini, soltanto l'11% degli articoli racconta come
va a finire un processo, scrive Maurizio Tortorella il 15 dicembre 2016 su
Panorama. È probabilmente la prima volta che un tribunale penale aggredisce la
"gogna giudiziaria" su internet. Il primato spetta a Genova, dove sono state
appena depositate le motivazioni di una sentenza del 20 giugno scorso (per i
cultori del genere, è la numero 3582). È una condanna per diffamazione:
stabilisce che "chi inserisce notizie a mezzo internet relative a indagini
penali è tenuto a seguirne lo sviluppo e, una volta appreso l'esito positivo per
l'indagato o l'imputato, deve darne conto con le stesse modalità di pubblicità.
In caso contrario è configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa". Il
processo di primo grado ha chiuso così la vicenda della pubblicazione sul sito
di un’associazione di consumatori della notizia relativa al rinvio a giudizio
per concussione del presidente e vicepresidente di un'associazione, alla fine di
un’inchiesta su presunti appalti irregolari. In seguito, i due indagati erano
stati prosciolti, ma la notizia online non era mai stata aggiornata. Per il
tribunale di Genova il reato sussiste in quanto non c'è dubbio che "l'omesso
aggiornamento mediante inserimento dell'esito del procedimento penale"
configuri un comportamento diffamatorio. Per il giudice, infatti, la qualifica
di un soggetto quale indagato o imputato "è certamente idonea a qualificare
negativamente l'immagine, il decoro e la reputazione di una persona, soprattutto
quando si tratta di soggetto noto al pubblico". Quindi la notizia, che pure era
vera e corretta al momento della sua pubblicazione online, avrebbe dovuto essere
aggiornata perché smentita dall'evolversi del procedimento penale. "La verità
della notizia" sostiene testualmente la condanna "deve essere riferita agli
sviluppi d’indagine quali risultano al momento della pubblicazione
dell'articolo, mentre la verifica di fondatezza della notizia, effettuata
all'epoca dell'acquisizione di essa, deve essere aggiornata nel momento
diffusivo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso
processuale della vicenda". La sentenza, ignorata dai siti internet come dalla
stragrande maggioranza dei giornali, arriva proprio nel momento in cui
l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle camere penali
italiane (l’associazione degli avvocati penalisti) dà alle stampe un saggio
rivelatore. Per sei mesi, dal giugno al dicembre 2015, gli avvocati hanno
raccolto e analizzato la cronaca giudiziaria di 27 quotidiani. È una massa
imponente di materiale: 7.373 articoli. Quasi sette su dieci danno notizie sulle
indagini preliminari, e in particolare il 27,5% tratta dell’arresto di un
indagato. Ma quando poi il processo arriva al dibattimento, l’attenzione si
dissolve: solo il 13% degli articoli segue le udienze in tribunale. Va ancora
peggio alla sentenza: appena l’11% degli articoli informa i lettori su come è
andata a finire la vicenda giudiziaria che nelle fasi iniziali, invece, veniva
squadernata su pagine e pagine. Beniamino Migliucci, che dell’Ucpi è presidente,
scrive che "le informazioni sulle indagini preliminari vengono sapientemente
pubblicate e divulgate per creare consenso preventivo". Il risultato è negativo
anche sulla correttezza del processo, perché si viola "la verginità cognitiva
del giudice, che viene bombardato da informazioni riguardanti le indagini".
Secondo lo studio, gli articoli sono dichiaratamente colpevolisti quasi nel 33%
dei casi; un altro 33% riporta le tesi della pubblica accusa senza esprimere
giudizi; il 24% ha toni neutri. E soltanto il 3% prende una posizione più
garantista, se non direttamente innocentista. Soltanto il 7% degli articoli
riporta notizie di natura difensiva, fornite dall’avvocato dell’indagato o
dell’imputato.
Devastare le città non è reato Assolto un
altro antagonista. Alla vigilia delle proteste di Roma
cade l'accusa principale contro il leader No Expo per i danni del 1° maggio a
Milano, scrive Luca Fazzo, Sabato 25/03/2017, su "Il Giornale". Alla lettura
della sentenza gli imputati si abbracciano in aula, increduli. E allo stesso
modo potrebbero festeggiare i loro compagni di fede che oggi si preparano a
calare su Roma per urlare la loro rabbia contro le celebrazioni dei Trattati di
Roma, perché la sentenza pronunciata ieri dalla Corte d'appello di Milano
sancisce l'inerzia dello Stato davanti alle violenze di piazza: violenze
annunciate e micidiali come quelle che il Primo Maggio 2015 rovinarono
l'inaugurazione di Expo, e come quelle che - secondo l'allarme del Viminale -
frange antagoniste apparecchiano per la giornata di oggi nella Capitale. A quasi
due anni di distanza dal giorno di fuoco inflitto a Milano dai no Expo, con le
forze dell'ordine attaccate a freddo e una lista interminabile di auto, negozi,
banche e vetrine incendiate e distrutte, la Corte d'appello milanese annulla
l'unica condanna per devastazione inflitta in primo grado. Già era quasi
grottesco che delle centinaia di incappucciati del Primo Maggio ne fosse stato
condannato solo uno. Ora anche quell'uno - Andrea Casieri, 38 anni, militante di
un centro sociale milanese - viene salvato dai giudici d'appello: la
devastazione sparisce, i tre anni e otto mesi inflitti in primo grado si
riducono a due anni e quattro mesi per resistenza e travisamento, la prospettiva
di finire davvero in carcere a scontare la pena svanisce nel nulla. Casieri
raggiunge gli altri tre imputati nella certezza dell'impunità. Tripudio in aula.
Nel dispositivo letto dal giudice Guido Piffer, Casieri viene assolto «per non
avere commesso il fatto». Significa che la devastazione vi fu (e sarebbe
difficile negarlo, di fronte a immagini che fecero il giro del mondo) ma che il
giovanotto non ne risponde. Come e più dei giudici di primo grado, la Corte
d'appello spezzetta l'analisi dei fatti, si ferma al singolo gesto del singolo
incappucciato: una scelta che nel suo ricorso contro le assoluzioni dei compagni
di Casieri il pm Piero Basilone aveva definito «illogica» e «inaccettabile»,
perché in una guerriglia pianificata come fu il Primo Maggio «l'agire di ciascun
imputato nel medesimo contesto criminoso ha generato i gravi fatti di
devastazione: e ogni facinoroso aveva la chiara percezione del contributo
materiale e morale dato con la propria condotta al complessivo ampio scenario di
devastazione». Ad Andrea Casieri, peraltro, la sentenza di primo grado
attribuiva ruoli diretti e addirittura di comando tra i black bloc protagonisti
delle violenze: «Le foto consentono di apprezzare come Casieri sia stabilmente
posizionato nel gruppo di appartenenti al blocco nero, anche armati di bastone
(...) l'azione di Casieri si segnala come quello di coordinamento/direzione di
persone partecipanti agli attacchi»: è lui, scrisse il giudice, che fa segno di
avanzare, lui a «presidiare l'avanzamento di un contingente in attacco», lui a
«dirigere il formarsi di un altro contingente armato di bastoni e dotato di
caschi». Bisognerà attendere le motivazioni per capire come, di fronte a simili
comportamenti, la Corte abbia deciso di graziare l'unico condannato. Resta il
fatto che il bilancio giudiziario della peggiore giornata vissuta da Milano è un
nulla di fatto. In diretta, durante gli scontri, le forze dell'ordine scelsero
(su ordine del governo) di non intervenire, anche quando sarebbe stato agevole
farlo, lasciando di fatto mano libera ai violenti. «Li identificheremo, li
processeremo e li puniremo», venne garantito all'epoca. Sono stati identificati
e processati: ma nessuno è stato punito. A rispondere di devastazione restano
solo cinque anarchici greci: che se ne stanno tranquilli a casa loro, dopo che
Atene ha rifiutato la loro estradizione.
Il procuratore assolve gli scafisti:
«Sono migranti come gli altri», scrive Simona Musco su
"Il Dubbio" il 24 marzo 2017. Secondo Carmelo Zuccaro, capo dei Pm di Catania,
chi guida i barconi viene scelto tra gli stessi rifugiati: «Gli danno in mano
una bussola, un telefono satellitare e una rotta da seguire». Inutile
prendersela con gli scafisti: sono migranti disperati come gli altri, scelti a
caso al momento della partenza. A dirlo, davanti al comitato Schengen a Palazzo
San Macuto, è stato il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. Una
consapevolezza nata da un’indagine conoscitiva effettuata sui flussi migratori
volta a fare chiarezza sul ruolo delle organizzazioni non governative
nell’ambito del salvataggio in mare. Dall’indagine, è stato spiegato nel corso
dell’audizione, sono emerse ipotesi di collaborazione “eccessiva” tra ong e
trafficanti di uomini durante i viaggi della speranza. Accuse che sarebbero già
state prospettate in due rapporti di Frontex, con riferimento alla rotta
migratoria dalla Libia all’Italia. In uno dei rapporti si leggerebbe che i
migranti irregolari provenienti dal nord Africa avrebbero ricevuto indicazioni
chiare alla partenza sul tragitto da seguire per raggiungere le imbarcazioni
della Ong. Una presenza, quella delle organizzazioni non governative, che non ha
diminuito il numero di morti in mare. «Quelli che riusciamo a prendere sono
soltanto gli scafisti ma questi scafisti non sono né più né meno che migranti
individuati a caso», ha spiegato Zuccaro. Le indicazioni fornite ai magistrati,
dunque sono chiare: «Ho detto loro che non si doveva più richiedere misura
cautelare nei loro confronti perché la gravità della condotta a loro ascrivibile
non era tale da giustificare la misura, essendo da giudicare come migranti a
tutti gli effetti. Registriamo così una sorta di scacco che la presenza di
queste ong provoca nelle attività di contrasto nel fenomeno degli organizzatori
del traffico». Una visione illuminata che svuota le carceri da quelli che
finiscono per essere vittime due volte. Zuccaro ha spiegato come i barconi
utilizzati dai migranti siano sempre più inadeguati al loro scopo, così come
inidonee sono le persone che si mettono alla guida degli stessi. «Ormai non sono
più persone che appartengono, seppur a livello basso, all’organizzazione del
traffico, ma persone scelte all’ultimo momento tra gli stessi migranti, a cui
viene data in mano una bussola e un telefono satellitare e a cui si dice di
seguire una determinata rotta che tanto prima o poi li verrà a soccorrere una
ong. Ma per quanto queste organizzazioni possano essere numerose – ha aggiunto
Zuccaro – non riescono a coprire tutto l’intenso traffico che parte dalle coste
della Liba. Cosa comporta per quanto riguarda l’attività giudiziaria? La
possibilità di intercettare i cosiddetti facilitatori, che accompagnavano le
imbarcazioni nei primi tratti, ce la possiamo dimenticare, perché queste ong
hanno fatto venir meno questa esigenza». Le indagini puntano a comprendere i
canali di finanziamento di queste organizzazioni, in molti casi ingrassate con
il 5 per mille. Sono 13 le navi di ong attive nel Canale di Sicilia e nei primi
mesi del 2017, a Catania, il 50% dei migranti soccorsi è arrivato a bordo di
quelle. Zuccaro ha anche evidenziato, nel corso dell’audizione, «fenomeni di
radicalizzazione al terrorismo» registrati tra i migranti finiti in carcere. «Ci
giungono segnalazioni molto concrete – ha spiegato – di fenomeni di
reclutamento, di radicalizzazione che vedono come promotori alcuni dei migranti
che sono stati arrestati per avere commesso degli illeciti e che a loro volta
tentano di fare proselitismo nelle carceri. E nei due istituti di Catania
abbiamo riscontri su questo». Fenomeni di radicalizzazione si sarebbero
registrati anche in alcuni centri in cui è vivo il fenomeno del ‘ caporalato”,
nei campi e nelle serre dove i migranti entrano in contatto con soggetti che poi
sono risultati più o meno collegati con organizzazioni terroristiche. Il
sospetto è che parte dei soldi derivanti dal traffico di clandestini finisca
nelle mani di gruppi militari o paramilitari. «Non si possono escludere anche
organizzazioni che siano collegate con il mondo del terrorismo – ha spiegato -.
La mafia non è interessata direttamente dal traffico di migranti, se non
indirettamente e in maniera marginale nel caporalato, perché agisce dove ci sono
i grandi flussi finanziari, come quelli per i centri di accoglienza e
assistenza. Le organizzazioni criminali hanno grosso interesse a potere
intercettare il flusso di denaro abbastanza cospicuo che riguarda i centri di
accoglienza». Come il Cara di Mineo, dove la criminalità «ha preteso l’utilizzo
d’imprese a lei vicine o collegate per ottenere appalti da parte delle
cooperative che gestiscono il Centro accoglienza richiedenti asilo».
Treviso, giudice inseguito in auto: "Io
mi armo, lo Stato non c'è". Lettera aperta ai
quotidiani Finegil del magistrato Angelo Mascolo: "Avevo superato un'auto e me
la sono trovata dietro che mi abbagliava. Finché ho incontrato una pattuglia dei
carabinieri. E i miei inseguitori hanno detto che volevano solo esprimermi
critiche per la guida. Cosa sarebbe successo se mi avessero aggredito e io,
armato come è mio diritto, avessi sparato? Troppe leggine tutelano simili
gentiluomini", scrive Paolo Gallori il 24 marzo 2017 su "La Repubblica". Se un
giudice irrompe a livello personale nel dibattito che divide la Nazione tra chi
invoca il diritto di armarsi per difendersi e chi invece crede fermamente che
l'uso della forza debba restare monopolio dello Stato, la sua opinione pesa. E
se lo stesso giudice si schiera con il primo, proprio in quel Nordest dove
esercita e dove il tema è rovente, il peso di quella opinione diventa
incalcolabile. Perché destinato a spaccare il fronte di coloro ai quali proprio
lo Stato demanda l'amministrazione delle sue prerogative chiedendo loro fedeltà
e distacco rispetto ai tumulti dell'anima del comune cittadino. Ma è proprio
l'esperienza da comune cittadino che si sente in pericolo e scopre di non
sentirsi protetto dallo Stato che ha indotto il togato trevigiano Angelo Mascolo
a lanciare la sfida. Pubblicamente, con una lettera aperta indirizzata ai
quotidiani veneti del gruppo Finegil in cui racconta dell'incubo personale
vissuto non tra le pareti domestiche ma in auto, l'abitacolo come unica barriera
protettiva dalla violenza della strada e l'acceleratore come unica ancora a cui
aggrapparsi per sfuggire al male. Per tenersi a distanza dai fari abbaglianti di
un inseguitore senza volto, che ti bracca e ti sfinisce. Come in Duel, il film
di debutto di Steven Spielberg. Se nella pellicola l'automobilista corre su
strade aride e deserte senza trovare un'anima che corra in suo aiuto, il giudice
Mascolo si imbatte invece in una pattuglia dei carabinieri. Ma il finale della
storia non è quello che l'inseguito si aspetta. E allora il giudice rompe gli
indugi e annuncia: "D'ora in poi sarò armato". Nella lettera Mascolo fa
riferimento a un episodio accadutogli qualche sera fa. Aveva sorpassato un'auto
di grossa cilindrata e una volta davanti si era ritrovato la maschera aggressiva
della vettura incollata dietro e raffiche di abbaglianti ad accecarlo
rimbalzando sui suoi occhi dallo specchietto retrovisore. Situazione anche
piuttosto familiare agli automobilisti delle grandi città, dove sulle strade
accanto alle auto corrono gli stress, i malumori, l'aggressività repressa di chi
è al volante. Ma dove il coatto confronto con un "altro" senza identità
risveglia anche paure e insicurezze addormentate tra le pieghe più profonde
dell'inconscio. Uno di quei momenti in cui ci si ritrova a sperimentare una
legge della giungla con cui l'umanità si è illusa di aver chiuso con il
contratto sociale. Il giudice è immerso in quello che percepisce come un
confronto diretto e dalle conseguenze imprevedibili con un improvviso nemico,
quando esce dalla giungla e torna nella civiltà, rappresentata dalla pattuglia
di carabinieri. Di fronte alle divise, i selvaggi e aggressivi inseguitori
tornano cittadini, ritrovano l'uso della parola. E si spiegano: Mascolo era
stato "seguito" per "esprimere critiche sul suo modo di guidare". A freddo, il
giudice si fa delle domande. E si dà le sue risposte, arrivando alla fine a
dubitare del senso del suo stesso lavoro. "Se fossi stato armato, come è mio
diritto e come sarò d'ora in poi, che sarebbe successo se, senza l'intervento
dei carabinieri, le due facce proibite a bordo della Bmw mi avessero fermato e
aggredito, come chiaramente volevano fare?". E aggiunge: "Se avessi sparato,
avrei subito l'iradiddio dei processi - eccesso di difesa, la vita umana è sacra
e via discorrendo - da parte di miei colleghi che giudicano a freddo e
difficilmente - ed è qui il grave errore - tenendo conto dei gravissimi stress
di certi momenti". Il problema della legittima difesa "è un problema di secondo
grado - accusa Mascolo - come quello di asciugare l'acqua quando si rompono le
tubature. Il vero problema sono le tubature. E cioè: lo Stato ha perso
completamente e totalmente il controllo del territorio, nel quale, a qualunque
latitudine, scorazzano impunemente delinquenti di tutti i colori". Per il
giudice, "la severità nei confronti di questi gentiluomini è diventata, a dir
poco, disdicevole, tante sono le leggi e le leggine che provvedono a tutelarli
per il processo e per la detenzione e che ti fanno, talvolta, pensare: ma che
lavoro a fare?".
"Lo Stato non c'è, voglio un'arma". Lo
sfogo del giudice terrorizzato, scrive il 25 marzo
2017 Alessandro Gonzato su "Libero Quotidiano". Che in Italia la questione della
legittima difesa sia molto sentita non è una novità. Ma non avevamo mai sentito
un magistrato affermare pubblicamente - e con una simile veemenza - di volersi
armare per difendersi dai delinquenti, «perché lo Stato ha perso completamente
il controllo del territorio». Il giudice Angelo Mascolo, componente dell'ufficio
dei gip del tribunale di Treviso, ha inviato una lettera ad alcuni quotidiani
veneti per denunciare il clima di insicurezza che ci attanaglia. Ha preso spunto
da un episodio capitatogli qualche sera fa quando, sorpassata un'auto, il
conducente (che viaggiava con un passeggero) ha cominciato a inseguirlo a colpi
di abbaglianti. Il giudice, qualche minuto dopo, ha incrociato una pattuglia dei
carabinieri, ha segnalato gli inseguitori che, fermati, si sono giustificati
dicendo che volevano solo esprimere le proprie rimostranze sul modo di guidare
del magistrato. Il quale nella lettera si chiede: «Se fossi stato armato, come è
mio diritto e come sarò d' ora in poi, cosa sarebbe successo se, senza
l'intervento dei carabinieri, le due facce proibite a bordo della Bmw mi
avessero fermato e aggredito, come chiaramente volevano fare? Se avessi
sparato», continua Mascolo, «avrei subito l'iradiddio dei processi - eccesso di
difesa, la vita umana è sacra e via discorrendo - da parte di miei colleghi che
giudicano a freddo e difficilmente, ed è qui il grave errore, tenendo conto dei
gravissimi stress di certi momenti». Il magistrato si è poi soffermato sulle
conseguenze economiche di una sua eventuale reazione: «Sarei andato incontro
quantomeno alla rovina per le spese dell'avvocato». In Italia, secondo il
giudice del tribunale di Treviso, «scorrazzano a qualunque latitudine
delinquenti di tutti i colori, nonostante gli sforzi eroici di poliziotti
anziani, mal pagati e meno ancora motivati dallo scarso rigore della
magistratura». Mascolo prosegue puntando il dito contro «le leggi» che spesso
tutelano i criminali «e che talvolta ti fanno pensare: ma cosa lavoro a fare? Il
lavoro di un giudice penale oggi è paragonabile a quello del soldato al quale,
per tenerlo calmo, fanno scavare un buco per poi riempirlo». Va detto che
Mascolo non è nuovo a uscite di un certo tipo. Lo scorso luglio, dopo aver
scarcerato un imprenditore e due finanzieri accusati di corruzione, in
un'intervista aveva derubricato a «regalino» due orologi consegnati a chi doveva
effettuare l'ispezione. «Non ho visto nessun elemento da cui si desuma la
corruzione» aveva detto, motivando la sua decisione. «Può essere benissimo che
questo qui, grato del fatto che non ci sono stati problemi, abbia fatto un
regalo di sua volontà. Sono cose che sfuggono alla mente, ci sono reazioni
psicologiche che non sono controllabili e che non sono comprensibili». Ma
torniamo alla lettera del giudice e alle reazioni che ha suscitato. «Sono
contento che anche tra la magistratura comincino a sentirsi voci autonome» dice
a Libero Matteo Salvini. «Per molti versi, in Italia, la magistratura è un
problema. Io non ho il porto d' armi, però chi ce l'ha deve potersi difendere
senza essere perseguitato. Se avessi detto io le stesse cose che ha detto il
giudice sarei finito probabilmente sotto processo: sono contento che le abbia
dette un magistrato e sarei felice di prendermi un caffè con lui». Va però
ricordato che poco più di un anno fa la Lega si era scagliata contro lo stesso
giudice reo, secondo il Carroccio, di aver liberato tre immigrati presunti
complici di un rapinatore. Questa volta no: il magistrato e i leghisti la
pensano allo stesso modo. «Sono d' accordo col giudice Mascolo» afferma il
governatore del Veneto Luca Zaia. «Aggiungo che è urgente rivedere e ampliare al
massimo il concetto di legittima difesa. E i carabinieri, la polizia e la
guardia di finanza devono poter scendere in strada con il codice penale, non con
il libro del galateo».
"Non urla e non piange": violentatore
assolto Torino diventa porto delle nebbie sugli stupri.
Terzo caso in poche settimane sotto la Mole: vittime non credute
o reati prescritti, scrive Luca Fazzo, Giovedì 23/03/2017, su "Il Giornale".
Torino, di nuovo Torino: nelle cronache giudiziarie dei processi per stupro le
sentenze che arrivano dal capoluogo piemontese hanno avuto spesso negli ultimi
mesi la prima pagina dei giornali; e ogni volta si è trattato di vicende in
grado di suscitare dubbi sull'operato dei magistrati chiamati a processare i
responsabili di crimini odiosi. Al punto da rendere inevitabile chiedersi se
esista un «caso Torino», una sorta di buco nero nella macchina della giustizia
che all'ombra della Mole offre ai violentatori la scappatoia verso l'impunità.
L'ultimo caso viene alla luce ieri, quando un articolo del Corriere rende note
le motivazioni con cui il tribunale torinese ha assolto un infermiere accusato
dello stupro di una collega, e hanno proposto alla Procura di incriminare per
calunnia la presunta vittima. A rendere inattendibile la versione della donna
sarebbe il fatto che durante l'aggressione non avrebbe cercato di difendersi e
nemmeno gridato. «Non grida, non urla, non piange e pare abbia continuato il
turno dopo gli abusi», scrivono i giudici. Non lamenta dolori, non fa neanche un
test di gravidanza, e anche questo convince la corte che menta. Eppure altre
sentenze di altri tribunali si guardano bene dal pretendere dalle vittime
comportamenti logici e lineari durante e dopo l'aggressione. L'assoluzione
dell'infermiere arriva a poche settimane di distanza da altre due notizie
torinesi sullo stesso tema: e che sollevano entrambe l'aspetto dei tempi biblici
che a Torino permettono a due violentatori di farla franca. Il 21 febbraio si
era scoperto che uno stupratore di bambini era tornato libero, dopo essere stato
condannato in primo grado a dodici anni di carcere, per il semplice motivo che
in dieci anni la Corte d'appello torinese non era riuscita a fissare l'esame del
suo ricorso, provocando così la prescrizione del reato. Una manciata di giorni
dopo, il 3 marzo, storiaccia simile: un patrigno che stuprava la figlia della
sua compagna se la cava in Cassazione con tre anni e mezzo di condanna perché
gli altri capi d'accusa sono prescritti grazie alla Corte d'appello torinese ha
impiegato otto anni a fare il suo lavoro. Intanto lo stupratore se n'è tornato a
casa sua, in Perù, donde difficilmente verrà mai estradato; e a rendere tutto
più tragico c'è il fatto che la vittima non conoscerà mai l'esito del processo
perché si è ammazzata lanciandosi dalla finestra. Sui giudici che hanno lasciato
prescrivere il primo caso il ministro della Giustizia ha disposto una inchiesta
interna, ma il timore è che il problema sia più vasto, ovvero una
sottovalutazione della gravità di questi crimini e della necessità di reprimerli
severamente e rapidamente. Il Giornale ha parlato di numerosi casi di processi
per stupro persi per anni nelle nebbie torinesi. E anche altre fonti confermano
che - almeno fino a tempi recenti - a Torino nessuno si era mai preso la briga
di garantire una corsia preferenziale ai processi per stupro, che finivano a
bagnomaria nel minestrone dei furti e delle bancarotte, delle truffe e dei
piccoli spacci di droga: perché indicare delle priorità vuol dire anche
prendersi responsabilità e correre dei rischi. Ora l'aria sta cambiando: «Sono
reati su cui indagare è delicato e complesso - dice il procuratore torinese
Armando Spataro - ma i pm che qui se ne occupano lavorano tanto e bene. E col
nuovo presidente del tribunale abbiamo stilato un programma che prende di petto
queste esigenze».
Un convegno a Milano per parlare di
malagiustizia all’italiana. Dal settimanale Radar del
9 marzo 2017. Basta un piccolo errore, una semplice superficialità, una svista o
un cavillo, e qualunque persona può finire nel tritacarne di un sistema
giustizia che, come un meccanismo che si inceppa, improvvisamente inizia a
lavorare male. E succede così che la vita di quella persona, e la sua salute
mentale, subiscono dei danni gravi e sono compromesse per sempre. Quante sono le
cosiddette vittime della malagiustizia penale, civile, amministrativa e
tributaria in Italia? E come si può fare se si ritiene di stare subendo un
errore giudiziario? A Milano dal 2012 è nata un’associazione che si chiama Aivm.
L’ha fondata Mario Caizzone, un commercialista siciliano che da trent’anni
lavora a Milano e che, sulla sua pelle, ha sperimentato il tormento e la pena di
essere accusato ingiustamente. Finì dentro un’inchiesta avviata dalla Procura di
Milano nel 1993 quando venne ritenuto responsabile del fallimento della società
Imprenori spa: peccato che Caizzone non aveva mai ricoperto in quella società
nessuna carica.
“Il mio processo è durato 21 anni – racconta – e
soltanto dopo 21 anni sono stato finalmente assolto”. In questo tempo
lunghissimo ci sono stati per lui arresti domiciliari, finanzieri che non lo
hanno mai ascoltato (lui lo ha raccontato, col risultato che poi è stato
rinviato a giudizio per calunnia per poi, dopo il processo nel pro- cesso,
essere assolto), amici che lo hanno abbandonato, carte su carte, solitudine e
sofferenza interiore. Ancora adesso, quando lo racconta, gli viene da piangere.
Gli hanno rovinato così tanto la vita che l’associazione l’ha fondata lui. Con
l’obiettivo di aiutare tutti quelli che sono vittime di sbagli. E le storie sono
tante.
Tanto per fare un esempio, Mario Caizzone racconta
che l’associazione ha provato a fare un sondaggio tra i parlamentati italiani.
La domanda era: chi è vittima di un errore giudiziario a chi può rivolgersi? Le
risposte da sole fanno capire più di ogni altro commento. Al primo posto: al
Padre Eterno. Al secondo posto: al Papa. Al terzo: al Presidente della
Repubblica. Al quarto: al Consiglio superiore della magistratura. Al quinto
posto: Al consiglio giudiziario presso la Corte d’appello. Nessuna di queste
cinque risposte è risolutiva. Chi cade vittima della malagiustizia si può
ritenere in un modo e basta: una persona che resterà sola.
Elisa Fasolin è la segretaria della Aivm: “A
Milano abbiamo uno sportello in piazza Luigi di Savoia in cui riceviamo le
persone e anche un centro di ascolto telefonico allo 02.66715134. Dal 2012 ci
sono arrivate 5mila richieste di aiuto. La nostra associazione è tutta composta
sol-tanto da volontari: ci sono studenti di giurisprudenza che si fanno le ossa
ma anche legali professionisti. Analizziamo tutte le carte che ci vengono
fornite, dalla prima all’ultima, e valutiamo se sussiste una base per parlare di
malagiustizia. Di quelle 5mila richieste, ne abbiamo portate avanti 3mila. Cosa
facciamo? Procediamo per chiedere una revisione del processo”.
Dentro al sito internet aivm.it ci sono le
opinioni di parlamentari, esperti, giornalisti che spiegano quali sono le cause
secondo loro della malagiustizia. Qui vi riportiamo per fare un esempio quella
di Piero Colaprico, firma storica di Repubblica: “Tra le cause, temo che ci sia
un intreccio tra la mancanza di professionalità e la mancanza di empatia, in
primis da parte di avvocati, che illudono e imbrogliano il cliente, dandogli
sempre e comunque ragione, e poi da parte di magistrati, che vedono talvolta
numeri e seccature dove ci sono persone e storie”.
Le storie sono tantissime. C’è quella di don Marco
Doppido, 47 anni, di Zidibo San Giacomo. “Andavo in bicicletta, c’era un tombino
rotto, sono caduto e mi sono rotto una clavicola”, racconta. Il giovane parroco
decide di chiedere il risarcimento al comune ma ha un avvocato che lo consiglia
male. Succede che una perizia del Tribunale gli dà ragione (quel tombino era
pericoloso), ma il giudice, non si sa perché, gli dà torto. Gli arriva il conto
delle spese del processo: 8mila euro che deve pagare lui. “Il mio avvocato mi ha
detto di pagare e l’ho fatto”. Cornuto e mazziato.
C’è il caso di Giuseppe Casto, di Lecce, che nel
1996 per- de il padre, investito e ucciso da un pirata della strada. Lui e la
famiglia si affidano ad un avvocato per chiedere il risarcimento: il legale alla
fine chiede una parcella di 160mila euro. Giuseppe li paga. Solo alla fine scopre
che l’avvocato si era intascato anche i soldi dell’assicurazione. “Siccome non
pagavo, hanno anche pignorato la pensione di mia madre. Alla fine me ne sono
andato dall’Italia”.
La faccenda è aggravata da ulteriori due fattori:
sui social “si è per sempre”. Sempre più avvocati chiedono l’applicazione del
diritto all’oblio perché spesso, quasi sempre, su internet restano articoli
datati anche dieci o vent’anni, quando magari una persona ha terminato il
processo con l’assoluzione. Ma il problema è a monte: i giornalisti dovrebbero
imparare a usare di più il condizionale, quanto meno finché non sono sicuri della
colpevolezza di una persona. C’è differenza tra “preso il boss” e “preso il
presunto boss”. Ricordiamoci che nessuno è colpevole finché non lo stabilisce una
sentenza e in questo Paese esiste la presunzione di innocenza.
Deborah Nasti, avvocato civilista volontaria
dell’associazione, aggiunge poi un altro tassello: “In Italia ci sono 250mila
avvocati, in Francia ce ne sono 50mila. Un numero così alto, e l’ha detto il
magistrato Piercamillo Davigo, è uno dei motivi per cui ci sono così tante cause
in Italia.
Al posto di spingere le persone alla conciliazione
civile (ndr la conciliazione è il procedimento attraverso il quale due parti in
contrasto raggiungono un accordo amichevole con l’aiuto di un terzo), gli
avvocati spingono i loro clienti a fare causa. E poi c’è il fenomeno dei
cosiddetti avogati, cioè quelli che la laurea in giurisprudenza se la vanno a
prendere in Spagna perché è più facile e poi vengono ad esercitare in Italia,
peggiorando questo problema”.
Don Virgilio Balducchi è ispettore e cappellano
delle carceri. Ha passato la vita a stare dalla parte dei detenuti: “In carcere
non ci sono solo colpevoli ma ci finiscono anche innocenti. Uno dei primi che ho
incontrato era un pregiudicato che non voleva ammettere di aver commesso un
certo reato che gli veniva attribuito. Diceva: io quella cosa non l’ho fatta! Si
è fatto quattro anni in più ma alla fine è uscito innocente. Purtroppo la
giustizia cerca quasi sempre un colpevole a cui addossare la colpa”. Il
cappellano ricorda due frasi dette da Papa Francesco: “State attenti a non
incitare alla violenza”, e “Attenzione al populismo penale: non fate processi
sui giornali”. Don Virgilio poi ricorda una cosa: “Giustizia non è punire il
colpevole ma riconciliare una situazione. Altrimenti è vendetta”. Il carcere in
effetti servirebbe a questo: in teoria dovrebbe essere un modo per far pagare
una colpa riuscendo però a redimere la persona che ha sbagliato, restituendola
alla società consapevole del suo errore e in grado di non sbagliare più.
Masturbarsi in auto davanti ai minori si
può: la Cassazione salva un moldavo, scrive il 23
Giugno 2017 Cristiana Lodi su "Libero Quotidiano”. Il moldavo ha cercato le
minorenni per sentirsi ispirato. E una volta che queste sono arrivate davanti ai
suoi occhi, lui ha preso a masturbarsi. Una volta lo ha fatto in macchina,
un’altra al parco e successivamente si è esibito per strada. Alla luce del
giorno. E sempre aspettando le bambine. Segnalato dai passanti. Beccato in
flagranza in tutte e tre le occasioni. Denunciato e condannato in primo e
secondo grado dalla corte d’Appello di Trieste per atti osceni. Fino a quando la
corte di Cassazione (sentenza numero 30798 - Presidente Amoresano - Relatore
Gentili) non lo ha assolto. Depenalizzando la sua condotta oscena. Motivo? Il
maniaco, quegli atti di autoerotismo deliberato e stimolato dalle minorenni, li
ha sì consapevolmente messi in scena davanti alle stesse che (anzi) ha
appositamente cercato (come riconoscono i giudici), ma lo merita ugualmente di
essere assolto, proprio perché quegli stessi atti li ha consumati al parco. E
poi per strada, in macchina e non certo in un luogo (per usare le parole del
legislatore) «abitualmente frequentato dalle sue vittime», cioè le minori.
Insomma per gli ermellini, che già si erano pronunciati allo stesso modo (nel
2015 e nel 2016) assolvendo altri maniaci sessuali per fatti identici, a fare la
differenza è il luogo in cui il depravato si masturba.
I giudici lo spiegano nel linguaggio del codice,
tecnico ma eloquente: «nel caso in questione, la condotta dell’uomo, sebbene
veda come soggetti passivi delle condotte delle bambine o comunque delle
adolescenti, non è stata realizzata, come locus commissi delicti» ossia in un
ambito territoriale «abitualmente frequentato da minori «come, invece, impone
«il secondo comma dell’articolo 527 c.p., affinché il compimento di atti osceni
conservi la sua rilevanza penale». Tradotto: il moldavo si è reiteratamente
masturbato sotto gli occhi strabiliati e terrorizzati delle bambine, però questo
in fondo non è accaduto davanti a un asilo, una scuola, un oratorio o
qualsivoglia luogo frequentato “abitualmente” e “sistematicamente” dalle
bambine. Basta e avanza dunque per assolvere il moldavo da ogni colpa. Di più
quel «abitualmente» e quel «sistematicamente» per i magistrati supremi che hanno
pronunciato il verdetto (fotocopia), non sono termini casuali.
E lorsignori provano a spiegarlo. Scrivono: «anche
se la nozione di luogo “abitualmente frequentato da minori”, va tenuta distinta
da quella di “prevalentemente frequentato da minori”, essa deve comunque
intendersi un luogo connotato da una frequentazione nel senso di una certa sua
“elettività e sistematicità”, tale da fare ritenere “abituale”, quindi “attesa”
ovvero “prevista” sulla base di una valutazione significativamente
probabilistica, la specifica presenza di minori in tale ubicazione». Significa
che per i giudici, i luoghi abitualmente frequentati da minori, sarebbero le
vicinanze di un edificio scolastico, o i centri di aggregazione giovanile. Poco
importa che il maniaco masturbatore (da perfetto predatore sessuale) abbia
puntato le sue vittime e si sia messo all’opera soltanto quando le bambine gli
sono finite davanti; il luogo in cui egli ha agito non era “sistematicamente”
battuto dalle sue stesse vittime. Vittime che non si possono proprio definire
“per caso”, se è vero che la strada o il parco (magari attrezzato di giostre
scivoli e altalene come la maggior parte dei parchi che si definiscano tali),
non sono siti interdetti alle bambine. Ma per i giudici in ermellino, si legge
nella sentenza numero 30798 «affinché ricorra il predetto requisito della
“abitualità” della frequentazione del luogo da parte dei minori non è
sufficiente - laddove non si voglia diluire il concetto sino a farlo
sostanzialmente coincidere con quello di luogo aperto o esposto al pubblico, in
tal modo trascurando la evidente volontà del legislatore che ha inteso
conservare la rilevanza penale solamente a quelle condotte che presentino una
potenziale maggiore offensività - che in quello stesso luogo si possa trovare un
minore, ma è necessario che, sulla base di una attendibile valutazione
statistica, sia “altamente probabile” che il luogo presenti la presenza di più
soggetti minori di età». Da qui, l’annullamento senza rinvio della sentenza di
condanna per il maniaco moldavo, che resterà libero di ripetere i suoi gestacci.
Di notte o in pieno giorno, ai giardinetti, in piazza, al supermercato o alle
Poste o in chiesa durante la Messa. Insomma liberi di masturbarsi tra la folla,
purché le statistiche non dimostrino che la stessa (folla) non sia composta da
minorenni. Se gli atti osceni vengono consumati e sbandierati in ogni dove, il
massimo che si può rischiare è una multa. Stessa sorte capitata al moldavo, per
il quale la Corte ha scritto: «si ordina la trasmissione degli atti al prefetto
per l’irrogazione della sanzione amministrativa». Cristiana Lodi
Uccisa nel parcheggio dell’ospedale.
«Quel maledetto che ti perseguitava», scrive Giusi
Fasano il 22 giugno 2017 su “Il Corriere della Sera”. «Basta, basta, fermati!».
Le urla, disperate, prima di cadere a terra colpita alla gola e al petto. È
morta così, nel parcheggio dove stava prendendo la sua auto a fine turno, Ester
Pasqualoni. Aveva 53 anni, era responsabile del day hospital oncologico
dell’ospedale di Sant’Omero, in provincia di Teramo, madre di due ragazzi di 14
e 16 anni, Nausicaa e Alessio. Erano circa le 16. L’aggressione è stata feroce.
«L’hanno sgozzata, uno spettacolo straziante» hanno raccontato i colleghi
accorsi attorno al corpo a terra, coperto dal lenzuolo verde. Si cercano
testimoni, ma sembra che nessuno abbia visto niente. Qualcuno ha sentito le
grida e poi un rumore sordo, come un tonfo. Roberta, titolare del ristorante di
fronte, è in lacrime: «Stamattina, come ogni giorno, è venuta a prendere un
caffè, era tranquilla e gioiosa. Dietro quel sorriso nascondeva le sue paure».
Le sue paure avevano un volto ben definito, quello di un uomo più grande di lei,
65 anni circa, di Martinsicuro, un ex investigatore privato che la perseguitava
da oltre dieci anni e che lei aveva conosciuto perché aveva in cura il padre.
Solo gli amici più stretti di Ester sapevano. «Se non ti posso avere, prima o
poi ti ammazzerò» le aveva detto. Lei quasi si vergognava di quelle persecuzioni
e cercava di tenere nascosta la cosa al lavoro anche se, in passato, aveva
denunciato quell’uomo che la tormentava con appostamenti, telefonate, messaggi.
Si era decisa, raccontano gli amici, quando l’aveva trovato sotto casa di
Fabrizio, il compagno scomparso a febbraio di due anni fa per un infarto. Si era
decisa a farlo, sottolinea il suo avvocato, Caterina Longo, «con ben due
denunce, ma non era servito a niente, erano state archiviate. Lui aveva avuto
anche il divieto di avvicinarsi ma poi la misura è stata revocata». Il legale
non si dà pace e, sul profilo Facebook, scrive: «Quante volte sedute a ragionare
di quell’uomo, quel maledetto che ti perseguitava... e non sono riuscita a
risolverti questa cosa... Me lo porterò dentro tutta la vita. Ti voglio bene
donna e amica speciale... Ti voglio bene». Sul luogo dell’omicidio arriva il pm
Davide Rosati. I carabinieri del reparto operativo di Teramo, coordinati dal
comandante Roberto Petroli, cercano un’auto, forse una Peugeot 205 bianca, che
alcuni testimoni hanno visto girare più volte intorno all’ospedale prima del
delitto e poi allontanarsi subito dopo. Chi ha ucciso Ester è stato fortunato
oppure molto bravo: nel parcheggio non ci sono telecamere e all’ora in cui la
vittima è stata colpita l’edicola all’ingresso era ancora chiusa. «È morta tra
le mie braccia. Una cosa assurda pensare che fosse lei» dice Piergiorgio
Casaccia, il medico del pronto soccorso di Sant’Omero intervenuto per primo.
Racconta di averla trovata a terra, in una pozza di sangue, e di non aver capito
subito che era lei. «Quando sono arrivato non aveva polso, non c’era più nulla
da fare». Intorno al corpo segni di colluttazione, due borse, il cellulare. Il
manager della Asl, Roberto Fagnano, ricorda le qualità professionali di Ester.
«È stata uccisa barbaramente una persona che lavorava per salvare le vite degli
altri».
Sant’Omero. Ammazzata a coltellate
davanti all’ospedale: morta donna medico. Aggredita e ferita a morte,
scrive il 21 Giugno 2017 "Prima da noi". Una dottoressa dell'ospedale di
Sant'Omero, Ester Pasqualoni, 53 anni, oncologa, è stata accoltellata davanti
all'ospedale. Ricoverata in gravi condizioni, si è appreso, è morta poco dopo.
Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica e
i colleghi del Reparto operativo di Teramo che hanno trovato la donna riversa in
una pozza di sangue. Fatale, secondo i primissimi accertamenti, un fendente alla
gola. A far scattare l'allarme dopo aver coperto il corpo senza vita, a terra
tra due macchine, è stato un altro medico che ha tentato di rianimare la donna
senza successo. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 16 quando la donna
si stava dirigendo verso la sua auto per tornare presumibilmente a casa. Il suo
turno era infatti terminato. Pasqualoni, madre di due figli minorenni, abitava a
Roseto e aveva già presentato due denunce per stalking. Non si sa se chi ha
agito sia proprio la persona indicata dalla vittima come responsabile di atti
persecutori. Pasqualoni veniva descritta dai suoi pazienti come un medico
preparato, competente e dalla grande sensibilità e umiltà. Nel giro di meno di
24 ore è il secondo delitto efferato che si registra nella provincia teramana.
Ester Pasqualoni, 53 anni, lascia due figli
minori, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 17 anni. Un medico molto amato
sia nella professione che a livello umano, come testimoniano i tanti colleghi
giunti sul posto e i commenti su Facebook postati sotto i profili dei suoi
amici. «Abbiamo idea di chi possa essere l'omicida e lo stiamo cercando», ha
riferito un investigatore aggiungendo che «si tratta molto probabilmente di una
persona che dava fastidio alla vittima». Verifiche sono in corso in merito a
denunce che la donna avrebbe presentato. A dare conferma di quanto stesse
accadendo è una sua amica, Caterina Longo. «Aveva presentato due denunce contro
il suo stalker, ma erano state entrambe archiviate».
L'uomo, dice Caterina Longo, la perseguitava «da
diversi anni, la osservava e seguiva, sempre e dappertutto. Si era intrufolato
nella sua vita non sappiamo neanche come, con artifici e raggiri. Non era un suo
ex, non avevano niente a che fare, era solo ossessionato da lei». E sempre
Caterina su Fb aveva scritto: «Quante volte sedute a ragionare di quell'uomo...
quel maledetto che ti perseguitava... e non sono riuscita a risolverti questa
cosa.....e me lo porterò dentro tutta la vita.....ti voglio bene». E sotto una
valanga di commenti di chi l'ammirava. Ad accorrere per primo subito dopo la
tragedia un medico del pronto soccorso che era in servizio: «È morta tra le mie
braccia. Una cosa assurda pensare che era Ester», dice Piergiorgio Casaccia, che
lì, in quella pozza di sangue non l'aveva riconosciuta. Intorno c'erano evidenti
segni di colluttazione, c'erano due borse in terra, il cellulare. Una cosa
assurda. Poi c'è stata solo disperazione e pianto. Perché, chi, chi può volere
del male a Ester? Una persona che ha aiutato tutti i pazienti, anche di notte.
Tra le mie mani ha fatto gli ultimi respiri. Assurdo pensare che era Ester».
«Sapevamo di questa paura che lei aveva e di
quest’uomo che la perseguitava. Spesso si faceva accompagnare al parcheggio
perchè lei aveva paura», ha detto ancora Casaccia intervistato da Chi l’ha
visto?. «Ero a lavorare al pronto soccorso», ha detto il medico, «ad un certo
punto è arrivato un signore a chiedere aiuto perchè c’era una persona a terra in
una pozza di sangue. Sono uscito con le mie mani nude, non era proprio
vicinissimo. Ho visto una persona a terra in una pozza di sangue che stava
esalando gli ultimi respiri. Mi è parso subito chiaro che la persona a terra era
stata accoltellata. Ho urlato, ho detto “chiamate subito i carabinieri, questo è
un omicidio”. Ho sentito il polso ma non c’era più. Ho coperto il corpo e mi
sono assicurato che nessuno inquinasse la scena. Poi sono arrivati i carabinieri
e sono andato via». Poi il medico ha raccontato di essere stato contattato dai
carabinieri che gli hanno mostrato il tesserino di Ester e solo allora ha
realizzato che si trattasse della sua collega. «Io purtroppo non l’ho
riconosciuta e quando mi sono accorto della barbarie che è capitata mi sono
disperato. Una oncologa così non si trova facilmente in giro, aiutava i pazienti
al di fuori del lavoro, lei c’era sempre per tutti. E’ stata colpita con
l’intento di uccidere. Non è riuscita a dire nulla. Ha esalato gli ultimi
respiri, era già in arresto cardiaco». Il luogo del delitto, il parcheggio
dell’ospedale, è un luogo ben in vista soprattutto dalle camere e tutto è
accaduto in pieno giorno tra le auto parcheggiate a pettine. Tutti dunque
avrebbero potuto vedere. Non ci sono invece telecamere che avrebbero ripreso la
scena.
L’amica Caterina Longo ha poi confermato anche a
Chi l’ha visto? che Ester si era recata alla questura di Atri per sporgere
querela per stalking ma che subito si è giunti alla archiviazione. «Era una
cosa che aveva tenuta nascosta a tutti», ha raccontato Longo, «“Perchè hai fatto
la querela ad Atri?” le domandai, “non volevo che si sapesse in giro per non far
preoccupare i figli, il compagno e l’ex marito” mi rispose. Lei era fatta così.
Ci teneva alla tranquillità dei suoi familiari e doveva risolversela da sola.
Devo dire, però, che è andata in questura, ha denunciato i fatti gravi e di
essere perseguitata. Aveva mostrato gli sms, gli aveva dato orari e riprese
fatte col cellulare, quell’uomo passava davanti casa, al lavoro, all’angolo
della strada: se lo trovava ovunque andasse. Ho poi saputo che sono state fatte
perquisizioni anche nella sua abitazione ma nelle videocassette che sono state
trovate non c’erano fotogrammi che ritraevano Pasqualoni. La denuncia è stata
poi archiviata per difetto di querela ovvero Ester non aveva espresso in maniera
esplicita la volontà di denunciarlo». La donna, delusa dall’esito della vicenda,
non ha voluto fare una nuova denuncia. “Si stancherà” diceva, non aveva nessun
tipo di rapporto con questa persona, non aveva mai dato adito a nulla, mai stata
insieme, mai uscita insieme.
Poi l’amica ha racconta anche un altro particolare
inquietante. L’uomo denunciato sarebbe stato anche fermato dagli investigatori
mentre era in auto nei pressi della scuola dei figli della donna e sorpreso a
filmare. «Ester sapeva di questa cosa glielo aveva scritto: aveva tante
videocassette nascoste in casa ma non le hanno trovate. Una volta le scrisse:
“non le troveranno mai”. Lei ha denunciato, ha avvisato le autorità ma non ha
voluto fare la guerra giudiziaria opponendosi all’archiviazione: sperava sempre
che si stancasse. Ma non è stato così».
Secondo alcune fonti non confermate l'uomo sarebbe
stato rintracciato ieri sera a Martinsicuto e arrestato dai carabinieri. Si
tratterebbe di un uomo di più di 60 anni. Non sono arrivate però arrivate
conferme dalle forze dell'ordine a questa notizia. Sembrerebbe più realistico
invece il recupero dell'auto utilizzata dall'uomo vista allontanarsi dalla scena
e descritta da alcuni testimoni. Si tratterebbe della Peugeot di colore bianco
che è stata ritrovata proprio a Martinsicuro e all'interno vi sarebbero delle
macchie di sangue.
Sistema pro-killer: due denunce
archiviate, oncologa uccisa dallo stalker, scrive
Lucia Mosca il 21 giugno 2017 su "La Notizia.net". Ci hanno abituati ad un
sistema che non funziona. Hanno abbassato il nostro livello culturale. Ci hanno
abituati ad un sistema ingiusto, privo di tutele, in cui i cittadini onesti non
hanno voce. Ci hanno abituati alla violenza, fisica e psicologica, agli abusi,
senza poter in alcun modo alzare la voce. Ci hanno abituati a dover assistere
alle pantomime della politica come se si trattasse di un dovere, a cui non ci si
può sottrarre. Ci hanno anche abituati al fatto che la vita delle persone oneste
non vale più nulla. Ci hanno abituati ad una giustizia che non svolge le proprie
reali funzioni. Ogni qual volta si parla di violenza, spesso con vittime di
sesso femminile, si susseguono stucchevoli interviste in tv che parlano della
rete protettiva tessuta intorno alla donna che deve solo avere la forza di
denunciare. Tutto ciò non è assolutamente vero. Ne abbiamo parlato nel corso
degli ultimi giorni. Dodici denunce senza che si sia ritenuto opportuno fermare
il potenziale assassino. La vittima che descrive persino l’arma con la quale si
reciderà la sua esistenza. La giustizia arriva solo a fatto compiuto e dopo la
morte per mano del killer. Oggi è accaduto di nuovo, a Sant’Omero. Un’oncologa
di 53 anni, Ester Pasqualoni, è stata uccisa nel parcheggio dell’ospedale della
Val Vibrata. Lei, che salvava vite, è stata brutalmente uccisa probabilmente per
mano di uno stalker, denunciato per ben due volte. Quindi, ci dicono di
denunciare, ci chiedono di esporci. E spesso il coraggio si paga con la vita. In
tutto questo, dov’è questo lo Stato, che non tutela i terremotati, che non si
cura delle nostre vite, che non ha interesse nel creare un futuro ai nostri
giovani, che scappano all’estero per cercare lavoro e rimangono uccisi in
attentati terroristici, e che si preoccupa esclusivamente dello Ius Soli e della
legge elettorale? Siamo vittime di un sistema cleptocratico, che si
disinteressa del benessere dei cittadini perbene. L’oncologa è stata trovata con
la gola tagliata, riversa a terra in una pozza di sangue. Inutili i tentativi di
rianimarla. La vittima, responsabile del day hospital oncologico dell’ospedale
di Sant’Omero, nata nel 1964 a Roseto degli Abruzzi (Te) e madre di due figli,
aveva concluso il suo turno di lavoro e stava raggiungendo la sua vettura quando
è stata aggredita. Questo il post con cui un’amica della vittima ha descritto
la situazione subita dalla dottoressa e poi denunciata. “Quante volte sedute a
ragionare di quell’uomo – si legge – quel maledetto che ti perseguitava. E non
sono riuscita a risolverti questa cosa, e me lo porterò dentro tutta la vita. Ti
voglio bene, donna e amica speciale… Ti voglio bene”. “Aveva presentato – spiega
– due denunce, ma erano state entrambe archiviate”. Quell’uomo la perseguitava
“da diversi anni”, la “osservava e seguiva, sempre e dappertutto. Si era
intrufolato nella sua vita non sappiamo neanche come, con artifici e raggiri.
Non era un suo ex, non avevano niente a che fare, era solo ossessionato da lei”.
E questa è la nostra giustizia. Quella che ti rende impotente di fronte alla
violenza ma che poi, se rubi un’arancia per fame, ti mette dietro le sbarre.
Archiviazione per tenuità del fatto.
Reati lievi, da oggi parte l’archiviazione. I giudici
potranno archiviare la lite con il vicino o il furto ed evitare che si finisca
in aula di tribunale, scrive Mario Valenza, Giovedì 02/04/2015, su "Il
Giornale". Da oggi parte la rivoluzione nel sistema giudiziario italiano voluto
dal governo Renzi per i reati "minori". I giudici possono bollare la lite con il
vicino o il furto ed evitare che si finisca in aula di tribunale. Non c'è solo
la bega condominiale o il furtarello per disperazione. Potrà godere della
"tenuità del fatto" anche chi è accusato di aver aperto una discarica abusiva o
di aver trafficato con rifiuti pericolosi e scarichi industriali. Questioni di
grande impatto sociale nelle quali rientrano ancora l'adulterazione di cibi, di
medicinali, l'omissione delle misure di sicurezza sul lavoro, la truffa,
l'intrusione informatica. E anche la guida in stato di ebbrezza. Senza
dimenticare la detenzione sul proprio pc di materiale pedopornografico. Stavolta
c’è il plauso dei magistrati: da anni sollecitavano un intervento del genere.
Neanche gli avvocati fanno le barricate. Il loro timore, semmai, è che le
decisioni dei giudici non siano uniformi per fatti analoghi, influenzate dalla
sensibilità personali, dai contesti e persino dai luoghi geografici. Il giudice
diventa dominus della decisione. La valutazione dei fatti è rimessa alla sua
serenità e al suo equilibrio. Una discrezionalità, secondo alcuni, persino
eccessiva. Ecco qui di seguito la lista dei reati compresi nella nuova norma:
- Esercizio abusivo della professione
- Abuso d’ufficio
- Accesso abusivo a sistema informatico o
telematico
- Appropriazione indebita
- Arresto illegale
- Attentati alla sicurezza dei trasporti
- Atti osceni
- Commercio o somministrazione di medicinali
guasti
- Commercio di sostanze alimentari nocive
- Danneggiamento
- Detenzione di materiale pedopornografico
- Diffamazione
- Frode informatica
- Furto semplice
- Gioco d’azzardo
- Guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato
- Ingiuria
- Interruzione di pubblico servizio
- Istigazione a delinquere
- Lesioni personali colpose
- Millantato credito
- Minaccia
- Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale
- Omissione di soccorso
- Rissa
- Simulazione di reato
- Sostituzione di persona
- Truffa
- Turbata libertà degli incanti
- Violazione di domicilio
- Violenza privata
Addio a tutti i reati più piccoli,
saranno archiviati senza processo. La Camera sta per
modificare il codice di procedura penale per dire basta ai procedimenti contro i
"mini crimini". Così i "fatti di particolare tenuità" come microfurti, liti e
ingiurie non saranno più perseguiti: ma la modifica non riguarderà recidivi e
delitti gravi, scrive Liana Milella il 22 febbraio 2012 su "La Repubblica".
Piccoli reati addio. Archiviati dal giudice senza arrivare al processo. Niente
più primo, secondo, terzo grado. Un decreto per dire che non hanno né il peso né
il valore per meritare ore di dibattimento. Proprio perché sono piccoli e
occasionali reati. Perché hanno un valore economico modesto. Perché possono
essere "perdonati". Alla Camera stanno per approvare un nuovo articolo del
codice di procedura penale, il 530bis, il "proscioglimento per particolare
tenuità del fatto". Il relatore, il pd Lanfranco Tenaglia, fa l'esempio del
furto della mela: "Se la rubo in un supermercato è un furto, ma il danno per il
proprietario è tenue. Ma se la rubo alla vecchietta che ne ha comprate tre, quel
fatto non sarà tenue". La Lega lo ha già battezzato legge "svuota-processi" dopo
quella svuota-carceri. Ribatte la pd Donatella Ferranti: "È un articolo
rivoluzionario, una pietra miliare sulla via della depenalizzazione". Basta
leggere il testo: "Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per
le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue
conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità". Chi
commette reati di frequente è fuori. Fuori rapine, omicidi, sequestri, violenze
sessuali. Il giudice archivia e avvisa la parte offesa che può utilizzare il
decreto per rivalersi in sede civile.
Furto al supermercato. Di un capo di biancheria,
reggiseno, slip, maglietta intima. Forzando e sganciando la placchetta
anti-taccheggio. Il ladro viene scoperto e fermato. Il suo, codice alla mano, è
un furto aggravato con violenza sulle cose, a stare agli articoli 624 e 625 del
codice penale la persona rischia da uno a sei anni. Ma il giudice prende in mano
il caso, valuta innanzitutto l'esiguo valore dell'oggetto portato via, poi si
documenta e soppesa la personalità e la storia del soggetto che ha commesso il
furto. Scopre che si tratta della prima volta. Il suo non è un reato abituale.
Decide di archiviare per la "tenuità del fatto".
Assegni trafugati. Un commerciante in difficoltà
economiche e strozzato dagli usurai incassa un assegno di cento euro senza
andare troppo per il sottile. Lo riutilizza pagando un fornitore. Purtroppo
l'assegno arriva da un furto e il commerciante rischia, come ricettatore e in
base all'articolo 648 del codice penale, da due a otto anni di reclusione. Ma se
davanti al giudice riesce a dimostrare la sua buona fede, rivela le sue
difficoltà, documenta che nella sua vita professionale non è mai incorso in un
simile incidente, potrà evitare il processo e ottenere un'archiviazione.
I beni pubblici. Telefonate private di due
dipendenti da un ministero di Roma. Nel quale è in corso un'inchiesta proprio
per evitare questi abusi. Il primo chiama una volta New York perché suo figlio,
che vive lì, è gravemente malato. Il secondo telefona ogni giorno, e a lungo,
alla fidanzata che vive a Milano. Il codice, all'articolo 314, punisce il
peculato dai tre ai dieci anni. La prima persona potrà fruire di
un'archiviazione perché il suo è un "piccolo" reato, una sola chiamata e per
ragioni gravi. Il secondo andrà incontro al suo processo perché abusa
quotidianamente e di nascosto di un bene pubblico.
Lite di condominio. In un appartamento vive una
coppia di coniugi. In quello accanto un gruppo di studenti che spesso invitano
gli amici e si divertono fino a notte fonda. Un giorno, dopo l'ennesima nottata,
scoppia una lite furibonda in cui volano parole grosse e si arriva alle mani. I
vicini si allarmano e chiamano la polizia. Scatta una denuncia per minaccia e
violenza privata contro i coniugi. Il 612 prevede il carcere fino a un anno e la
procedibilità d'ufficio. Passa qualche giorno e i ragazzi chiedono scusa. Il
fatto è isolato, occasionale, non ha precedenti. Il giudice archivia pure questo
"piccolo" reato.
Armi dimenticate. Un fucile vecchio, ma
funzionante, scoperto in soffitta dalla polizia durante un controllo. Ma il
proprietario della casa dice di non saperne niente, poi si ricorda che quel
fucile era di suo padre, che aveva un regolare porto d'armi e aveva fatto
regolare denuncia. Alla sua morte il figlio non si è più ricordato del fucile
chiuso in un baule. La sua è detenzione illegale d'armi punibile da uno a otto
anni in base alla legge 895 del 1967 poi modificata da quella del 1974, la 497.
Rischia l'arresto in flagranza. Ma se dimostrerà la buona fede e proverà d'aver
davvero "dimenticato" il fucile lasciandolo inutilizzato, potrà ottenere
un'archiviazione.
Guida in stato di ebbrezza. Un giovane manager va
a cena a casa di amici che abitano poco lontano da lui. Tre isolati in tutto.
Usa l'auto perché sa che rientrerà tardi. Durante la serata beve un paio di
bicchieri di vino e un paio di whisky. Al ritorno, quando sta per arrivare sotto
casa, viene fermato da una volante che lo sottopone alla prova del palloncino.
Che risulta positiva. In base al codice della strada rischia il sequestro
dell'auto, la revoca della patente, il processo. Ma se non ha infranto il codice
della strada né provocato incidenti e se il fatto è isolato può usufruire
dell'archiviazione.
La diffamazione. Il giornalista scrive un articolo
su un personaggio pubblico riportando nel suo pezzo una citazione dal pezzo di
un suo collega che contiene una ricostruzione, peraltro non smentita, ma
giudicata falsa e diffamatoria solo quando essa viene riportata, per citazione,
in questo articolo. L'articolo 595 del codice penale sulla diffamazione infligge
una pena da sei mesi a tre anni. Ma se il giornalista può dimostrare che
riteneva la fonte attendibile, che non aveva un intento persecutorio nei
confronti del destinatario dell'articolo, che il suo curriculum professionale è
immacolato, il giudice può archiviare la sua posizione.
Ingiuria aggravata. Due colleghi, di fronte ad
altri dello stesso ufficio, litigano per il possesso di una scrivania.
S'insultano malamente ("Sei un cornuto..." dice uno all'altro, "tua moglie è una
grande p..." risponde l'altro), arrivano alle mani, parte un cazzotto che
colpisce a un occhio uno dei due. È un caso classico di ingiuria aggravata,
punita dal 594 del codice penale con una pena fino a un anno di carcere. Ma se,
di fronte ad altri testimoni che possono provare l'autenticità del fatto, i due
si riappacificano veramente, il giudice può valutare l'opportunità di
un'archiviazione.
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. Tenuità
del fatto: il vademecum della Cassazione, scrive
Carmelo Minnella, Avvocato penalista, il 5 Gennaio 2016.Dopo i primi arresti
giurisprudenziali sulla causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, a seguito dell’introduzione dell’art. 131-bis c.p. da parte
dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28/2015, la Corte di Cassazione ha iniziato a
perimetrare i confini applicativi dell’istituto. Dopo i primi arresti
giurisprudenziali sulla causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, a seguito dell’introduzione dell’art. 131-bis c.p. da parte
dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28/2015 (vedasi Non punibilità per “tenuità del
fatto”: primi orientamenti in giurisprudenza), la Corte di Cassazione ha
iniziato a perimetrare i confini applicativi dell’istituto, secondo il quale,
nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la
punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del
danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., l’offesa è
di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Non si applica
dinanzi al Giudice di Pace. L’art. 131-bis c.p. si affianca alle analoghe figure
per irrilevanza del fatto già presenti nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R.
n. 448/1988) e in quello relativo alla competenza penale del Giudice di Pace
(art. 34 d.lgs. n. 274/2000). Proprio prendendo atto della specificità della
disciplina configurata nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la
Suprema Corte ha espressamente escluso che, in tale sede, possa trovare
applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto,
proprio perché prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice
ordinario (sezione IV, 14 luglio 2015, n. 31920).
“Offensività necessaria” del fatto lieve. Per la
Sez. III, 7 luglio 2015, n. 38364, affrontando la questione della offensività in
concreto della condotta di coltivazione di piante da sostanza stupefacente, solo
dopo il vaglio positivo della offensività della condotta incriminata, è
possibile porsi in presenza di un fatto di coltivazione “modesto” la questione
della possibile applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., in
presenza ovviamente dei relativi presupposti.
Si applica a tutti i reati. Per Sez. IV, 2
novembre 2015, n. 44132, il legislatore, avendo posto l'istituto in parola nel
contesto della parte generale del codice penale, ha evidentemente inteso
attribuirgli valenza non limitata a alcune fattispecie di reato; pertanto, non
appare in dubbio che l'istituto possa e debba trovare applicazione in tutti i
reati, anche quelli tradizionalmente indicati come “senza offesa”, tranne le
eccezioni legate ai limiti di pena (detentiva superiore a cinque anni) o alle
particolari modalità del fatto (crudeltà, sevizie o condotte causative di un
danno grave come la morte o lesioni gravi) o del reato (abituale o fatto non
occasionale).
La stessa Cassazione ha d'altronde già affermato
in passato che la particolare tenuità del fatto, concretizzatasi nella nota
causa di improcedibilità di cui all'art. 34, d.lgs. n. 274/2000, trova
applicazione anche con riferimento a reati di pericolo astratto o presunto.
Anche quelli a diverse soglie di punibilità. La
Suprema Corte ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b,
d.lgs. n. 285/1992, in quanto l’incriminazione definisce la meritevolezza di
astratte classe di fatti, laddove l’art. 131-bis c.p. si impegna sul diverso
piano del singolo fatto concreto. Sicché che il legislatore abbia utilizzato la
tecnica della soglia (come nel caso della guida in stato di ebbrezza alcolica) o
meno per selezionare classi di ipotesi che, per essere in maggior grado
offensive, impongono il dispiegarsi dell’armamentario penalistico, vi è in ogni
caso la necessità di verificare se la manifestazione reale e concreta – il fatto
unico ed irripetibile descritto dall’imputazione elevata nei confronti di un
determinato soggetto – non presenti rispetto alla cornice astratta un
ridottissimo grado di offensività (Sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44132; 31 luglio
2015, n. n. 33821).
Che la previsione di più soglie di punibilità sia
compatibile con il giudizio di tenuità del fatto considerato, in quanto essa
manifesta un giudizio legislativo già ispirato ai principi di sussidiarietà e
offensività della tutela penale, ai quali si ispira pure l’istituto descritto
dall’art. 131-bis c.p., è stata affermato anche in relazione ai reati tributari
(Sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449, anche se Sez. III, con ordinanza del 20
maggio 2015, n. 21014, ha rimesso alle Sezioni Unite (tra le altre) la quaestio
se sia possibile l’applicabilità della particolare tenuità del fatto per i reati
tributali per i quali è prevista la soglia di punibilità.
In verità gli Ermellini ricordano che le due
ipotesi non sono perfettamente coincidenti in quanto nell’art. 186, comma 2,
CdS, la progressione dell’offensiva è scandita non soltanto dal passaggio
dall’area delle sanzioni amministrative all’area del penalmente rilevante ma dal
trascorrere di due fattispecie di reato diversamente punite.
Anche al reato permanente. Per Sez. III, 27
novembre 2015, n. 47039, il reato permanente è caratterizzato non tanto dalla
reiterazione della condotta, quanto, piuttosto, da una condotta persistente (cui
consegue la protrazione nel tempo dei suoi effetti e, pertanto, dell’offesa e
del bene giuridico protetto) e non è quindi riconducibile nell’alveo del
comportamento abituale come individuabile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.,
sebbene possa essere certamente oggetto di valutazione con riferimento
all’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa, la cui sussistenza
sarà tanto più difficilmente rilevabile quanto più tardi sia cessata la
permanenza.
Anche al reato formale di reati. Sempre per Sez.
III, n. 47039/2015, essendo il concorso formale tra i reati (violazione di due o
più distinte violazioni di legge, pacificamente tra loro concorrenti, stante la
diversità del bene giuridico tutelato) caratterizzato da una unicità di azione
od omissione, risulta impossibile collocarlo tra le ipotesi di “condotte
plurime, abituale e reiterate” menzionate nel terzo comma dell’art. 131-bis
c.p., mentre riguardo ai “reati della stessa indole”, il fatto che la
disposizione rivolga l’attenzione al soggetto che abbia commesso più reati, va
escluso il concorso formale in quanto l’espressione va riferita all’unica
azione od omissione che ha poi comportato la violazione di diverse disposizioni
di legge.
Ma non al reato continuato. Invece, nel caso di
commissione di più reati uniti dal vincolo della continuazione, Sez. III, 13
luglio 2015, n. 29897, ha affermato che la particolare tenuità del fatto è
esclusa in presenza di reato continuato, che ricade tra le ipotesi di “condotta
abituale” ostativa al riconoscimento del beneficio.
Sentenza predibattimentale: non opposizione
dell’imputato e del P.M.. Per la sentenza di non doversi procedere, prevista
dall’art. 469, comma 1-bis c.p.p., perché l’imputato non è punibile ai sensi
dell’art.131-bis c.p., presume che l’imputato medesimo e il pubblico ministero
non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica
dibattimentale (Sez. III, n. 47039/2015).
Le parti potrebbero infatti avere interesse ad un
diverso esito del procedimento. L’imputato potrebbe mirare all’assoluzione nel
merito o ad una diversa formula di proscioglimento o mirare alla prescrizione
(per sez. III, con la sentenza n. 27055 depositata il 26 giugno 2015, la
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione
della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art.
131-bis c.p.), considerato che anche che la dichiarazione di non punibilità per
particolare tenuità del fatto comporta, quale conseguenza, l’iscrizione del
relativo procedimento nel casellario giudiziale.
… la persona offesa non ha alcun veto ma va
avvisata. La persona offesa che, diversamente dall’imputato e dal P.M., non ha
alcun potere di veto (Sez. IV, n. 31920/2015), mancando una espressa previsione
in tal senso, deve essere comunque messa in condizione di scegliere se comparire
ed interloquire sulla questione della tenuità e deve ricevere avviso della
fissazione dell’udienza in camera di consiglio, con l’espresso riferimento alla
specifica procedura dell’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., non potendovi sopperire
la notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata quando tale
particolare esito del procedimento non è neppure prevedibile (Sez. III, n.
47039/2015).
… appello o ricorso in Cassazione avverso
pronuncia sulla tenuità? Se la pronuncia avviene in camera di consiglio, l’unico
rimedio esperibile avverso la pronuncia che dichiara l’esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto è il ricorso per cassazione.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è
unanime nel ritenere che, indipendentemente dalla qualificazione datane dal
giudice, la sentenza pronunciata in pubblica udienza (anche per una causa di
improcedibilità dell’azione come la tenuità del fatto o di estinzione del
reato), dopo la formalità di verifica della costituzione delle parti, deve
considerarsi come sentenza dibattimentale ed è pertanto soggetta ad appello. In
questi casi, il ricorso immediato in Cassazione per violazione di legge
costituisce, quindi, ricorso per saltum, con la conseguenza che, se il suo
accoglimento comporti l’annullamento con rinvio, il giudice del rinvio è
individuato in quello che sarebbe competente per l’appello (ancora Sez. III, n.
47039/2015).
Questa la sostanza, poi c’è la prassi.
"Nel dubbio archiviate le inchieste":
tribunale intasato dai processi, il consiglio ai pm di Cagliari,
scrive Enrico Fresu il 12 Giugno 2017 su "Youtg". Il messaggio ai magistrati
cagliaritani è: nel dubbio, archiviate le inchieste penali. Il tribunale di
Cagliari è soffocato dai processi e molti – stando alle statistiche del 2016 –
si chiudono con un’assoluzione per l’imputato. Per questo l’ex procuratore
Gilberto Ganassi ha diramato una circolare tra i pm: portate avanti solo le
indagini che hanno buona probabilità di finire con una condanna all’esito del
giudizio. Il provvedimento firmato dal procuratore aggiunto risale a marzo, ad
aprile è stato comunicato all’Ordine degli avvocati. Intanto a capo della
Procura cagliaritana è arrivata Maria Alessandra Pelagatti ma la circolare di
Ganassi continua a sortire i suoi effetti. Creando qualche malcontento tra gli
avvocati. Perché non ci sono solo i procedimenti per reati contro la pubblica
amministrazione, altre ruberie o spaccio. C’è anche l’altissima incidenza dei
processi scaturiti da querele e denunce: sono queste a intasare le aule. E tra
vedere e non vedere, il pm deve archiviare. Ganassi nella circolare richiamava
due interpretazioni del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Secondo la prima “l’archiviazione deve essere richiesta solo nei casi di
inequivoca infondatezza della notizia di reato”. Ossia quando è chiaro, senza
ombra di dubbio, che il processo non andrà da nessuna parte. Secondo un’altra
tesi c’è “idoneità a sostenere l’accusa in giudizio solo quando gli elementi
acquisiti fanno ragionevolmente prevedere che all’esito del giudizio verrà
confermata la responsabilità penale dell’imputato”. Il pm quindi deve cercare di
capire se l’azione penale porterà con molta probabilità a una condanna, sulla
base degli elementi raccolti durante le indagini. Sennò, se quindi ha qualche
dubbio, la bilancia della giustizia deve pendere verso l’archiviazione. Il
procuratore consigliava così di presentare “richiesta di archiviazione anche nei
casi di insufficienza o contraddittorietà della prova non superabili in
giudizio”. Fatte salve, è l’inciso, “le specifiche particolarità di ogni singola
vicenda”.
Sicilia, condannata la procura: non fermò
in tempo l'uomo che uccise la moglie. Saverio Nolfo
era stato denunciato dodici volte dalla moglie alla Procura di Caltagirone. La
corte d'Appello: "Inerzia dei magistrati". Condanna a 260mila euro, scrive
Manuela Modica il 13 giugno 2017 su “La Repubblica”. “Mi ha minacciato con un
coltello, non so più che devo fare: aiutatemi”: con queste parole Marianna
Manduca si rivolgeva alla procura di Caltagirone, poco prima di essere uccisa
dal marito, Saverio Nolfo con sei coltellate al petto e all’addome il 4 ottobre
del 2007 a Palagonia. Dodici denunce cadute nel vuoto e fattesi particolarmente
allarmanti negli ultimi sei mesi di vita. Quei sei mesi in cui i pm la
ignorarono: “All’epoca la questione fu considerata alla stregua di una lite
familiare”, commenta l’avvocato del padre adottivo dei figli di lei, Alfredo
Galasso. La procura di Caltagirone (genericamente il capo dell'ufficio all’epoca
dei fatti, Onofrio Lo Re, che nel frattempo è morto) è stata infatti condannata
da tre giudici messinesi, due donne e un uomo, della corte d'Appello di Messina.
Si tratta della presidente Caterina Mangano, Giovanna Bisignano e Mauro Mirenna,
che hanno riconosciuto il danno patrimoniale condannando la presidenza del
Consiglio dei ministri al risarcimento di 260mila euro, e riconoscendo l’inerzia
dei magistrati dopo una lunga trafila giudiziaria. L’azione legale di Carmelo
Calì, lontano cugino della donna uccisa che ha oggi adottato i tre figli maschi
(15, 13 e 12 anni) è iniziata cinque anni fa. Il processo infatti ha dovuto
passare un giudizio di ammissibilità, richiesto nel caso di responsabilità dei
magistrati. L’ammissibilità della richiesta era stata rifiutata dal tribunale di
Messina, poi dalla corte d’Appello fino alla Cassazione che ha bocciato le corti
messinesi. Solo dopo la sentenza della corte di Cassazione, dunque, che ha
accolto la richiesta dei legali Alfredo Galasso e Licia D’Amico, il processo ha
avuto inizio e il 7 giugno il tribunale di Messina ha depositato la sentenza
riconoscendo la responsabilità negli ultimi sei mesi di vita di Marianna della
magistratura. La donna aveva 35 anni quando fu uccisa da sei coltellate al petto
e al torace sferrate dal marito Saverio Nolfo, all’epoca trentasettenne, adesso
in carcere, condannato a vent’anni per l’omicidio. Lei era geometra e lavorava
presso uno studio privato mentre lui era disoccupato e tossicodipendente. I
giudici di Messina hanno riconosciuto il danno patrimoniale derivato dal
fatto che i tre figli non hanno più goduto dello stipendio della madre: “Siamo
parzialmente soddisfatti, ricorreremo in appello: c’è un danno morale che a
Messina non è stato riconosciuto soltanto perché all’epoca la legge sulla
responsabilità della magistratura era diversa ma non è un caso che sia stata
modificata e che non riguardi più soltanto la limitazione della libertà
personale”, ha concluso Galasso.
Denunce a perdere. Marianna Manduca e la
condanna civile dei Pubblici Ministeri negligenti. 12
denunce disattese che hanno causato la morte di Marianna per mano del marito. La
condanna è per responsabilità civile del Magistrato, fatto eccezionale e dopo
traversie, dove a pagare sarà lo Stato e non il Magistrato, in quanto i fatti
sono antecedenti all'entrata in vigore della legge sulla responsabilità civile.
Lo Stato, comunque, se si si rivarrà sul suo dipendente, sarà rimborsato
dall’assicurazione per responsabilità civile che i magistrati hanno stipulato
per poche decine di euro annue. Assicurazione valida anche come strumento
risarcitorio post riforma. Come dire: Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
La condanna non è per omissione d’atti di ufficio.
La condanna non è per omicidio colposo o per
concorso in omicidio volontario con dolo eventuale, in quanto l’evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, è conseguenza della sua
azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 c.p.).
Cari giornali, fate i nomi dei condannati
anche se si tratta di due pm di Catania, scrive
Vincenzo Vitale il 15 giugno 2017 su "Il Dubbio". Le agenzie di stampa e i
giornali di tutta Italia hanno riportato in questi giorni a più riprese la
triste vicenda di quella donna – Marianna Manduca – uccisa dal marito, ma che
inutilmente aveva denunciato, alla Procura della Repubblica, numerosi precedenti
di aggressioni subite dallo stesso. Per tale motivo, i figli della donna uccisa
hanno intentato causa allo Stato per ottenere un congruo risarcimento del danno
per la negligenza mostrata nel caso in specie da parte di due pubblici ministeri
– allora in servizio a Catania o a Caltagirone (le notizie si contraddicono) – i
quali, esaminando le denunce della donna, non avevano fatto quanto necessario a
dotarla di un opportuno dispositivo di sicurezza che la ponesse al sicuro dalle
aggressioni del marito. E dunque, lo Stato dovrà pagare trecentomila euro ai
figli e poi si potrà rivalere sui due magistrati riconosciuti responsabili dal
Tribunale di Messina per tale inescusabile negligenza. La notizia suscita
interesse per due motivi.
Innanzitutto, perché si tratta di una delle
rarissime occasioni in cui un Tribunale riconosce la responsabilità di un
magistrato (anzi di due magistrati) nell’esercizio della propria funzione: a
questi esiti l’opinione pubblica è del tutta non avvezza, al punto che ormai di
ricorsi per responsabilità dei giudici se ne propongono in misura sempre
decrescente – prossima allo zero – temendo appunto che vengano rigettati,
consacrando invece una sorta di originaria infallibilità di costoro.
Invece, da un secondo punto di vista, scandalizza
davvero che nessuna agenzia di stampa o fonte giornalistica in tre giorni filati
che la notizia esce a ripetizione abbia sentito il normale impulso professionale
a fare i nomi di questi due pubblici ministeri: silenzio assoluto! Nessuno, dico
nessuno fra gli organi di stampa li ha pubblicati o forse addirittura
conosciuti: e questo sarebbe ancor più assurdo.
Ma come è possibile? Come è possibile che chi
siano costoro – tanto più se, come pare, uno almeno di loro è ancora in servizio
– rimanga avvolto dalla nebbia più fitta? Che si tratti di un segreto di Stato?
Che ce lo dicano… E allora delle due l’una. O la stampa si autocensura, evitando
di rendere pubblici i nomi dei due pubblici ministeri, per una sorta di timore
non confessabile (ma timore di che cosa? Di possibili ritorsioni? Da parte di
chi? E perché?); oppure opera in modo sotterraneo, ma ben percepibile dagli
addetti ai lavori, una sorta di silenziosa forza intimidatrice, proveniente dal
sistema giudiziario nel suo complesso, la quale mette paura a chi sia incaricato
per vocazione e per obbligo deontologico – come appunto il giornalista – di dire
la verità: in questo caso la verità del nome di questi due pubblici ministeri.
Questa eventualità – se fosse vera – sarebbe ancor
più inquietante dell’autocensura. E allora, siccome io non credo né alla prima
tesi né alla seconda, chiedo qui formalmente a tutti gli organi di stampa
italiani di trattare questi due pubblici ministeri come di solito si trattano in
casi del genere i sindaci, gli assessori, i primari di medicina, gli avvocati,
gli stessi giornalisti e in genere tutti gli uomini normali: chiedo cioè di fare
una buona volta i nomi di questi due innominati. Chi sono? Come si chiamano?
Attendo.
In Italia, spesso, ottenere giustizia è una
chimera. In campo penale, per esempio, vige un istituto non previsto da alcuna
norma, ma, di fatto, è una vera consuetudine. In contrapposizione al Giudizio
Perenne c’è l’Insabbiamento.
Rispetto al concorso esterno all’associazione
mafiosa, un reato penale di stampo togato e non parlamentare, da affibbiare alla
bisogna, si contrappone una norma non scritta in procedura penale:
l’insabbiamento dei reati sconvenienti.
A chi è privo di alcuna conoscenza di diritto,
oltre che fattuale, spieghiamo bene come si forma l’insabbiamento e quanti gradi
di giudizio ci sono in un sistema che a livello scolastico lo si divide con i
fantomatici tre gradi di giudizio.
Partiamo col dire che l’insabbiamento è applicato
su un fatto storico corrispondente ad un accadimento che il codice penale
considera reato.
Per il sistema non è importante la punizione del
reato. E’ essenziale salvaguardare, non tanto la vittima, ma lo stesso soggetto
amico, autore del reato.
A fatto avvenuto la vittima incorre in svariate
circostanze che qui si elencano e che danno modo a più individui di intervenire
sull’esito finale della decisione iniziale.
La vittima, che ha un interesse proprio leso, ha
una crisi di coscienza, consapevole che la sua querela-denuncia può recare
nocumento al responsabile, o a se stessa: per ritorsione o per l’inefficienza
del sistema, con le sue lungaggini ed anomalie. Ciò le impedisce di proseguire.
Se si tratta di reato perseguibile d’ufficio, quindi attinente l’interesse
pubblico, quasi sempre il pubblico ufficiale omette di presentare denuncia o
referto, commettendo egli stesso un reato.
Quando la denuncia o la querela la si vuol
presentare, scatta il disincentivo della polizia giudiziaria.
Ti mandano da un avvocato, che si deve pagare, o
ti chiedono di ritornare in un secondo tempo. Se poi chiedi l’intervento urgente
delle forze dell’ordine con il numero verde, ti diranno che non è loro
competenza, ovvero che non ci sono macchine, ovvero di attendere in linea,
ovvero di aspettare che qualcuno arriverà………
Quando in caserma si redige l’atto, con motu
proprio o tramite avvocato, scatta il consiglio del redigente di cercare di
trovare un accordo e poi eventualmente tornare per la conferma.
Quando l’atto introduttivo al procedimento penale
viene sottoscritto, spesso l’atto stanzia in caserma per giorni o mesi, se
addirittura non viene smarrito o dimenticato…
Quando e se l’atto viene inviato alla procura
presso il Tribunale, è un fascicolo come tanti altri depositato su un tavolo in
attesa di essere valutato. Se e quando…Se il contenuto è prolisso, non viene
letto. Esso, molte volte, contiene il nome di un magistrato del foro. Non di
rado il nome dello stesso Pubblico Ministero competente sul fascicolo. Il
fascicolo è accompagnato, spesso, da una informativa sul denunciante, noto agli
uffici per aver presentato una o più denunce. In questo caso, anche se fondate
le denunce, le sole presentazioni dipingono l’autore come mitomane o pazzo.
Dopo mesi rimasto a macerare insieme a centinaia
di suoi simili, del fascicolo si chiede l’archiviazione al Giudice per le
Indagini Preliminari. Questo senza aver svolto indagini. Se invece vi è il faro
mediatico, allora scatta la delega delle indagini e la comunicazione di garanzia
alle varie vittime sacrificali. Per giustificare la loro esistenza, gli
operatori, di qualcuno, comunque, ne chiedono il rinvio a giudizio, quantunque
senza prove a carico.
Tutti i fascicoli presenti sul tavolo del Giudice
per l’Udienza Preliminare contengono le richieste del Pubblico Ministero:
archiviazione o rinvio a giudizio. Sono tutte accolte, a prescindere. Quelle di
archiviazione, poi, sono tutte accolte, senza conseguire calunnia per il
denunciante, anche quelle contro i magistrati del foro. Se poi quelle contro i
magistrati vengono inviate ai fori competenti a decidere, hanno anche loro la
stessa sorte: archiviati!!!
Il primo grado si apre con il tentativo di
conciliazione con oneri per l’imputato e l’ammissione di responsabilità, anche
quando la denuncia è infondata, altrimenti la condanna è già scritta da parte
del giudice, collega del PM, salvo che non ci sia un intervento divino, (o
fortemente terrestre sul giudice), o salvo che non interviene la prescrizione
per sanare l’insanabile. La difesa è inadeguata o priva di potere. Ci si tenta
con la ricusazione, (escluso per il pm e solo se il giudice ti ha denunciato e
non viceversa), o con la rimessione per legittimo sospetto che il giudice sia
inadeguato, ma in questo caso la norma è stata sempre disapplicata dalle toghe
della Cassazione.
Il secondo grado si apre con la condanna già
scritta, salvo che non ci sia un intervento divino, (o fortemente terrestre sul
giudice), o salvo che non interviene la prescrizione per sanare l’insanabile. Le
prove essenziali negate in primo grado, sono rinegate.
In terzo grado vi è la Corte di Cassazione,
competente solo sull’applicazione della legge. Spesso le sue sezioni emettono
giudizi antitetici. A mettere ordine ci sono le Sezioni Unite. Non di rado le
Sezioni Unite emettono giudizi antitetici tra loro. Per dire, la certezza del
diritto….
Durante il processo se hai notato anomalie e se
hai avuto il coraggio di denunciare gli abusi dei magistrati, ti sei scontrato
con una dura realtà. I loro colleghi inquirenti hanno archiviato. Il CSM invece
ti ha risposto con una frase standard: “Il CSM ha deliberato l’archiviazione non
essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di
censure ad attività giurisdizionale”.
Quando il processo si crede che sia chiuso, allora
scatta l’istanza al Presidente della Repubblica per la Grazia, ovvero l’istanza
di revisione perchè vi è stato un errore giudiziario. Petizioni quasi sempre
negate.
Alla fine di tutto ciò, nulla è definitivo. Ci si
rivolge alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che spesso rigetta. Alcune
volte condanna l’Italia per denegata giustizia, ma solo se sei una persona con
una difesa capace. Sai, nella Corte ci sono italiani.
Per i miscredenti vi è un dato, rilevato dal foro
di Milano tratto da un articolo di Stefania Prandi del “Il Fatto Quotidiano”.
“Per le donne che subiscono violenza spesso non c’è giustizia e la
responsabilità è anche della magistratura”. A lanciare l’accusa sono avvocate e
operatrici della Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano che
puntano il dito contro la Procura della Repubblica di Milano, “colpevole” di non
prendere sul serio le denunce delle donne maltrattate. Secondo i dati su 1.545
denunce per maltrattamento in famiglia (articolo 572 del Codice penale)
presentate da donne nel 2012 a Milano, dal Pubblico ministero sono arrivate
1.032 richieste di archiviazione; di queste 842 sono state accolte dal Giudice
per le indagini preliminari. Il che significa che più della metà delle denunce
sono cadute nel vuoto. Una tendenza che si conferma costante nel tempo: nel 2011
su 1.470 denunce per maltrattamento ci sono state 1.070 richieste di
archiviazione e 958 archiviazioni. Nel 2010 su 1.407 denunce, 542 sono state
archiviate.
«La tendenza è di archiviare, spesso de plano,
cioè senza svolgere alcun atto di indagine, considerando le denunce
manifestazioni di conflittualità familiare – spiega Francesca Garisto, avvocata
Cadmi – Una definizione, questa, usata troppe volte in modo acritico, che
occulta il fenomeno della violenza familiare e porta alla sottovalutazione della
credibilità di chi denuncia i maltrattamenti subiti. Un atteggiamento grave da
parte di una procura e di un tribunale importanti come quelli di Milano».
Entrando nel merito della “leggerezza” con cui vengono affrontati i casi di
violenza, Garisto ricorda un episodio accaduto di recente: «Dopo una denuncia di
violenza anche fisica subita da una donna da parte del marito, il pubblico
ministero ha richiesto l’archiviazione de plano qualificandola come espressione
di conflittualità familiare e giustificando la violenza fisica come possibile
legittima difesa dell’uomo durante un litigio».
Scarsa anche la presa in considerazione delle
denunce per il reato di stalking (articolo 612 bis del codice penale). Su 945
denunce fatte nel 2012, per 512 è stata richiesta l’archiviazione e 536 sono
state archiviate. Per il reato di stalking quel che impressiona è che le
richieste di archiviazione e le archiviazioni sono aumentate, in proporzione,
negli anni. In passato, infatti, la situazione era migliore: 360 richieste di
archiviazione e 324 archiviazioni su 867 denunce nel 2011, 235 richieste di
archiviazione e 202 archiviazioni su 783 denunce nel 2010. Come stupirsi,
dunque, che ci sia poca fiducia nella giustizia da parte delle donne? Manuela
Ulivi, presidente Cadmi ricorda che soltanto il 30 per cento delle donne che
subiscono violenza denuncia. Una percentuale bassa dovuta anche al fatto che
molte, in attesa di separazione, non riescono ad andarsene di casa ma sono
costrette a rimanere a vivere con il compagno o il marito che le maltrattata.
Una scelta forzata dettata spesso dalla presenza dei figli: su 220 situazioni di
violenza seguite dal Cadmi nel 2012, il 72 per cento (159) ha registrato la
presenza di minori, per un totale di 259 bambini.
Non ci dobbiamo stupire poi se la gente è
ammazzata per strada od in casa. Chiediamoci quale fine ha fatto la denuncia
presentata dalla vittima. Chiediamoci se chi ha insabbiato non debba essere
considerato concorrente nel reato.
Quando la giustizia è male amministrata, la gente
non denuncia e quindi meno sono i processi, finanche ingiusti. Nonostante ciò vi
è la prescrizione che per i più, spesso innocenti, è una manna dal cielo. In
queste circostanze vien da dire: cosa hanno da fare i magistrati tanto da non
aver tempo per i processi e comunque perché paghiamo le tasse, se non per
mantenerli?
"In Italia ci sono milioni di vittime della male
giustizia". Silvio Berlusconi non poteva evitare di ricordarlo durante
l’incontro con il club lombardo di Forza Silvio, riunito a Milano. "Siamo
arrivati ad avere magistrati che con troppa leggerezza arrivano a togliere
libertà a cittadini italiani - dice Berlusconi - e per questo nella riforma
della giustizia che vogliamo realizzare dopo aver vinto le elezioni inseriremo
anche l’istituto della cauzione, come accade in America, che sarà graduata a
seconda delle possibilità economiche del singolo cittadino. In carcere si
dovrebbe andare solo per reati di sangue". Sempre in tema di giustizia, il
Cavaliere ha anticipato qualcosa dell’instant book che ha scritto in questi
giorni e che verrà distribuito a tutti i club Forza Silvio d'Italia. "Nel libro
- ha detto l’ex premier - spiego la magistratura con cui abbiamo a che fare. Che
è incontrollata e incontrollabile. Non paga mai anche quando sbaglia. Sono
impuniti, godono di un privilegio medioevale. Se ci sono 100 imputati in un
processo di solito 50 sono giudicati colpevoli. Ma qual è il risultato se
l'imputato è un giudice? la percentuale scende al 4-5%. Ci troviamo in una
situazione molto lontana da quella di libertà in cui dovremmo vivere. Nessun
italiano può essere sicuro, in queste condizioni dei propri diritti".
Frodi, furti, corruzioni: quando il
processo diventa criminogeno, scrive Donatella Stasio
il 23 luglio 2013 su "Il Sole 24 ore". A leggerla bene, la cronaca giudiziaria
recente descrive un paradosso: il processo, luogo di accertamento della verità,
viene stravolto e piegato a interessi criminali. Nello Rossi, Procuratore
aggiunto di Roma e capo del pool sui reati economici, lo conferma: «Il processo
si trasforma in un inedito ambiente criminogeno, nel quale si corrompe, si
falsifica, si ruba. Siamo di fronte a un segmento altamente specializzato della
criminalità dei colletti bianchi: la criminalità del giudiziario». I
protagonisti principali sono giudici e avvocati, che «sfruttano a proprio
vantaggio, spesso con straordinaria astuzia, tutti i fattori di crisi della
giustizia in Italia: l'enorme numero di processi, la complessità e farraginosità
delle procedure, le difficoltà degli enti (soprattutto previdenziali) di
controllare i dati di un contenzioso spesso sterminato». L'ultimo caso eclatante
è di ieri, con i sette arresti per corruzione in atti giudiziari chiesti dalla
Procura di Roma e ordinati dal Gip. Una fogna in cui sguazzavano giudici,
imprenditori, banchieri, faccendieri, aspiranti notai bocciati al concorso. Uno
scandalo di dimensioni enormi. L'ennesimo emblema di un «fenomeno» più generale
e allarmante, su cui Rossi accetta di riflettere con Il Sole 24 ore.
Premettendo: «Forse dobbiamo avere il coraggio di guardare di più al nostro
interno, ai meccanismi che vengono alterati e alle cadute di moralità dei
protagonisti della giustizia». La corruzione dei giudici, anzitutto. «È
certamente il fenomeno più inquietante: qui il patto tra corruttore e corrotto è
il più iniquo perché getta sulla "bilancia" un peso truccato con effetti
devastanti sia sulla singola vicenda processuale sia sulla credibilità del
sistema giudiziario, tant'è che neanche un anno fa il legislatore ha aumentato
le pene per questo reato». Eppure, l'effetto deterrente di questo intervento
sembra smentito dalla cronaca. Come mai? «Spesso, negli episodi più recenti non
siamo di fronte a un singolo accordo corruttivo; il giudice infedele mette in
moto un vero e proprio ciclo corruttivo, un ingranaggio ben oliato che investe
più processi». Il vero deterrente sono «indagini accurate, che reggano alla
prova del processo, eliminando il senso di impunità del giudice corrotto». Ma
«molto resta da fare sul piano della deontologia di tutte le categorie, compresi
gli avvocati». La corruzione giudiziaria è infatti solo uno dei tasselli del
mosaico della «criminalità del giudiziario». C'è anche «l'utilizzazione
truffaldina del processo», come quella emersa nel caso altrettanto clamoroso - e
recente - dei processi previdenziali "finti". «Avvocati che falsificano le firme
di incarico di clienti inesistenti (persone ignare, per lo più residenti
all'estero, o morte), che ottengono in giudizio moltissime condanne dell'Inps a
pagare interessi e rivalutazione su prestazioni previdenziali e che infine
incassano personalmente le somme liquidate, grazie alla complicità di funzionari
di banca. Non solo: su questa frode ne hanno subito innestata un'altra,
altrettanto redditizia, imbastendo ulteriori processi, anch'essi fittizi, e
incassando, in base alla legge Pinto, anche il risarcimento per l'eccessiva
durata dei processi previdenziali fasulli». Un'integrale strumentalizzazione del
processo, insomma. «Sì, come luogo in cui vengono fatti agire dei fantasmi, vere
e proprie "anime morte" della giurisdizione». Va bene Gogol', ma ci sono anche
processi veri con anime vive e avide. «È la terza tessera del mosaico»,
occasione di torsione della giustizia e di clamorose ruberie. Sono «i furti
perpetrati sui beni che restano dopo il fallimento dell'impresa, da ripartire
ugualmente tra tutti i creditori e spesso sviati su altre strade. Soldi
dirottati da curatori infedeli, ingannando il giudice o talvolta con la sua
complicità, verso creditori inesistenti o per prestazioni artificiose in favore
dell'impresa fallita, e subito smistati verso banche di paradisi fiscali».
L'elenco potrebbe continuare. Le indagini rivelano
trucchi e stratagemmi sofisticati. «Certo, la stragrande maggioranza di chi
opera nel mondo della giustizia è fatta di onesti. Anche loro sono vittime della
criminalità del giudiziario. La repressione dei corrotti e dei falsari, oltre a
tutelare i cittadini, serve anche a salvaguardare questi onesti».
Il tribunale di Vicenza, nuovo porto
delle nebbie. Prima non si è occupata del caso BpVi,
ora dichiara la sua incompetenza territoriale e spedisce gli atti a Milano, che
a sua volta ha passato le carte alla Cassazione, scrive Paolo Madron su "Lettera
43" l'8 giugno 2017. La giustizia italiana ha un nuovo porto delle nebbie. No,
non è più il tribunale di Roma, in passato famoso per la sua propensione a
insabbiare. È quello di Vicenza che, di fronte al disastro della locale Popolare
(siccome bisogna essere trasparenti con i lettori, azionista minore di questo
giornale) ha girato la testa dall’altra parte. E quando qualcuno dei suoi
magistrati pensò invece di non girarla, il tracollo era di là da venire ma già
se ne intuiva qualche indizio, si pensò bene di risolvere il problema alla
radice trasferendo l’impicciona, visto che era anche una discreta alpinista,
nella ridente Cortina. Sto parlando del gip Cecilia Carreri, che nel 2002
respinse la richiesta di archiviazione delle indagini nei confronti di Gianni
Zonin, per oltre vent’anni incontrastato dominus della banca. Da allora nel
tribunale della città del Palladio (il nuovo è un obbrobrio urban paesaggistico
che non ha eguali) quello della Popolare di Vicenza è diventato un non luogo a
procedere. Fino a due anni fa, quando la Bce squarciò il velo mostrando tutto il
marcio che allignava in un istituto che tutti credevano sano e al riparo dai
rovesci della crisi. Fu solo allora che, di fronte alla protesta di migliaia di
risparmiatori ridotti sul lastrico e all’irrompere del caso Vicenza sul
palcoscenico nazionale, la Procura si mosse accusando i vertici dell’istituto di
aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Ma, come quasi sempre avviene, al suo
risveglio i buoi erano già scappati e il danno consumato. Il gip di Vicenza,
dopo essersi tenuta per mesi il fascicolo sula scrivania, ha pensato bene di
dichiarare la sua incompetenza territoriale spedendo gli atti a Milano. Zonin
aveva trasferito per tempo tutti i suoi beni a figli e parenti, e sui suoi
sodali complici del misfatto non si registra esserci stata una particolare lena
nell’indagarli. Almeno fino a quando due sostituti della Procura, meglio tardi
che mai, hanno deciso di mettere sotto sequestro 106 milioni di euro chiedendo
sei mesi fa al gip di convalidarla. Non a tutti, però, visto che tra coloro
oggetto del provvedimento guarda caso non compare incredibilmente il presidente
Zonin, ma solo l’ex direttore generale dell’istituto e il suo vice. Ma al danno
ora i aggiunge la beffa. Il gip di Vicenza, dopo essersi tenuta per mesi il
fascicolo sula scrivania, ha pensato bene di dichiarare la sua incompetenza
territoriale spedendo gli atti a Milano dove, fino a prova contraria, hanno sede
molte importanti istituzioni ma non la Consob e nemmeno la Banca d’Italia.
Ovviamente ai colleghi di Milano è bastata una rapida occhiata alle carte per
dichiarare a loro volta l’incompetenza. Toccherà quindi alla Cassazione, non si
sa bene quando, risolvere l’arcano. Un pasticcio che anche nel porto delle
nebbie vicentino deve essere sembrato troppo, visto che il procuratore capo ha
pubblicamente denunciato come abnorme la decisione del gip. Piccola nota
conclusiva giusto per capire come gira da noi il mondo. Ricorda
oggi Repubblica che le indagini aperte sul cda della Vicenza, quando ancora era
additata come un modello di banca, per la mancata iscrizione a bilancio di
alcuni milioni di minusvalenza furono repentinamente archiviate dall’allora
procuratore capo Antonio Fojadelli. Il cui nome, una volta dimessosi dalla
magistratura nel 2011, compare tra i consiglieri d’amministrazione della Nordest
Merchant, società interamente controllata dalla Popolare di Vicenza.
L'IMPRESA IMPOSSIBILE DELLA RIPARAZIONE DEL
NOCUMENTO GIUDIZIARIO.
La melanzana rubata che ci costa 8.000
euro. In Italia si moltiplicano le cause intentate per
motivi assurdi e si accumulano pendenze che non si riesce a sbrigare. In
Cassazione nell’ultimo anno sono circa 106 mila, scrive il 27 marzo 2018 Gian
Antonio Stella su "Il Corriere della Sera". Può una melanzana costare ai
contribuenti 8.000 euro? Certo, ci sono questioni di principio che non hanno
prezzo. Ed è ovvio che la magistratura deve esser libera di andare avanti con
una causa giudiziaria anche se dovesse costare un milione. Ma solo se si tratta,
appunto, di una questione di principio fondamentale. Non per una melanzana
rubata nel campo di un contadino che, per non coprirsi di ridicolo, non aveva
neppure sporto denuncia. Eppure così è andata: Simone Saba, rubato nel lontano
2009 l’ortaggio (1,20 euro al chilo, oggi) è stato protagonista di tre processi
finché la Cassazione, finalmente, ha chiuso la faccenda per la «tenuità» del
reato. Il tutto a spese, come spiegano le cronache, della collettività. Compreso
il difensore dato che il ladruncolo era nullatenente. Se si trattasse di una
curiosità bizzarra, amen. Il guaio è che il costosissimo tormentone è solo
l’ultimo di una lunga serie. Che ha visto la Cassazione trascinata nel gorgo di
processi demenziali. Come quello sul bucato steso ad asciugare: «Qualora i panni
sciorinati invadano con la loro parte pendente o l’acqua gocciolante il terrazzo
alieno ci si trova di fronte a una compressione del godimento del proprietario
sottostante?». O sull’asina andata a brucare sul campo del vicino: anni di
udienze e scontri dal primo grado al secondo e su su in Cassazione finché i
giudici avevano rinviato tutto al primo grado perché, per quel reato, l’asina
solitaria andava «considerata mandria».
Per non dire di altre cause avviate con le
motivazioni più assurde. Dalla permalosissima signora che querela la vicina
perché le ha mandato un Sms con scritto «Perepe qua qua qua qua perepe» fino al
suocero che fa causa per truffa alla nuora rea di aver messo in tavola agnolotti
comprati e non fatti in casa e così via... Deliri. Tanto più in un Paese dove la
Cassazione, dice l’ultimo dossier di Studio Ambrosetti, continua ad accumulare
pendenze che non riesce a sbrigare: «Circa 106mila rispetto alle 103mila
dell’anno precedente». «Causa che pende / causa che rende», recita un vecchio
adagio degli avvocati più cinici. Certo è che ancora una volta torniamo a
rimpiangere Eleonora, la giudicessa d’Arborea che alla fine del Trecento stabilì
nella «Carta de Logu»: «Vogliamo e ordiniamo che al fine di limitare le spese ai
sudditi ed ai litiganti circa vertenze o liti che non superano i 100 soldi sia
vietato appellarsi a Noi o ad altri funzionari regi...».
Per uscire fuori dall'incubo giudiziario si ha
bisogno di una forte dose di culo (inteso come fortuna). Essere innocenti non è
essenziale. Il malcapitato che incappa nell'amo della giustizia, si dibatte come
un pesce, ma il malcapitato più si muove (a rivendicare la sua innocenza), più
l'amo si infilza nella bocca. Il sistema è programmato a produrre risultati, per
giustificare il suo costo, ed il conto si presenta in fascicoli chiusi, non in
rei condannati. La riparazione del nocumento (danno che altera o interrompe la
funzionalità o l'efficacia di un fatto naturale) è quasi impossibile che si
compia. Per corporativismo delle toghe giudiziarie, ossia per viltà delle toghe
forensi, perchè è difficile trovare qualcuno di loro che abbia il coraggio di
additare un magistrato come reo di un errore eclatante e chiederne conto,
inimicandosi tutta la categoria del foro locale e suscitando il biasimo dei
colleghi, che temono ritorsioni.
È necessario precisare e distinguere i casi di
riparazione per ingiusta detenzione da quelli di riparazione derivante da
errore giudiziario. Nel primo caso si fa riferimento alla detenzione subita
in via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della
condanna eventuale, mentre nel secondo si presuppone invece una condanna a cui
sia stata data esecuzione e un successivo giudizio di revisione instaurato (a
seguito di una sentenza irrevocabile di condanna) in base a nuove prove o alla
dimostrazione che la condanna è stata pronunciata in conseguenza della falsità
in atti. In questa sezione ci occuperemo del caso di riparazione per ingiusta
detenzione.
Secondo quanto disposto (artt. 314 e 315 c.p.p.)
all'imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere
un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, diritto che
è stato introdotto con il codice di procedura penale del 1988 ed è in
adempimento di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo
(cfr. art 5, comma 5, C.E.D.U.). Rilevanti novità In materia sono state
apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta "Legge Carotti". In
particolare, è aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito
un'ingiusta permanenza in carcere, passando da cento milioni di lire ad un
miliardo (oggi € 516.456,90), ed è altresì aumentato il termine ultimo per
proporre, a pena di inammissibilità, domanda di riparazione: da 18 a 24 mesi. Il
presupposto del diritto ad ottenere l'equa riparazione consiste
nella ingiustizia sostanziale o nella ingiustizia formale della custodia
cautelare subita.
L'ingiustizia sostanziale è prevista dall'art.
314, comma 1, c.p.p. e ricorre quando vi è proscioglimento con sentenza
irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto,
perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
E' importante tenere presente che, ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 314
c.p.p., alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a
procedere e il provvedimento di archiviazione. L'ingiustizia formale è
disciplinata dal comma 2 dell'art. 314 c.p.p. e ricorre quando la custodia
cautelare è stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le
condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., a prescindere
dalla sentenza di assoluzione o di condanna. La domanda di riparazione per
l'ingiusta detenzione (315 c.p.p.- 102 norme di attuazione cpp) deve essere
presentata (a pena di inammissibilità) entro due anni dal giorno in cui la
sentenza di assoluzione o condanna è diventata definitiva, presso la cancelleria
della Corte di Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il
provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di
sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, è competente la Corte di Appello nel
cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato; sulla richiesta decide
la Corte di Appello con un procedimento in camera di consiglio. E' obbligatoria
l'assistenza di un legale munito di procura speciale e la parte che si trovi
nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere il patrocinio a
spese dello Stato. Nel caso di decesso della persona che ha subito l'ingiusta
detenzione possono richiederne la riparazione: il coniuge, i discendenti e gli
ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini entro il primo grado e le
persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. La riparazione per
ingiusta detenzione deve essere estesa alle ipotesi di detenzione cautelare
sofferta in misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata
assoluzione nel merito. Tutti coloro che sono stati licenziati dal posto di
lavoro che occupavano prima della custodia cautelare e per tale causa, hanno
diritto di essere reintegrati nel posto di lavoro se viene pronunciata a favore
sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero ne
viene disposta l'archiviazione. Vale la pena ricordare che La Corte di Giustizia
di Strasburgo (sentenza 9 giugno 2005 ricorso 42644/02) ha richiesto una
modifica dell'art. 314 c.p.p. che ammette l'indennizzo per ingiusta detenzione
solo se l'imputato è assolto, se è disposta l'archiviazione del caso o il non
luogo a procedere o se, in caso di condanna, la custodia cautelare è stata
disposta in assenza di gravi indizi di colpevolezza o per reati per i quali la
legge stabilisce una reclusione superiore a tre anni. Per la Corte si tratta di
previsioni restrittive perché l'art 5 comma 5 della convenzione prevede in ogni
caso di illegittima restrizione il diritto ad una riparazione.
L'interessato deve presentare in cancelleria
(Corte d'Appello – Cancellerie Penali):
la domanda di riparazione del danno per ingiusta
detenzione da lui sottoscritta, eccetto il caso di procura speciale. Oltre
all'originale devono essere presentate 2 copie dell'istanza;
la sentenza di assoluzione con l'attestazione di
irrevocabilità;
il certificato dei carichi pendenti;
le dichiarazioni rese al Giudice Indagini
Preliminari (G.I.P.) o al Pubblico Ministero (P.M.);
fotocopia del documento di riconoscimento e codice
fiscale.
Nel caso di arresti domiciliari deve essere
depositato anche:
il provvedimento di concessione degli arresti
domiciliari e l'ordine di scarcerazione;
la posizione giuridica, da richiedere all'ultimo
carcere di detenzione previa autorizzazione della Corte di Appello;
gli atti del procedimento da cui si evince che il
ricorrente non ha concorso a dar causa alla sua carcerazione per dolo o colpa
grave.
Tutti i documenti a corredo dell'istanza possono
essere depositati in carta semplice e per la loro richiesta non è dovuto alcun
diritto di cancelleria. Ogni comunicazione o richiesta in merito al pagamento
della somma dovrà essere indirizzata a: "Ministero dell'Economia e delle Finanze
– dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del
Tesoro – Serv. Centr. Per gli AA. GG. e la Qualità dei Processi e
dell'Organizzazione – responsabile sig.ra Lofaro -via Casilina, -00182 Roma".
Ufficio XIV 06-47615451 fax 06-47615155
Utopia, invece è riconoscersi il danno per
INGIUSTA IMPUTAZIONE.
«Sì, sei innocente ma ora le spese te le paghi da
solo», scrive il Aprile 2017 "Il Dubbio". Una nuova legge in discussione prevede
un rimborso di appena 5mila euro per l’imputato innocente. Il disegno di legge
n.2153 in materia di rimborso delle spese di giudizio, presentato lo scorso anno
in Commissione giustizia dal senatore Gabriele Albertini (Ap), era composto da
un solo articolo. Un articolo che introduceva un principio di “equità e di
giustizia” nell’ordinamento e che era in grado di rivoluzionare in radice il
sistema giustizia del Paese. All’articolo 530 del codice di procedura penale
(sentenza di assoluzione) era previsto che fosse inserito il comma 2bis: «Se il
fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice, nel
pronunciare la sentenza, condanna lo Stato a rimborsare tutte le spese di
giudizio, che sono contestualmente liquidate (…) Nel caso di dolo o di colpa
grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l’azione penale, lo
Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha
esercitato l’azione penale». Tecnicamente la disposizione prende il nome di
“ingiusta imputazione”. Attualmente, quando l’imputato viene riconosciuto
innocente, le spese legali affrontate per difendersi restano comunque a suo
carico. L’unico tipo di risarcimento previsto è quello nei casi di “ingiusta
detenzione”. Quando, cioè, sottoposto inizialmente alla misura della custodia
cautelare, l’imputato è stato al temine del processo assolto. Oltre all’aspetto
economico, le traversie giudiziarie, va ricordato, hanno pesanti ricadute sul
quelle che sono le condizioni morali e familiari. La modifica legislativa in
questione, dunque, avrebbe introdotto una norma di civiltà giuridica a tutela
del cittadino nel suo complesso, “responsabilizzando” di fatto anche il pubblico
ministero. Il disegno di legge Albertini riscosse un grandissimo consenso
bipartisan, con ben 194 senatori che lo sottoscrissero immediatamente. A memoria
è difficile trovare nella storia del Parlamento italiano una proposta di legge
condivisa da una maggioranza così ampia. La disposizione sul rimborso delle
spese legali, per altro, è in vigore, pur con qualche differenza, in 30 paesi
europei. Particolare questo non da poco. In alcuni paesi la cifra da rimborsare
viene valutata di volta in volta dal giudice, in altri, come ad esempio la Gran
Bretagna, il rimborso attiene all’intera parcella del legale. La discussione del
disegno di legge 2153 in questi mesi si è, però, scontrata con un problema di
carattere strettamente economico. Non ci sarebbe, infatti, la necessaria
copertura. Per capire meglio quanto davvero sarebbe costata la norma, il
senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia, che in Commissione è il relatore
della legge, ha provato anche a cercare dati certi sul numero delle assoluzioni
piene negli ultimi anni. Ma oltre all’aspetto economico è subentrato un problema
di natura “tecnica” che ha impedito alla legge di vedere la luce nella sua
formulazione originaria: l’unificazione della proposta Albertini con quella di
Maurizio Buccarella (M5s), il ddl 2259, che propone la sola deducibilità fiscale
delle spese legali, ma non oltre i 5 mila euro. Un obolo, considerati quelli che
sono i costi della difesa penale. Il testo unificato, sul quale c’è tempo fino
al 26 aprile per presentare gli emendamenti, stabilisce che si possa chiedere la
detrazione al massimo di 10.500 euro in tre anni. Stop, quindi, al rimborso
integrale come voleva Albertini. La maggioranza, che prevede di stanziare 12
milioni nel 2016 e 25 dal 2017, obietta che una copertura finanziaria più ampia
sia impossibile da trovare di questi tempi. Strano perché per le indagini i
budget a disposizione delle Procure sono “no limits”. Tanto per fare qualche
esempio, solo per le intercettazioni telefoniche, le Procure italiane hanno
speso nel 2014 la cifra monstre di 250 milioni di euro. Albertini, comunque, non
ci sta a che il suo testo sia “annacquato” e ha già annunciato battaglia:
«Presenterò un emendamento che alzi almeno a 100 mila euro la detrazione fiscale
e preveda il rimborso totale per gli incapienti».
OTTENERE IL RISARCIMENTO PER INGIUSTA
DETENZIONE È UN’ODISSEA. Scrive Roberto Paciucci su
"Fino a Prova Contraria". Arrivano in casa alle 5 di mattina e ti buttano in
carcere. L’opinione pubblica pensa: qualcosa di losco avrà fatto altrimenti non
gli capitava. Anni dopo sei innocente. Nessuno ti chiede scusa e resta il
pregiudizio dei problemi con la giustizia. Con chi te la pigli? In Italia con
nessuno. Si dirà che è prevista la riparazione per l’ingiusta detenzione. Vero.
Ma quanto devi tribolare? Per ottenere una equa riparazione il Malcapitato dovrà
provvedere ad una serie di procedure e formalismi bizantini buoni solo ad
ostacolare l’esercizio di un diritto al punto che alcuni uffici giudiziari (ad
esempio la Corte di Appello di Roma) hanno elaborato delle vere e proprie
avvertenze sulle modalità di presentazione e sui documenti da allegare. La
domanda deve essere proposta per iscritto, a pena di ammissibilità, entro due
anni dalla decisione definitiva e l’entità della riparazione non può eccedere €
516.456,90.
La domanda deve essere depositata in cancelleria
personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
La domanda deve essere sottoscritta personalmente
dall’interessato con eventuale procura speciale e delega per la presentazione
nonché espressa richiesta di svolgimento in camera di consiglio o udienza
pubblica.
Il presentatore della domanda deve essere
identificato dal cancelliere.
Nell’istanza devono essere indicate le date di
inizio e fine di ciascuna misura cautelare sofferta e la specie di essa
(detenzione, arresti domiciliari).
All’istanza devono essere allegati una miriade di
atti e documenti (formando due distinti fascicoli con indice, il primo dei quali
dovrà contenere alcuni atti in copia autentica, il secondo gli stessi atti
(compresa l’istanza) ma tutti in copia semplice) nonché altre tre copie della
sola istanza:
Decreto di archiviazione e relativa richiesta del
PM o sentenza di assoluzione in forma autentica completa di timbri di
collegamento tra i fogli e data di attestazione del passaggio in giudicato;
Copia delle sentenze di merito emanate nello
stesso procedimento e che riguardano l’istante;
Copia dell’eventuale verbale di fermo e ordinanza
di convalida;
Copia del verbale di arresto e ordinanza di
convalida;
Copia della richiesta del PM di applicazione della
custodia cautelare;
Copia dell’ordinanza applicativa della custodia
cautelare in forma autentica; provvedimento di eventuale concessione degli
arresti domiciliari; provvedimento di modifica del luogo degli arresti
domiciliari; provvedimento di rimessione in libertà;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in
cui l’istante attesta la pendenza di procedimenti penali (da indicare con i
rispettivi numeri di registro e le relative imputazioni) in circoscrizioni
diverse da quella di residenza con firma autenticata dal difensore o da un
pubblico ufficiale oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ove
l’istante dichiara di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti in
circoscrizioni diverse da quelle di residenza;
Copia degli interrogatori resi prima della
carcerazione e in ogni fase del processo;
Copia dell’ordinanza di rinvio a giudizio nonché
copia della requisitoria del PM ove trattasi di procedimenti con vecchio rito;
Certificato dei carichi pendenti della Procura del
luogo di residenza;
L’istante deve indicare i luoghi in cui sono stati
trascorsi gli arresti domiciliari.
Poi la domanda dovrà essere valutata nel merito in
quanto l’equa riparazione non spetta al soggetto sottoposto a custodia cautelare
qualora, così recita la legge, “vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo
o colpa grave”.
È facile imbattersi in sentenze secondo cui la
condotta dell’indagato è causa ostativa all’indennizzo qualora si sia avvalso
della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio come suo diritto
difensivo oppure “sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo
della libertà personale abbia agito con leggerezza o macroscopica
trascuratezza”. Insomma a perdere la libertà è un attimo, per prendere i soldi
un’odissea. Roberto Paciucci
In cella per errore, nessun risarcimento.
Ogni anno su 7mila richieste solo una minima parte
viene accolta. Gli indennizzi solo per mille detenuti. E così un articolo del
codice di procedura penale finisce sotto accusa, scrive Alessandro Belardetti il
7 marzo 2017 su "Il Quotidiano.net". Un esercito tradito dalla giustizia. Sono
circa 6mila all’anno le persone assolte in Italia che non ricevono l’indennizzo
dopo aver subito una custodia cautelare ingiusta (in carcere o ai domiciliari).
Tra loro c’è Raffaele Sollecito, accusato e detenuto quattro anni per il delitto
di Meredith Kercher, poi assolto in Cassazione. L’anno scorso sono state 1.001
le ordinanze di pagamenti per riparazioni a ingiuste detenzioni ed errori
giudiziari, pari a 42.082.096 euro. Dunque, uno su sette riceve l’indennizzo,
stabilito da un tariffario governativo: 250 euro per ogni giorno in carcere, 125
euro per i domiciliari, con un massimo di 516mila euro (mentre per gli errori
giudiziari non c’è limite al risarcimento). «Ma l’entità dell’indennizzo
dev’essere proporzionata alle conseguenze personali e familiari dell’imputato –
spiega l’avvocato Gabriele Magno, presidente dell’Associazione nazionale vittime
di errori giudiziari –: non può bastare un quantum al giorno perché ci sono, per
esempio, danni come la perdita di guadagni dal fallimento dell’azienda di un
imprenditore incarcerato». I Giudici d’appello di Firenze nel caso Mez,
sopraggiungendo l’assoluzione di Sollecito, hanno ammesso la
sua ingiusta detenzione «ma lui ha concorso a causarla con la propria condotta
dolosa o colposa». Comma uno dell’articolo 314 del codice di procedura penale:
se un imputato provoca la propria ingiusta detenzione, non ha diritto
all’indennizzo. «È un paracadute dello Stato, che lo usa a piacimento – prosegue
il 41enne Magno –. A livello costituzionale così appare più importante
l’essersi, per esempio, avvalso della facoltà di non rispondere durante un
interrogatorio nelle indagini, che l’essere stato assolto con formula piena.
Abbiamo proposto una modifica alla legge chiedendo di cambiare l’articolo 315.
Ora il soggetto assolto ha due anni per chiedere l’indennizzo, ma è un trucco:
questo fa prescrivere l’errore del giudice. Un limite che va cancellato». Il
giurista Giuseppe Di Federico, ex membro laico del Csm, aggiunge: «È ridicolo
che si allunghi la prescrizione per le attività commesse dai cittadini e si
tengano strette quelle dei giudici. Quando uno ha subito un’ingiusta detenzione
l’indennizzo deve essere automatico. Rovistare nei comportamenti degli imputati
per non dargli i soldi non è giusto, le loro condotte non possono giustificare
la mancanza di capacità professionale nei magistrati». I distretti in cui
vengono rimborsati gli indennizzi maggiori per gli errori dei magistrati sono al
Sud e Centro Italia: Napoli, Catanzaro, Bari, Catania, Roma le maglie nere.
Eurispes e Unione delle Camere penali italiane, analizzando sentenze e
scarcerazioni degli ultimi 50 anni, hanno rilevato che sono 4 milioni gli
italiani dichiarati colpevoli, arrestati e rilasciati dopo tempi più o meno
lunghi, perché innocenti. «Un fenomeno patologico, ma non c’è solo un colpevole:
si va dalla polizia giudiziaria che crede in una pista e non batte le altre, al
pm che perseguita gli indagati, fino agli avvocati che non fanno il proprio
dovere. La giustizia è una bilancia, ma questi numeri gridano vendetta»,
analizza l’avvocato chietino. Proprio gli avvocati, però, vengono accusati di
fare super guadagni con questi casi: «Nessun business, la nostra associazione è
composta anche da giudici, periti, giornalisti e politici». Dal 1992 il
ministero dell’Economia e Finanze ha pagato 630 milioni di euro per indennizzare
quasi 25mila vittime di ingiusta detenzione, ma negli ultimi anni i risarcimenti
sono calati: se nel 2015 lo Stato ha versato 37 milioni di euro, nel 2011 sono
stati 47, mentre nel 2004 furono 56. «Se lo Stato deve indennizzare un’ingiusta
detenzione prova imbarazzo – conclude Magno – e i soldi per i risarcimenti si
trovano a fatica. Il fatto che sia la Corte d’appello dello stesso distretto che
ha sbagliato il giudizio ad accogliere o rigettare l’indennizzo, limita la
disponibilità del magistrato a riconoscere un errore».
Quella confessione estorta con botte e
scariche ai testicoli…scrive Simona Musco il 27 Aprile
2017 su "Il Dubbio". Il racconto di Giuseppe Gulotta che ha passato 22 anni in
carcere da innocente per la strage di Alcamo Marina. «Ho subito tutto senza
sapere né come né perché». Ora arriva il risarcimento. Tredici milioni di euro
per mettere la parola fine a quello che forse verrà ricordato come il più grande
errore giudiziario italiano e che ancora continua a registrare colpi di scena.
Tredici milioni da dividere per due famiglie dilaniate per anni e anni da accuse
ingiuste, che hanno divorato le vite di tutti i protagonisti. Si tratta di
Giovanni Mandalà e Giuseppe Gulotta, due dei protagonisti della strage di
Alcamo. Una strage alla quale, in realtà, non hanno mai preso parte. Ma per
riconoscerlo hanno dovuto passare decenni dietro le sbarre e affrontare torture
e tribunali. Un’innocenza che per Gulotta vale appunto 6 milioni e mezzo di
euro, la cifra stabilita per ripagare 22 anni in carcere senza motivo. Quaranta
anni dopo essere finito in manette con un’accusa pesantissima, ad aprile 2016,
la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha stabilito quanto costa l’errore
giudiziario che si è consumato sulle sue spalle, condannando il ministero
dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un maxi risarcimento. «Nessuna
cifra al mondo potrebbe risarcire quanto ho subito. Sei milioni e mezzo sono
tanti e di certo adesso, dopo una vita di stenti, potrò far fronte alle
necessità familiari. Ma dopo 40 anni di vita rubata, possono bastare?», ha
commentato Gulotta al Dubbio, lo scorso anno, poco dopo la lettura della
sentenza. Lo Stato, infatti, ha riconosciuto ad ogni anno della sua vita un
valore di 163mila euro. Poco, pochissimo a fronte di come Gulotta ha trascorso
quegli anni: dietro le sbarre. Per questo i suoi avvocati, Saro Lauria e Pardo
Cellini, avvalendosi di un tecnico, avevano chiesto 56 milioni di euro. «Non è
una somma a caso. Questa, forse, è l’ennesima beffa subita in questi 40 anni –
ha spiegato -. Speravo in qualcosa di più ma se per lo Stato tutte le mie
difficoltà corrispondono a questa cifra rispetterò la sentenza. Però l’amarezza
rimane. Alle volte non si trovano le parole per esprimere i sentimenti». La vita
di Gulotta è stata presa e gettata via quando aveva solo 18 anni. Era un giovane
muratore quando, di notte, si è ritrovato ammanettato, legato con le caviglie ad
una sedia, picchiato e umiliato fino a confessare un reato che non aveva
commesso e del quale non sapeva nulla. Per 22 lunghissimi anni, quel 27 gennaio
del 1976 è stato lui a trucidare il 19enne Carmine Apuzzo e l’appuntato
Salvatore Falcetta, della caserma di “Alkamar”, in provincia di Trapani. Dopo
settimane di rastrellamenti, il colonnello Giuseppe Russo e i suoi uomini
ammanettarono quattro ragazzi. Furono ore di pestaggi, minacce, finte
esecuzioni, scariche elettriche ai testicoli, acqua e sale in gola, fino ad una
confessione urlata per ottenere la salvezza. Iniziarono così i 36 anni di
calvario di Gulotta, che ha ottenuto la revisione del processo dopo la
rivelazione di un ex carabiniere, Renato Olino, sui metodi usati per estorcere
quelle confessioni. Fu poi un pentito, Vincenzo Calcara, a parlare di un ruolo
della mafia nella strage, collegandola all’organizzazione “Gladio”, la struttura
militare segreta con base nel trapanese: i militari potrebbero essere stati
uccisi per avere fermato un furgone carico di armi destinato a loro.
L’assoluzione di Gulotta è arrivata il 13 febbraio 2012, 36 anni esatti dopo il
suo arresto. «Ho subito tutto senza sapere né come né perché. So che è stato
fatto il mio nome, mi hanno fatto confessare e, anche se ho ritrattato subito, i
giudici non mi hanno creduto – ha raccontato -. Lo Stato, per errore, ha tenuto
la mia vita in sospeso per 40 anni. Spero in un futuro migliore. Ma il mio
passato è andato perso, i miei 18 anni non ci saranno più».
Ecco come la giustizia in
Italia sia strabica. A Firenze il silenzio vale il diniego all’indennizzo; a
Reggio Calabria una confessione di colpevolezza vale una elargizione del
medesimo.
Indagati e condannati per
sbaglio Il risarcimento? Lo tiene lo Stato.
Uno preso per corruttore, l'altro 2 anni in cella per droga Indennizzo negato
alla 81enne: è scivolata per colpa sua, scrive Stefano Zurlo, Mercoledì
22/02/2017, su "Il Giornale". C'è l'errore, d'accordo. Ma spesso i guai sono
come le ciliegie. Uno tira l'altro. E così l'imputato o più semplicemente la
persona che vorrebbe solo giustizia deve strisciare sotto una galleria di
umiliazioni, sofferenze, paradossi. Qualche volta la sentenza timbra anche la
beffa, dopo aver certificato il danno subito dal malcapitato. Dipende. Il
ventaglio delle sorprese è purtroppo sterminato. Torna in mente l'errore
giudiziario per eccellenza, quello di Daniele Barillà, il piccolo imprenditore
brianzolo arrestato sulla tangenziale di Milano il 13 febbraio 1992, nei giorni
in cui il motore di Mani pulite scalda i motori. Barillà non c'entra niente con
Tangentopoli, lui dovrebbe essere, e invece non è, un trafficante di droga. Ma
il gip che lo interroga, Italo Ghitti, è lo stesso che firmerà nei mesi seguenti
centinaia di arresti per i colletti bianchi dei partiti. E Ghitti si sorprende
perché l'indagato, ammanettato secondo lui con le mani nel sacco, resiste e si
ostina a proclamarsi innocente. «Se lei non confessa - è la profezia - si
beccherà vent'anni». Previsione quasi azzeccata, perché l'artigiano viene
condannato a 18 anni, ridotti poi a 15 in appello e confermati in cassazione.
Lui, per tirarsi fuori da quel disastro, racconterebbe pure quello che non ha
fatto, ma il problema è che non sa cosa confessare. Come Crainquebille, il
verduraio uscito dalla penna di Anatole France che racconterebbe volentieri il
proprio peccato alle forze dell'ordine se solo sapesse qual è. La storia di
Barillà si trascina per sette anni mezzo, fino alla svolta nel 1999, come una
somma di equivoci: il suo silenzio colmo di angoscia viene scambiato, anche nei
verdetti, per lo spessore criminale di un boss incallito. E quei testimoni,
amici e parenti, che gli hanno garantito l'alibi narrando per filo e per segno
cosa ha fatto, e dove era nelle ore decisive del 13 febbraio 1992, vengono
incriminati e rischiano di essere processati a loro volta. L'errore chiama
errore. A volte invece si mischia alla prepotenza. Enrico Maria Grecchi, altro
nome sconosciuto al grande pubblico e lontano dai riflettori, si fa 654 giorni
di cella per traffico di stupefacenti, prima di essere assolto in appello e
secondo grado. Con la banda di malfattori lui non c'entra niente. Potrebbe
bastare, ma la giustizia si prende la rivincita alleandosi con la burocrazia più
ottusa. Succede infatti che il ministro dell'Economia stacchi finalmente
l'assegno per l'ingiusta detenzione: 91.560 euro. Stirati. Stiratissimi, molti
meno di quelli richiesti perché Grecchi, a sentire i magistrati, non ha schivato
l'amicizia con un tipo poco raccomandabile e questo ha indotto in errore i
giudici che l'hanno incarcerato. Alla fine, è sempre colpa sua. Ma non è finita.
Quei soldi dovrebbero essere un mezzo risarcimento, innescano un nuovo scempio.
Nella partita si butta infatti Equitalia che vanta crediti pari a 67.056,21
euro. Pare si tratti di somme legate a tasse automobilistiche. Sembra
impossibile, ma dopo tante esitazioni e balbettii, Equitalia piomba come un
fulmine sul tesoretto e glielo porta via. Con tanto di bollo del tribunale di
Lecco. Nessun rispetto, dunque, per quello che è successo. Lo Stato avrebbe
dovuto cospargersi il capo di cenere, invece eccolo azzannare quel gruzzolo
sacrosanto. Poi, altro colpo di scena in un procedimento surreale, si scopre che
gran parte delle multe contestate, ormai datate, è andata in prescrizione. Una
parte, una parte soltanto del malloppo conteso, viene restituita a Grecchi in un
andirivieni indecoroso. Errori grandi, errori piccoli. Nel penale e nel civile.
Conditi spesso con la pena supplementare del disprezzo. La signora ottantunenne
è caduta nella buca? Affari suoi, altro che risarcimento da parte del Comune di
Milano. «È noto - scrive una toga di rito ambrosiano - che con il progredire
dell'età il sistema motorio e quello sensoriale (oltre che quello cognitivo)
perdono parte della propria efficienza». E avanti con diagnosi serrate e
impietose. Nessun indennizzo, ci mancherebbe. Ma una conclusione folgorante: se
la donna è scivolata è solo colpa sua.
Processo dura 20 anni, lo
stupro è prescritto. Il giudice: "Chiedo scusa alla vittima".
Cade l'accusa per l'uomo che abusò della figlia della convivente. In Appello
tutto si è arenato. Il ministro Orlando manda gli ispettori: "è un fatto che
ribollire il sangue", scrive Sarah Martinenghi il 21 febbraio 2017 su "La
Repubblica". "Questo è un caso in cui bisogna chiedere scusa al popolo
italiano". Con queste parole, la giudice della Corte d'Appello Paola Dezani,
ieri mattina, ha emesso la sentenza più difficile da pronunciare. Ha dovuto
prosciogliere il violentatore di una bambina, condannato in primo grado a 12
anni di carcere dal tribunale di Alessandria, perché è trascorso troppo tempo
dai fatti contestati: vent'anni. Tutto prescritto. La bambina di allora oggi ha
27 anni. All'epoca dei fatti ne aveva sette. Dall'aula l'hanno chiamata per
chiederle se volesse presentarsi al processo, iniziato nel 1997, in cui era
parte offesa. Ma lei si è rifiutata: "Voglio solo dimenticare". Il procedimento
è rimasto per nove anni appeso nelle maglie di una giustizia troppo lenta. Lo
ammette senza mezzi termini il presidente della corte d'Appello Arturo Soprano:
"Si deve avere il coraggio di elogiarsi, ma anche quello di ammettere gli
errori. Questa è un'ingiustizia per tutti, in cui la vittima è stata violentata
due volte, la prima dal suo orco, la seconda dal sistema". In aula, a sostenere
l'accusa della procura generale, è sceso l'avvocato generale Giorgio Vitari. "Ha
espresso lui per primo il rammarico della procura generale per i lunghi tempi
trascorsi - spiega il procuratore generale, Francesco Saluzzo - Questo
procedimento è ora oggetto della valutazione mia e del presidente della Corte
d'Appello. È durato troppo in primo grado, dal 1997 al 2007. Poi ha atteso per
nove anni di essere fissato in secondo". La storia riguarda una bambina
violentata ripetutamente dal convivente della madre. La piccola, trovata per
strada in condizioni precarie, era stata portata in ospedale, dove le avevano
riscontrato traumi da abusi e addirittura infezioni sessualmente trasmesse. La
madre si allontanava da casa per andare a lavorare e l'affidava alle cure del
compagno. Il procedimento alla procura di Alessandria parte con l'accusa di
maltrattamenti e violenza sessuale. In udienza preliminare viene però chiesta
l'archiviazione per parte delle accuse e l'uomo riceve una prima condanna, ma
solo per maltrattamenti. Contemporaneamente, il giudice dispone il rinvio degli
atti in procura perché si proceda anche per violenza sessuale. Nel frattempo,
però, sono già trascorsi anni. L'inchiesta torna in primo grado e, dopo un anno,
viene emessa la condanna nei confronti dell'orco: 12 anni di carcere. Da
Alessandria gli atti rimbalzano a Torino per il secondo grado. Ma
incredibilmente il procedimento resta fermo per nove anni in attesa di essere
fissato. Finché, nel 2016, il presidente della corte d'Appello Arturo Soprano,
allarmato per l'eccessiva lentezza di troppi procedimenti, decide di fare un
cambiamento nell'assegnazione dei fascicoli. "Ho tolto dalla seconda sezione
della corte d'Appello circa mille processi, tra cui questo, e li ho
ridistribuiti su altre tre sezioni. Ognuna ha avuto circa 300 processi tutti del
2006, 2007 e del 2011. Rappresentavano il cronico arretrato che si era
accumulato", spiega. La prima sezione ha avuto tra le mani per un anno il caso
iniziato nel 1997. E l'udienza si è svolta solo ieri. "Ormai, però, era
intervenuta la prescrizione". Un altro errore si è aggiunto alla catena di
intoppi giudiziari: per sbaglio è stata contestata all'imputato una recidiva che
non esisteva, il che avrebbe accorciato ulteriormente la sopravvivenza della
condanna. I giudici, ascoltate le scuse della procura generale, si sono chiusi a
lungo in camera di consiglio. Forse nella speranza di trovare un'ancora di
salvezza. Alla fine, però, ha vinto il tempo. Sulla vicenda è anche intervenuto
il ministro della giustizia Andrea Orlando che ha deciso di mandare gli
ispettori di via Arenula per svolgere accertamenti preliminari in merito al
processo, caduto in prescrizione.
Reato prescritto, pedofilo
libero: il giudice chiede scusa,
scrive di Roberta Catania il 22 febbraio 2017 su “Libero Quotidiano”. «Abbiamo
chiesto scusa alla vittima perché siamo stati costretti a chiedere il
proscioglimento dell'imputato, nonostante non volessimo. È intervenuta la
prescrizione». Ecco la giustificazione del procuratore generale di
Torino, Francesco Saluzzo, dopo che si è concluso, senza alcuna condanna,
il processo a carico di un uomo che violentò la figlia della sua compagna
dell'epoca, una bimba di sette anni. Per carità, sentire un giudice chiedere
scusa è un evento di tale rarità che non si può non darne atto. Però rimane un
fatto gravissimo che un caso così delicato sia rimbalzato per vent' anni da una
scrivania all' altra senza trovare una giusta collocazione e dare un giusto
processo alla vittima e al suo aguzzino. L'altro ieri la vittima di quelle
violenze sessuali - che il compagno della madre le infieriva mentre la donna era
al lavoro - non si è presentata in aula al Palagiustizia di Torino. Lei oggi ha
27 anni, vuole solo dimenticare e andare avanti. Un reset che sarebbe stato
giusto offrirle molti anni fa, con tempi della giustizia più rapidi, condannando
il suo stupratore ai giusti anni di prigione, invece di rammaricarsi oggi
dichiarando «la prescrizione». Anche il presidente della corte d' Appello ha
chiesto perdono alla donna e «al popolo italiano» per l'esito di una vicenda «su
cui giustizia non c' è stata, perché non è stato possibile farla». Ma la colpa
di chi è? Di quella ragazza che forse non aveva il denaro per pagare un
brillante avvocato che incalzasse le udienze o di quei giudici che oggi chiedono
perdono? Forse non loro direttamente, visti gli intoppi in cui è inciampato il
caso, ma comunque qualcuno dovrebbe pagare un risarcimento o i danni morali. Il
primo passo di questo processo è datato 1997. Il fascicolo arriva al tribunale
di Alessandria, dove avviene il primo inciampo della giustizia. In udienza
preliminare, il gup della provincia piemontese non aveva riconosciuto l'accusa
di violenza sessuale ma soltanto quella di maltrattamenti. Accusa contestata
successivamente dal giudice, che riesce a far riconoscere lo stupro, ma intanto
altri anni erano andati persi. Il processo di primo grado dura tantissimo: dieci
anni. E non per colpa di centinaia di testimoni da sentire o migliaia di perizie
da esaminare, ma perché tra un'udienza e l'altra trascorrevano tempi
inspiegabilmente biblici. Come se non fosse bastato un primo grado durato dieci
anni, ce ne sono voluti altri nove prima che venisse fissato l'Appello.
Diciannove anni, quindi, perché il caso arrivasse al tribunale di Torino per
discutere il secondo grado di giudizio. E quando il fascicolo è stato preso in
mano dai togati, oplà, era già tutto scaduto. Dopo molte ore di camera di
consiglio, due giorni fa la giudice della Corte d' Appello Paola Dezani che ha
dichiarato «prosciolto lo stupratore». Lo ha fatto con imbarazzo, dicono. Anche
lei mortificata per una lentezza della giustizia che non ha lasciato impunito un
abuso edilizio, ma che ha condonato le ripetute violenze sessuali su una bambina
di sette anni. Adesso, in Piemonte arriveranno gli ispettori del ministero della
Giustizia. Adesso, i giudici chiedono scusa. Adesso, la notizia rimbalza su
tutti i giornali. Ma per venti anni nessuno ha preso a cuore la giustizia che
meritava quella bambina e domani nessuno pagherà per qualcosa che tornerà ad
essere catalogato come ordinaria lentezza della giustizia italiana.
Reato di stupro prescritto: ma chi paga?
Le parole non restituiranno sollievo alla 27enne che
20 anni fa fu abusata, ma la sanzione dei responsabili. Di chi ha omesso,
ignorato, e non ha vigilato, scrive il 22 febbraio 2017 Marco Ventura su
Panorama. Per la giustizia negata non c’è altra soluzione che accelerare i
processi e far valere il principio che chi sbaglia paga. Anche il magistrato
negligente o lavativo. Tutto il resto è retorica: proposte di grande riforma del
sistema giudiziario, ipotesi illiberali come quella di rendere infinito il tempo
della prescrizione, scuse pubbliche prive di conseguenze concrete che servono
soltanto a lavare le coscienze. Ben venga la prescrizione per l’uomo condannato
in primo grado a 12 anni per aver abusato della figlia (che di anni ne aveva 7)
della convivente; ben venga la notizia dei 20 anni di processo che non sono
bastati a restituire, se non la serenità, almeno la giustizia a una donna che
oggi ha 27 anni e dice di voler “solo dimenticare”; ben venga il proscioglimento
del (dobbiamo dire presunto?) violentatore, se questa ennesima sconfitta della
giustizia italiana servirà a qualcosa. Per esempio, a evitare in futuro nuove
sentenze di prescrizione di reati che se non puniti “fanno ribollire il sangue”,
come ha sollecitamente dichiarato con espressione suggestiva il ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, annunciando l’invio di ispettori. E ben vengano
le scuse agli italiani del giudice della Corte d’Appello di Torino, Paola
Dezani, che ha dovuto emettere “in nome della legge” la sentenza, prendendo atto
che il reato era prescritto: troppi dieci anni per il processo di primo grado
(1997-2007) più altri nove per fissare l’udienza in appello. Ben venga la
denuncia del presidente della Corte d’Appello, Arturo Soprano, che parla
di “ingiustizia per tutti” e vittima “violentata due volte, la prima dall’orco,
la seconda dal sistema”. Eppure. Il Sistema ha un volto. Un nome. Altrimenti
sono tutti colpevoli e nessuno è colpevole. E anche questo è il Sistema. Che si
difende auto-accusandosi. Il dubbio che qualcosa cambi davvero è forte.
Perché in Italia manca del tutto il concetto di responsabilità, che è sempre
personale ed è quella per la quale meriti e demeriti producono premi o sanzioni.
Succede invece che il buon giudice continui a svolgere il proprio lavoro in
silenzio, smazzando sentenze e trattando equamente le cause che trova sul
tavolo, sforzandosi di leggere le carte prima di prendere decisioni. E capita
poi che vengano emesse sentenze prima ancora di ascoltare le parti in udienza:
la condanna pre-confezionata e “per errore” firmata e controfirmata. Per dire
quanto la giustizia possa essere veloce: la sentenza precede l’udienza. Svista
che smaschera anch’essa un Sistema. C’è una lacuna nello scandalo dello stupro
pedofilo impunito. Un difetto, forse, nella comunicazione dei magistrati. Un
dubbio, un rovello anzi, che deve assillare chiunque non si accontenti di
denunciare le imperfezioni del Sistema. Il dubbio è che la vittima di 7 anni che
oggi ne ha 27 e vuole solo dimenticare abbia tragicamente ragione. Primo, perché
se anche la giustizia fosse arrivata in tempo (nei termini) sarebbe stata
comunque tardiva. È ragionevole che si debbano aspettare 17-18 anni per vedere
condannato il proprio violentatore o perché un uomo accusato di violenza venga
processato? Siamo un Paese incivile. È di ieri la notizia che a Rio de Janeiro
sono stati condannati a 15 anni di carcere due autori della violenza di gruppo
su una sedicenne commessa lo scorso maggio. E parliamo di Brasile e favelas. Non
di Alessandria o Torino. Secondo, perché il moltiplicarsi di scuse dei
magistrati (pur benvenute e doverose) e dichiarazioni di quanti hanno la
responsabilità della “giustizia” nascondono una diffusa ipocrisia. Qui non sono
le parole a poter restituire uno straccio di riparazione alla 27enne che
vent’anni fa fu abusata, ma la sanzione dei responsabili. Di chi ha omesso,
ignorato, sottovalutato. Di chi ha lavorato male e provocato un danno con la sua
negligenza. Di chi non ha vigilato. La sanzione può anche essere semplicemente
un fermo alla carriera, un trasferimento, una censura. La magistratura gode di
benefici economici (e non solo) in ragione della sua autorevolezza. Che oggi è
ai minimi nell’opinione pubblica. E la sua autonomia, invece, rischia di esser
vista come arroccamento corporativo e difesa dei privilegi. Se nessuno, alla
fine e dopo tante belle parole, non pagherà per la denegata giustizia o per
l’errore giudiziario (le carceri ne sono piene), avrà sempre ragione il
presidente della Corte d’Appello di Torino, che ha scelto male le parole quando
ha detto che la 27enne che vuole solo dimenticare è vittima due volte: dell’orco
e del sistema. E la vittima rischia così di essere vittima non due ma tre volte,
vittima dell’ipocrisia di quelli che puntano l’indice contro un ente
inafferrabile e irresponsabile (il Sistema) invece di volgere lo sguardo al
proprio fianco, nell’ufficio accanto, tra i colleghi, e additare i colpevoli, i
veri ir-responsabili, con nome e cognome.
Se il processo dura 20 anni non c’entra
la legge ma i magistrati, scrive Piero Sansonetti il
22 Febbraio 2017, su "Il Dubbio". Lo scandalo non sta nel fatto che è scattata
la prescrizione, dopo 20 anni dal reato e 20 anni dall’inizio del procedimento
penale. Lo scandalo sta nel fatto che non sono bastati 20 anni alla magistratura
per concludere l’iter processuale. Se un processo per lo stupro di una bambina
dura vent’anni e poi l’accusa cade in prescrizione, la colpa di chi è? È
successo in Piemonte. Ieri la notizia ha conquistato le home page di tutti i
siti, e l’hanno data le Tv. Un po’ ovunque è sembrato sentire un atto di accusa
vibrante contro la prescrizione, cioè quel meccanismo satanico e da
azzeccagarbugli che permette agli imputati di farla franca. Il procuratore
generale di Torino ha dichiarato ai giornali che occorre una profondissima
riforma, e che il compito tocca al legislatore. È il ritornello di sempre,
ripetuto incoro da giornali e procure: le colpe per la malagiustizia comunque
sono del potere politico e delle norme troppo garantiste. Mentre i magistrati,
di solito, si comportano in modo egregio e infatti, come è noto, combattono
contro la prescrizione. Se il potere politico non si opponesse alle giuste
battaglie dei magistrati e facesse le cose a modino, come i magistrati chiedono,
ecco che questo scandalo del presunto pedofilo che la fa franca non sarebbe
avvenuto…Davvero è così? Non solo non è così ma è esattamente il contrario. La
prescrizione è una misura estrema che serve solo a mettere un argine alla
violazione di un principio costituzionale che è quello della “ragionevole durata
del processo” (art 111 della Costituzione). E nessuno può avere dubbi sul fatto
che 18 o 19 anni devono essere più che sufficienti per concludere un processo
nel quale un uomo è accusato di avere esercitato violenza sessuale su una
bambina di 7 anni. Noi, né nessun altro giornalista, non siamo assolutamente in
grado di sapere se a carico dell’imputato ci fossero o no prove sufficienti.
Essere accusati d i pedofilia, insegnano casi giudiziari anche molto recenti,
non vuole assolutamente dire essere colpevoli. Spesso le accuse per pedofilia
cadono, risultano infondate (pensate solo alla vicenda assurda di quei poveretti
accusati di “pedofilia” di massa in una scuola di Rignano, in provincia di Roma,
e poi risultati tutti completamente innocenti, dopo mesi di carcere e anni di
infamie). Ma qui la questione non è certo quella di stabilire se l’imputato
fosse o no colpevole. Si tratta semplicemente di capire perché il processo è
andato in appello dopo 20 anni, quando ormai l’accusato era diventato vecchio, e
la bambina era diventata una signora (la quale, tra l’altro, ha fatto sapere che
di questa storia non vuole sapere più niente). Allora, proviamo a vedere come
stanno le cose. Le Procure e le Corti d’appello, sicuramente, sono intasate da
migliaia di procedimenti giudiziari che non riescono a smaltire. Questo vuol
dire che tutti i provvedimenti giudiziari durano 20 anni? No. E sarebbe logico
che i processi per i reati più gravi andassero più spediti. Non sempre è così.
Per esempio gli avvocati di tal Silvio Berlusconi ci dicono che dal 1995 a oggi
il suddetto Silvio Berlusconi ha subito 70 processi. Naturalmente nei processi a
Berlusconi, la procura di Alessandria e la corte d’appello di Torino (cioè le
due istituzioni che non sono riuscite a processare il sospetto pedofilo) non
c’entrano niente. Berlusconi è stato processato soprattutto dalla Procura di
Milano. Però il paragone, dal punto di vista politico, regge eccome. Le procure
hanno trovato tutto il tempo necessario per processare 70 volte Berlusconi,
mentre altre procure non riuscivano a fare un solo processo a quel signore
accusato di aver violentato una bambina. Come è possibile questo? Forse c’è una
sola spiegazione: processare un tipo come Berlusconi è attività assai più
attraente che processare un sospetto pedofilo sconosciuto. Produce uno
spettacolo molto maggiore, titoli sui giornali in grande rilievo, tv, fama. Un
procedimento giudiziario che garantisca un alto tasso di spettacolarità e che
magari abbia la possibilità di avere un peso significativo sulla vicenda
politica italiana, procede spedito. Nell’unica condanna subita da Berlusconi
(quella per una evasione fiscale commessa da Mediaset) tra la conclusione
dell’appello e la sentenza della Cassazione (assegnata a una sezione presieduta
da un giudice che poi è andato in pensione e ora fa il commentatore sul “Fatto
Quotidiano”) passarono addirittura pochi mesi. Fu un caso esemplare di giustizia
speedy gonzales. Dunque è del tutto evidente che non è l’istituto della
prescrizione il colpevole, ma il colpevole va cercato nel funzionamento di
alcuni settori della magistratura. Ha fatto molto bene la giudice Paola Dezani,
pronunciando la sentenza che prendeva atto dell’avvenuta prescrizione, a
chiedere scusa agli italiani a nome della magistratura. Però ora sarebbe anche
il caso di chiedersi di chi sia la colpa del sovraffollamento di procedimenti
penali. Forse, per esempio, è colpa dell’obbligatorietà dell’azione penale,
norma difesa col coltello tra i denti dall’Associazione magistrati, e che ormai
è diventata insensata? E magari è colpa anche dell’ostinazione con la quale
molti Pm ricorrono in appello di fronte a una sentenza di assoluzione in primo
grado (che pure dovrebbe far scattare, a lume di logica, il ragionevole dubbio
previsto dal codice penale come condizione di non condanna)? È chiaro che una
riforma della giustizia è assolutamente necessaria. Da anni molti governi di
centrodestra e di centrosinistra tentano di realizzarla, ma nessuno ci riesce
proprio per la tenace e potente resistenza dell’Anm.
Giustizia carogna,
scrive Fabrizio Boschi il 31 gennaio 2017 su "Il Giornale”. Nel febbraio 2012 ci
provò un deputato di Forza Italia, Daniele Galli: presentò una proposta di legge
per obbligare lo Stato a rifondere le spese legali del cittadino che viene
imputato in un processo penale e ne esce assolto con formula piena. Non venne
mai nemmeno discussa. Eppure affrontava una delle peggiori ingiustizie italiane.
Il corto circuito che ne viene fuori è poi un altro: chi è sotto la soglia di
povertà, ovvero meno di 16mila euro all’anno, può ottenere l’avvocato pagato
dallo Stato, ovvero il gratuito patrocinio. Chi usufruisce di questo favore
pagato da noi cittadini sono di solito, delinquenti, evasori seriali, ed
extracomunitari. Pochissimi gli italiani. Doppia beffa. Davanti al Tar poi la
cosa si fa ancora più triste: le cause contro lo Stato vengono pagate dallo
Stato stesso. Ogni anno in questo paese si aprono 1,2 milioni di procedimenti
penali, più alcune centinaia di migliaia di processi tributari. Gli assolti,
alla fine, sono la maggioranza: secondo alcune stime sono quasi i due terzi del
totale. Moltissimi sono quelli che escono dalle aule di giustizia assolti con
una “formula piena”, come si dice, e cioè perché il fatto non sussiste o per non
avere commesso il fatto. Costoro, però, devono comunque pagare di tasca propria
l’avvocato e i professionisti di parte: periti, tecnici, consulenti. Si tratta
di cifre a volte molto importanti. La famiglia di Raffaele Sollecito, processato
per otto anni come imputato per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, ha
dovuto pagare 1,3 milioni di euro al suo avvocato Giulia Bongiorno. Elvo
Zornitta, accusato ingiustamente di essere “Unabomber”, il terrorista del
Nord-Est, dovrebbe pagarne 150mila al suo avvocato. Giuseppe Gulotta, vittima
del peggiore errore giudiziario nella storia d’Italia (22 anni di carcere da
innocente) dovrebbe affrontare una spesa da 600mila euro. Ci sono poi tantissimi
casi nei quali anche parcelle da alcune decine di migliaia di euro rappresentano
la rovina economica per qualcuno. Oppure casi in cui per non sentir più parlare
di quel caso, il cliente soccombe a questa ingiustizia, si china e paga. Quando
poi il querelante decide di rimettere la querela, perché magari ha obbligato,
tramite il proprio avvocato, ad un accordo segreto il querelato, che decide di
pagare (in nero) pur di veder finito il suo calvario (un ricatto in piena regola
insomma: io rimetto la querela se tu mi dai tot altrimenti vado avanti con la
causa), allora dopo alcuni anni il querelato si vede pure arrivare a casa una
bella cartella di Equitalia, riguardo alle spese originate dalla remissione di
querela, come prevede la legge: è la norma processuale, infatti, che fissa a
carico del querelato la refusione delle spese del procedimento. Altra follia
pura. Insomma, lo Stato ti obbliga a pagare le spese legali anche se vinci le
cause, ma non ha remore nel pagare il difensore all’extracomunitario che non ha
nulla ed è in Italia illegalmente. Anche importanti giuristi e magistrati
concordano col fatto che far pagare le spese legali a chi ha vinto la causa o è
innocente sia una pura follia. Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia, si
dice convinto che sia «una fondamentale questione di giustizia: con il
discutibile principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, lo Stato
stabilisce il dovere d’indagare dei pubblici ministeri; ma ha anche l’obbligo di
risarcire l’avvocato all’innocente che senza alcun motivo ha dovuto affrontare
spese legali, spesso elevate». Giorgio Spangher, docente di procedura penale
alla Sapienza di Roma, ipotizza un fondo «che provveda almeno in parte a
indennizzare le spese sostenute», come già avviene per l’ingiusta detenzione.
Certo, il problema (come sempre in questi casi) sono le casse dello Stato: con
la legge di Stabilità per il 2016 il governo ha appena dimezzato e reso
praticamente inaccessibili le disponibilità previste per la legge Pinto, la
norma che dal 2001 indennizzava gli imputati vittime della lunghezza dei
processi a un ritmo di circa 500 milioni l’anno. Sarà forse difficile, pertanto,
che si possa mettere in atto qualcosa di valido sul rimborso delle spese legali.
Ma non può essere questa la scusa per distogliere lo sguardo da questa vera
ingiustizia. Se sei stato accusato di un reato o querelato ingiustamente e poi
al termine di un processo una sentenza sancisce la tua innocenza o estraneità ai
fatti o il fatto non sussiste, o il fatto non costituisce reato, non è giusto
che sia tu a pagare l’avvocato: deve farlo lo Stato. Che invece paga il
patrocinio ai delinquenti.
La confessione SHOCK del GIUDICE: “In
ITALIA giustifichiamo i REATI degli IMMIGRATI! Ecco perché…”
Si chiama Ignazio de Francisci, ed è procuratore capo di Bologna,
che ha espresso molti dei suoi dubbi nel discorso di inaugurazione dell’anno
giudiziario. Oggi, su “La Verità”, è uscita un’esclusiva intervista nel quale ha
rilasciato dichiarazioni molto forti. Ha iniziato dicendo che in Italia “c’è un
malinteso senso di accoglienza che disorienta i giudici” che quindi
diventerebbero molto più clementi con i furfanti stranieri, rispetto a quelli
italiani. Inoltre, secondo De Francisci, le nostre carceri sarebbero ricercate
dagli stranieri “perché meno dure e perché si esce più in fretta”. In pratica,
accade che a causa di una serie di regole europee, un immigrato che viene
arrestato in un altro paese della comunità europea, può richiedere di scontare
la pena qui da noi in Italia. E così le nostre carceri diventano quelle più
ambite da una gran bella parte di furfanti immigrati di mezza Europa. Perché
l’Italia è uno dei pochissimi paesi della Comunità Europea dove vige il
principio della buona condotta, con enormi sconti di pena. Come se non
bastassero i delinquenti nostrani, ci ritroviamo a carico dello stato anche
migliaia di delinquenti stranieri!
Lo dice il pm: "Carcere comodo: criminali
stranieri scelgono l'Italia". La denuncia choc del
procuratore di Bologna, Ignazio De Francisi: "Qui carcere più vantaggioso,
vengono soprattutto dall’Est", scrive Claudio Cartaldo, Lunedì 30/01/2017, su
"Il Giornale". La denuncia non viene da un pericoloso razzista xenofobo. Ma dal
procuratore generale della Corte di Appello d Bologna. Ignazio De Francisci,
durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha lanciato l'allarme riguardo le
leggi troppo poco severe, le "carceri comode" e gli sconti di pena che spingono
i criminali stranieri a venire in Italia dove hanno vita facile. Non è un
segreto infatti che negli ultimi anni si siano impennati i reati commessi da
stranieri, che spesso vanno a ingolfare le carceri italiane. Il 32% dei detenuti
(17mila su 52mila) è straniero, sebbene la popolazione immigrata in Italia sia
appena l'8,5%. Gli immigrati, in sostanza, delinquono in media 4 volte in più.
"Agli occhi della criminalità dell’est Europa, la commissione di delitti in
Italia è operazione più lucrosa e meno rischiosa che in patria - ha detto De
Francisci - E alle loro carceri sono preferibili le nostre". Per gli
"amministratori di giustizia", anche in Emilia-Romagna i problemi sono sempre
complessi e, rispetto al passato, in parte più gravi. I mali della giustizia. Ma
i problemi della giustizia non finiscono ovviamente qui. Ieri è arrivata anche
una sferzata al "troppo precariato", l'allerta sui troppi reati prescritti, il
boom dei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale che
rendono la situazione "critica". A cui si è aggiunto il monito di De Francisci
sulla "radicalizzazione" dei detenuti riguardo al terrorismo.
Gli intoccabili clandestini,
scrive Nino Spirlì su “Il Giornale” il 2 Febbraio 2017. E perché mai dovremmo
tacere sui reati e sui problemi che commettono e procurano gli oltre
cinquecentomila clandestini, sbarcati forzatamente sulle nostre coste senza
alcuna vera giustificazione? Fossero realmente dei poveracci che scappano da
persecuzioni personali, familiari, razziali, perpetrate a loro danno nei loro
paesi d’origine, potremmo anche cominciare a riflettere sulla possibilità di dar
loro una mano. Ma sono quaglie grasse e arroganti, pretenziose e violente, senza
nome e senza documenti che attestino la loro vera identità, nazionalità,
fedina penale pulita; invece, no: spacconi, con le tasche piene di soldi
destinati a caporali, scafisti, volontari venduti, capibranco e smistatori
corrotti, tonache sporcaccione e nere come i fumi dell’inferno. Tutto un popolo,
quello dei loro “difensori e padrini”, di delinquenti, massopoliticomafiosi, che
sta costruendosi un futuro unto di sangue e merda, quanto e più dei nazisti che
si spartivano gli ori raccattati nei lager. Bestie dalla faccia (ri)pulita dalla
Comunicazione al soldo dei poteri occulti. Finti moralizzatori che vorrebbero
imporci le loro sporche regole del silenzio, a danno della nostra onestà e
libertà, costate la vita ai nostri nonni, ai nostri Eroi. No! Non resteranno
impuniti o, peggio, occultati, gli orrori commessi dai clandestini sul suolo
Italiano. Non taceremo sugli stupri, le violenze, gli accoltellamenti, le
arroganze, le rapine, gli abusi, le pretese assurde. Non chiameremo solo
delinquenti, gli zingari delinquenti che scippano quotidianamente migliaia di
indifesi turisti e cittadini Italiani nelle nostre città d’Arte. Non chiameremo
solo malfattori, gli africani malfattori che distruggono alberghi e case
d’accoglienze, stuprano le volontarie, ammazzano la gente per strada
sull’esempio di quel kabobo, che nel maggio 2013 seminò il terrore per le strade
di Milano. Non saranno solo terroristi, o, peggio, malati di mente, gli islamici
terroristi che stanno tritando carne umana Cristiana con le loro sporche bombe
attaccate ai coglioni e fatte esplodere in mezzo alla gente ignara ed innocente.
Non saremo onerosi, né stitici della lingua Italiana. Sarà pane, al pane. Nero
al nero. Zingaro allo zingaro, che sia rom o sinti. Ci scandalizzeremo ancora a
vedere gli Italiani che crepano di fame e si impiccano per la vergogna di essere
rimasti senza lavoro e senza casa, mentre una pletora di beduini e neri
scansafatiche dorme al caldo e si sveglia sui comodi letti degli hotel a 4
stelle, scia e gioca a pallone a nostre spese, mentre – per giunta – ci urla in
faccia il proprio odio razziale. Difenderemo il diritto dei popoli occidentali
di alzare gli stessi muri che esistono nel resto del mondo, per contrastare
invasioni e malaffare. Così come difenderemo il diritto dello stato vaticano,
sede non solo di vergogne e immoralità da enciclopedia, a mantenere e tutelare
la bellezza e la ricchezza della cinta muraria medievale che lo preserva (e ci
preserva), oggi, dalla possibile evasione del peggior papa della sua storia.
Sorrideremo ancora tragicomicamente davanti ai cortei di femmine e femministe
che urlano contro Trump, il quale cerca di difenderle, e restano mute davanti
agli orrori e alle violenze dei paesi islamici, dove le donne valgono meno di
uno sputo a terra. E continueremo a lottare perché il mare diventi muro e le
navi militari, sentinelle. Perché i confini nazionali vengano rispettati,
onorati. Difesi. Perché esista il nazionale e il forestiero. Lo straniero.
LE COMPATIBILITA’ ELETTIVE.
IO SON IO E TU NON SEI UN CAZZO.
QUANDO IL DNA GIUDICANTE E’
QUESTIONE DI FAMIGLIA.
Come la legislazione si
conforma alla volontà ed agli interessi dei magistrati.
Un’inchiesta svolta in virtù
del diritto di critica storica e tratta dai saggi di Antonio Giangrande
“Impunitopoli. Legulei ed impunità” e “Tutto su Messina. Quello che non si osa
dire”.
Marito giudice e moglie
avvocato nello stesso tribunale: consentito o no?
Si chiede Massimiliano Annetta il 25 gennaio 2017 su “Il Dubbio”. Ha destato
notevole scalpore la strana vicenda che si sta consumando tra Firenze e Genova e
che vede protagonisti due medici, marito e moglie in via di separazione, e un
sostituto procuratore della Repubblica, il tutto sullo sfondo di un procedimento
penale per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo il medico, il pm che
per due volte aveva chiesto per lui l’archiviazione, ma poi, improvvisamente,
aveva cambiato idea e chiesto addirittura gli arresti domiciliari – sia l’amante
della moglie. Il tutto sarebbe corredato da filmati degni di una spy story.
Ebbene, devo confessare che
questa vicenda non mi interessa troppo. Innanzitutto per una ragione etica, ché
io sono garantista con tutti; i processi sui giornali non mi piacciono e, fatto
salvo il sacrosanto diritto del pubblico ministero di difendersi, saranno i
magistrati genovesi (competenti a giudicare i loro colleghi toscani) e il Csm a
valutare i fatti. Ma pure per una ragione estetica, ché l’intera vicenda mi
ricorda certe commediacce sexy degli anni settanta e, a differenza di Quentin
Tarantino, non sono un cultore di quel genere cinematografico.
Ben più interessante, e
foriero di sorprese, trovo, di contro, l’intero tema della incompatibilità di
sede dei magistrati per i loro rapporti di parentela o affinità. La prima
particolarità sta nel fatto che l’intera materia è regolata dall’articolo 18
dell’ordinamento giudiziario, che la prevede solo per i rapporti con esercenti
la professione forense, insomma gli avvocati. Ne discende che, per chi non veste
la toga, di incompatibilità non ne sono previste, e quindi può capitare, anzi
capita, ad esempio, che il pm d’assalto e il cronista sempre ben informato sulle
sue inchieste intrattengano rapporti di cordialità non solo professionale. Ma
tant’è.
Senonché, pure per i rapporti
fra avvocati e magistrati la normativa è quantomeno lacunosa, poiché l’articolo
18 del regio decreto 30.1.1941 n. 12, che regola la materia, nella sua
formulazione originale prevedeva l’incompatibilità di sede solo per “i
magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali […]
nei quali i loro parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado sono
iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore”. Insomma, in
origine, e per decenni, si riteneva ben più condizionante un nipote di una
moglie, e del resto non c’è da sorprendersi, la norma ha settantasei anni e li
dimostra tutti; infatti, all’epoca dell’emanazione della disciplina
dell’ordinamento giudiziario le donne non erano ammesse al concorso in
magistratura ed era molto limitato pure l’esercizio da parte loro della
professione forense.
Vabbe’, vien da dire, ci avrà
pensato il Csm a valorizzare la positiva evoluzione del ruolo della donna nella
società, ed in particolare, per quanto interessa, nel campo della magistratura e
in quello dell’avvocatura. E qui cominciano le soprese, perché il Cxm con la
circolare 6750 del 1985 che pur disciplinava ex novo la materia di cui
all’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, ribadiva che dovesse essere
“escluso che il rapporto di coniugio possa dar luogo a un’incompatibilità ai
sensi dell’art. 18, atteso che la disciplina di tale rapporto non può ricavarsi
analogicamente da quella degli affini”. Insomma, per l’organo di governo
autonomo (e non di autogoverno come si suol dire, il che fa tutta la differenza
del mondo) della magistratura, un cognato è un problema, una moglie no,
nonostante nel 1985 di donne magistrato e avvocato fortunatamente ce ne fossero
eccome. Ma si sa, la cosiddetta giurisprudenza creativa, magari in malam partem,
va bene per i reati degli altri, molto meno per le incompatibilità proprie.
Della questione però si avvede
il legislatore, che, finalmente dopo ben sessantacinque anni, con il decreto
legislativo 109 del 2006, si accorge che la situazione non è più quella del ‘41
e prevede tra le cause di incompatibilità pure il coniuge e il convivente che
esercitano la professione di avvocato. Insomma, ora il divieto c’è, anzi no.
Perché a leggere la circolare del Csm 12940 del 2007, successivamente modificata
nel 2009, si prende atto della modifica normativa, ma ci si guarda bene dal
definire quello previsto dal novellato articolo 18 come un divieto tout court,
bensì lo si interpreta come una incompatibilità da accertare in concreto, caso
per caso, e solo laddove sussista una lesione all’immagine di corretto e
imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e,
in generale, dell’ufficio di appartenenza. In definitiva la norma c’è, ma la si
sottopone, immancabilmente, al giudizio dei propri pari. E se, ché i costumi
sociali nel frattempo si sono evoluti, non c’è “coniugio o convivenza”, ma ben
nota frequentazione sentimentale? Silenzio di tomba: come detto, l’addictio in
malam partem la si riserva agli altri. Del resto, che il Csm sia particolarmente
indulgente con i magistrati lo ha ricordato qualche giorno fa pure il primo
presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio che, dinanzi al Plenum di
Palazzo dei Marescialli, ha voluto evidenziare come “il 99% dei magistrati”
abbia “una valutazione positiva (in riferimento al sistema di valutazione delle
toghe, ndr). Questa percentuale non ha riscontro in nessuna organizzazione
istituzionale complessa”.
Insomma, può capitare, e
capita, ad esempio, che l’imputato si ritrovi, a patrocinare la parte civile nel
suo processo, il fidanzato o la fidanzata del pm requirente.
E ancora, sempre ad esempio,
può capitare, e capita, che l’imputato che debba affrontare un processo si
imbatta nella bacheca malandrina di un qualche social network che gli fa
apprendere che il magistrato requirente che ne chiede la condanna o quello
giudicante che lo giudicherà intrattengano amichevoli frequentazioni con
l’avvocato Tizio o con l’avvocata Caia. Innovative forme di pubblicità verrebbe
da dire.
Quel che è certo, a giudicare
dalle rivendicazioni del sindacato dei magistrati, è che le sempre evocate
“autonomia e indipendenza” vengono, evidentemente, messe in pericolo dal tetto
dell’età pensionabile fissato a settant’anni anziché a settantacinque, ma non da
una disciplina, che dovrebbe essere tesa preservare l’immagine di corretto ed
imparziale esercizio della funzione giurisdizionale, che fa acqua da tutte le
parti.
Al fin della licenza, resto
persuaso che quel tale che diceva che i magistrati sono “geneticamente
modificati” dicesse una inesattezza. No, non sono geneticamente modificati,
semmai sono “corporativamente modificati”, secondo l’acuta definizione del mio
amico Valerio Spigarelli. E questo è un peccato perché in magistratura c’è un
sacco di gente che non solo è stimabile, ma è anche piena di senso civico, di
coraggio e di serietà e che è la prima ad essere lesa da certe vicende più o
meno boccaccesche. Ma c’è una seconda parte lesa, alla quale noi avvocati – ma,
a ben vedere, noi cittadini – teniamo ancora di più, che è la credibilità della
giurisdizione, che deve essere limpida, altrimenti sovviene la sgradevole
sensazione di nuotare in uno stagno.
Saltando di palo in frasca,
come si suo dire, mi imbatto in questa notizia.
Evidentemente quello che vale per gli avvocati non
vale per gli stessi magistrati.
VIETATO SPIARE L'AMORE TRA GIUDICI.
I CASI DI INCOMPATIBILITA' FINO AL 1967 (prima di quell' anno, i magistrati
erano soltanto uomini): Tra padre e figli (o tra fratelli o tra zio o nonno e
nipote) entrambi magistrati nello stesso collegio giudicante o nel collegio d'
impugnazione; oppure uno magistrato e uno avvocato nello stesso circondario,
scrive Giovanni Marino il 25 maggio 1996 su "La Repubblica". Dopo IL 1967 (cioè
dopo la legge che permetteva l'ingresso in magistratura delle donne):
Incompatibilità estesa anche: Tra marito e moglie, uno magistrato e uno avvocato
nello stesso circondario Tra marito e moglie entrambi magistrati, se nello
stesso collegio giudicante o nel collegio d' impugnazione Tra marito Pm e moglie
Gip (o viceversa) nello stesso circondario Magistrati conviventi e operanti
nello stesso circondario.
Giudici e avvocati compagni di vita. Il
Csm apre una pratica a Torino. Palazzo dei
Marescialli, contestata la compatibilità ambientale, scrive Raphael Zanotti il
18/09/2010 su “La Stampa”. L’amore non ha diritto di cittadinanza nelle aride
lande della Giustizia e dei codici deontologici. Non è previsto, non è
contemplato. Quando lo si scopre, si cerca di annichilirlo, azzerarlo. Si può
essere buoni magistrati se si ama l’avvocato dall’altra parte della barricata?
Si può difendere al meglio il proprio assistito se si deve battagliare con il
giudice con cui, il mattino dopo, ci si alza per fare colazione? L’uomo è
fragile, la legge no. Tra gli uomini e le donne di giustizia, l’amore è vietato.
Lo si cancella con due parole e un articolo di legge: incompatibilità
ambientale. Oppure, il più delle volte, lo si tiene nascosto, riservato. Perché
tra quelle aule austere, tra i corridoi e gli scartafacci, è come in qualsiasi
altro posto: l’amore sboccia, cresce, s’interrompe. È la vita che preme contro
le regole che gli uomini si sono dati per riuscire a essere più equi, per non
doversi affidare a eroi e asceti. Ma per quanto discreto, disinteressato e
onesto, l’amore - a volte - viene scoperto. E allora la legge interviene,
implacabile. E gli amanti tremano. Per uno che viene sorpreso, altri nove
restano nell’ombra. Tutti sanno di essere di fronte a una grande ipocrisia.
Perché nei tribunali ci sono sempre stati amori clandestini, che vivono di
complicità. Oppure ufficiali e stabili da così tanto da sentirsi al sicuro. Il
giudice torinese Sandra Casacci e l’avvocato Renzo Capelletto vivono la loro
storia sentimentale da 31 anni. Una vita. L’hanno sempre fatto alla luce del
sole. Il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, targato Michele Vietti,
che solo per un caso è torinese e avvocato anch’egli, ha appena aperto la sua
prima pratica disciplinare. L’ha aperta nei confronti del giudice Casacci per
incompatibilità ambientale. Il suo compagno, Capelletto, è amareggiato: «Mi
spiace per Sandra - racconta - Stiamo insieme da tanto, non ci siamo mai
nascosti. Sono stato anche presidente degli avvocati di Torino e nessuno ha mai
potuto dire che ci siano stati contatti tra la mia attività di avvocato e la sua
di giudice. Il vero problema è che Sandra, dopo una vita di lavoro, sta per
diventare capo del suo ufficio e forse questo dà fastidio a qualcuno». Il Csm ha
aperto un’altra pratica contro un giudice torinese. Questa volta si tratta di
Fabrizia Pironti, legata per anni sentimentalmente all’avvocato Fulvio Gianaria,
uno dei legali più conosciuti e stimati del foro torinese. «Della mia vita
privata preferirei non parlare - dice l’avvocato - ma una cosa la dico: in tutto
questo tempo non ho mai partecipato a un processo che avesse come giudice la
dottoressa Pironti. E così i miei colleghi di studio. È la differenza tra la
sostanza e il formalismo». La pratica aperta dal Csm mette il dito in una piaga.
Nei tribunali italiani non ci sono solo coppie formate da giudici e avvocati, ma
anche giudici e giudici sono incompatibili in certi ambiti. Oppure parenti,
affini. La legge dice, fino al secondo grado. «Abbiamo aperto questa pratica
perché ci è arrivata una segnalazione - si limita a dire il vicepresidente del
Csm, Vietti - È una pratica nuova, verificheremo». Il 4 ottobre, a Palazzo dei
Marescialli, è stato convocato il procuratore generale del Piemonte Marcello
Maddalena che dovrà spiegare se esiste una situazione di incompatibilità dei
suoi due giudici. E, nel caso esista da tempo, perché non è stata risolta prima.
Dovrà spiegare, insomma, come mai l’amore ha trovato spazio tra le aule austere
e i faldoni dei suoi uffici giudiziari.
TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE L’EXPO
- PER GIUSTIFICARE IL SILURAMENTO DI ROBLEDO DAL POOL ANTITANGENTI, BRUTI
LIBERATI HA SEGNALATO AL CSM CHE LA NOVELLA MOGLIE DEL PM LAVORA ALL’UFFICIO
LEGALE DI EXPO: “C’ERA INCOMPATIBILITÀ”. Per Robledo la storia della moglie
sarebbe solo un “pretesto” di Bruti Liberati per dare legittimità alla propria
rimozione, bocciata il 28 ottobre dal Consiglio Giudiziario come “esautoramento
usato per risolvere in modo improprio l’esistenza di un conflitto”…, scrive
Luigi Ferrarella per “il Corriere della Sera” il 6 novembre 2014. L’ex capo del
pool antitangenti Alfredo Robledo, che indagava sugli appalti collegati a Expo
2015, ha la moglie avvocato amministrativista che lavora all’ufficio legale di
Expo 2015: è quanto il procuratore Edmondo Bruti Liberati ha segnalato ieri al
Csm e al Consiglio Giudiziario, alla vigilia dell’odierna assemblea dei pm da
lui convocata per «voltare pagina» e «rilanciare l’orgoglio di appartenere alla
Procura». Lo fa inviando anche una lettera di risposta richiesta al commissario
di Expo 2015 Giuseppe Sala, e aggiungendo che la potenziale incompatibilità nel
pool antitangenti tra il pm e la coniuge non esiste invece ora nel nuovo pool
(«esecuzione delle pene») al quale il procuratore rivendica di aver trasferito
Robledo il 3 ottobre. Ma questi ribatte che la storia della moglie sarebbe solo
un «pretesto» di Bruti per dare una rinfrescata di legittimità alla propria
rimozione, bocciata il 28 ottobre dal Consiglio Giudiziario come «esautoramento
usato per risolvere in modo improprio l’esistenza di un conflitto»: ad avviso di
Robledo, infatti, non c’è mai stata alcuna possibile incompatibilità neppure
quando la moglie faceva l’amministrativista perché — spiega — operava in una
nicchia estranea alle indagini, e comunque ora proprio per evitare «pretesti» si
è cancellata dall’Ordine degli Avvocati. L’ordinamento giudiziario, per
prevenire incompatibilità nel lavoro, impone ai magistrati di segnalare entro 60
giorni (e ai capi di vigilare) relazioni sentimentali con altri magistrati o
avvocati del distretto. Robledo non lo fa nei 60 giorni dopo le nozze il 10
luglio 2014 con l’avvocato amministrativista Corinna Di Marino. A Bruti che ne
chiede conto, risponde che non ravvisa alcuna incompatibilità. Bruti chiede
allora il 23 ottobre «dettagli» sul tipo di lavoro della moglie, e il 31 ottobre
Robledo, pur «ribadendo l’insussistenza di incompatibilità», aggiunge che la
moglie, avvocato dal 2009, ha svolto la professione forense «esclusivamente nel
campo del diritto amministrativo sino a giugno 2013», quando ha smesso e ha
chiuso in luglio la partita Iva. Ma «al solo di fine di non lasciare spazio a
qualsiasi ulteriore incertezza o pretesto, si è anche cancellata dall’Albo degli
Avvocati il 27 ottobre 2014». Intanto Bruti ha interpellato il commissario di
Expo, Sala, che il 3 novembre spiega che l’avvocato «nel settembre 2013» rispose
a un bando online di Expo «per una posizione di specialista legale
amministrativa», fece la preselezione con altri candidati, la superò, svolse i
colloqui e infine ebbe il punteggio più alto. Mentre in Expo raccontano che è
una professionista stimata e chi l’ha selezionata non sapeva fosse legata a un
pm, la lettera di Sala prosegue indicando in 60.000 euro lordi l’anno lo
stipendio della moglie di Robledo con contratto co.co.pro. sino a fine 2015 per
la stipula dei «contratti commerciali» del Padiglione Italia in Expo. In linea
con quanto Robledo scrive sul fatto che la moglie, «in seguito al superamento di
concorso pubblico nel settembre 2013, svolge attività di mera consulenza legale
interna presso Expo 2015 nella materia specifica della valorizzazione ed
esposizione di prodotti tipici d’eccellenza nella filiera agroalimentare ed
enogastronomica italiana».
Procuratore Napoli, il figlio legale
ostacolo per Cafiero de Raho, scrive Mercoledì 7
Giugno 2017 Il Mattino. Il suo curriculum è eccellente, così come le sue doti
professionali sono riconosciute al Csm da tutti. Ma sulla via che potrebbe
portare il capo della procura di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho alla
nomina a procuratore di Napoli c'è un ostacolo che non si sa ancora se possa
essere aggirato: un figlio che fa l'avvocato penalista proprio nel capoluogo
campano. Una situazione che potrebbe determinare - se effettivamente De Raho
venisse preferito al suo diretto concorrente, l'ex capo di gabinetto del
ministro della Giustizia, Giovanni Melillo - quella che tecnicamente viene
chiamata «incompatibilità parentale», e che è causa di trasferimento ad altra
sede per i magistrati. Per questo al Csm c'è chi chiede di affrontare subito
questo nodo, prima ancora che, la prossima settimana, la Commissione Direttivi
entri nel vivo della discussione sul candidato da proporre al plenum. Anche per
Melillo - che con De Raho si contende pure la nomina a procuratore nazionale
antimafia - la strada non è in discesa: su di lui restano i dubbi di una parte
dei consiglieri di Area (gruppo di riferimento dello stesso magistrato e ago
della bilancia in questa difficile partita), che giudicano poco opportuno
affidare la guida della procura di Napoli, alle prese con inchieste delicate con
implicazioni politiche, come quella su Consip, a chi sino a poco tempo fa ha
ricoperto un ruolo di diretta collaborazione con il ministro Orlando. Per quanto
riguarda De Raho, il problema del figlio avvocato, Francesco, si era già posto
in passato, quando il magistrato era procuratore aggiunto a Napoli. E nel 2009,
dopo una lunga istruttoria, il Csm aveva escluso che vi fosse un'incompatibilità
ambientale e funzionale. Non c'è «il pericolo di interferenze», stabilirono
allora i consiglieri, accertato che Francesco non aveva mai trattato la materia
specialistica del padre (all'epoca alla guida della sezione sulle misure di
prevenzione della Dda), non aveva con lui nessun rapporto di natura
professionale, e che, esercitando a Napoli, non avrebbe potuto occuparsi nemmeno
in futuro di criminalità casertana, materia di competenza del genitore. Allora
però De Raho era un procuratore aggiunto e dunque coordinava un settore
limitato. Per questo il ragionamento seguito all'epoca non potrebbe essere
riproposto ora per il ruolo di capo dell'ufficio. E il fatto che tra il
magistrato e il figlio non ci siano più rapporti dal 1997, ribadito dal capo
della procura di Reggio nell'audizione di dieci giorni fa al Csm, potrebbe non
essere decisivo. Anzi, nel 2009, i consiglieri ritennero questo elemento «privo
di rilevanza» perché «l'intensità della frequentazione tra i congiunti non è
presa in considerazione dalla legge e può mutare nel tempo in maniera del tutto
imprevista». La più facile soluzione del rebus sarebbe destinare De Raho al
vertice della procura nazionale antimafia e Melillo alla guida di quella
campana. Ma un piano del genere richiederebbe l'unità di Area, che ancora non
c'è.
Parentopoli al tribunale di Lecce, il
presidente verso l'allontanamento. Il figlio di
Alfredo Lamorgese, avvocato iscritto a Bari, segue in Salento 37 cause civili,
ma in base alla legge sono ammesse, in via eccezionale, deroghe
all'incompatibilità parentale solo per piccole situazioni. Sul caso è
intervenuto il Csm per il trasferimento d'ufficio, scrive Chiara Spagnolo 12
giugno 2012 su "La Repubblica". Il padre presidente del Tribunale di Lecce, il
figlio avvocato, formalmente iscritto all’albo di Bari, ma con 37 cause civili
in itinere davanti allo stesso Tribunale del capoluogo salentino. È la saga dei
Lamorgese, famiglia di giudici e avvocati, che potrebbe costare il trasferimento
al presidente Alfredo, dopo che la prima commissione del Csm ha aperto
all’unanimità la procedura per "incompatibilità parentale". A Palazzo dei
Marescialli è stata esaminata la copiosa documentazione inoltrata dal Consiglio
giudiziario di Lecce, che, qualche settimana fa, ha rilevato la sussistenza
delle cause di incompatibilità attribuite all’attuale presidente del Tribunale.
Le verifiche effettuate dall’ordine degli avvocati hanno permesso di appurare
che Andrea Lamorgese risulta nominato come legale in 193 procedimenti pendenti
davanti agli uffici giudiziari salentini e che la sua appartenenza al Foro di
Bari, probabilmente, non basta a far venire meno le cause di incompatibilità
previste dall’ordinamento giudiziario. La legge prevede, infatti, che i
magistrati non possano esercitare funzioni direttive in un Tribunale in cui un
familiare svolga l’attività forense. La deroga a tale norma si può ottenere solo
quando l'attività difensiva del congiunto sia "sporadica e poco significativa"
anche dal punto di vista della qualità. Per ottenere la deroga, tuttavia, i
legami parentali tra giudici e avvocati devono essere portati all’attenzione del
Csm, cosa che Lamorgese non avrebbe fatto all’atto della sua nomina a presidente
del Tribunale, avvenuta nel 2009. A distanza di soli tre anni quella leggerezza
rischia di costargli cara, ovvero un trasferimento prematuro rispetto agli otto
anni previsti per il suo incarico, perché l’accertamento sull’attività svolta
dal figlio ha permesso di scoprire come l’esercizio della funzione legale di
Andrea a Lecce non fosse né sporadica né poco significativa. Diversamente per
quanto riscontrato rispetto alla figlia e alla nuora, anche loro avvocati, le
cui professioni non sarebbero però incompatibili con l’attività del presidente,
dal momento che la prima non esercita la professione e la seconda si occupa di
giustizia amministrativa. Il prossimo passo del Consiglio superiore della
magistratura sarà la convocazione di Lamorgese a Roma, che sarà ascoltato il
prossimo 25 giugno per chiarire la propria posizione. All’esito dell’ascolto, e
dell’esame di eventuali documenti prodotti, la prima commissione deciderà se
chiedere al plenum il trasferimento o archiviare il caso.
Lecce, trasferito il presidente del
tribunale. "Il figlio fa l'avvocato, incompatibile".
La decisione presa all'unanimità dal Csm: Alfredo Lamorgese non può esercitare
nello stesso distretto dove lavora il suo congiunto. Il magistrato verso la
pensione anticipata, scrive Chiara Spagnolo il 13 febbraio 2013 su "La
Repubblica". Finisce con la parola trasferimento l’esperienza di Alfredo
Lamorgese alla guida del Tribunale di Lecce. Il plenum del Csm è stato
perentorio: impossibile sedere sulla poltrona di vertice degli uffici giudicanti
salentini se il figlio avvocato, formalmente iscritto all’albo di Bari, in
realtà esercita la sua professione anche a Lecce. Trasferimento d’ufficio per
incompatibilità ambientale era stato chiesto dalla Prima commissione e così
sarà, in seguito alla decisione presa ieri all’unanimità a Palazzo dei
Marescialli. Prima che la Terza commissione scelga per Lamorgese una nuova
destinazione, tuttavia, il giudice potrebbe presentare domanda di pensionamento,
così come è stato comunicato ad alcuni membri del Csm, che avevano consigliato
di chiudere immediatamente la lunga esperienza professionale onde evitare l’onta
di una decisione calata dall’alto. La vicenda tiene banco da mesi nei palazzi
del barocco, da quando il Consiglio giudiziario di Lecce ha inoltrato al
Consiglio superiore una copiosa documentazione che ha determinato l’apertura
della pratica per incompatibilità “parentale”. Le verifiche effettuate
dall’ordine degli avvocati hanno permesso infatti di appurare che Andrea
Lamorgese risulta nominato come legale in 193 procedimenti pendenti davanti agli
uffici giudiziari salentini e che la sua appartenenza al Foro di Bari,
probabilmente, non basta a far venire meno le cause di incompatibilità previste
dall’ordinamento giudiziario. La legge prevede che i magistrati non possano
esercitare funzioni direttive in un Tribunale in cui un familiare svolga
l’attività forense. La deroga a tale norma si può ottenere solo quando
l'attività difensiva del congiunto sia "sporadica e poco significativa" anche
dal punto di vista della qualità e deve essere tempestivamente comunicata
all’organo di autogoverno della magistratura. Stando a quanto verificato dal
Csm, tuttavia, il presidente non avrebbe comunicato alcuna causa di
incompatibilità all’atto della sua nomina, avvenuta nel 2009, né negli anni
successivi. E a poco è servito il tentativo di difendersi che in realtà le cause
in cui il figlio è stato protagonista come avvocato sono in numero di gran lunga
inferiore rispetto alle 193 contestate, perché l’accertamento sull’attività
svolta dal figlio ha permesso di scoprire come l’esercizio della funzione legale
di Andrea a Lecce non fosse né sporadica né poco significativa. Al punto che,
secondo il Consiglio superiore, uno dei due Lamorgese avrebbe dovuto lasciare.
Brindisi, giudici contro il procuratore,
scrive il 27 giugno 2008 Sonia Gioia su "La Repubblica". Il procuratore Giuseppe
Giannuzzi, oggetto di un pronunciamento di incompatibilità parentale da parte
del Consiglio superiore della magistratura, che lo costringe ad abbandonare il
ruolo rivestito nella procura brindisina, non potrà mai più dirigere un'altra
procura. E' questo, a quanto pare, quello che stabilisce la legge. Sebbene a
Giannuzzi resti la chance del ricorso al tribunale amministrativo contro il
provvedimento adottato dall' organo di autogoverno dei magistrati.
Incompatibilità sorta sulla base di un procedimento penale nel quale un figlio
del magistrato, Riccardo Giannuzzi, avvocato iscritto all'albo forense di Lecce,
assunse la difesa di alcuni indagati sulla base di una richiesta al gip
controfirmata dallo stesso procuratore capo. Giannuzzi junior, raggiunto
telefonicamente, si esime da qualsiasi commento: "Non parlo per una questione di
correttezza nei confronti di mio padre. Senza il suo consenso non sarebbe giusto
rilasciare alcuna dichiarazione". Ma la famiglia, coinvolta in una vicenda senza
precedenti, almeno nella procura brindisina, è comprensibilmente provata. Sono
stati i magistrati della città messapica i primi a far emergere il caso della
presunta incompatibilità parentale. Gli stessi giudici difesi a spada tratta da
Giannuzzi quando gli strali del gip Clementina Forleo, autrice della denuncia
contro i pm Alberto Santacatterina e Antonio Negro, si sono abbattuti sulla
procura di Brindisi. A settembre scorso la sezione locale dell'associazione
nazionale magistrati si riunì per discutere il caso, dopo che da tempo, nei
corridoi del palazzo al civico 3 di via Lanzellotti, si mormorava
insistentemente e non senza insofferenza. L'avvocato Giannuzzi, per quanto
iscritto all'albo salentino dal 1999, figurava in qualità di difensore in
diversi processi celebrati nel tribunale brindisino. Fino all' ultimo caso,
esploso a seguito di un blitz per droga. Il legale assunse la difesa di uno
degli indagati, arrestato a seguito dell'operazione, sulla base di una richiesta
al gip controfirmata da Giuseppe Giannuzzi. A seguito della vicenda, i giudici
tanto della procura quanto del tribunale, riuniti in consesso, insorsero
siglando a maggioranza una delibera in cui si legge: "L' evidente caso di
incompatibilità parentale mina il prestigio di cui la magistratura brindisina ha
sempre goduto". Parole pesanti, che il procuratore capo Giuseppe Giannuzzi, di
stanza a Brindisi dal settembre 2004, non ha mai voluto commentare. Adesso, il
pronunciamento del Csm: padre e figlio non possono convivere professionalmente
nello stesso distretto giudiziario. Diciotto i voti a favore, sei i favorevoli a
Giannuzzi, fra cui quello del presidente Nicola Mancino. La decisione è stata
adottata sebbene l'avvocato Riccardo Giannuzzi abbia, a seguito del putiferio
venutosi a creare, rinunciato a tutti i mandati che potevano vedere in qualche
modo coinvolto il procuratore capo della Repubblica di Brindisi. La prima
commissione del Csm si era già espressa all' unanimità a favore del
trasferimento, sempre alla luce del fatto che Giannuzzi junior esercita la
professione forense anche nel capoluogo messapico. Le conseguenze del
procedimento, a quanto pare, non sortiranno effetti in tempi brevi: la decisione
del plenum del Csm infatti, dopo la notifica potrà essere impugnata dal
procuratore capo. La prassi prevede che a indicare le nuove, possibili sedi di
destinazione sia ora la terza commissione del Consiglio superiore della
magistratura. La scelta toccherà direttamente al giudice, che se non dovesse
esprimersi, sarà trasferito d' ufficio. Ma in nessuna sede in cui Giuseppe
Giannuzzi verrà destinato, lo prevede il regolamento, mai più potrà rivestire il
ruolo di procuratore capo. A meno che non presenti ricorso al Tar e lo vinca.
Uccise il figlio, condanna ridotta a 18
anni di reclusione per un 66enne barcellonese, scrive
il 22 febbraio 2017 “24live.it”. Condanna ridotta a 18 anni per il 66enne
muratore barcellonese Cosimo Crisafulli che nel maggio del 2015 uccise con un
colpo di fucile il figlio Roberto, al termine di una lite verificatisi nella
loro abitazione di via Statale Oreto. Nel giugno 2016 per l’uomo, nel giudizio
del rito abbreviato davanti al Gup del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
Salvatore Pugliese, era arrivata la condanna a 30 anni di reclusione. La Corte
d’Assise d’Appello di Messina, che si è pronunciata ieri, presieduta dal giudice
Maria Pina Lazzara, ha invece ridotto di 12 anni la condanna, sebbene il
sostituto procuratore generale, Salvatore Scaramuzza, avesse richiesto la
conferma della condanna emessa in primo grado. Decisiva per il 66enne la
concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti,
richieste già in primo grado dall’avvocato Fabio Catania, legale del 66enne
Cosimo Crisafulli.
Cosa c’è di strano direte voi.
E già. Se prima si è parlato
di incompatibilità tra magistrati e parenti avvocati, cosa si potrebbe dire di
fronte ad un paradosso?
Leggo dal post pubblicato il 2
febbraio 2018 sul profilo facebook di Filippo Pansera, gestore di Messina
Magazine, Tele time, Tv Spazio e Magazine Sicilia. “Nel 2016, la dottoressa
Maria Pina Lazzara presidente della Corte d'Assise d'Appello di Messina, nonchè
al vertice della locale Sezione di secondo grado minorile emetteva questa
Sentenza riformando il giudizio di primo grado statuito dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto. L'accusa era rappresentata in seconde cure, dall'ex
sostituto procuratore generale Salvatore Scaramuzza (oggi in pensione). La
dottoressa Lazzara ed il dottor Scaramuzza... sono marito e moglie dunque per la
presidente della Corte vi era una incompatibilità ex articolo 19
dell'Ordinamento Giudiziario. Invece come al solito, estese ugualmente il
provvedimento giudiziario... che è dunque da intendersi nullo. Inoltre, malgrado
il dottor Salvatore Scaramuzza sia andato in pensione, la dottoressa Lazzara è
comunque incompatibile anche al giorno d'oggi nel 2018. Salvatore Scaramuzza e
Maria Pina Lazzara infatti, hanno una figlia... Viviana... anch'essa magistrato
che opera presso Barcellona Pozzo di Gotto in tabella 4 dal 2017. Sempre ex
articolo 19 dell'Ordinamento Giudiziario, madre e figlia non possono esercitare
nello stesso Distretto Giudiziario... come invece succede ora ed in costanza di
violazione di Legge. A Voi..., il giudizio.”
Egregio signore, apprendo in
data odierna da telefonate di amici che una citazione riferentesi a me è apparsa
nel contesto di un articolo intitolato " IO SON IO E TU NON SEI UN
C........quando il dna giudicante è questione di famiglia". Il riferimento
concerne un presunto rapporto di coniugio tra me e il sostituto procuratore
generale di Messina, Dr. Scaramuzza oggi in pensione, e un rapporto filiale tra
me e tale Viviana. Mi sorprende come circostanze di semplice verifica siano
attestate senza il minimo controllo: la informo che mio marito non è il dr.
Scaramuzza, è persona estranea all'ordine giudiziario ed io ho tre figli tutti
maschi, nessuno dei quali ha intrapreso la carriera di magistrato. Il primo
anzi, e per fortuna, ha pensato bene di andarsene all'estero dove si è
guadagnato un dottorato con borsa, è un libero pensatore, studioso dei movimenti
e attivista lui stesso per tentare di scardinare questo sistema che -
sembrerebbe- ella cerchi di mettere alla gogna. L'accostamento del mio nome ad
altre vicende che non conosco e non giudico non fa giustizia del mio
ultratrentennale impegno professionale e personale: per mia formazione ho in
odio chiunque cerchi scorciatoie e agevolazioni, fosse anche il saltare una fila
o segnalare per un esame all'università il proprio figlio (nell'ultimo anno uno
di essi è stato bocciato per ben 3 volte ad un esame, senza che questo abbia
creato turbamenti o sensazione di lesa maestà). Per questo il suo articolo mi ha
fatto sorridere, ma mi ha anche lasciato l'amaro in bocca. Spero in una pronta
rettifica, ma ove questa non intervenisse, me ne farò una ragione. F.to D.ssa
Maria Pina LAZZARA.
Dr.ssa Lazzara mi spiace per
il qui pro quo e per il turbamento creato, a cui porrò immediato rimedio con la
doverosa rettifica. Ha fatto bene ad avvisarmi. Io sono un saggista. Ho
riportato un post di un direttore di un portale d’informazione. Un giornalista a
cui spetta la verifica delle fonti e di cui io mi sono fidato. Questo comunque
non mi esime dal chiederle scusa e ringraziarla nell’essersi comportata da
perfetta gentil donna. Alle sentite scuse, seguirà pronta rettifica.
Si rettifica un errore di
persona. Maria Pina Lazzara non è moglie del dr Scaramuzza e Viviana Scaramuzza
non è sua figlia. Nel saggio si è riportato un post di un direttore di un
portale d’informazione. Un giornalista a cui spetta la verifica delle fonti.
Dopo il tono conciliante e
nonostante la pronta rettifica segue messaggio di minaccia.
Buonasera, sono la d.ssa Maria
Pina LAZZARA, Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Messina, nonchè della
sezione Minori. Con riferimento all'articolo pubblicato in data 4/2/2018 dal
titolo IO SON IO E TU NON SEI UN C.....QUANDO IL DNA GIUDICANTE E' QUESTIONE DI
FAMIGLIA, vi segnalo - sempre che la verità abbia per voi rilevanza- che : a)
sono coniugata con BARTOLO Umberto fin dal 1985 e non con il dr Salvatore
Scaramuzza, sostituto procuratore generale oggi in pensione; mio marito , in
quiescenza dal 2017, ha svolto le sue funzioni sempre al di fuori dell'ambito
giudiziarioi b) non ho alcuna figlia femmina a nome Viviana , ma tre figli
maschi , ancora studenti. La collocazione della citata falsa notizia in un
contesto di evidente denigrazione dei magistrati, indicati come soggetti adusi
ad operare al di fuori delle regole, è quanto di più estraneo alla mia
formazione personale e professionale: ho sempre odiato le prevaricazioni da
chiunque esse provengano ( ho sempre rispettato la fila, ho sempre prenotato le
visite mediche con il numero verde delle prenotazioni , ho assistito rigorosa ed
impassibile alle numerose bocciature ad alcuni esami universitari di qualcuno
dei miei figli, che sono cresciuti con la consegna del silenzio sulla identità
della madre e di tutto ciò vado orgogliosa). Proprio in ragione di quanto sopra,
mi ha particolarmente turbato l'accostamento della mia persona alle altre
vicende trattate nel corpo dell'articolo e mi riservo di valutare le opportune
iniziative da assumere a tutela della mia dignità. F.to D.ssa Maria Pina LAZZARA
«Cari giornalisti dovete sentire le due
campane», scrive Giulia Merlo l'11 Marzo 2018 su "Il
Dubbio". Un giornale scrive il falso, ma il diritto di stampa prevale su quello
alla reputazione e dunque il cittadino non ha diritto a veder ristabilita in via
immediata (e dunque con un ricorso cautelare) la verità, ma solo dopo un
processo di cognizione piena. A contraddire almeno parzialmente questo
principio, stabilito da due sentenze delle Sezioni Unite di Cassazione penali
del 2015 (29 gennaio 2015 n. 31022e civili del 2016 (18 novembre 2016 n. 23469),
è intervenuto il Tribunale civile di Milano. Il caso è quello di due avvocati,
indicati da un articolo apparso sul sito de L’Espresso come titolari di conti
correnti off shore e come amministratori di società off shore, sulla base del
contenuto dei cosiddetti “Paradise Papers” (un fascicolo riservato composto da
13,5 milioni di documenti confidenziali presso la Appleby, uno studio legale che
fornisce consulenze internazionali in campo societario e fiscale). I due,
dimostrando di non avere conti off shore e di non essere amministratori di
società, hanno chiesto in via d’urgenza al tribunale di ordinare la rimozione
dei loro nomi dal sito del settimanale. L’ordinanza di primo grado ha dichiarato
la richiesta inammissibile proprio sulla base delle sentenze delle Sezioni Unite
ma, in sede di reclamo, il tribunale ha parzialmente riformato la decisione. «La
vicenda presenta un problema di giustizia sostanziale molto chiaro», ha spiegato
l’avvocato Iuri Maria Prado, difensore dei due diffamati, «Se una testata online
pubblica una notizia palesemente e provatamente falsa, seguendo l’orientamento
della Cassazione il cittadino non ha diritto ad avere una tutela d’urgenza con
la rimozione della notizia, ma deve attendere i tempi di un processo ordinario
per diffamazione: e questo perché il diritto alla reputazione è considerato da
quella giurisprudenza ‘ recessivo’ ( cioè vale meno) rispetto al diritto alla
libera manifestazione del pensiero attraverso la stampa». Il Tribunale, dunque,
ha stabilito che non è possibile privare la vittima di qualunque tutela di
urgenza, anche se questa tutela in via cautelare non può tradursi nè nel
sequestro della pubblicazione, nè nell’inibizione alla sua ulteriore diffusione,
ma «sono ammissibili rimedi di tipo integrativo e correttivo» o «un
“aggiornamento” della notizia». Si tratta di «un piccolo spiraglio aperto dal
tribunale di Milano, che scalfisce almeno in parte il poco condivisibile
orientamento delle Sezioni Unite», ha riconosciuto l’avvocato Prado. Tuttavia, a
fronte di questa apertura sul piano del riconoscimento generale di un diritto,
nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la richiesta di far pubblicare sul
sito de L’Espresso il provvedimento del giudice, Secondo il collegio, infatti,
«nel caso di specie sarebbe superfluo, perchè nel corpo dell’articolo è stato
inserito il link contenente le lettere di precisazioni e spiegazioni inviate per
email alla redazione dai reclamanti». In questo modo, secondo i giudici, «è
stato garantito il diritto degli stessi di far conoscere la “loro verità”,
informando il lettore dell’esistenza di elementi ulteriori e contrastanti
rispetto a quelli contenuti nell’articolo». Proprio in questo, secondo
l’avvocato Prado, sta l’elemento di non condivisibilità: «Il fatto che non siano
titolari di conti off shore non è la “loro verità” ma “la” verità oggettiva e
non controvertibile. Nel caso dei due avvocati la diffamazione non sta
nell’espressione di un giudizio, ma nell’attribuzione di un fatto specifico
falso». In sostanza, aggiungere ad un articolo online la rettifica dei diretti
interessati non ha certo la stessa portata di pubblicare un provvedimento che
attesta la verità stabilita da un giudice, sia pure in via d’urgenza. Eppure,
anche se l’ordinanza non riconosce pieno diritto alla richiesta di vedere
ristabilita la verità da parte delle vittime, riconosce un elemento importante:
«il carattere pervasivo e diffusivo» di una notizia pubblicata online «è idoneo
a causare danni potenzialmente irreparabili». Per questo, il cittadino non deve
attendere il corso di un giudizio a cognizione piena, ma ha diritto ad ottenere
una qualche forma di tutela immediata. Un piccolo passo nella direzione di
riconoscere che il diritto all’onore e alla reputazione del cittadino non possa
essere considerato figlio di un Dio minore rispetto al diritto di stampa.
Allargando l’orizzonte della vicenda, infatti, si potrebbe arrivare al paradosso
che «per diffondere fake news contando sul fatto che esse possano essere
eliminate dalla rete solo al termine di un lungo processo per diffamazione,
basterebbe che un ricco magnate apra una testata online e la registri in
tribunale indicando un direttore responsabile», ha spiegato Prado. Se contiene
notizie false, infatti, un sito ordinario può essere sequestrato, una testata
giornalistica online invece no. Dunque, incuneandosi tra le maglie della
giurisprudenza, basterebbe un adempimento burocratico per riparare sotto
l’ombrello dei diritti costituzionalmente riconosciuti un abuso dei mezzi di
informazione.
Scrive Filippo Pansera il 9 marzo 2018 sulla sua
Pagina Facebook: "Molte settimane fa, scrivevo di una giudice altolocata (perchè
con incarichi direttivi di vertice a Palazzo Piacentini - Messina), che essa
avesse una figlia magistrato ed un marito giudice..., in realtà sono stato
tratto in inganno da una dei miei avvocati e da un secondo amico mio avvocato.
Successivamente, ho scoperto come stanno effettivamente le cose. La dottoressa
non ha figli giudici o avvocati, bensì è cognata di una avvocatessa con Studio
legale in Messina presso altro collega... arrestato nel 2017... e con trascorsi
politici di centro-destra. Dunque, la signora, è incompatibile ex articolo 18
dell'Ordinamento Giudiziario".
Tribunale di Messina, le relazioni
pericolose emerse dallo screening di un gruppo di giovani avvocati,
scrive l'1 settembre 2016 "100 Nove". Nello “screening” effettuato in relazione
al Tribunale di Messina, un gruppo di giovani avvocati emergono una serie di
rapporti in chiaroscuro tra magistrati, prima sposati e poi divorziati, che si
trovano ad operare nello stesso tribunale; magistrati che si ritrovano cognati
avvocati a discutere le stesse cause. E altro, dopo l’esplosione del caso Simona
Marra. Un dettagliato elenco di tutte le anomalie nei rapporti tra avvocati e
magistrati nel distretto giudiziario di Messina. Lo ha predisposto un gruppo di
giovani avvocati che ha passato al setaccio le situazioni “controverse” nei
tribunali della provincia, dopo l’esplosione del “caso Simona Merra”, il pm di
Trani titolare del fascicolo sull’incidente ferroviario del 12 luglio tra Bari e
Barletta dove hanno perso la vita 23 persone, sorpresa da uno scatto fotografico
a farsi baciare il piede dall’avvocato Leonardo De Cesare, legale di Vito
Picaretta, capostazione di Andria che è il principale indagato della strage.
Nello “screening” del Tribunale di Messina, conosciuto in passato come “rito
peloritano”, emergono una serie di rapporti in chiaroscuro tra magistrati, prima
sposati e poi divorziati, che si trovano ad operare nello stesso tribunale;
magistrati che si ritrovano cognati avvocati a discutere le stesse cause;
magistrati togati che, tra i 64 incaricati alla commissione tributaria, si
ritrovano nella rotazione ad avere parenti diretti in commissione; magistrati
invitati la sera a cena da avvocati, con i quali hanno fascicoli aperti. Una
situazione anomala, tollerata per una sorta di quieto vivere, che preoccupa ora
i giovani avvocati promotori dello screening: si stanno interrogando se inviare
in forma anonima il documento solo ai giornali e al Consiglio giudiziario, o
solo alla sezione disciplinare del Csm e alla procura generale della Cassazione:
temono rappresaglie professionali, da parte dei magistrati e consiglieri
dell’Ordine. Sulla questione delle incompatibilità, si è aperto un vivace
dibattito anche a livello nazionale. Se da una parte il vicepresidente del
Csm Giovanni Legnini chiede ai magistrati di assumere un maggiore senso di
sobrietà e finirla con la giustizia-spettacolo, dall’altra, la stessa categoria
dei magistrati, dilaniata dalle correnti, si è spaccata sul caso “Simona Marra”
con posizioni divergenti tra Magistratura Indipendente, Magistratura
Democratica, Unicost, Area, la corrente di sinistra, e Autonomia & Indipendenza,
il gruppo che fa capo al presidente nazionale dell’Associazione nazionale
magistrati, Piercamillo Davigo, che ha raccolto un buon numero di adesioni in
provincia di Messina, dove esponente di punta è il procuratore
aggiunto, Sebastiano Ardita.
Giustizia alla cosentina: tutte le
“parentele pericolose” tra giudici, pm e avvocati,
scrive Iacchite il 22 luglio 2016. Diciassette magistrati del panorama
giudiziario di Cosenza e provincia risultano imparentati con altrettanti
avvocati dei fori cosentini. Una situazione impressionante, che corre da anni
sulle bocche di tutti i cosentini che hanno a che fare con questo tipo di
“giustizia”. Il dossier Lupacchini, già dieci anni fa, faceva emergere in tutta
la sua gravità questo clima generale di “incompatibilità ambientale” ma non è
cambiato nulla, anzi. La legge, del resto, non è per niente chiara e col passare
del tempo è diventata anche più elastica. Per cui diventa abbastanza facile
eludere il comma incriminato e cioè che il trasferimento diventa
ineludibile “quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio
della Amministrazione”. Si tratta, dunque, di un potere caratterizzato da
un’ampia discrezionalità. E così, dopo un decennio, siamo in grado di darvi una
lettura aggiornata di tutto questo immenso “giro” di parentele, difficilmente
perseguibili da una legge non chiara e che comunque quantomeno condiziona
indagini e sentenze. E coinvolge sia il settore penale che quello civile. Anzi,
il civile, che è molto più lontano dai riflettori dei media, è ricettacolo di
interessi, se possibile, ancora più inconfessabili. Cerchiamo di capirne di più,
allora, attraverso questo (quasi) inestricabile reticolo di relazioni familiari.
LE PARENTELE PERICOLOSE
Partiamo dai magistrati che lavorano nel Tribunale
di Cosenza.
Il pubblico ministero Giuseppe Casciaro (chè tanto
da qualcuno dovevamo pur cominciare) è sposato con l’avvocato Alessia Strano,
che fa parte di una stimata famiglia di legali, che coinvolge anche il suocero
Luciano Strano e i cognati Amedeo e Simona.
Il giudice Alfredo Cosenza è sposato con
l’avvocato Serena Paolini ed è, di conseguenza, cognato dell’avvocato Enzo
Paolini, che non ha certo bisogno di presentazioni.
Il gip Giusy Ferrucci, dal canto suo, è sposata
con l’avvocato Francesco Chimenti.
Paola Lucente è stata giudice del Tribunale penale
di Cosenza e adesso è in servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro e mantiene
il ruolo di giudice di sorveglianza e della commissione tributaria cosentina. Di
recente, il suo nome è spuntato fuori anche in alcune dichiarazioni di pentiti
che la coinvolgono in situazioni imbarazzanti riguardanti il suo ruolo di
magistrato di sorveglianza.
Anche la dottoressa Lucente ha un marito avvocato:
si chiama Massimo Cundari.
Del giudice Lucia Angela Marletta scriviamo ormai
da tempo. Anche suo marito, Maximiliano Granata, teoricamente è un avvocato ma
ormai è attivo quasi esclusivamente nel settore della depurazione e, come si sa,
in quel campo gli interventi della procura di Cosenza, in tema di sequestri e
dissequestri, sono assai frequenti. Quindi, è ancora peggio di essere “maritata”
con un semplice avvocato.
Se passiamo al civile, la situazione non cambia di
una virgola.
La dottoressa Stefania Antico è sposata con
l’avvocato Oscar Basile.
La dottoressa Filomena De Sanzo, che proviene
dall’ormai defunto tribunale di Rossano, si porta in dote anche lei un marito
avvocato, Fabio Salcina.
La dottoressa Francesca Goggiamani è in servizio
nel settore Fallimenti ed esecuzioni immobiliari ed è sposato con
l’avvocato Fabrizio Falvo, che fino a qualche anno fa è stato anche consigliere
comunale di Cosenza.
GIUDICI COSENTINI IN ALTRA SEDE
Passando ai magistrati cosentini che adesso
operano in altri tribunali della provincia o della regione, il giudice penale
del Tribunale di Paola Antonietta Dodaro convive con l’avvocato Achille
Morcavallo, esponente di una famiglia da sempre fucina di legali di spessore.
Il giudice penale del Tribunale di Castrovillari,
nonché giudice della commissione tributaria di Cosenza, Loredana De Franco, è
sposata con l’avvocato Lorenzo Catizone. Anche lui, come Granata, non fa
l’avvocato di professione ma in compenso fa parte da anni dello staff di Mario
Oliverio. Che non ha bisogno di presentazioni. Catizone, inoltre, è cugino di
due noti avvocati del foro cosentino: Francesco e Rossana Cribari.
Il neoprocuratore di Castrovillari Eugenio
Facciolla si trascina molto più spesso rispetto al passato la figura ingombrante
del fratello Marco, avvocato. In più, lo stesso Facciolla è cognato
dell’avvocato Pasquale Vaccaro.
Sempre a Castrovillari, c’è un altro giudice
cosentino, Francesca Marrazzo, che ha lavorato per molti anni anche al Tribunale
di Cosenza. E che è la sorella dell’avvocato Roberta Marrazzo.
La dottoressa Gabriella Portale invece è in
servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro (sezione lavoro) ed è giudice della
commissione tributaria di Cosenza. Suo marito è l’avvocato Gabriele Garofalo.
Il dottor Biagio Politano, giudice della Corte
d’Appello di Catanzaro già proveniente dal Tribunale di Cosenza e giudice della
commissione tributaria di Cosenza, ha una sorella tra gli avvocati. Si
chiama Teresa.
Non avevamo certo dimenticato la
dottoressa Manuela Morrone, oggi in servizio nel settore civile del Tribunale di
Cosenza dopo aver lavorato anche nel penale. Tutti sanno che è la figlia
di Ennio Morrone e tutti sappiamo quanto bisogno ha avuto ed ha tuttora di una
buona parola per le sue vicissitudini giudiziarie, sia nel penale, sia nel
civile.
Morrone non è un avvocato ma riteniamo, per tutte
le cause che lo vedono protagonista, che lo sia diventato quasi honoris causa.
Poiché non ci facciamo mancare veramente nulla,
abbiamo parentele importanti anche per giudici onorari e giudici di pace.
La dottoressa Erminia Ceci è sposata con
l’avvocato Alessandro De Salvo e il dottor Formoso ha tre avvocati in famiglia:
suo padre e le sue due sorelle.
Tra i giudici di pace, infine, la
dottoressa Napolitano è la moglie dell’avvocato Mario Migliano.
CHE COSA SIGNIFICA
Mentre le “conseguenze” delle reti personali nel
settore penale sono molto chiare e riguardano reati di una certa gravità, le
migliori matasse si chiudono nel settore civile, come accennavamo. Numerosi
avvocati, familiari di magistrati, sono nominati tutori dai giudici tutelari del
Tribunale di Cosenza, per esempio gli avvocati De Salvo e Politano, ma anche
curatori fallimentari oppure avvocati nelle cause dei tutori e della curatela
del fallimento in questione. Alcuni avvocati, per evitare incompatibilità, fanno
condurre le cause ad altri avvocati a loro vicini. Cosa succede quando uno degli
avvocati che cura gli interessi del familiare di un giudice ha una causa con un
altro avvocato imparentato con un altro giudice? Lasciamo ai lettori ogni tipo
di risposta. Un discorso a parte meritano le nomine dei periti del tribunale.
Parliamo di una schiera pressoché infinita di consulenti tecnici d’ufficio,
medici, ingegneri, commercialisti, geologi e chi più ne ha più ne metta. Pare
che alcuni, quelli maggiormente inseriti nella massoneria, facciano collezione
di nomine e di soldini. Questo è il quadro generale, diretto, tra l’altro da un
procuratore in perfetta linea con i suoi predecessori: coprire tutto il marcio e
continuare a far pascere i soliti noti. Questa è la giustizia “alla cosentina”.
E nessuno si lamenta. Almeno ufficialmente.
Sarebbe interessante, però,
sapere di quanti paradossi sono costellata i distretti giudiziari italiani.
Art. 19 dell’Ordinamento
Giudiziario. (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con
magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non
possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso
ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di
sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma,
per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non
possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati
in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in
un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei
due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede
centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di
convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle
corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici
giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di
incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti
organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile
e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla
base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili,
se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità
entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al
medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed
i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della
Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un
magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i
minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso
ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in
primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La
ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
Si sa che chi comanda detta legge e non vale la
forza della legge, ma la legge del più forte.
I magistrati son marziani. A chi può venire in
mente che al loro tavolo, a cena, lor signori, genitori e figli, disquisiscano
dei fatti di causa approntati nel distretto giudiziario comune, o addirittura a
decidere su requisitorie o giudizi appellati parentali?
A me non interessa solo l'aspetto
dell'incompatibilità. A me interessa la propensione del DNA, di alcune persone
rispetto ad altre, a giudicare o ad accusare, avendo scritto io anche:
Concorsopoli.
«Ciao Melitta, hai saputo? Mio marito è stato
nominato all'unanimità presidente della Corte d'Appello di Messina. Sono molto
contenta, dillo anche a Franco (Tomasello, rettore dell'Università) e ricordagli
del concorso di mio figlio. Ciao, ciao». Chi parla al telefono è la moglie del
presidente della Corte d'appello di Messina, Nicolò Fazio, chi risponde è
Melitta Grasso, moglie del rettore e dirigente dell'Università, il cui telefono
è intercettato dalla Guardia di Finanza perché coinvolta in una storia di
tangenti per appalti di milioni di euro per la vigilanza del Policlinico
messinese. Ma non è la sola intercettazione. Ce ne sono tante altre, anche di
magistrati messinesi, come quella del procuratore aggiunto Giuseppe Siciliano
che raccomanda il proprio figlio. Inutile dire che tutti e due i figli, quello
del presidente della Corte d'appello e quello del procuratore aggiunto, hanno
vinto i concorsi banditi dall'ateneo. Posti unici, blindati, senza altri
concorrenti. Francesco Siciliano è diventato così ricercatore in diritto
amministrativo insieme a Vittoria Berlingò (i posti erano due e due i
concorrenti), figlia del preside della facoltà di Giurisprudenza, mentre
Francesco Siciliano è diventato ricercatore di diritto privato. Senza nessun
problema perché non c'erano altri candidati, anche perché molti aspiranti, come
ha accertato l'indagine, vengono minacciati perché non si presentino. Le
intercettazioni sono adesso al vaglio della procura di Reggio Calabria che, per
competenza, ha avviato un'inchiesta sulle raccomandazioni dei due magistrati
messinesi, che si sarebbero dati da fare con il rettore Franco Tomasello per
fare vincere i concorsi ai propri figli. Altri guai dunque per l'ateneo che,
come ha raccontato «Repubblica» nei giorni scorsi, è stato investito da una
bufera giudiziaria che ha travolto proprio il rettore, Franco Tomasello, che è
stato rinviato a giudizio e sarà processato il 5 marzo prossimo insieme ad altri
23 tra docenti, ricercatori e funzionari a vario titolo imputati di concussione,
abuso d' ufficio in concorso, falso, tentata truffa, maltrattamenti e peculato.
In ballo, alcuni concorsi truccati e le pressioni fatte ad alcuni candidati a
non presentarsi alle prove di associato. E in una altra indagine parallela è
coinvolta anche la moglie del rettore, Melitta Grasso, dirigente universitaria,
accusata di aver favorito, in cambio di «mazzette», una società che si era
aggiudicata l'appalto, per quasi due milioni di euro, della vigilanza
Policlinico di Messina. Un appalto che adesso costa appena 300 mila euro.
L'inchiesta sull'ateneo messinese dunque è tutt'altro che conclusa ed ogni
giorno che passa si scoprono altri imbrogli. Agli atti dell'inchiesta, avviata
dopo la denuncia di un docente che non accettò di far svolgere concorsi
truccati, ci sono molte intercettazioni della moglie del rettore. Convinta di
non essere ascoltata, durante una perquisizione della Guardia di Finanza Melitta
Grasso dice ad un suo collaboratore («Alberto») di fare sparire dall'ufficio
documenti compromettenti. In una interrogazione del Pd al Senato, si chiede al
ministro della Pubblica istruzione Mariastella Gelmini «se intende costituirsi
parte civile a tutela dell'immagine degli atenei e inoltre se intenda sospendere
cautelativamente il rettore di Messina». (Repubblica — 20 novembre 2008 pagina
20, sezione: cronaca).
L'INCHIESTA DI M. SCHINELLA SULLA
PARENTOPOLI DI MESSINA: LE CATTEDRE DI FAMIGLIA. TUTTI I NOMI DI TUTTE LE
FACOLTA'! Scrive il 18 novembre 2008
"Stampalibera.it". Identico cognome. Identico luogo di nascita. Il 50% dei 1500
docenti dell’Ateneo di Messina, uno ogni 20 iscritti, ha almeno un omonimo. Ed è
accomunato ai colleghi dallo stesso luogo di nascita, la città di Messina. Il
dato statistico, rapportato alla esigua popolazione della città, è l’indizio che
la parentopoli nell’Università peloritana non teme confronti neanche con gli
altri Atenei siciliani. Un indizio che diventa prova non appena si va oltre le
omonimie. Altro che Palermo. Del “dovere morale di sistemare mio figlio”, come
dice Battesimo Macrì, ordinario e preside di Medicina Veterinaria impegnato a
fine 2006 a far vincere a tutti i costi un posto di associato al figlio
Francesco, che benchè già ricercatore è considerato dalla commissione “carente
di preparazione di base, in possesso di superficiale conoscenza della materia,
di scarsa capacità espositiva e sensibilità didattica”, all’Università di
Messina nel reclutamento dei docenti ma anche degli amministrativi, si è fatto
un larghissimo uso. L’Ateneo da luogo del sapere si è trasformato in azienda in
cui sistemare i familiari. E se molti hanno scalato i gradini accademici con
sacrifici e dopo anni di gavetta, i numeri sono impietosi: sono legati da
parentela 27 dei 75 docenti di Giurisprudenza. A Palermo sono 21 su 132. A
Medicina e Chirurgia i rapporti di parentela diretta uniscono 90 dei 531. A
Palermo, per rimanere al confronto, 58 su 440. A Medicina Veterinaria, dei 63
docenti 23 sono legati da un rapporto che non va oltre a quello che intercorre
tra nonno e nipote. Gruppi familiari si sono impadroniti di intere facoltà. E
quando i rampolli da piazzare sono stati troppi o i posti pochi sono stati
dirottati su altre. Chi a Messina ha fatto carriera universitaria ha avuto la
fortuna di nascere nella famiglia giusta: Navarra, Carini, Vermiglio, Saitta,
Galletti, Tommasini, Falzea, Dugo, Tigano, Teti, Resta, Guarnieri, Basile,
Trimarchi, Germanà. O ha avuto un padre ordinario: decine sono i cattedratici
che non sono riusciti ad insediare l’intera famiglia ma prima di abbandonare si
sono assicurati un erede. Un risultato frutto di valutazioni comparative che di
comparativo hanno avuto poco: tra la fine del 2006 e l’inizio 2007, l’Università
ha bandito74 concorsi per ricercatore. Nel 60% di questi la valutazione ha avuto
un solo candidato, il vincitore. Gli altri si sono ritirati anzitempo. «Che il
fenomeno fosse imponente lo sospettavo. Ma il problema più grosso è che i figli
di qualcuno hanno comunque, anche se i concorsi fossero regolari, molte più
opportunità dei figli di nessuno», dice Andrea Romano, preside di Scienze
politiche, una delle facoltà meno colpita. Adesso l’Università ha pronto un
codice etico: lo ha preparato Antonio Ruggeri, docente di Diritto costituzionale
e prorettore. Prevede che il figlio del cattedratico, se vuole seguire le orme
del padre nella stessa disciplina debba emigrare in altri atenei. Ironia della
sorte, la chiamata nello stesso dipartimento, alla cattedra di procedura penale,
del figlio trentenne di Ruggeri, Stefano, associato (l’idoneità l’aveva
conseguita all’Università privata Kore di Enna), la cui madre, Carmela Russo, è
ordinario nella stessa facolta di Istituzione di diritto romano, determinò nel
corso del Consiglio di facoltà del 21 dicembre 2007, una mezza sollevazione. Il
segno che in una delle Facoltà più prestigiose dell’Ateneo il livello di guardia
fosse stato superato, lo sintetizzò Sara Domianello, ordinario di diritto
Ecclesiastico: «Da questo momento mi rifiuterò di esprimere un giudizio su
conferimenti di incarichi a persone legate a colleghi da vincoli di parentela od
affinità fino al quarto grado», affermò nello stupore generale la docente.
Centonove, è andato a caccia dei vincoli di parentela.
GIURISPRUDENZA – La Domianello, allieva del
preside, Salvatore Berlingò, ha presieduto la commissione che ha attribuito
l’idoneità di associato a Marta Tigano, figlia di Aldo Tigano, ordinario di
diritto amministrativo. Che si ritrova come collaboratrice la figlia di
Berlingò, Vittoria, ricercatrice di diritto amministrativo. E nel corpo docente
vanta 2 nipoti, Francesco Martines, e Valeria Tigano, entrambi ricercatori.
Nello stesso dipartimento gomito a gomito lavorano Giuseppe Giuffrida, ordinario
di diritto agrario, e la figlia Marianna, ordinario anch’ella, della stessa
disciplina del padre. All’Istituto di diritto privato impera Raffaele Tommasini,
ordinario di Lavoro e Civile, un numero di incarichi compendiato in un elenco
che riempirebbe un’intera pagina, che si avvale nel proprio dipartimento della
figlia Alessandra. E del genero, Antonino Astone, associato. L’altra figlia
Maria, è associato, sempre della stessa disciplina, alla facoltà di Economia.
L’altro genero, Orazio Pellegrino, è ricercatore a Ingegneria. Nello stesso
settore, diritto privato, in cui opera anche Francesca Panuccio, associata
figlia di Vincenzo, una vita da ordinario, muove i primi passi da cattedratico,
Francesco Rende, figlio di Ciraolo Clorinda, associato nella stessa disciplina,
e di Mario Rende, assistente ad Economia. Vincenzo Michele Trimarchi, era stato
anche giudice della Corte costituzionale, il figlio Mario, è ordinario di
privato, (la moglie di questi, Renata Altavilla, è associato nello stesso
dipartimento), il nipote Francesco è ordinario a Medicina.
MEDICINA E CHIRURGIA – Trecentoventi dei 540
docenti della Facoltà, secondo il Ministero dell’Università, sono di troppo ma
l’Ateneo di Messina fa finta di nulla e continua a bandire concorsi (7
nell’ultima tornata) per ricercatori, associati e ordinari. Che vanno quasi
sempre ai soliti figli di cattedratico. Come quello del 2005 per ricercatore di
Chirurgia, andato a Giuseppinella Melita, figlia di Paolo, ordinario. O a Rocco
Caminiti, figlio di un ordinario in pensione. La dinastia dei Galletti regna
all’Otorinolaringoiatria: Cosimo Galletti è stato il capostipite, il figlio
Franco, ordinario, e Bruno, associato, i suoi eredi. L’ultimo figlio Claudio si
è spostato ad Anestesiologia, dove è ricercatore. Massimo, invece, è divenuto
associato di diritto privato a Giurisprudenza. Al defunto chirurgo Salvatore
Navarra, è succeduto in sala operatoria uno dei 3 figli, Giuseppe, diventato
ordinario giovanissimo. Pietro, è ordinario ad Economia (e prorettore). Michele
è associato a Scienze. La Dermatologia porta il nome di Guarnieri: Biagio è
ordinario, i figli Claudio e Fabrizio, ricercatori. Diana Teti, patologo, e
Giuseppe Teti, microbiologo, entrambi ordinari, hanno raccolto lʼeredità del
padre, Mario, ordinario di microbiologia in pensione. Diana si è sposata con
Matteo Venza, ordinario a Scienze. Un’unione che ha dato a Medicina altri due
ricercatori: Mario e Isabella Venza. L’oculista Giuseppe Ferreri, ordinario,
lavora fianco a fianco della figlia Felicia, ricercatrice. Cosi come Gaetano
Barresi, ordinario, con la figlia, Valeria, ricercatrice. Ci lavoravano fino
alla scorsa settimana Giuseppe Romeo, ordinario di Chirurgia pediatrica, e il
figlio Carmelo, ordinario delle stessa disciplina. Corrado Messina, ordinario di
Neurologia ha una figlia Maria Francesca, ricercatrice in altro settore.
Maurizio Monaco, ordinario, figlio dell’ex Prefetto di Messina, ha il figlio
Francesco ricercatore. Hanno avuto un padre o la madre, ordinario o associato
nella stessa o in disciplina affine, solo per fare degli esempi, Eugenio
Cucinotta, Antonio D’Aquino, Marcello Longo, Massimo Marullo, Filippo De Luca,
Antonino Germanò, Ignazio Barberi, Giorgio Ascenti, Michele Colonna, Impallomeni
Carlo, Giuseppe Santoro, Antonella Terranova.
MEDICINA VETERINARIA – Giovanni Germanà, ordinario
di Fisiologia, ha lasciato il segno. Nello stesso settore è associato il figlio
Antonino e la nipote Germana. Un’altra nipote, Maria Beatrice Levanti, è
ricercatrice, sempre nello stesso settore. Luigi Chiofalo era ordinario di
Zootecnia, Vincenzo, il figlio, attuale preside di Facoltà ne ha preso il posto,
Biagina, l’altra figlia è ricercatrice, così come il marito, Luigi Liotta: tutti
nello stesso settore. Ma a Veterinaria nello stesso settore, Sanità pubblica,
operano Antonio Pugliese, ordinario e la figlia Michela che si è aggiudicata un
posto di ricercatrice in un concorso in cui era unica candidata, per le
pressioni, secondo la Procura di Messina, del padre su concorrenti più titolati.
E Battesimo Macrì, e il figlio ricercatore, Francesco, la cui ascesa è stata
interrotta dalla magistratura. Sono figli di cattedratici ormai in pensione una
schiera di docenti: Anna Maria Passantino, associato, figlia di Michele; Bianca
Orlandella, ricercatrice, figlia di Vittorio; Antonio Panebianco, diventato
ordinario senza salire per gli scalini intermedi; Antonio Ajello e Adriana
Ferlazzo, (moglie di Alberto Calatroni, ordinario a Medicina) sorelle entrambe
ordinario, figlie di Aldo, ordinario, invece, di Pediatria. Pippo Cucinotta,
ordinario di Chirurgia, infacoltà non ha parenti, ma da Claudia Interlandi,
associato dello stessa disciplina ha avuto 2 figli.
SCIENZEMATEMATICHE E FISICHE – La fisica e la
matematica a Messina parla Carini. Giovanni, il capostipite, era ordinario di
Fisica Matematica. E ha sdoppiato i geni scientifici: il figlio Giuseppe, è
ordinario di Fisica; la figlia Luisa, associato di Matematica è moglie di
Giuseppe Magazzù, ordinario a Medicina. Il primo ha 2 figli, Manuela, già
ricercatrice di Matematica all’Università della Calabria. L’altro figlio
Giovanni è assegnista di ricerca. I fratelli Dugo, Giacomo e Giovanni, sono
entrambi ordinari. Giovanni, nello stesso Dipartimento a Farmacia ha una figlia,
Paola, associato, moglie di Luigi Mondello, ordinario nello stesso dipartimento
del suocero. Laura, figlia di Giovanni, ha già ottenuto un dottorato di ricerca
e si prepara a seguire le orme del padre. Come Giuseppe Gattuso, ricercatore di
chimica, figlio di Mario, ordinario della stessa disciplina, di Marisa Ziino,
ordinario a Scienze. E Armando Ciancio, figlio di Vincenzo, ordinario di
Matematica e delegato del rettore, che si è aggiudicato un recente concorso di
ricercatore dello stesso settore del padre, bandito, però, dalla Facoltà di
Medicina. Ed è in attesa di chiamata. Nella facoltà di Scienze operano come
associati, Enza Marilena Crupi, il padre era ordinario nella stessa facoltà.
Cosi come lo era il padre dell’ordinario Viviana Bruni, Augusto, docente per
decenni di Microbiologia. E il padre di Ulderico Wanderling, associato, figlio
di Franco, ordinario. Di cui è nipote Rita Giordano, associato sempre di Fisica.
La figlia di Rita De Pasquale, ordinario a Farmacia e prorettore, Chiara Costa,
figlia anche di Giovanni, ordinario di farmacologia, si è aggiudicata un posto
da ricercatrice a Medicina. Carlo Caccamo, ordinario, ha potenziato il corredo
genetico sposandosi con Maria Caltabiano, ordinario a Lettere: la figlia Daniela
è ricercatrice di biologia a Medicina.
ECONOMIA – Lavorano nella stessa Facoltà, ma in
dipartimenti diversi, Antonino Accordino, ordinario, e la figlia Patrizia,
ricercatrice. E’ figlia d’arte anche Maria Teresa Calapso, ordinario di
Matematica: il padre Pasquale Calapso, era ordinario di matematica seppure a
Scienze. Così come Paolo Cubiotti, ordinario di analisi matematica, cui ha
trasferito i geni scientifici il padre Gaetano, ex ordinario di Fisica. E
Filippo Grasso, associato, figlio dell’ordinario a Fisica, Vincenzo.
LETTERE – L’attuale preside, Vincenzo Fera, ha una
figlia Maria Teresa, che ha intrapreso la carriera medica ed è associato. L’ex
preside Gianvito Resta ha passato il testimone alla figlia Caterina, ordinario
nella facoltà del padre. L’altra figlia, Maria Letizia è associato a Medicina.
L’ordinario Angelo Sindoni, prorettore, ha una figlia, Maria Grazia, uscita di
recente vincitrice di un concorso per ricercatrice. Lavora, invece, a Scienze
politiche, nello stesso dipartimento del padre, Mario Centorrino, ordinario ed
ex prorettore, Marco, benchè il posto di ricercatore lo avesse bandito la
facoltà di Lettere.
TRAVERSALITA’ – Francesco Basile, ordinario, è
stato preside di Scienze. Non si può dire che i suoi figli nel mondo accademico
non abbiano fatto strada: Maurizio, ordinario a Medicina, Massimo, ordinario di
diritto a Scienze politiche, Fabio, ordinario a Ingegneria. La figlia di
quest’ultimo, Rosa, ha appena vinto un concorso di ricercatrice in diritto
costituzionale a Giurisprudenza. Dopo il ritiro degli altri candidati è rimasta
da sola. A presiedere la commissione Antonio Saitta, ordinario, ex sindaco di
Messina, appartenente ad una delle famiglie che all’Ateneo ha dato molto. E’
figlio di Emilio, che fu ordinario a Medicina. E nipote di Nazzareno, ordinario
a Giurisprudenza, il cui figlio Fabio è docente a Catanzaro, e di Gaetano,
ordinario a Ingegneria. Sono solo cugini tra di loro ma i Vermiglio si sono
fatto valere: uno, Mario Vermiglio, è vincitore di un concorso di ordinario a
Medicina, sempre a Medicina c’è Giuseppe, associato di Fisica, la moglie Maria
Giulia Tripepi, è associato dello stesso settore. Franco è invece ordinario ad
Economia. L’eredità di Diego Cuzzocrea, ordinario di Chirurgia, ed ex rettore
dell’Università, l’hanno raccolta, Salvatore, associato a Medicina e Francesca,
ricercatrice a Scienze della Formazione. Del precedente rettore Guglielmo Stagno
D’alcontres, ordinario di Chimica, sono nipoti Francesco, deputato nazionale,
ordinario di Chirurgia plastica a Messina e Alberto, ordinario di diritto
commerciale a Palermo. MICHELE SCHINELLA – CENTONOVE 07-11-08
Se il rettore non può firmare. I casi in cui il
Magnifico deve ricorrere al vicario. Da Gaetano Silvestri a Franco Tomasello. Il
concorso ad un posto di ricercatore in diritto amministrativo si è celebrato nel
giugno del 2008. Francesco Martines, figlio di Maria Chiara Aversa, ordinario
alla facoltà di Scienze, delegato del rettore per la ricerca, nipote di Aldo
Tigano, ordinario di diritto amministrativo, e genero del rettore Franco
Tomasello, di cui ha sposato la figlia, si è aggiudicato il posto. Ed è rimasto
in attesa della chiamata della facoltà di Scienze politiche. A firmare il
decreto di approvazione degli atti del concorso non è stato il suocero, come
succede in tutti gli altri casi: per prassi consolidata, infatti, lo fa il
rettore vicario. Non è la prima volta che il rettore vicario debba intervenire
per firmare gli atti di un concorso vinto da un parente stretto di Tomasello. Lo
fece già per il figlio Dario, vincitore nel 2005, del concorso di associato alla
Facoltà di Lettere. E non è il primo rettore vicario dell’Università di Messina.
Toccò anche al predecessore. Durante il rettorato di Gaetano Silvestri, la
moglie di quest’ultimo, Marcella Fortino, divenne docente ordinario. Insegna a
Scienze politiche. (M.S.)
Concorsi truccati: «Io raccomandata pentita, mi
sono riscattata...», scrive Nino Luca il 18 novembre 2008 su "Il Corriere della
Sera". «Non ci dormivo la notte. I finanziamenti "ad hoc " sono la prassi
accettata da tutti». Raccomandazioni all'università: il mondo del web reagisce.
Raccomandazioni all'università: il mondo del web reagisce. «Un posto, un solo
candidato: il figlio del professore». Sommersi dalle email. Dare spazio alle
denunce oppure spiegare il meccanismo cioè come si fa a truccare un concorso
nelle università italiane? Citare a caso qualcuna tra le centinaia di
segnalazioni che ci sono arrivate da Milano, Roma, Avellino, Bari o scegliere
solo alcuni casi emblematici? La storia che abbiamo raccontato venerdì, del
concorso da ricercatore a Messina, «Un posto, un solo candidato: il figlio del
professore», ha scatenato il web. Dalle centinaia e centinaia di e-mail ricevute
è chiaro che si tratta di un fenomeno che colpisce tutti gli atenei italiani, da
nord a sud. Molte di queste email contengono delle vere e proprie notizie di
reato e innumerevoli casi di disonestà che scatta in maniera meccanica laddove
la legge lascia margini di discrezionalità all'individuo. E quindi «taroccare»
diventa quasi una prassi. Molti, impauriti da possibili ritorsioni, ci chiedono
di non pubblicare i loro nomi ma fanno nomi, precisando anche i fatti e
circostanziandoli. E sono tantissimi anche gli italiani, fuggiti all'estero, che
ci hanno scritto. Quindi, dopo le opportune verifiche, organizzeremo meglio
questo «urlo di denuncia» e magari lo faremo attraverso una pubblicazione. Ma
adesso non troviamo di meglio che pubblicare un'autodenuncia che è anche un
augurio. Perché, come in tanti ci hanno scritto, la «parola "cultura" dovrebbe
necessariamente essere associata ad un vivere corretto e civile».
LA LETTERA - Ecco il testo di Lucia (nome di
fantasia): «Io ottenni una borsa di studio dottorale messa in palio
dall'università di ... che fu finanziata dall'ente pubblico presso il quale
lavoravo, ergo: era la mia borsa di dottorato. Volevo fare il dottorato da
quando mi ero iscritta all'università; non sono né figlia né nipote di, ma ero
l'assistente di... In attesa nel concorso trovai un posto come consulente presso
un ente pubblico, nel quale mi occupavo della stessa materia della mia tesi, e
il mio Professore «arrangiò» il finanziamento. Mi presentai al concorso. Mi
sedetti coi 7 partecipanti; si fecero gli scritti a porte aperte e gli orali a
porte chiuse. Vinsi, ovviamente, la borsa. Sono pronta a difendere quanto le sto
per dire sotto giuramento: mi creda quando le dico che non ci dormivo la notte,
mentre questa prassi (di raccomandazione o finanziamenti ad hoc) era del tutto
accettata, e non criticata, dai dottorandi che ne usufruivano».
I DUBBI - «Io invece - prosegue Lucia - mi
chiedevo in continuazione: sono un dottorando perché sono veramente dotata in
questo campo o perché sono l'assistente di con la borsa finanziata da? Le
sembrerà banale e invece è un punto chiave: quel che i dottorandi si sentono
dire è infatti che, in virtù della mancanza di risorse, «vanno create le
occasioni» per poterli mandare avanti. Mi domandavo: mi mandano avanti perché
sono brava, o sono brava perché mi mandano avanti? Inutile dirle infatti che io
ricerca, negli 8 mesi che resistetti, non ne feci mai. Feci solo, e tanta,
assistenza. Senza mai sentire NESSUNO lamentarsene oltre misura. Torturata -
letteralmente - da una profonda insicurezza circa le mie reali capacità e la mia
volontà di sostenere un compromesso che mi sembrava, di fatto, una truffa
venduta come «l'aver creato l'occasione», mi iscrissi di nascosto ad un secondo
concorso al Politecnico di Milano. Mi alzai alle 4 del mattino per presentarmi
al concorso senza sapere nulla né della commissione né dei partecipanti, e vinsi
la seconda borsa in palio; inutile dire che si fecero scritti e orali a porte
aperte. Ricordo il messaggio che spedii a mia sorella con le lacrime agli occhi:
"Una vittoria mia, ma una vittoria di tutta l'università italiana".
IL RISCATTO - Di lì a poche settimane mi chiamò
per una intervista di lavoro un politecnico olandese per un posto di assistente
alla ricerca, sulla base del mio mero curriculum vitae, e mi fu offerto il
posto. Me ne andai, e non mi sono mai voltata indietro. Mi «licenziai»
dall'Università di... con una lettera congiunta a tutto il dipartimento in cui
spiegavo le mie ragioni ed il mio grande senso di autostima ritrovato. Nessuno
dei dottorandi, mi rispose; dal mio professore e dal preside fui presa,
verbalmente, ma letteralmente, a calci, e fui accusata di aver tradito la loro
fiducia e di aver osato non presentare prima le mie rimostranze di fronte a quel
che io definii «il sistema». Ma questa è un'altra storia, che riguarda me e la
mia coscienza, e di cui sono alla fine, tutto sommato, orgogliosa.
IL CAMBIAMENTO - Sono passati tanti anni e quel
che vorrei dirle in sostanza è questo: il cambiamento vero partirà dalla volontà
e dal senso di dignità dei singoli di non accettare il compromesso cui le
università italiane chiamano la nostra coscienza. Essere un buon ricercatore
significa avere gli standard per lavorare non in quell'ateneo o quel
dipartimento, ma nel mondo. La conoscenza appartiene al mondo; e quindi, a cosa
serve avere il posticino messo in palio da papà, senza poi il rispetto della
comunità scientifica internazionale, che è l'unico vero giudice dell'operato di
un ricercatore? Mi rendo conto che è molto banale quanto le scrivo. Ma è tutto
quel di cui mi sento di far da tramite e testimone, nel mio immensamente
piccolo. Cordialmente, Lucia».
Eppure è risaputo come si svolgono i concorsi in
magistratura.
Roma, bigliettini negli slip al concorso
magistrati. Bufera sulle perquisizioni intime. Nel
mirino della polizia oltre 40 persone sospettate di aver occultato le tracce:
cinque candidate espulse, scrive Roberto Damiani il 2 febbraio 2018 su
“Quotidiano.net. Il concorso in magistratura iniziato il 20 gennaio a Roma per
320 posti (sono state presentate 13.968 domande) rischia di diventare una
questione da intimissimi. Nel senso di slip. Perché attraverso le mutandine sono
state espulse diverse candidate. Stando a ciò che trapela, i commissari d’esame
hanno mandato a casa cinque candidate e c’era incertezza su una sesta. Tutte
hanno avuto una perquisizione totale, cioè la polizia penitenziaria femminile ha
fatto spogliare completamente le candidate perché sospettate di nascondere
qualcosa. E su circa 40 controlli corporali totali, cinque o forse sei ragazze
avevano foglietti con dei temi (non gli stessi poi usciti per la prova) negli
slip. E per queste candidate, non c’è stata giustificazione che potesse tenere:
sono state espulse immediatamente. La polemica delle perquisizioni fino a
doversi abbassare le mutande è divampata per un post della candidata Cristiana
Sani che denunciava l’offesa di doversi denudare: «Ero in fila per il bagno
delle donne – ha scritto su Facebook la candidata – arrivano due poliziotte, le
quali si avvicinano alla nostra fila e iniziano a perquisire una ad una le
ragazze in fila. Me compresa. Io lì per lì non ho capito quello che stesse
succedendo, non me lo aspettavo, visto che durante le due giornate precedenti
non avevo avuto esperienze simili». «Capisco – continua Cristiana – che c’è un
problema nel momento in cui una ragazza esce dal bagno piangendo. Tocca a me e
loro mi dicono di mettermi nell’angolo (non del bagno, ma del corridoio, con
loro due davanti che mi fanno da paravento) per la perquisizione. Non mi mettono
le mani addosso, sono sincera. Mi fanno tirare su maglia e canotta, davanti e
dietro. Mi fanno slacciare il reggiseno. Poi giù i pantaloni. Ma la cosa
scioccante è stata quando mi hanno chiesto di tirare giù le mutande. Io mi stavo
vergognando come la peggiore delle criminali e le ho tirate giù di mezzo
millimetro. A quel punto mi hanno detto: ‘Dottoressa, avanti! Si cali le
mutande. Ancora più giù, faccia quasi per togliersele e si giri. Cos’è? Ha il
ciclo, che non se le vuole tirare giù?!’. Mi sono rifiutata, rivestita e tornata
al mio posto ma ero allibita. Questa si chiama violenza». Nel forum del
concorso, i candidati si scambiano opinioni, tutte abbastanza negative
sull’esperienza in atto e contestano le perquisizioni ritenendole illegali. Ma
nessuno sembra aver letto il regio decreto del 15/10/1925, n. 1860, all’art. 7
che regola i concorsi pubblici e tuttora in vigore: «... i concorrenti devono
essere collocati ciascuno a un tavolo separato (...) È vietato ai concorrenti di
portare seco appunti manoscritti o libri. Essi possono essere sottoposti a
perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante
gli esami». Sembra che le perquisizioni siano scattate solo nei confronti di chi
frequentava troppo il bagno. Eppure quegli aspiranti magistrati espulsi
avrebbero dovuto conoscere la regola d’oro: l’«assassino» torna sempre due volte
sul luogo del delitto.
Ma non è lercio solo quel che appare. E’ da scuola
l’esempio della correzione dei compiti in magistratura, così come dimostrato,
primo tra tutti gli altri, dall’avv. Pierpaolo Berardi, candidato bocciato.
Elaborati non visionati, ma dichiarati corretti. L’avvocato astigiano Pierpaolo
Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per
magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali
dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media
(comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e
quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel
1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una
vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che
vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario,
tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si
occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti
i compiti identici e tutti abilitati. Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010
il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati
idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60
candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei
e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con
abuso del pubblico ufficio. Risultato: un buco nell'acqua. Questi magistrati,
nel frattempo diventati dei, esercitano. Esperienza diretta dell'avvocato
Giovanni Di Nardo che ha scoperto temi pieni di errori di ortografia giudicati
idonei alle prove scritte del concorso in magistratura indetto nel 2013 le cui
prove si sono tenute nel Giugno del 2014. Se trovate che sia vergognoso
condividete il più possibile, non c'è altro da fare. Concorsi Pubblici ed
abilitazioni Truccati. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.
Ma come ci si può difendere da decisioni
scellerate?
Le storture del sistema
dovrebbero essere sanate dallo stesso sistema. Ma quando “Il Berlusconi” di
turno si sente perseguitato dal maniaco giudiziario, non vi sono rimedi. Non è
prevista la ricusazione del Pubblico Ministero che palesa il suo pregiudizio. Vi
si permette la ricusazione del giudice per inimicizia solo se questi ha
denunciato l’imputato e non viceversa. E’ consentita la ricusazione dei giudici
solo per giudizi espliciti preventivi, come se non vi potessero essere
intendimenti impliciti di colleganza con il PM. La rimessione per legittimo
sospetto, poi, è un istituto mai applicato. Ci si tenta con la ricusazione,
(escluso per il pm e solo se il giudice ti ha denunciato e non viceversa), o con
la rimessione per legittimo sospetto che il giudice sia inadeguato, ma in questo
caso la norma è stata sempre disapplicata dalle toghe della Cassazione.
A Taranto per due magistrati su tre, dunque, Sebai
non è credibile. Il tunisino è stato etichettato dalla pubblica accusa come un
«mitomane» che vuole scagionare detenuti che ha conosciuto in carcere. Solo
l’omicidio Lapiscopia, per il quale è stata chiesta la condanna, era ancora
insoluto, quindi senza alcun condannato a scontare la pena. Il gup Valeria
Ingenito nel corso dell’udienza ha respinto la richiesta di sospensione del
processo e l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del Codice di
procedura penale nella parte in cui prevede la facoltà e non obbligo di
astensione del pubblico ministero. L'eccezione era stata sollevata dal legale di
Sebai, Luciano Faraon. Secondo il difensore, i pm Montanaro e Petrocelli, che
hanno chiesto l’assoluzione del tunisino per tre dei quattro omicidi confessati
dall’imputato, "avrebbero dovuto astenersi per gravi ragioni di convenienza per
evidenti situazioni di incompatibilità, esistente un grave conflitto
d’interesse, visto che hanno sostenuto l’accusa di persone, ottenendone poi la
condanna, che alla luce delle confessioni di Sebai risultano invece essere
innocenti e quindi forieri di responsabilità per errore giudiziario". Non solo
i pm erano incompatibili, ma incompatibile era anche il foro del giudizio, in
quanto da quei procedimenti addivenivano responsabilità delle parti giudiziarie,
che per competenza erano di fatto delegate al foro di Potenza. Nessuno ha
presentato la ricusazione per tutti i magistrati, sia requirenti, sia
giudicanti.
Comunque il presidente del Tribunale di Taranto
Antonio Morelli, come è normale per quel Foro, ha respinto l'astensione dei
giudici Cesarina Trunfio e Fulvia Misserini, rispettivamente presidente e
giudice a latere della Corte d'Assise chiamata a giudicare gli imputati al
processo per l'omicidio di Sarah Scazzi. I due magistrati si erano astenuti,
rimettendo la decisione nelle mani del presidente del Tribunale dopo la
diffusione di un video in cui erano “intercettate” mentre si interrogavano sulle
strategie difensive che di lì a poco gli avvocati avrebbero adottato al
processo. Secondo il presidente del Tribunale però dai dialoghi captati non si
evince alcun pregiudizio da parte dei magistrati, non c'è espressione di
opinione che incrini la capacità e serenità del giudizio e quindi non sussistono
le condizioni che obbligano i due giudici togati ad astenersi dal trattare il
processo. Il presidente del Tribunale di Taranto ha respinto l’astensione dei
giudici dopo che era stata sollecitata dalle difese per un video fuori onda con
frasi imbarazzanti dei giudici sulle strategie difensive delle imputate. E
adesso si va avanti con il processo. Tocca all’arringa di Franco Coppi. Posti in
piedi in aula. Tutti gli avvocati del circondario si sono dati appuntamento per
sentire il principe del Foro. Coppi inizia spiegando il perché della loro
richiesta di astensione: «L’avvocato De Jaco ed io abbiamo sollecitato
l’astensione in relazione alle frasi note.
29 agosto 2011. La rimessione
del processo per incompatibilità ambientale. «Le lettere scritte da Michele
Misseri le abbiamo prodotte perchè‚ sono inquietanti non tanto per il fatto che
lui continua ad accusarsi di essere lui l'assassino, ma proprio perchè mettono
in luce questo clima avvelenato, in cui i protagonisti di questa inchiesta
possono essere condizionati». Lo ha sottolineato alla stampa ed alle TV l’avv.
Franco Coppi, legale di Sabrina Misseri riferendosi alle otto lettere scritte
dal contadino di Avetrana e indirizzate in carcere alla moglie Cosima Serrano e
alla figlia Sabrina, con le quali si scusa sostenendo di averle accusate
ingiustamente. «Michele Misseri – aggiunge l’avv. Coppi – afferma che ci sono
persone che lo incitano a sostenere la tesi della colpevolezza della figlia e
della moglie quando lui afferma di essere l’unico colpevole e avanza accuse
anche molto inquietanti. Si tratta di lettere scritte fino a 7-8 giorni fa».
«Che garanzie abbiamo – ha fatto presente il difensore di Sabrina Misseri – che
quando dovrà fare le sue dichiarazioni avrà tenuta nervosa e morale sufficiente
per affrontare un dibattimento?». «La sera c'è qualcuno che si diverte a sputare
addosso ad alcuni colleghi impegnati in questo processo. I familiari di questi
avvocati non possono girare liberamente perchè c'è gente che li va ad accusare
di avere dei genitori o dei mariti che hanno assunto la difesa di mostri, quali
sarebbero ad esempio Sabrina e Cosima. Questo è il clima in cui siamo costretti
a lavorare ed è il motivo per cui abbiamo chiesto un intervento della Corte di
Cassazione». «E' bene – ha aggiunto l'avvocato Coppi – allontanarci
materialmente da questi luoghi. Abbiamo avuto la fortuna di avere un giudice
scrupoloso che ha valutato gli atti e ha emesso una ordinanza a nostro avviso
impeccabile. La sede alternativa dovrebbe essere Potenza. Non è che il processo
si vince o si perde oggi, ma questo è un passaggio che la difesa riteneva
opportuno fare e saremmo stati dei cattivi difensori se per un motivo o per
l'altro e per un malinteso senso di paura non avessimo adottato questa
iniziativa». A volte però non c'è molto spazio per l'interpretazione. Il
sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta è chiarissimo: «Una serie di
indicatori consentono di individuare un'emotività ambientale tale da contribuire
all'alterazione delle attività di acquisizione della prova». Mazzotta parla
davanti alla prima sezione penale della Cassazione dove si sta discutendo la
richiesta di rimessione del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi: i difensori
di Sabrina Misseri, Franco Coppi e Nicola Marseglia, chiedono di spostare tutto
a Potenza perché il clima che si respira sull'asse Avetrana-Taranto «pregiudica
la libera determinazione delle persone che partecipano al processo». Ed a
sorpresa il sostituto pg che rappresenta la pubblica accusa sostiene le ragioni
della difesa e chiede lui stesso che il caso venga trasferito a Potenza per
legittima suspicione. A Taranto, in sostanza, non c'è la tranquillità necessaria
per giudicare le indagate.
12 ottobre 2011. Il rigetto
dell’istanza di rimessione. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti
respinto la richiesta di rimessione del processo per incompatibilità ambientale,
con conseguente trasferimento di sede a Potenza, avanzata il 29 agosto 2011 dai
difensori di Sabrina Misseri, gli avvocati Franco Coppi e Nicola Marseglia.
Eppure la stessa Corte ha reso
illegittime tutte le ordinanze cautelari in carcere emesse dal Tribunale di
Taranto.
Per quanto riguarda la Rimessione, la Cassazione
penale, sez. I, 10 marzo 1997, n. 1952 (in Cass. pen., 1998, p. 2421), caso
Pomicino: "l'istituto della rimessione del processo, come disciplinato dall'art.
45 c.p.p., può trovare applicazione soltanto quando si sia effettivamente
determinata in un certo luogo una situazione obiettiva di tale rilevanza da
coinvolgere l'ordine processuale - inteso come complesso di persone e mezzi
apprestato dallo Stato per l'esercizio della giurisdizione -, sicché tale
situazione, non potendo essere eliminata con il ricorso agli altri strumenti
previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del processo -
quali l'astensione o la ricusazione del giudice -, richiede necessariamente il
trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria … Consegue che non hanno
rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli
magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non
coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso".
Per quanto riguarda la
Ricusazione: «Evidenziato che non può costituire motivo di ricusazione per
incompatibilità la previa presentazione, da parte del ricusante, di una denuncia
penale o la instaurazione di una causa civile nei confronti del giudice, in
quanto entrambe le iniziative sono “fatto” riferibile solo alla parte e non al
magistrato e non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la
scelta di chi lo deve giudicare. (Cass. pen. Sez. V 10/01/2007, n. 8429).
In questo modo la pronuncia
della Corte di Cassazione discrimina l’iniziativa della parte, degradandola
rispetto alla presa di posizione del magistrato: la denuncia del cittadino non
vale per la ricusazione, nonostante possa conseguire calunnia; la denuncia del
magistrato vale astensione. Per la Cassazione per avere la ricusazione del
singolo magistrato non astenuto si ha bisogno della denuncia del medesimo
magistrato e non della parte. Analogicamente, la Cassazione afferma in modo
implicito che per ottenere la rimessione dei processi per legittimo sospetto è
indispensabile che ci sia una denuncia presentata da tutti i magistrati del Foro
contro una sola parte. In questo caso, però, non si parlerebbe più di
rimessione, ma di ricusazione generale. Seguendo questa logica nessuna istanza
di rimessione sarà mai accolta.
Qui non si vuole
criminalizzare una intera categoria. Basta, però, indicare a qualcuno che si
ostina a difendere l’indifendibile che qualcosa bisogna fare. Anzi, prima di
tutto, bisogna dire, specialmente sulla Rimessione dei processi.
Questa norma a vantaggio del
cittadino è da sempre assolutamente disapplicata e non solo per Silvio
Berlusconi. Prendiamo per esempio la norma sulla rimessione del processo
prevista dall’art. 45 del codice di procedura penale. L'articolo 45 c.p.p.
prevede che "in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi
situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano
al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di
legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del
procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso
il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice,
designato a norma dell'articolo 11".
Tale istituto si pone a
garanzia del corretto svolgimento del processo, dell'imparzialità del giudice e
della libera attività difensiva delle parti. Si differenzia dalla ricusazione
disciplinata dall'art. 37 c.p.p. in quanto derogando al principio costituzionale
del giudice naturale (quello del locus commissi delicti) e quindi assumendo il
connotato dell'eccezionalità, necessita per poter essere eccepito o rilevato di
gravi situazioni esterne al processo nelle sole ipotesi in cui queste non siano
altrimenti eliminabili. Inoltre mentre per la domanda di ricusazione è
competente il giudice superiore, per decidere sull'ammissibilità della
rimessione lo è solo la Corte di Cassazione.
«L’ipotesi della rimessione,
il trasferimento, cioè, del processo ad altra sede giudiziaria, deroga, infatti,
alle regole ordinarie di competenza e allo stesso principio del giudice naturale
(art. 25 della Costituzione) - spiega Edmondo Bruti Liberati, già Presidente
dell’Associazione nazionale magistrati. - E pertanto già la Corte di Cassazione
ha costantemente affermato che si tratta di un istituto che trova applicazione
in casi del tutto eccezionali e che le norme sulla rimessione devono essere
interpretate restrittivamente. La lettura delle riviste giuridiche, dei saggi in
materia e dei codici commentati ci presenta una serie lunghissima di casi, in
cui si fa riferimento alle più disparate situazioni di fatto per concludere che
la ipotesi di rimessione è stata esclusa dalla Corte di cassazione. Pochissimi
sono dunque fino al 1989 stati i casi di accoglimento: l’ordine di grandezza è
di una dozzina in tutto. Il dato che si può fornire con precisione – ed è
estremamente significativo – riguarda il periodo dopo il 1989, con il nuovo
Codice di procedura penale: le istanze di rimessione accolte sono state due.»
I magistrati criticano
chiunque tranne se stessi,
scrive Pietro Senaldi su Libero Quotidiano il 28 gennaio 2018. I procuratori
generali hanno inaugurato l'anno giudiziario con discorsi pieni di banalità e
senza fare nessun mea culpa. "Abbiamo una giustizia che neppure in Burkina
Faso". "La Banca Mondiale mette l'Italia alla casella numero 108 nella
classifica sull'efficienza dei tribunali in rapporto ai bisogni dell'economia".
"Se per far fallire un'azienda che non paga ci vogliono sette anni, è naturale
che gli stranieri siano restii a investire nel nostro Paese". "Ultimamente
abbiamo ridotto i tempi ma non si può dire che tre anni di media per arrivare a
una sentenza in un processo civile sia un periodo congruo". "È imbarazzante che
restino impuniti per il loro male operato e non subiscano rallentamenti di
carriera magistrati che hanno messo sotto processo innocenti, costringendoli a
rinunciare a incarichi importanti e danneggiando le aziende pubbliche che questi
dirigevano, con grave nocumento per l'economia nazionale". "Non se ne può più di
assistere allo spettacolo di pubblici ministeri che aprono inchieste a carico di
politici sul nulla, rovinandone la carriera, e poi magari si candidano
sfruttando la notorietà che l'indagine ha procurato loro". "La giustizia viene
ancora strumentalizzata a fini politici". "In Italia esistono due pesi e due
misure a seconda di chi è indagato o processato". "L'economia italiana è frenata
da un numero spropositato di ricorsi accolti senza ragione". "Le vittime delle
truffe bancarie non hanno avuto giustizia e i responsabili dei crack non sono
stati adeguatamente perseguiti". "A questo giro elettorale qualcosa non torna,
se Berlusconi non è candidabile in virtù di una legge entrata in vigore dopo il
reato per cui è stato condannato".
Una pioggia di denunce
contro i magistrati Ma sono sempre assolti.
Più di mille esposti l'anno dai cittadini. E le toghe si auto-graziano:
archiviati 9 casi su 10, scrive Lodovica Bulian, Lunedì 29/01/2018, su "Il
Giornale". Tra i motivi ci sono la lunghezza dei processi, i ritardi nel
deposito dei provvedimenti, ma anche «errori» nelle sentenze. In generale, però,
è il rapporto di fiducia tra i cittadini e chi è chiamato a decidere delle loro
vite a essersi «deteriorato». Uno strappo che è all'origine, secondo il
procuratore generale della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, «dell'aumento
degli esposti» contro i magistrati soprattutto da parte dei privati. Il fenomeno
è la spia di «una reattività che rischia di minare alla base la legittimazione
della giurisdizione», spiega il Pg nella sua relazione sul 2017 che apre il
nuovo anno giudiziario con un grido d'allarme: «Una giustizia che non ha
credibilità non è in grado di assicurare la democrazia». Nell'ultimo anno sono
pervenute alla Procura generale, che è titolare dell'azione disciplinare, 1.340
esposti contenenti possibili irregolarità nell'attività delle toghe, tra pm e
giudicanti. Numeri in linea con l'anno precedente (1.363) e con l'ultimo
quinquennio (la media è di 1.335 all'anno). A fronte della mole di segnalazioni,
però, per la categoria che si autogoverna, che si auto esamina, che auto punisce
e che, molto più spesso, si auto assolve, scatta quasi sempre l'archiviazione
per il magistrato accusato: nel 2017 è successo per l'89,7% dei procedimenti
definiti dalla Procura generale, era il 92% nel 2016. Di fatto solo il 7,3% si è
concluso con la promozione di azioni disciplinari poi portate avanti dal
Consiglio superiore della magistratura. Solo in due casi su mille e duecento
archiviati, il ministero della Giustizia ha richiesto di esaminare gli atti per
ulteriori verifiche. Insomma, nessun colpevole. Anzi, la colpa semmai, secondo
Fuzio, è della politica, delle campagne denigratorie, dell'eccessivo carico di
lavoro cui sono esposti i magistrati: «Questo incremento notevole di esposti di
privati cittadini evidenzia una sfiducia che in parte, può essere la conseguenza
dei difficili rapporti tra politica e giustizia, in parte, può essere l'effetto
delle soventi delegittimazioni provenienti da parti o imputati eccellenti. Ma -
ammette - può essere anche il sintomo che a fronte di una quantità abnorme di
processi non sempre vi è una risposta qualitativamente adeguata». Il risultato è
che nel 2017 sono state esercitate in totale 149 azioni disciplinari (erano 156
nel 2016), di cui 58 per iniziativa del ministro della Giustizia (in diminuzione
del 22,7%) e 91 del Procuratore generale (in aumento quindi del 13,8%). Tra i
procedimenti disciplinari definiti, il 65% si è concluso con la richiesta di
giudizio che, una volta finita sul tavolo del Csm, si è trasformata in
assoluzione nel 28% dei casi e nel 68% è sfociata nella censura, una delle
sanzioni più lievi. Questo non significa, mette in guardia il procuratore, che
tutte le condotte che non vengono punite allora siano opportune o consone per un
magistrato, dall'utilizzo allegro di Facebook alla violazione del riserbo. E
forse il Csm, sottolinea Fuzio, dovrebbe essere messo a conoscenza anche dei
procedimenti archiviati, e tenerne conto quando si occupa delle «valutazioni di
professionalità» dei togati. Che, guarda caso, nel 2017 sono state positive nel
99,5% dei casi.
Messina, pornografia minorile: un giudice
finisce in carcere. Gaetano Maria Amato, 57 anni, era
in servizio alla corte d'Appello di Reggio Calabria. Il gip ha emesso
un'ordinanza di custodia cautelare. Nel 2009 aveva subito una sanzione dal Csm
per i ritardi nella pubblicazione delle sentenze, scrive il 2 ottobre 2017 "La
Repubblica". Un giudice in servizio alla corte d'Appello di Reggio Calabria,
Gaetano Maria Amato, è stato arrestato dalla polizia a Messina per pornografia
minorile. Nei suoi confronti il gip della città dello Stretto, su richiesta del
procuratore capo Maurizio de Lucia e dell'aggiunto Giovannella Scaminaci, ha
emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli investigatori non
forniscono particolari, a tutela delle vittime. Gaetano Maria Amato, 57 anni,
nato a Messina, ha iniziato la sua carriera giudiziaria come pretore a Naso. Si
era poi spostato a Messina, prima al tribunale civile e poi a quello
fallimentare. Infine, nel 2009, il trasferimento alla corte d'Appello di Reggio
Calabria. È padre di tre figli. Il giudice Amato nel 2009, quando era in
servizio a Messina, subì un procedimento del Consiglio superiore della
magistratura per presunti ritardi nel deposito degli atti. Nella contestazione
si rilevava come ci fossero troppe sentenze del magistrato depositate oltre i
termini. Per questi ritardi il Csm lo aveva dichiarato colpevole e sanzionato
con l'ammonizione. Il reato di pedopornografia configura vari tipi di
comportamento, dalla sola detenzione di materiale pornografico alla cessione e
diffusione, fino alla produzione di immagini con lo sfruttamento di minori. Il
reato prevede, in caso di condanna, la reclusione fino a 12 anni. Pornografia
minorile, tre foto a un unico “amico” della rete. Ecco nel dettaglio l’accusa al
giudice Gaetano Maria Amato: qualche settimana prima degli arresti aveva ammesso
le chat e l’invio di immagini. Sequestrati personal computer e cellulare, gli
inquirenti a caccia di nuove prove e di (eventuali) altri “appassionati” di
bambini.
Tre foto di due persone minorenni
seminude (due) e nude (una), tutte carpite all’insaputa delle vittime e inviate
tra il 2014 e il 2015 a un solo utente della rete con dei commenti a corredo,
scrive il 5 ottobre 2017 Michele Schinella. Sono questi i fatti per cui il
giudice della Corte d’appello di Reggio Calabria Gaetano Maria Amato, su
richiesta della Procura di Messina accolta dal Giudice per le indagini
preliminari Maria Vermiglio, è stato arrestato e condotto nel carcere di Gazzi
il 3 ottobre scorso. L’accusa per il cinquantottenne è di Pornografia minorile,
reato per cui è prevista una pena da 6 a 12 anni di reclusione. Tuttavia, le
indagini sul magistrato sono tutt’altro che chiuse. Da quanto si è riuscito a
sapere da ambienti vicini agli inquirenti, pochi giorni prima che scattassero
gli arresti, a casa del giudice residente a Messina si sono presentati gli
agenti della polizia con in mano un provvedimento di perquisizione e di
sequestro di supporti telematici e informatici. Nell’occasione della
perquisizione, lo stesso giudice ha fatto dichiarazioni spontanee, minimizzando
i fatti e ammettendo che in passato aveva intrattenuto delle chat con un
pedofilo a cui aveva inviato tre o 4 foto: in sostanza, ciò che gli inquirenti
sapevano già e che gli è stato contestato al momento dell’esecuzione della
misura cautelare. Gli inquirenti al termine della perquisizione hanno
sequestrato e portato via personal computer e telefoni cellulari. La perizia sui
supporti informatici permetterà di stabilire se il magistrato ha raccontato la
verità e, quindi lo scambio di materiale pedo pornografico è stato occasionale e
limitato a quello già accertato, oppure le foto prodotte e inviate sono molto di
più e l’interlocutore del giudice non è stato uno solo ma diversi. In
quest’ultimo caso, altri interlocutori con la “passione” per le immagine pedo
pornografiche potrebbero finire nel mirino della Procura.
Nella rete…della perizia informatica. E’ con lo
strumento della consulenza tecnica su strumentazione informatica che – secondo
quanto si è riuscito a sapere dagli inquirenti della squadra mobile della
polizia di Stato di Bolzano – ci è si imbattuti nel giudice di Messina. Le
indagini infatti erano concentrate su un pedofilo che, a tempo pieno, usando
diversi account e nick name, navigava sulla rete alla ricerca di materiale pedo
pornografico. E’ stata l’accertamento tecnico sul materiale sequestrato a
quest’ultimo che ha consentito di individuare tra la miriade di chat e scambio
di materiale scottante, le comunicazioni e, soprattutto, le foto che il giudice
gli ha inviato. Le carte sono state così trasmesse per competenza territoriale
alla Procura di Messina.
La partita giuridica. La normativa che il
legislatore ha dettato dal 1998 in poi contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minore,
prevede diverse fattispecie di reato, di gravità diversa e quindi punite con
pena diversa, i cui confini sono stati oggetto di interpretazioni non sempre
univoche da parte della giurisprudenza. Al magistrato Amato, in attesa degli
esiti degli ulteriori accertamenti tecnici sul pc e sul cellulare, è contestata
la fattispecie più grave (art. 600 ter, primo comma): quella che incrimina chi
“utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici
ovvero produce materiale pornografico”.
Per quanto le foto inviate dal giudice sono state
realizzate all’insaputa delle vittime (e, ovviamente, senza la loro minima
collaborazione), e sono state inviate a un solo utente, i fatti accertati
sembrano rispondere appieno alla interpretazione che la Cassazione (a Sezioni
unite) ha offerto della norma. La cassazione nel 2000 (numero 13) ha, infatti,
stabilito che la norma “offre una tutela penale anticipata volta a reprimere
quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo
personale del minore, mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito
perverso della pedofilia. Per conseguenza il reato è integrato quando la
condotta dell’agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una
consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale
pornografico prodotto”. Non sarà semplice, ma ciò dipenderà anche dal tipo e
dalla natura delle chat, per il giudice Amato difendersi sostenendo che l’aver
trasmesso le foto a uno sconosciuto (che quindi non dava alcuna garanzia di
riservatezza) non abbia determinato il concreto pericolo di diffusione delle
stesse e quindi il rischio di pregiudicare il libero sviluppo personale dei
minori raffigurati.
Primi provvedimenti. In applicazione della legge,
che sul punto non ammette deroghe e riguarda tutti i pubblici funzionari senza
che via la necessità di alcuna richiesta specifica di alcuno, il magistrato in
conseguenza degli arresti e sin dal giorno successivo è stato sospeso dalle
funzioni e dallo stipendio. Allo stesso modo, è stato avviato nei suoi confronti
procedimento disciplinare: si tratta, allo stato delle cose, di un grave
illecito disciplinare, rientrante nella categoria degli “Illeciti conseguenti a
reato” (e dunque diverso da quello compiuto nell’esercizio delle funzioni o
fuori dalle stesse, ma sempre facendo pesare il ruolo di magistrato). Questo
tipo di illeciti possono portare alla sanzione (anche della rimozione dalla
magistratura) solo dopo la condanna irrevocabile.
I viaggi, il teatro e i chihuahua: chi è
il giudice arrestato per pedopornografia. Gaetano
Maria Amato aveva iniziato la sua carriera in magistratura nel 1986.
Adesso rischia da sei a dodici anni di carcere per pornografia minorile, scrive
il 03/10/2017 "Tribupress.it". Viaggi, teatro, mostre d’arte. Abbondanti foto di
due chihuahua di nome Dino e Minou. Sono gli elementi principali del profilo
Facebook di Gaetano Maria Amato, il giudice della Corte d’Appello di Reggio
Calabria arrestato nelle scorse ore per pornografia minorile. Un’accusa
pesantissima, quella avanzata nei suoi confronti dal Procuratore di Messina
Maurizio De Lucia e dall’Aggiunto Giovannella Scaminaci, che ha fatto in breve
tempo il giro d’Italia. L’ipotesi di reato è quella prevista dall’articolo 600
ter del Codice Penale, che punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con
la multa fino a 240.000 euro chiunque produca materiale pornografico o
realizzi esibizioni o spettacoli pornografici con protagonisti minorenni. Sulla
vicenda gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo a tutela delle
vittime. Le indagini sarebbero state svolte dalla Polizia Postale di Catania e
riguarderebbero fatti avvenuti a Messina. Nato a Messina cinquantasette anni fa,
Amato aveva iniziato la sua carriera in magistratura nel 1986, con l’incarico di
Pretore a Naso, piccolo centro dei Nebrodi. Poi il trasferimento nel capoluogo e
gli scatti di carriera, dalla sezione Civile a quella Fallimentare alla Penale.
Qui aveva partecipato ai Collegi di Corte di Assise e alla Sezione Misure di
prevenzione. Una carriera regolare, quella del magistrato messinese, che adesso
oltre al procedimento penale rischia di essere sospeso e messo fuori organico
dal Consiglio Superiore della Magistratura. Non sarebbe la prima volta che la
toga passa al vaglio del Csm. Già nel 2009, a seguito di un’ispezione avvenuta
durante il suo servizio a Messina nell’inverno del 2005, Amato subì un
procedimento per ritardi nel deposito degli atti. Troppe sentenze depositate
oltre i termini, secondo l’organo di autogoverno della magistratura,
che sanzionò il giudice con un’ammonizione. Nel 2016 aveva difeso con altri
giudici l’operato di una collega accusata della stessa inadempienza. Fin qui il
profilo professionale. Ma l’accusa per la quale Amato è finito in manette
attiene alla sfera privata. A dire qualcosa in più del magistrato finito nella
bufera resta soltanto il profilo social. Popolato appunto da una grande quantità
di foto di viaggi, di pièce teatrali, di cani per i quali mostra grande
tenerezza. Foto di Lipari, Istanbul, delle Bahamas raggiunte a coronamento di un
lungo viaggio negli States, iniziato a New York con la visita alla collezione
Guggenheim. Poi foto in famiglia, qualche considerazione estemporanea sulla
società e le sue brutture. E sempre i cagnolini fotografati in tutte le salse,
anche sulle carte che il giudice si portava a casa dal lavoro. “Io ho tre vite,
la mia, quella che si inventano gli altri e quelli che gli altri pensano che sia
la mia vita”, fa dire a Snoopy in una foto condivisa nel gennaio 2015. Quale di
queste sia oggetto delle valutazioni degli inquirenti che hanno portato
all’arresto sarà compito della giustizia chiarirlo.
«Ciao Melitta, hai
saputo? Mio marito è stato nominato all'unanimità presidente della Corte d'
appello di Messina. Sono molto contenta, dillo anche a Franco (Tomasello,
rettore dell'Università) e ricordagli del concorso di mio figlio. Ciao, ciao».
Chi parla al telefono è la moglie del presidente della Corte d'appello di
Messina, Nicolò Fazio, chi risponde è Melitta Grasso, moglie del rettore e
dirigente dell' Università, il cui telefono è intercettato dalla Guardia di
Finanza perché coinvolta in una storia di tangenti per appalti di milioni di
euro per la vigilanza del Policlinico messinese. Ma non è la sola
intercettazione. Ce ne sono tante altre, anche di magistrati messinesi, come
quella del procuratore aggiunto Giuseppe Siciliano che raccomanda il proprio
figlio. Inutile dire che tutti e due i figli, quello del presidente della Corte
d'appello e quello del procuratore aggiunto, hanno vinto i concorsi banditi
dall' ateneo. Posti unici, blindati, senza altri concorrenti. Francesco
Siciliano è diventato così ricercatore in diritto amministrativo insieme a
Vittoria Berlingò (i posti erano due e due i concorrenti), figlia del preside
della facoltà di Giurisprudenza, mentre Francesco Siciliano è diventato
ricercatore di diritto privato. Senza nessun problema perché non c' erano altri
candidati, anche perché molti aspiranti, come ha accertato l'indagine, vengono
minacciati perché non si presentino. Le intercettazioni sono adesso al vaglio
della procura di Reggio Calabria che, per competenza, ha avviato un'inchiesta
sulle raccomandazioni dei due magistrati messinesi, che si sarebbero dati da
fare con il rettore Franco Tomasello per fare vincere i concorsi ai propri
figli. Altri guai dunque per l'ateneo che, come ha raccontato «Repubblica» nei
giorni scorsi, è stato investito da una bufera giudiziaria che ha travolto
proprio il rettore, Franco Tomasello, che è stato rinviato a giudizio e sarà
processato il 5 marzo prossimo insieme ad altri 23 tra docenti, ricercatori e
funzionari a vario titolo imputati di concussione, abuso d' ufficio in concorso,
falso, tentata truffa, maltrattamenti e peculato. In ballo, alcuni concorsi
truccati e le pressioni fatte ad alcuni candidati a non presentarsi alle prove
di associato. E in una altra indagine parallela è coinvolta anche la moglie del
rettore, Melitta Grasso, dirigente universitaria, accusata di aver favorito, in
cambio di «mazzette», una società che si era aggiudicata l'appalto, per quasi
due milioni di euro, della vigilanza Policlinico di Messina. Un appalto che
adesso costa appena 300 mila euro. L'inchiesta sull'ateneo messinese dunque è
tutt'altro che conclusa ed ogni giorno che passa si scoprono altri imbrogli.
Agli atti dell' inchiesta, avviata dopo la denuncia di un docente che non
accettò di far svolgere concorsi truccati, ci sono molte intercettazioni della
moglie del rettore. Convinta di non essere ascoltata, durante una perquisizione
della Guardia di Finanza Melitta Grasso dice ad un suo collaboratore («Alberto»)
di fare sparire dall'ufficio documenti compromettenti. In una interrogazione del
Pd al Senato, si chiede al ministro della Pubblica istruzione Mariastella
Gelmini «se intende costituirsi parte civile a tutela dell' immagine degli
atenei e inoltre se intenda sospendere cautelativamente il rettore di Messina».
(Repubblica — 20 novembre 2008 pagina 20 sezione: cronaca).
COME SI DICE…“CANE NON
MANGIA CANE!”
Risarcire Morlacchi o Di Matteo,
scrive Piero Sansonetti il 14 ago 2016 su "Il Dubbio". L'editoriale del
Direttore sulle sproporzioni. Piero Ostellino, recentemente, è stato condannato
a risarcire con 150 mila euro due delle tre magistrate che nel giugno del 2013
condannarono Berlusconi per il caso Ruby. Ostellino criticò aspramente quella
sentenza. I giudici dell'appello e della Cassazione, successivamente, diedero
retta ad Ostellino e torto alle due magistrate: bocciarono la sentenza e
assolsero Berlusconi. Le due magistrate però si sono sentite offese da Ostellino
e gli hanno fatto causa. Hanno vinto. Criticare un magistrato - sembra - è
proibito. Manolo Morlacchi - cittadino come un altro - è stato accusato qualche
anno fa di aver rifondato le Brigate Rosse. Cinque mesi in cella. Rischio
ergastolo. L'accusa era falsa: assolto in primo e secondo grado. Assolto in
Cassazione. Lo hanno risarcito con 15 mila euro. C'è proporzione tra i 15 mila
euro per cinque mesi di galera ingiusta, e 150 mila euro per una critica (giusta
o ingiusta che fosse)? Le due magistrate hanno fatto causa anche a me (forse per
questo sono particolarmente sensibile). A me addirittura hanno fatto due cause:
una per un'intervista e una per una dichiarazione in Tv: in tutto altri 150 mila
euro. Intanto mi ha fatto causa anche un altro magistrato. Il famoso Pm di
Palermo Di Matteo. Altri centomila euro, vuole, perché ho scritto che lui è
stato maleducato nell'interrogatorio di De Mita nel famoso processo Stato-Mafia.
Ho così appreso che dire a un magistrato che è stato maleducato è dieci volte
più grave che prendere un povero cristo e sequestrarlo in cella per cinque mesi.
Tra i 150 mila euro alle due milanesi e i 100 mila a Di Matteo, mi tocca
impegnare l'intero mio reddito futuro, se va bene, per sette o otto anni. Ho
pensato che l'alternativa è quella di farmi arrestare ingiustamente e poi farmi
risarcire per ingiusta detenzione. Però, per arrivare a 250 mila euro (Morlacchi
docet) mi ci vorranno sempre sette o otto anni.
Le carriere con l'air bag di certi pm:
sbagliano e vengono pure promossi. Il privilegio
speciale delle toghe: da Esposito e Robledo a Woodcock, quando la punizione
diventa un premio, scrive Enrico Lagattolla, Martedì 24/02/2015 su "Il
Giornale". Ammettiamolo: è il sogno di tutti. Una carriera con l'air bag, una
vita con la rete di protezione, pochi rischi e tanto onore, l'invidiabile
privilegio di cadere sempre in piedi e la lunare dispensa dai contraccolpi di
uno sciagurato sfondone. Anzi, a volte pure l'insensato beneficio di un
avanzamento per demeriti. È il sogno di tutti e per qualcuno è realtà. Prendete
il giudice di Torino che - pochi giorni fa - è stato trasferito a Milano perché
strapagava le consulenze all'amante. Non a Canicattì. A Milano, l'ufficio più
prestigioso del Paese. Promoveatur ut amoveatur. A essere trombati in questo
modo, c'è da metterci la firma. Vincenzo Toscano - il magistrato del capoluogo
piemontese - ha affidato «incarichi remunerati» a una consulente a «cui era
legato da vincoli sentimentali». La Cassazione, che lunedì ne ha confermato il
cambio di sede, spiega che dava lavoro alla compagna, liquidava «compensi molto
superiori alla media degli altri consulenti», e si lavorava il collegio
giudicante «per ottenere una decisione favorevole» alla donna. Cosa sarebbe
accaduto in qualunque azienda privata? Ma la giustizia segue altre regole.
Quindi, l'insopportabile sanzione è stata la perdita di un anno di anzianità - e
capirai - e il trasferimento nel palazzaccio più in vista d'Italia. Diciamola
tutta: promosso. Ma per uno che da Torino viene a Milano, due fanno il tragitto
opposto. L'estenuante disputa tra il procuratore Edmondo Bruti Liberati e il suo
ex vice Alfredo Robledo si è conclusa con il trasloco di quest'ultimo in
Piemonte. Che onta. Oddio, diciamo un alone. I fatti: secondo il Csm, Robledo è
culo e camicia con l'avvocato della Lega Domenico Aiello. Gli «soffia» notizie
riservate su un fascicolo che coinvolge alcuni politici del Carroccio. Vero o
falso che sia, il punto è un altro: l'organo di autogoverno dei magistrati gli
attribuisce un «provato rapporto di contiguità con l'avvocato Aiello»,
«improntato allo scambio di favori», così come è «inequivoca» la «propalazione»
al legale dei lumbard «di atti coperti dal segreto». Sembra grave. Perciò via,
Robledo lasci Milano e dismetta i panni da pm. E cosa va a fare? Il giudice. Un
gradino più in alto nella scala evolutiva dell'homo togatus. Ma a Torino è
andato anche un giovane pubblico ministero milanese, anche lui silurato con
tutte le cautele. È una storia di leggerezze e bella vita, quella di Ferdinando
Esposito, di amicizie bislacche e di un'improvvida visita ad Arcore che gli ha
attirato gli strali di Ilda Boccassini. Che l'ha indagato, l'ha fatto pedinare e
intercettare, e poi ha mandato gli atti a Brescia, dove un fascicolo è stato
aperto senza che finora abbia portato ad alcunché. Anche su Esposito si è
pronunciata la disciplinare del Csm: non può più fare il pm a Milano, sarà gip a
Torino. A parte l'incomodo della breve trasferta, la carriera del magistrato
prosegue spedita. Sono solo tre storie, le più recenti. Ma sono storie che si
ripetono. Henry John Woodcock - quello dei disastri Vip Gate e Savoia Gate - da
Potenza finisce a Napoli (qualche dubbio su quale sia la sede più rilevante?).
Per le disfatte giudiziarie Why not e Toghe lucane, Luigi De Magistris se la
cava con censura, trasferimento e cambio di casacca: da pm a giudice. Ma per non
sbagliare, Giggino Masaniello sceglie la terza via: la politica. Ai magistrati
di sorveglianza che concedono la semilibertà ad Angelo Izzo, e grazie alla quale
il «mostro del Circeo» torna a uccidere, il Csm riserva un ammonimento. L'ex
magistrato antimafia di Napoli che va a caccia con i boss viene assolto dal
Consiglio. E il sottobosco degli sconosciuti è pieno di miracolati. Vero che
ultimamente le condanne nei procedimenti disciplinari sono aumentate, ma si
tratta perlopiù di sanzioni minime. Di gente cacciata dalla magistratura, negli
ultimi vent'anni, se ne conta sulle dita di una mano. Quanto alla responsabilità
civile, peggio che andar di notte: in un quarto di secolo i ricorsi accolti sono
stati quattro su 400. È un tratto tristemente sbagliato in questa nobile
categoria, semidei del diritto con la tendenza all'autoassoluzione. Avete mai
visto la deferenza con cui un avvocato bussa all'ufficio di un pm? Credete
davvero che in un'aula di giustizia accusa e difesa godano sempre di pari
dignità? Ci dev'essere qualcosa che, strada facendo, scolla alcuni magistrati
dal mondo reale. Non si spiega altrimenti, sennò, la meravigliosa ingenuità con
cui il fu presidente del tribunale di sorveglianza di Milano Francesco
Castellano si rivolse al Csm. Accusato di aver brigato per parare il didietro
all'indagato Giovanni Consorte, Castellano propose alla disciplinare del
Consiglio la sua soluzione. Facciamo così: io lascio Milano, voi mandatemi in
Cassazione. Non si sa se a qualcuno scappò da ridere, ma almeno in quel caso
sembrò troppo persino ai suoi pari.
Libri: "Quattro anni a Palazzo dei
Marescialli", se la lottizzazione diventa magistratura. Recensione
di Antonio Bevere su Il Manifesto, 15 luglio 2015. Aniello Nappi racconta in un
libro i suoi quattro anni all'interno di Palazzo dei Marescialli. E si misura
con i 200 "fuori ruolo", ma anche con alcune pratiche di valutazione da parte
del Csm. "Soprattutto a Roma c'è contiguità fra amministrazione della giustizia
e politica". Per fronteggiare la crescente espropriazione di potere giuridico ed
economico, attuata da organizzazioni mafiose e da ceti finanziari e
imprenditoriali, gli attuali vertici dello Stato sono ricorsi al rimedio
costituito da un'anomala collocazione di pubblici ministeri in torri di
controllo (Autorità Nazionale Anticorruzione, assessorato comunale delle
legalità e simili) nel territorio dell'illegalità dominante. Questi avamposti
delle guardie togate nelle terre dei ladri creano perplessità sotto due aspetti:
da un lato, aggravano il fenomeno di magistrati distolti dal lavoro giudiziario
ed inseriti nella gestione di incarichi dell'amministrazione centrale e
periferica, con palese violazione del principio della separazione dei poteri
prevista dalla Costituzione; dall'altro, i singoli magistrati si espongono al
rischio di essere coinvolti, quanto meno per scarsa capacità di vigilanza e di
prevenzione, nelle inevitabili indagini dei colleghi togati, con paradossali
risvolti negativi nell'accertamento delle responsabilità penali e contabili. È
di tutta evidenza che la presenza delle avanguardie giudiziarie non potrà non
costituire un argomento difensivo di ottimo spessore per dimostrare la buona
fede del politico e dell'imprenditore che hanno trasgredito le regole, ma sotto
il vigile occhio del fuori ruolo giudiziario in missione per conto dello Stato.
Né va sottovalutato che il fenomeno delle carriere parallele di alcuni
magistrati, che si sviluppa frequentemente con la decisione del Consiglio
superiore della magistratura di concedere collocamenti "fuori ruolo" con la
destinazione a funzioni non giudiziarie presso pubbliche amministrazioni, è
stato fortemente criticato dal consigliere di Cassazione Aniello Nappi, reduce
dall'esperienza di componente dell'organo di autogoverno. Questa anomalia
riguarda circa duecento posti, ma coinvolge una popolazione di postulanti ben
più numerosa. "E questo crea le basi per un rapporto inquinante della
magistratura, soprattutto a Roma, dove c'è la contiguità tra amministrazione
della giustizia e politica. Qui la questione dei fuori ruolo si pone come
questione morale fondamentale" (Quattro anni a Palazzo dei Marescialli, Aracne,
2014, p. 45). La lettura di questo libro - ricco di un'impressionate casistica
di deroghe alla legge e alle regole interne - fa sorgere il quesito se la
magistratura-impegnata in maniera generalmente encomiabile nella tutela della
legalità tra i comuni cittadini e tra i cittadini eccellenti - sia capace di
autogovernarsi correttamente attraverso l'organo assembleare previsto dall'art.
104 della Costituzione. È noto che il Csm è un'istituzione democratica nel senso
che i suoi componenti vengono eletti da tutti i magistrati e dal Parlamento in
seduta comune e nel senso che nei dibattiti in commissione e nel plenum è
garantita la piena libertà di espressione, con conseguente immunità, al pari dei
parlamentari. I singoli consiglieri non hanno vincolo di mandato nei confronti
degli elettori e dei gruppi che ne hanno proposto la candidatura. Nel quotidiano
svolgimento della valutazione della capacità professionale dei singoli, della
assegnazione dei ruoli dirigenziali, il consigliere Nappi ha dovuto fare i conti
con la consolidata regola pragmatica, secondo cui le determinazioni e le scelte
espresse con il voto devono essere soggette al principio di maggioranza, nel
senso devono essere assunte non secondo coscienza, ma secondo l'indicazione
della maggioranza del gruppo di appartenenza. È stato facile rilevare che il
voto per vincolo di maggioranza, alias per disciplina di gruppo, risponde alla
logica, alla teorizzazione, alla pratica del voto di scambio: io voto uno dei
tuoi se tu voti uno dei miei, come la riconosciuta esigenza di risarcire il
contraente nei confronti del quale si è rimasti inadempienti...È vero che
all'interno dei gruppi il principio di maggioranza viene applicato con qualche
elasticità. Ma è proprio questa elasticità a farne lo strumento fondamentale dei
baratti, che sono di per sé occasionali. È appunto l'accettazione del principio
di maggioranza a rendere possibili occasionali accordi, ora con l'uno ora con
l'altro gruppo, tanto più vantaggiosi quanto maggiori sono i pacchetti di voti
disponibili. In questo contesto è nato un goffo e spiacevole episodio che ha
avuto inopinata diffusione, nella totale indifferenza delle istituzioni: da una
corrispondenza riservata di un componente dell'organo di autogoverno
inavvertitamente è volata in rete, il 23.11.2012, una missiva in cui il mittente
- pur riconoscendo "più opportuno politicamente piazzare una giovane collega
napoletana di Area ad un posto direttivo, sia pure di rilievo minore", auspicava
che non si facesse "tuttavia una ingiustizia troppo grossa". Nappi osserva che,
pur essendo l'opportunità politica collegata a più criteri (età, territorio,
appartenenza ad una corrente), è documentabile che "il criterio
dell'appartenenza è accettato e riconosciuto all'interno dei gruppi consiliari".
Che non si sia trattato di un caso eccezionale è dimostrato dal silenzio e
dall'indifferenza della corporazione: mercoledì 8 maggio 2014 il medesimo
consigliere, in qualità di Presidente della Quarta Commissione del Csm
(competente per materia nelle progressioni in carriera), ha partecipato, nella
sessione della Scuola superiore della magistratura dedicata all'ordinamento
giudiziario, a un confronto a due voci sul tema Standard di rendimento e carichi
esigibili). Talvolta gli scambi falliscono per una sopravvenuta modifica tattica
delle alleanze e più raramente per l'imprevista dissociazione dal gruppo di
appartenenza, con reazioni sanzionatorie, come è accaduto proprio a Nappi, la
cui espulsione "venne giustificata anche con la dissociazione nel voto per un
incarico semi direttivo". La lottizzazione guidata dai vertici delle tre
correnti - osserva l'autore - è giustificata con l'esigenza di garantire il
pluralismo culturale negli uffici e nell'organo di autogoverno, ostentando di
ignorare una realtà ben visibile in magistratura e in tutte le istituzioni: "La
pratica della lottizzazione, spacciata per pluralismo, ha impoverito il nostro
Paese, privandolo di una classe dirigente adeguata". In conclusione, poiché è
impossibile presumere che la bussola del criterio di appartenenza, impiegato per
selezionare e premiare con pratiche spartitorie e preordinate, conduca
infallibilmente a beneficiare i migliori, è indubbio il danno degli
"indipendenti n.n." e il pregiudizio dei cittadini cui è sottratta la
possibilità di avvalersi adeguatamente della capacità professionale di questi
ultimi.
Quattro anni a Palazzo dei Marescialli.
Pubblichiamo, a cura dell’Unione delle Camere Penali, fra gli editoriali, il
testo integrale dell’intervento del Presidente dott. Aniello Nappi al convegno
tenutosi a Camerino il 19 novembre 2015 a margine della presentazione
dell’omonimo libro, nel quale l’autore racconta la sua esperienza al CSM. Il
volume contiene una lucida e spietata disamina sul declino dell’organo di
autogoverno della magistratura, le cui cause vengono individuate proprio nella
sindacalizzazione delle correnti dell'Anm, che ha determinato inesorabilmente la
trasformazione del Consiglio stesso “in una sorta di condominio sindacale”. La
gestione correntizia delle carriere dei magistrati, recentemente evidenziata
dalla Commissione Scotti istituita dal governo, coincide con l’allarme, come si
legge nel libro, sulla degenerazione del Csm che, afferma l’autore, “rischia di
mettere in discussione l’essenza stessa dell’attività giurisdizionale, che è
nella sua indipendenza e nella sua terzietà”. La sindacalizzazione della
componente togata del consiglio, sostiene sempre l’autore, comporta moltissime
conseguenze negative, perché “i sindacalisti tutelano il lavoratore, non il
giudice; e non sempre le due posizioni si sovrappongono”.
Camerino, 19 novembre 2015. Intervento del Dott.
Aniello Nappi. "Quando si tenne alla Luiss di Roma la presentazione del mio
libro sul CSM (Quattro anni a Palazzo dei marescialli – Idee eretiche sul
Consiglio superiore della magistratura), il Vicepresidente Legnini esordì in
funzione difensiva del Consiglio, domandando: “Ma chi ha mai parlato bene del
Consiglio?”; e qualcuno gli fece eco, rilevando che in effetti il CSM non ha mai
goduto di buona stampa. Sicché ci si domanda dov’è l’eresia, se del CSM si è
sempre parlato male. Sennonché non mi sarei di certo scomodato, non avrei
dedicato un’estate a mettere giù queste memorie, solo per parlar male del
Consiglio. Ho invece inteso proporre una ben precisa diagnosi di un problema,
che definisco come crisi di credibilità, come declino del Consiglio,
individuandone la causa nella sindacalizzazione delle correnti dell'Anm, con la
trasformazione del Consiglio in una sorta di condominio sindacale. Considero
questa una degenerazione, non perché ce l’abbia con i sindacati, ma per una
ragione molto semplice e banale. Il Consiglio Superiore della Magistratura è un
particolare ufficio del personale: gestisce la carriera, la mobilità, la
valutazione di professionalità dei magistrati. Occorrerebbe domandarsi allora
perché per questa attività di gestione del personale, che in altri uffici
pubblici o nelle aziende private è svolta dall’amministrazione, da un consiglio
di amministrazione, si scomoda il Presidente della Repubblica e si mette su un
organo di rilevanza costituzionale. E la risposta è evidente: perché è chiaro
che nel momento in cui si decide del destino professionale di un magistrato, del
suo trasferimento piuttosto che della sua valutazione di professionalità, c’è il
rischio di condizionarne l’attività giurisdizionale. Si rischia dunque di
mettere in discussione l’essenza stessa dell’attività giurisdizionale, che è
nella sua indipendenza e nella sua terzietà. È questo che giustifica l’esistenza
del Consiglio Superiore della Magistratura. Tuttavia se le componenti togate del
CSM, che sono elette sulla base delle indicazioni dell’Associazione nazionale
magistrati, sono formate di sindacalisti, viene fuori un palese conflitto di
interesse. Tutti comprendono che il sindacalista non può essere l’amministratore
del personale, perché avrebbe due parti in commedia: quella della tutela del
lavoratore e quella della gestione del lavoratore. Questo determina una
situazione insostenibile. Ed è qui la mia denuncia, fondata su una diagnosi
precisa. Non parlo genericamente di degenerazione, perché la degenerazione delle
istituzioni pubbliche, non solo nel nostro Paese, è un fenomeno al quale
purtroppo ci siamo abituati. E parlare genericamente di degenerazione non
avrebbe giustificato che si scrivesse un libro sul CSM. Il problema del
Consiglio è dunque nella sindacalizzazione della sua componente togata. E questo
comporta moltissime conseguenze negative, perché la missione del Consiglio
sarebbe quella di tutelare il giudice come istituzione. I sindacalisti tutelano
invece il lavoratore, non il giudice; e non sempre le due posizioni si
sovrappongono. Molto spesso la tutela del lavoratore contraddice gli interessi e
la funzionalità dell’istituzione. Si determina inoltre una burocratizzazione dei
magistrati. La sindacalizzazione nella gestione del personale ne comporta la
burocratizzazione, perché si privilegia il rispetto delle garanzie destinate a
tutelare il lavoratore anziché le garanzie dell'istituzione giudiziaria. Il
giudice, ciascun giudice, è un’istituzione, di cui va garantita l’indipendenza e
l’autonomia, oltre a essere un lavoratore, cui vanno riconosciute tutele
economiche e “contrattuali”. Al Consiglio superiore della magistratura non è
demandata però la tutela economica e contrattuale del magistrato lavoratore,
bensì la ricerca di un equilibrio tra garanzie individuali dei magistrati ed
efficienza dell’istituzione giudiziaria. Le garanzie individuali dei magistrati,
che attengono all’ambito del loro ruolo istituzionale, vengono invece sempre più
interpretate all’interno del CSM in termini di garanzie sindacali del lavoratore
magistrato. Tutto questo accade per di più in un momento in cui il ruolo del
giudice va sempre più enfatizzandosi. Una volta il giudice doveva essere solo il
mediatore tra il caso concreto e la norma di diritto, espressa di regola in una
legge. La situazione è oggi radicalmente mutata. Viviamo oggi una
moltiplicazione degli ordinamenti, dalla Convenzione europea diritti dell’uomo
al diritto dell’Unione Europea; e una moltiplicazione delle corti, dalla Corte
europea di giustizia alla Corte europea dei diritti dell’uomo alla Corte
costituzionale. Si pensi solo alla recente sentenza europea sul caso Contrada,
quale esempio di riconoscimento della funzione normativa della giurisprudenza, a
proposito della punibilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Sicché
oggi il diritto lo fanno sempre di più i giudici. Cresce perciò l’esigenza di un
approccio sempre meno burocratico alla funzione giudiziaria, nel momento stesso
in cui si burocratizza invece sempre di più la posizione del giudice. È come lo
spostamento della crosta terrestre, la deriva dei continenti nella teoria della
tettonica delle placche. Le nostre istituzioni giudiziarie sono sollecitate da
due spinte opposte: da una parte la burocratizzazione, provocata dalla gestione
sindacalizzata del Consiglio, dall’altra la spinta di tutto il sistema, anche
sovranazionale, verso un’assunzione sempre maggiore di responsabilità del
giudice come produttore di norme. Temo che ne possa venir fuori un sommovimento
istituzionale, che metterà a rischio le tradizionali garanzie del nostro sistema
giudiziario. Quando in questo Paese la politica avrà finalmente conquistato il
suo primato, non accetterà più che il piccolo sindacato di una corporazione
burocratizzata rivendichi un ruolo di autonomo interlocutore istituzionale senza
assumersene anche le responsabilità. Così sarà a rischio non solo il destino di
qualche magistrato, ma sarà a rischio la tenuta dello stesso sistema
democratico. Per far fronte a questo rischio, occorre che la magistratura
associata recuperi al più presto l'orizzonte culturale di un tempo. E’ opportuno
a questo punto domandarsi in che senso il Consiglio tutela il magistrato come
lavoratore piuttosto che come giudice, come istituzione. Gli esempi sono tanti.
Prendiamo il caso dell’incompatibilità parentale tra magistrati e avvocati. La
legge prevede tre criteri per definirla: la natura delle materie (penale, civile
o lavoro), la dimensione dell’ufficio e l’importanza, l’intensità del lavoro
dell’avvocato. Questi sono i tre criteri che detta la legge, per stabilire
quando un magistrato non può svolgere le sue funzioni nella stessa sede in cui
opera un suo congiunto esercente la professione forense. Questa legge viene
interpretata nel senso che basta che risulti favorevole uno soltanto di questi
criteri per escludere l’incompatibilità. Insomma, se il magistrato è coniuge
dell’avvocato più importante del piccolo tribunale, purché l’uno si occupi di
diritto civile e l’altro di diritto penale, si esclude l’incompatibilità. Se
fosse invece richiesto l’esito favorevole di tutti e tre i criteri, non solo la
differenza delle materie, ma anche le dimensioni dell’ufficio e l’intensità
dell’attività lavorativa, dovrebbe in un caso del genere riconoscersi
l’incompatibilità. Contrariamente a quanto sarebbe stato ragionevole attendersi,
invece, è stata respinta la proposta di considerare necessariamente concorrenti
i tre criteri. E’ questa una tipica applicazione sindacale di una norma, perché
tende a tutelare l’interesse del lavoratore anziché dell'istituzione. Tende a
tutelare gli interessi di chi fa il magistrato nel luogo dove è nato, dove
abita. Ed è comprensibile che, se arriva un congiunto a fare l’avvocato, è duro
dover cambiare sede. Sennonché la logica sindacale è incompatibile con la logica
istituzionale. Non perché i sindacati siano cattivi. Ma perché i sindacati
debbono essere l’interlocutore dell’istituzione, non possono sostituire
l’istituzione. Le delibere del Consiglio sono pubbliche. E secondo la legge
sulla privacy, quando si tratta di un pubblico funzionario, di chiunque eserciti
funzioni pubbliche, tutto deve essere controllabile e deve essere conoscibile,
tutto ciò che attiene alla carriera e all’attività di chi svolge funzioni
pubbliche. Benché tanto preveda la legge, non è stato possibile ottenerlo. Si è
detto che soltanto la delibera è pubblica, ma i documenti sui quali la delibera
si fonda non sono pubblici. Mentre è evidente che, se non si può accedere ai
documenti, non si può controllare criticamente la delibera. In realtà il
Consiglio si dà regole molto rigide per le sue decisioni, detta criteri di
decisione molto rigorosi, che agevolano le risposte negative. Una decisione che
può determinare scontento risulta così giustificabile come inevitabile. Quando
però la domanda alla quale bisogna dare risposta viene da chi è vicino agli
apparati sindacali, allora il consiglio si riconosce esplicitamente il potere di
derogare all’eccessiva rigidità dei suoi stessi criteri. Ed è chiaro che, se si
riconoscesse il controllo dei documenti oltre che della delibera, risulterebbe
palese la singolarità della deroga. Veniamo così ad un altro aspetto, perché poi
tutto si tiene. Ci sono circa 450 magistrati, tra i 400 e i 500 magistrati, che
hanno esoneri dal lavoro, totali o parziali. Ad esempio gode giustamente di un
parziale esonero dal lavoro chi fa parte del Consiglio giudiziario. Ma un
parziale esonero dal lavoro è riconosciuto anche ai cosiddetti RID, referenti
informatici distrettuali, ai formatori decentrati, e via elencando. Questi
incarichi, che hanno il vantaggio di ridurre l’impegno nel lavoro giudiziario,
sono distribuiti su indicazione delle correnti dell’ANM. È uno dei mezzi per
creare un piccolo ceto dei sindacalisti, con la conseguenza di una separazione
sempre più netta da tutta la magistratura reale, dai tanti magistrati di
prim’ordine, di grandissimo valore, che in questo contesto non contano
assolutamente nulla. Negli anni in cui le correnti dell’associazione avevano un
contenuto progettuale, programmatico, c’erano idee diverse sul ruolo del
magistrato, sulla funzione dell’interpretazione della legge, E fu questa
diversità di orientamenti culturali a determinare la nascita delle correnti
dell’Associazione. La sindacalizzazione ha oggi portato all’omogeneizzazione su
quasi tutte le questioni di principio. Si è discusso ad esempio di quali
conseguenze debba avere la mancata osservanza del calendario del processo, uno
strumento di efficienza dell’istituzione giudiziaria. E tutti i gruppi sono
stati d’accordo nel dire che non debba avere conseguenze disciplinari,
indipendentemente dalla considerazione delle conseguenze sulla funzionalità del
sistema, perché del funzionamento del processo al sindacalista non interessa
molto. Al sindacalista interessa tutelare il magistrato lavoratore che, se non
ha rispettato il calendario, non deve andare incontro a una responsabilità
disciplinare. Sulla questione della partecipazione dei magistrati alle
commissioni d’esame degli avvocati, necessaria per favorire una comune cultura
forense, si è detto che non può essere considerata obbligatoria, perché ancora
una volta prevale l'interesse del lavoratore sull'interesse dell'istituzione. E
così sul problema dell’incompatibilità parentale tra magistrati (si ammette che
due coniugi svolgono le proprie funzioni all’interno della stessa Procura della
Repubblica, anche se di piccole dimensioni); sul problema del rapporto tra
condanna disciplinare e valutazione di professionalità (si esclude che il
giudicato disciplinare possa in qualche misura vincolare la valutazione di
professionalità); sul livello massimo di “carichi esigibili” di lavoro (si tende
a fissarlo in misura eguale per tutti, con un livellamento verso il basso della
professionalità dei magistrati, perché la logica sindacale non ammette che si
diano occasioni per distinzioni e comparazioni di merito). In questo senso si
può dunque affermare che la sindacalizzazione determina un conflitto
d’interessi, perché la gestione del personale non può essere affidata a chi il
personale lo tutela come lavoratore. È infatti questa logica individualistica e
sindacale che ha portato anche a una degenerazione del rapporto con il giudice
amministrativo, soprattutto, ma non solo, nel conferimento degli incarichi
direttivi. In realtà dovrebbe essere scontato che l’incarico direttivo non è
previsto per permettere ai magistrati di fare carriera; è previsto per far
funzionare gli uffici. E tra l’altro comporta tali e tanti impegni di lavoro,
aggiuntivo è diverso, che richiederebbe una notevole dose di altruismo. Se nella
scelta dei magistrati ai quali affidare gli incarichi direttivi si segue una
logica individualistica, intesa a soddisfare le aspirazioni del lavoratore
piuttosto che le esigenze dell’istituzione, è evidente che il giudice
amministrativo, abituato appunto a tutelare gli interessi individuali nei
confronti della Pubblica Amministrazione, non potrà non riconoscere ai
magistrati una sorta di diritto alla carriera. Solo se il CSM fosse in grado di
esprimersi secondo una logica istituzionale, anche il giudice amministrativo
avrebbe dei problemi a garantire i singoli piuttosto che la istituzione. Invece
il giudice amministrativo è giunto ad affermare che, se il presidente di un
tribunale trasferiva alla sede centrale una grande quantità di cause di una
sezione distaccata, ledeva illegittimamente gli interessi dell’ufficio
periferico. Mentre sarebbe stato più plausibile garantire gli interessi della
funzionalità dell’ufficio, anziché del gruppo locale di avvocati che protestava
contro quel provvedimento. Da questo sistema, da questo cambiamento della logica
della partecipazione e della selezione dei componenti del Consiglio, deriva poi
tutto il resto; deriva anche l’inefficienza degli uffici, perché tutto è
destinato a tutelare i singoli piuttosto che le istituzioni. Si sono avute in
particolare conseguenze estremamente negative e preoccupanti
nell’interpretazione della disciplina dell’organizzazione degli uffici di
Procura. Benché la legge dica chiaramente che il procuratore della Repubblica
può revocare l’incarico a un sostituto anche per un mero dissenso sulla
conduzione e conclusione delle indagini, si sostiene che il procuratore della
Repubblica, nel momento in cui ha assegnato il procedimento, ha consumato il suo
potere. I sostituti rivendicano, senza alcun fondamento, le stesse garanzie di
precostituzione e tendenziale immutabilità che la Costituzione prevede per il
giudice. E il CSM tende, almeno nelle proclamazioni di principio, ad assecondare
questa rivendicazione, rinunciando così a ricercare un equilibrio ragionevole
tra le garanzie individuali dei magistrati e le esigenze di funzionalità degli
uffici. Certo, è necessario un controllo del CSM sugli interventi del
procuratore della Repubblica, ma non è ammissibile una così palese elusione del
testo legislativo. I rimedi a questa situazione di crisi vanno ricercati
soprattutto sul piano culturale. Ma interventi normativi sono comunque
auspicabili. Le soluzioni sono necessarie innanzitutto con riferimento al
sistema elettorale dei togati e ai criteri di scelta dei laici. In realtà nella
selezione della componente laica si tende a predeterminare la nomina del
Vicepresidente. I partiti politici vogliono decidere preventivamente chi dovrà
essere il Vicepresidente, benché ne sia prevista l’elezione da parte
dell’Assemblea, dopo l’insediamento del consiglio. E’ certamente opportuno che
il compito del Vicepresidente sia affidato a un politico, perché si tratta di un
ruolo appunto politico, che richiede una specifica professionalità. Ma la
pretesa di predeterminare la scelta del Vicepresidente comporta che i segretari
dei partiti coinvolti prendano contatto con i responsabili delle correnti, con
evidenti problemi per l'autonomia dei singoli consiglieri. E poiché gli accordi
preliminari non sono abbastanza garantiti, si sceglie come predestinato alla
vicepresidenza un personaggio che abbia una certa levatura politica, avendo cura
di fare in modo che tutti gli altri siano ben al di sotto di questa levatura.
Altrimenti c’è il rischio che si vada in Assemblea e venga eletto un personaggio
diverso quello che era stato predeterminato. Dunque, poiché si deve fare in modo
che quello che sarà eletto Vicepresidente sarà proprio colui che hanno scelto i
gruppi parlamentari prima che il Consiglio si costituisca, si deve creare un gap
notevole di spessore politico tra chi è destinato a fare il Vicepresidente e gli
altri. Per quanto riguarda i professori il margine è più elastico, si può
eccedere in bravura per qualcuno; ma per quanto riguarda i politici, deve essere
netta la distinzione, la differenza di peso politico. E tutti gli altri vengono
preventivamente informati che non debbono candidarsi alla vicepresidenza. Per
quanto riguarda il sistema elettorale dei magistrati, l’obbiettivo dovrebbe
essere quello di evitare che ciascuna corrente limiti il numero dei propri
candidati al numero dei seggi che ritiene di poter ottenere, perché così si
predetermina il risultato delle elezioni. Occorre costringere ad aumentare il
numero di candidati, per evitare queste distorsioni del sistema istituzionale.
Quanto alla sezione disciplinare l’esigenza principale, in una prospettiva di
riforma, è quella della specializzazione dei suoi componenti. Si è detto: «chi
giudica non amministra e chi amministra non giudica». A me sembra ragionevole.
Ai componenti della sezione disciplinare dovrebbero essere affidati solo compiti
giurisdizionali e compiti di controllo. C'è una commissione di controllo sul
bilancio, una commissione che si occupa del regolamento interno e che vigila sul
regolamento. Affidiamo a questa commissione tutti i compiti di controllo e
giurisdizionali e non quelli di amministrazione: non perché questa commistione
sia di per sé ostativa a una corretta amministrazione della giustizia o a una
corretta amministrazione dei magistrati; ma perché comporta una scarsa
professionalità, non si riesce a ottenere una giurisprudenza coerente e
uniforme. Ci sono poi l’ufficio studi e i magistrati segretari, che sono uffici
importantissimi, perché il consigliere appena eletto e per almeno un anno o due
è in genere inesperto; mentre i magistrati segretari, cioè coloro che li
assistono, sono già del luogo, hanno competenza specifica in materia di
ordinamento giudiziario. C'è una marea di circolari, delibere, risoluzioni del
CSM, di cui è difficile impadronirsi senza il sostegno di chi è già del posto ed
è esperto. Ma sono le correnti dell’Anm a scegliere chi mandare all'ufficio
studi o alla segreteria, con una rigida lottizzazione. Per gli incarichi
direttivi c’è una competizione per i posti; e gli accordi sono occasionali, ora
con una corrente ora con un'altra. Non c’è una spartizione lottizzatoria, tranne
quando si debbono assegnare tanti posti insieme, come avviene ad esempio per la
Cassazione. Per i magistrati segretari c’è invece una proporzione rigorosa tra
il peso elettorale di ciascun gruppo e il numero di magistrati segretari e di
componenti dell’ufficio studi. Nel 1990 era stata approvata una legge che
escludeva i magistrati dalla segreteria e dall’ufficio studi, prevedendo
l’affidamento di questi ruoli a funzionari assunti per concorso. Con una
delibera di legittimità almeno dubbia si è detto che questa legge è stata
implicitamente abrogata. Sarebbe comunque necessario che questi posti fossero
sottratti alla lottizzazione, che esclude chi non ha una tessera, esclude chi
non ha appartenenza. Ma non si è voluto nemmeno che i magistrati vengano scelti
per concorso: si è preteso che siano scelti col bilancino delle correnti, perché
ciascuna corrente deve avere un numero di magistrati segretari e di componenti
dell’ufficio studi proporzionale al suo peso elettorale. Il fondo della
questione è tuttavia nell’involuzione dell’ANM. Negli anni ‘60 e ‘70 la
Magistratura ha rappresentato in questo Paese una forza di emancipazione,
contribuendo, ad esempio, all’attuazione della Costituzione e alla diffusione di
una sensibilità ecologica. Questa funzione propulsiva è stata conservata certo
dai giudici; ma è ormai del tutto estranea all’impegno delle correnti dell’ANM.
Le correnti si distinguono solo come apparati, come apparati che cercano di
giustificare la propria esistenza. Non c’è più differenza progettuale. Tant’è
che per quasi tutte le questioni di fondo, tutte le correnti finiscono per
convergere su un’impostazione sindacale. In una situazione disastrosa, qual è
quella del sistema giudiziario italiano, si è arrivati a proporre l’allungamento
dei termini di deposito delle sentenze civili monocratiche. La crisi della
giustizia è certamente una crisi da eccesso di input: c’è un eccesso di domanda.
E questo eccesso di input è responsabilità della politica, una politica
abnormemente interventista. Sul codice di procedura penale siamo ad oltre
centodieci leggi di modifica. Non c’è stabilità dei criteri di giudizio.
Tuttavia se non c’è un’assunzione di responsabilità da parte della magistratura,
per favorire una efficiente organizzazione degli uffici e una ragionevole
prevedibilità delle proprie decisioni; se i magistrati non si riappropriano del
proprio ruolo progettuale, nelle scelte anche politiche relative
all’organizzazione del proprio lavoro, risulterà inutile qualsiasi riforma.
Purtroppo il CSM, cui queste scelte organizzative sono in misura notevole
affidate, manca di capacità progettuale. In consiglio c’è solo un sindacato che
pensa prevalentemente agli interessi dei lavoratori, molto poco a quelli
dell’istituzione".
Interpellata dal Dubbio, il 2 agosto 2016, la
portavoce del Comitato Altra Proposta, il giudice presso il Tribunale di Pisa
Milena Balsamo, fa subito una premessa: «Noi vogliamo ricondurre le correnti,
patrimonio storico-culturale dell’Anm, al loro originario ruolo: quello di
essere centri di elaborazione culturale indispensabili alla democratica
affermazione dell’indipendenza interna e dell’autonomia che rappresentano le
prerogative fondamentali della magistratura». E per tale ragione, aggiunge la
giudice Balsamo, «siamo per il sorteggio come sistema di selezione dei candidati
al Csm».
Le correnti sono il problema principale della
magistratura?
«Per capire a
che punto siamo arrivati, suggerisco la lettura del libro scritto dall’ex togato
Aniello Nappi Quattro anni a Palazzo dei Marescialli. Idee eretiche sul
Consiglio Superiore della Magistratura, dove sono descritti il sistematico abuso
d’ufficio, la violazione delle regole e i favoritismi per gli amici».
Lei ritiene che la magistratura abbia perso di
credibilità a causa della cosiddetta deriva correntizia?
«Si, e questo
perché le correnti si sono trasformate in centri di potere che condizionano,
secondo strettissime logiche di appartenenza, ogni scelta di autogoverno della
magistratura, a cominciare dalla selezione dei magistrati dirigenti».
Riccardo Magherini,
un’altra "sentenzina" per omicidio colposo,
scrive Susanna Marietti, coordinatrice associazione Antigone, il 13 luglio 2016
su "Il Fatto Quotidiano". Un altro omicidio colposo. Di nuovo c’è stata
negligenza, imprudenza o imperizia in quelle manette messe dietro la schiena e
quella faccia buttata sul terreno per circa mezz’ora in una posizione che
impediva a Riccardo Magherini di respirare. “Aiuto, aiuto, sto morendo”, sono
state le ultime parole pronunciate da Riccardo in quella notte tra il 2 e il 3
marzo 2014 a Firenze, registrate dal cellulare di un uomo affacciato a una
finestra lì vicino. Arriva ora la sentenza di primo grado nella quale tre
carabinieri vengono condannati per omicidio colposo, uno di loro a otto mesi di
carcere e gli altri due a sette. Per il primo era stato chiesto ben un mese di
più. Sapete perché? Perché mentre Magherini era a terra
ammanettato e soffocante lui lo ha preso a calci. Ma il giudice non ha voluto
procedere per l’accusa di percosse. Un altro omicidio colposo, come quello
di Federico Aldrovandi, pericolosissimo ragazzino di diciotto anni, persino un
po’ mingherlino, che tornava dalla discoteca a Ferrara una notte del settembre
2005 ed è stato picchiato a morte da quattro poliziotti. Lui urlava “basta,
aiutatemi, sto morendo” e loro lo prendevano a manganellate e a calci. Cosa c’è
di colposo nella condotta tenuta dai poliziotti? Lo stesso pubblico ministero
affermò al processo: “Chiedeva aiuto, diceva basta, rantolava, e i quattro
imputati non potevano non accorgersi che stava morendo, eppure non lo aiutarono
ma lo picchiarono”. Un evidente omicidio preterintenzionale, punito con il
carcere dai dieci ai diciotto anni, per come viene descritto in queste parole.
Eppure è lo stesso pm a chiedere una condanna a tre anni e otto mesi, con il
crimine derubricato a omicidio colposo (scusate, non l’ho fatto apposta…). E
all’indomani della sentenza dicevamo tutti che finalmente Federico aveva avuto
giustizia, che ora si sapeva chi erano i suoi assassini. Il papà di Federico
affermava: “Sono fiero che in Italia ancora esistano magistrati così”. Oggi
accade lo stesso per il processo relativo alla morte di Riccardo Magherini. Il
fratello è contento della “sentenzina”, sa che di più non può aspettarsi per
rendere giustizia a Riccardo. Tutti noi lo sappiamo. Diamo per scontato che
quando di mezzo ci sono le forze dell’ordine la scelta sia tra impunità completa
o “sentenzine” esemplari. Ci hanno abituato che in Italia è così. Eppure i
crimini compiuti da funzionari dello Stato sono tra i più odiosi che si possano
immaginare. Quei poliziotti e quei carabinieri erano lì a nome di tutti noi. Il
loro non è un crimine privato.
Toghe innominabili,
scrive Filippo Facci il 12 luglio 2016 su “Libero Quotidiano”. Piercamillo
Davigo non è più lui. Da presidente dell'Anm è stato investito da così tante
bufere che ogni sua uscita pubblica ora suona imbarocchita da distinguo e
premesse: sabato ha parlato a un convegno dei Cattolici democratici (sarà
questo: era pieno di democristiani) e ogni volta premetteva che «non penso che
tutti i politici rubano, rubano in molti... Non credo siano tutti mascalzoni,
ma...». Ce l'hanno rovinato. Fortuna che non manca di che obiettargli. Ha
parlato di «politici che non si vergognano più» e verrebbe da chiedergli quando
mai si siano vergognati i magistrati colti in castagna: anche perché fare i loro
nomi è proibito. Già. Dovete sapere che la sezione disciplinare del Csm ogni
anno sanziona blandamente con ammonimenti, censure e perdite di anzianità una
serie di magistrati che, per esempio, non hanno pagato il conto al ristorante,
hanno dimenticato innocenti in carcere, hanno perso fascicoli e anni di lavoro
altrui, o semplicemente non lavorano, o sono mezzi pazzi (uno l'hanno visto
chiedere l'elemosina per strada, un altro ha spalmato l'ufficio di nutella, un
altro ha urlato «ti spacco il culo» a un avvocato) e però i loro nomi non sono
divulgabili. Il Csm ha invocato la legge sulla privacy e la protezione dei dati
personali, come d'obbligo solo per i minori e le vittime di violenze sessuali:
eppure parliamo di gente che giudica della vita altrui. Ecco, dottor Davigo:
secondo lei è giusto?
Subisci e taci ti intima il sistema gognatico
medio-giudiziario.
Un buon libro ricorda le perversioni
italiane del sistema “gognatico” giudiziario, scrive
Giulia De Matteo il 4 Agosto 2011 su "Il Foglio". La perp walk italiana comincia
con un avviso di garanzia e interminabili chilometri di carta in cui ci si
sbizzarrisce a interpretare ogni parola strappata alle intercettazioni, in cui
si costruiscono teoremi fatti di parole d’ordine (“cricca”, “la rete di
relazioni”, “appaltopoli”, “l’affare”) da cui si ricavano accuse vaghe ma
efficaci a relegare l’indagato nell’angolo dei cattivi. Il cammino è destinato a
concludersi nella dimenticanza generale, a luci spente, tra l’indifferenza dei
quotidiani e delle televisioni, animatori inferociti alla partenza. Maurizio
Tortorella ha raccolto le storie più eclatanti di questa dinamica nel libro “La
Gogna” (Boroli Editori), in cui smonta fase per fase la catena di montaggio
della diffamazione che prelude i processi ai personaggi pubblici, attraverso
un’analisi a freddo delle storie su cui ormai si sono spenti i bollori mediatici
e si è fatta strada la verità processuale. C’è per esempio la vicenda di Guido
Bertolaso, ex capo della Protezione civile, raggiunto dall’accusa di corruzione
negli appalti sui lavori straordinari per il G8 sull’isola della Maddalena (poi
spostato a L’Aquila) il 10 febbraio 2010. Tortorella racconta i giorni seguenti
l’apertura delle indagini attraverso i titoli dei giornali e le ricostruzioni
della vicenda. Così tra le intercettazioni pubblicate sui giornali quella in cui
Bertolaso racconta il piacere suscitato da un certo massaggio fattogli da una
tal Francesca diventa l’indizio che alimenta il sospetto del coinvolgimento di
Bertolaso in un giro di escort usate a mo’ di tangente nel giro di favori fra i
potenti dei grandi appalti. Quando si scopre che Francesca è una fisioterapista
professionista di quarantadue anni è troppo tardi. Soprattutto non interessa
più: gli untori degli scandali hanno già impresso il loro sigillo (quello che
conta per l’opinione pubblica). Il 5 aprile 2010 si è aperto il procedimento che
tratta degli abusi edilizi e da allora non una riga è stata più scritta.
Difficile dire quando questo selvaggio rito giudiziario sia iniziato in Italia,
sicuramente la sua massima celebrazione è stata Tangentopoli: l’età della
presunzione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Dalla caduta della
Prima Repubblica, è sorta la Seconda e i nuovi decisori, scampati al tritacarne
giustizialista, hanno riscritto l’articolo 111 della Costituzione, ispirandosi
ai principi di tutela dell’indagato e dell’imputato delle carte europee,
adeguato il codice penale ai principi del giusto processo e adottato il modello
accusatorio. Ma poco di questa mano di vernice garantista è riuscita a incidere
sulla mentalità comune. Soprattutto non ha impregnato il sistema mediatico che
ha continuato a riversare, con il sostegno dei gestori dei processi, il solito
appannaggio culturale collaudato durante Mani pulite. L’apertura di un’indagine,
a cui segue in automatico la carcerazione preventiva, giustificata da un uso
pervertito dell’articolo 56 del codice di procedure penale, è il vero fulcro
della vicenda processuale. I dati citati da Tortorella parlano di 37.591
condannati definitivi su un totale di 67.000 detenuti in carcere: 43 detenuti su
100 sono in cella senza che sia stata ancora pronunciata una sentenza di
condanna definitiva. E’ questa fase che dà il via a fiumi di inchiostro, ad
approfondimenti televisivi in cui si alimenta lo scandalo con gli indizi
raccolti nella indagini. La ricerca della verità è secondaria rispetto alla foga
di emettere un verdetto di popolo. Tutto questo dura fino al rinvio a giudizio.
Poi i riflettori si spengono e la farraginosa, lenta e poco accessibile ai non
addetti ai lavori macchina processuale comincia. “La Gogna” come un occhio di
bue ha seguito alcuni figuranti del circuito mediatico-giudiziario prima e dopo
il rinvio a giudizio, ricostruendo le vicende giudiziarie di Alfredo Romeo,
Ottaviano Del Turco, Calogero Mannino, Silvio Scaglia, Antonio Saladino (al
centro dell’operazione “Why Not”). Leggete le loro storie e capirete meglio in
che senso Tortorella usa la parola gogna.
Ed eccola l'orda dei gognatori. Il tipico esempio
di disinformazione.
Mafia capitale, la minaccia in aula
contro il cronista. L'avvocato difensore di Massimo
Carminati, Bruno Naso, aggredisce in aula con frasi ingiuriose e pesanti
insinuazioni il giornalista dell'Espresso Lirio Abbate, da anni sotto scorta per
le minacce subite dopo aver rivelato gli affari di mafia e crimine a Roma,
scrive Attilio Bolzoni il 30 gennaio 2016 su “La Repubblica”. Puntare il dito
contro un giornalista - sempre lo stesso - è come indicare un bersaglio,
prendere la mira. Ma c'è un avvocato, qui a Roma, che forse non ha capito che
Lirio Abbate non è solo. Una Mafia Capitale sotto processo si agita e si dimena
nelle gabbie cercando disperatamente alibi e vie di fuga, i suoi difensori
intanto sono a caccia di capri espiatori e di cronisti "colpevoli " per avere
raccontato un potere criminale tollerato per troppo tempo. Chi parla (o chi
scrive) sta diventando giorno dopo giorno e udienza dopo udienza obiettivo di
insinuazioni e di attacchi spericolati, sta diventando un'ossessione che non
annuncia niente di buono ma che al contrario comincia a preoccupare tutti noi
giornalisti. Potremmo chiamarlo il "caso Abbate", ci sembra però più opportuno
presentarlo come il "caso Naso". L'avvocato Bruno Naso, difensore del nero
Massimo Carminati e di alcuni imputati del dibattimento contro i boss Fasciani,
il penalista che all'apertura del processo su Mafia Capitale l'ha battezzato "un
processetto". È da settimane, da mesi, che questo legale non perde occasione in
pubblico dibattimento di aggredire - con frasi ingiuriose e pesanti allusioni -
il giornalista dell'Espresso Lirio Abbate, il primo che nel dicembre del 2012 ha
svelato i misteri e le contiguità della mafia della capitale italiana citando i
"quattro re di Roma ", Massimo Carminati, Michele Senese, Carmine Fasciani,
Giuseppe Casamonica. L'ultima imboscata dell'avvocato Naso contro Abbate è di
ieri mattina, in un'aula di Piazzale Clodio di Roma, al processo d'appello
contro i Fasciani, padrini e padroni di Ostia, malacarne di incerta nobiltà
mafiosa ma con entrature nel crimine che conta e nelle amministrazioni locali.
L'avvocato Naso nella sua arringa finale prima si augura che i giudici
"emetteranno una sentenza politicamente scorretta", poi parla della "regia
inequivoca" del procuratore Pignatone "che è venuto a Roma pensando che Roma
fosse una grande Reggio Calabria ", poi ancora riserva le sue azioni offensive -
davanti agli imputati, particolare non insignificante - a "De-lirio" Abbate, il
giornalista che prima ancora che i mafiosi di Roma fossero catturati aveva
descritto come si muovevano da Sacrofano al Campidoglio, dalle miserabili
periferie fino alle stanze della spartizione degli appalti. L'avvocato Naso si
chiede perché "non hanno dato a De-Lirio il premio Pulitzer", fa credere che non
sia un giornalista ma che agisca praticamente in combutta con investigatori e
magistrati: "Abbate, che è casualmente di Palermo, che casualmente ha lavorato a
Palermo quando c'era Pignatone, che casualmente frequenta ambienti frequentati
da Pignatone…il cerchio si chiude". Su un altro palcoscenico, quello di Mafia
Capitale a Rebibbia, il 4 gennaio scorso, lo stesso Naso aveva più volte citato
"De-Lirio" (interrotto dal pm Cascini e tra le risatine di alcuni suoi colleghi)
giustificando i suoi insulti al giornalista "perché se li meritava". E non era
neanche quella, la prima volta che gli dedicava la sua attenzione. L'avvocato
Naso ha naturalmente il diritto di difendere i suoi clienti - Carminati, gli
amici dei Fasciani, gli ex Nar che ha sempre assistito - con ogni mezzo che la
legge gli consente. Quello che non può fare - e non solo in un'aula di giustizia
ma anche fuori - è additare un giornalista come "organizzatore" di un complotto,
come protagonista di una trama ordita insieme a carabinieri e a pubblici
ministeri, come un supporter operativo della procura della Repubblica. Abbate ha
fatto semplicemente quello che sa fare: il giornalista. Trasformarlo in altro,
come sta provando l'avvocato Naso fin da prima del dibattimento di Mafia
Capitale - è estremamente pericoloso. Lirio Abbate vive sotto scorta dal 2007,
negli ultimi anni il livello di protezione intorno a lui si è elevato, nel
dicembre del 2013 è stato anche oggetto di una scorribanda (un'auto che ha
speronato quella della polizia dove era a bordo) mai chiarita, intercettazioni
ambientali e telefoniche ci svelano che Carminati ha più volte manifestato la
volontà di fargliela pagare. L'avvocato Naso tenga debitamente in conto tutto
questo. Ogni sua parola può venire facilmente fraintesa. Anche da chi sta dentro
le gabbie.
Ed ecco, invece, l'altra verità.
"Pignatone vive nel far west di Reggio".
L'avvocato Naso accusa: "Regia politico giudiziaria".
"Avvocati pedinati e intercettati, violato il principio di legalità e indagini
fatte con lo stampino per cercare reati e non ipotesi". Al processo al clan
Fasciani l'avvocato Naso difensore anche di Carminati si scaglia contro il
Procuratore di Roma e dice ai giudici..., scrive Venerdì, 29 gennaio 2016,
Valentina Renzopaoli su “Affari Italiani”. Pignatone “giudice del far west”,
abituato a utilizzare metodi istruttori che “violano il principio di legalità”,
capace di tessere una regia di “politica giudiziaria” che travalica i confini
del Tribunale. E' un attacco durissimo e senza precedenti: le parole
dell'avvocato Giosuè Bruno Naso impietriscono i giudici della II sezione della
Corte d'Appello del Tribunale di Roma, dove si sta svolgendo il processo di
secondo grado per Carmine Fasciani e altri diciassette imputati. Nell'arringa
finale, per la difesa del suo cliente Riccardo Sibio, considerato dall'ipotesi
accusatoria come uno degli organizzatori dell'associazione a delinquere di
stampo mafioso, Naso si lancia in uno scontro frontale. “Questo processo fa
parte di una certa operazione di politica giudiziaria, spiegata da una ragione
inequivocabile, che porta il nome del nuovo procuratore della Repubblica di Roma
Giuseppe Pignatone, che è venuto a Roma pensando che Roma fosse una grande
Reggio Calabria per applicare metodi investigativi e processuali da far west”,
ha tuonato l'avvocato nell'incipit del suo discorso. Parole di fuoco che, senza
lasciare molto spazio alla fantasia, demoliscono l'azione del super procuratore,
“padre” di Mafia Capitale, raccontando di “processi fatti con lo stampino” e
basati su una massa di intercettazioni “sparate” in ogni direzione, “non per
ricercare la prova di un reato ipotizzato ma per ricercare il reato”. “Il
meccanismo istruttorio è sempre lo stesso, mediante intercettazioni a catena: si
individua un soggetto che può incarnare sospetti, gli si viviseziona l'esistenza
e si comincia a intercettare “a strascico” tutti quelli che gli girano intorno,
alla ricerca di un reato ad ogni costo” ha spiegato. “La contestazione avviene
sotto il profilo della contestazione di stampo mafioso, scattano le misure di
natura patrimoniale per neutralizzare le possibilità di difesa e non ci si ferma
nemmeno di fronte all'attività defensionale”. A questo punto, si è voltato verso
i colleghi avvocati: “Guardate che ciascuno di voi è sottoposto ad un controllo
massiccio e invasivo, attraverso i vostri telefoni personali e di studio”. E
urlando: “Mia figlia, avvocato di Carminati, è stata pedinata dalle 8 del
mattino alle 19 di sera, un pedinamento che non poteva che nascere da
un'intercettazione. Questo procuratore pensa che il crimine si debba combattere
come nel far west”. Con una conclusione degna dell'intera arringa, alla Corte
esterrefatta il legale esclama: “Qui si vedrà se avete la cultura della
giurisdizione in forza della quale il crimine non si combatte con metodi
criminali, o se pensate che siamo tornati nel “far west” per fare giustizia ad
ogni costo. Il vero tema è: ve la sentite di fare una sentenza politicamente
scorretta?”. Il messaggio finale è ancora per Pignatone: “Chi sta coltivando
ambizioni non può servirsi della vostra libertà di coscienza. Questo è un
momento difficile e abbiamo bisogno che il principio di legalità siano
salvaguardato”.
L'Ordine degli avvocati di Roma pronto a
studiare il caso Naso - Abbate - Pignatone, scrive
Roberto Galullo l'1 febbraio 2016 Fino a questa mattina il telefono
dell'avvocato Mauro Vaglio, presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma non
aveva squillato. Nessuno, tra i suoi colleghi, in questi ultimi giorni, aveva
sollevato la necessità di prendere posizione su quanto accaduto in un aula di
Tribunale di Roma la scorsa settimana. Nel corso di un'udienza del processo di
appello contro i Fasciani di Ostia, l'avvocato Giosuè Naso, difensore di Massimo
Carminati, si era scagliato contro Lirio Abbate, inviato dell'Espresso
(definendolo “de-lirio” Abbate e rivendicando l'uso legittimo dell'ironia nella
sua requisitoria), che per primo descrisse la cupola criminale che ruotava
intorno al “cecato” e alla sua banda di allegri compari. Sorte analoga aveva
avuto il capo della procura di Roma Giuseppe Pignatone, descritto come sodale di
Abbate. Non vale quasi la pena ricordare che Abbate vive blindato da nove anni
per le continue minacce di morte. Vaglio, però, nel fine settimana ha studiato
la situazione ed è stato pronto a rispondere con la massima trasparenza
all'unica chiamata giunta: quella del Sole 24 Ore.
Presidente Vaglio, l'Ordine degli avvocati di
Roma viene chiamato in causa su quanto accaduto. Prego, esprima il suo giudizio.
«Tecnicamente
la situazione è questa: l'Ordine è ente pubblico non economico, e dunque è fuori
luogo la forzatura di chi cerca di suggerirci un comportamento pubblico da
sbandierare ai giornali».
Nulla quaestio, come direste voi legali, sulla
natura giuridica dell'Ordine ma insistiamo: i termini per un vostro intervento
ci sono o non ci sono?
«Effettivamente
c'è stato un riferimento al giornalista oltre che al procuratore e a questo
punto il consiglio dell'ordine ha due possibilità: ritenere che questa notizia
possa avere risvolti disciplinari oppure ritenere che non ci siano. La
valutazione non è discrezionale, di solito il consiglio dell'ordine dovrebbe
trasmettere la richiesta al consiglio di disciplina».
Bene. E a chi spetta fare il primo passo?
«Posso farlo
anche io come presidente dell'ordine, sentiti gli altri consiglieri. E'
l'ufficio nella sua coralità, comunque, che svolge questa funzione. Normalmente
c'è la comunicazione al consiglio di disciplina e contemporaneamente si dà un
termine di 20 giorni all'avvocato investito della questione, per le sue
deduzioni».
Ritentiamo la domanda: l'Ordine di Roma si
attiverà o no?
«Abbiamo un
ufficio apposito che ogni giorno analizza i giornali e quanto accade nelle aule
dei Tribunali in tutta Italia. E' molto probabile che il consiglio di disciplina
analizzi il caso».
Lei si sarebbe mai comportato come il suo
collega Naso?
«Non può pormi
questa domanda. Veramente sì. Sarebbe come chiedere a un giudice di esprimere un
concetto sul processo che si sta svolgendo».
Ma lei non deve intervenire su un processo in
corso.
«Non posso
rispondere. Non mi sembra corretto criticare pubblicamente un collega prima di
aver analizzato gli atti e le eventuali controdeduzioni».
Aggiriamo l'ostacolo: si è mai trovato nella
sua professione o nella sua vita associativa di fronte ad atteggiamenti simili?
«Capita molto
spesso di avere questo tipo di atteggiamento in ambito civile, con termini forti
nei confronti del collega o dell'avvocato controparte».
E cosa succede in quei casi?
«La procedura
descritta sopra. Ricordo che le sanzioni partono da un avvertimento, che è la
sanzione minima, una sorta di rimprovero e arrivano fino alla sospensione o alla
radiazione. Se ci dovesse essere un'azione penale da parte del giornalista o del
magistrato anche l'eventuale condanna costituisce un'azione disciplinare».
Solidarietà dell’AIGA all’Avv. Giosuè
Bruno Naso espressa l’8 febbraio 2016. L’Associazione
Italiana Giovani Avvocati esprime piena e incondizionata solidarietà
all’Avvocato Giosuè Bruno Naso, fatto oggetto di pesanti attacchi mediatici per
aver, nel corso di un’arringa difensiva, stigmatizzato il contenuto di alcune
inchieste giornalistiche del dott. Lirio Abbate e contestato la sistematica
violazione della segretezza delle indagini preliminari. La libertà di stampa,
presidio di garanzia di uno Stato democratico, non sarà mai messa in discussione
dall’avvocatura, che storicamente ha vigilato per il rispetto dell’art. 21 della
nostra Costituzione. È amaro constatare che, viceversa, un valore di rango
straordinariamente più elevato, quello della libertà personale e
conseguentemente il diritto di difesa, sia oggi messo in discussione, in modo
così becero e violento, da quello stesso mondo che vive in funzione della
libertà di manifestazione del pensiero. Proprio per tutelare al massimo la
sacralità del diritto di difesa, la Costituzione e il codice di procedura penale
pongono quale unico limite quello della continenza verbale, che è stato
considerato rispettato dall’unico soggetto legittimato a contestarlo (il giudice
procedente). Senza entrare nel merito dei fatti affermati dal Collega, della cui
fondatezza non spetta ad altri che al Tribunale compiere valutazioni, l’arringa
“incriminata”, lungi dal costituire, come pure gratuitamente lasciato intendere,
una sorta di “minaccia” al giornalista da parte di un “portavoce” di un presunto
criminale, rappresenta, viceversa, un luminoso esempio di richiamo ai valori
della Giurisdizione, della presunzione di innocenza, del rispetto delle regole
processuali, soprattutto da parte di chi rappresenta lo Stato ed esercita la
pretesa punitiva, e della libertà dell’avvocato nella difesa dei propri
assistiti. Senza scomodare l’esempio dell’Avvocato Otto Stahmer, protagonista al
processo di Norimberga della difesa di imputati poi riconosciuti responsabili di
crimini contro l’umanità, la Giovane Avvocatura tiene a sottolineare come la
difesa degli imputati, quanto più impopolare (e quindi difficile), tanto più è
nobile. L’AIGA auspica che tutte le Istituzioni Forensi prendano immediatamente
una rigida posizione a tutela dell’Avvocato Giosuè Bruno Naso e, tramite esso,
di tutta l’Avvocatura.
La Camera Penale di Trapani ha deciso di
far sentire su questo caso la propria voce, anche se
in fin dei conti le vicende romane sono lontane da questa città. In sostanza la
Camera Penale di Trapani, con un documento mandato al ministro della Giustizia
Orlando, per sottolineare il rango di diritto inviolabile che la Costituzione
riconosce alla difesa, prendendosela a male con i giornalisti che hanno
stigmatizzato il comportamento dell’avvocato Naso, ha deliberato che ad apertura
di tutte le udienze penali che si svolgeranno dal 22 al 26 febbraio 2016, gli
avvocati chiederanno che si metta a verbale la seguente dichiarazione:
“l’avvocato difende la libertà con la libertà di difendere”.
A Naso è tutto un De-Lirio, scrive
“Il Fango Quotidiano” il 31 gennaio 2016. A noi, piace fare la voce fuori dal
coro, non in modo pretestuoso, ma per cercare di offrire una visione, un punto
di vista meno fazioso e schierato con la massa. Non prendiamo parti, non siamo
amici di nessuno e si può dire non (su)sopportiamo nessuno: dai politici ai
criminali, fino ai giornalisti e agli sbirri (non usiamo il termine in senso
dispregiativo ma storico). Il caso, tutto giornalistico, che tiene banco in
questi giorni è quello della battuta fatta dall’avvocato Giosuè Naso difensore
di Massimo Carminati nel processo che vede quest’ultimo come imputato e accusato
di essere il capo della cosiddetta “mafia capitale”. In particolare 2 sono le
affermazioni che hanno indignato la stampa italiana: lo storpiamente del nome
del Giornalista Lirio Abbate in De-Lirio Abbate e quella in cui l’avvocato parla
di un complotto tutto politico che vedrebbe Lirio Abbate come collaboratore e
referente della procura, in particolare con il procuratore Giuseppe Pignatone.
Sono stupidaggini? Sicuramente, ma rientrano nelle facoltà, e nelle possibilità
lecite che ogni avvocato ha il diritto di utilizzare. Come previsto dalla legge
anche i serial killer o appunto i capimafia hanno diritto a una difesa e
naturalmente un avvocato non si può limitare a dire “il mio cliente è innocente”
o “sono tutte falsità” deve riuscire a trovare il modo di replicare e smontare e
dimostrare l’infondatezza delle accuse. Inoltre Volendo essere precisi un
avvocato difensore non deve trovare le prove. Quelle le deve trovare chi accusa
perchè secondo la legge si è innocenti fino a prova contraria e non viceversa.
Non avendo strumenti efficaci è quindi comprensibile che l’avvocato cerchi di
delegittimare coloro che hanno avviato l’inchiesta e coloro che l’hanno
ispirata/anticipata (in questo caso il giornalista Lirio Abbate). Il giornalista
Peter Gomez Lancia il suo editto via twitter (i giornalisti possono devono
usarlo, solo i politici ci fanno brutta figura…) "Gli avvocati italiani tolgano
il saluto all'avvocato Naso. Sanzionare socialmente le sue parole contro Lirio
Abbate". 22:23 - 30 Gen 2016. Anche il suo collega Marco Lillo segue a ruota.
"Non basta abbracciare il mio amico @LirioAbbate. Tutti quelli che incontrano
l'avv Naso in tribunale gli tolgano il saluto. O di qua o di là". 21:56 - 30 Gen
2016. Eh qui non capiamo. Naso è il difensore di Carminati per forza di cose sta
di là… Forse Lillo e Gomez pensano che il dovere di un avvocato con la schiena
dritta sia di non difendere i criminali e quelli d’ufficio dovrebbero fare solo
finta di difendere il loro assistito. Per carità, sono punti di vista. Roberto
Saviano che non perde certo occasione scrive (sempre su twitter) "Solidarietà a
Giuseppe Pignatone e @LirioAbbate per le violente parole dell'avvocato del boss
Carminati contro di loro". 21:01 - 30 Gen 2016. Ora, premesse le ovvietà sulla
solidarietà, sul giornalismo, sulla mafia che è una montagna di merda e bla bla
(no perchè se no Lillo pensa che stiamo di là). Noi vorremmo provare a
fare alcune riflessioni (sempre che ciò ci sia concesso). Prima che montasse la
vicenda soprannominata “mafia capitale” nessun magistrato, processo o condanna
aveva mai sancito o ipotizzato che la criminalità romana fosse ascrivibile alla
mafia (una leggera svista…). L’oggi super boss Carminati, prima di sentire le
intercettazioni di Buzzi che diceva che con gli Immigrati si facevano più soldi
che con la droga e che si imbastisse l’inchiesta girava tranquillamente per la
città e non aveva alcuna pendenza o reati da scontare. Era un uomo libero e
nessuno ne parlava (a parte Lirio Abbate). Durante il “sindacato” targato
Alemanno nessuno mai si era sognato di parlare di cooperative, di minacce,
pollici spezzati, mazzette ecc. Poi quando bisognava fare fuori Marino che aveva
“brutte intenzioni” ecco che hanno scoperchiato il vaso di pandora. Massimo
Carminati il 7 dicembre parla con una persona (non si sa chi sia…) con tono
“furioso”: “FINCHÉ MI DICONO CHE SONO IL RE DI ROMA MI STA PURE BENE, COME
L’IMPERATORE ADRIANO. PERÒ SUGLI STUPEFACENTI NON TRANSIGO, LUNEDÌ VOGLIO
ANDARE A PARLARE COL PROCURATORE CAPO E DIRGLI: SE SONO IL CAPO DEGLI
STUPEFACENTI A ROMA MI DEVI ARRESTARE IMMEDIATAMENTE. NON SO CHI C… È QUESTO
ABBATE, QUESTO INFAME PEZZO DI M… FINCHÉ MI ACCUSANO DI OMICIDI … MA LA DROGA
NO… COME TROVO IL GIORNALISTA GLI FRATTURO LA FACCIA… TANTO SARÀ SCORTATO, COSÌ
GLI AUMENTANO PURE LA SCORTA”. Carminati si incazza dopo aver letto l’articolo
di Lirio Abbate su L’Espresso. Ora, bisogna comprendere che Carminati è uno di
quei criminali che tengono alla loro reputazione, che ha un sistema di valori e
principi tutto suo. Ma quello che però lo rende credibile è che difficilmente un
criminale farebbe di tutto per smentire solo l’accusa meno grave nei suoi
confronti. Carminati non sa di essere intercettato e non ha motivo di mentire. A
lui non frega nulla delle accuse di omicidio, di mafia o dell’appellativo “Re di
Roma” (quelle lo lusingano) a lui dà fastidio la più insignificante, lo spaccio
di droga. L’articolo di Lirio Abbate, con tutto il rispetto per la causa,
l’impegno e le conseguenze che il giornalista ha subito e sta ancora
affrontando, non ci sembra un gran lavoro. Se dobbiamo essere sinceri è scritto
davvero maluccio. Un giornalista quando fa della accuse dovrebbe in un certo
senso dimostrarle, fornire fonti (non rivelarne l’identità ovviamente) fornire
argomentazioni, testimonianze. Abbate fa solo una lunga lista di quelle che a
noi sembrano più che altro sue convinzioni riportate con lo stile del
romanziere. Ci sarebbero dovute essere delle “prove” (non di livello processuale
naturalmente) ma almeno argomentazioni in grado di supportare le tesi espresse.
Se provassimo a metterci nei panni di uno dei mafiosi di qui parla l’articolo
non ci saremmo preoccupati più di tanto perchè non c’è nulla nell’articolo che
possa costituire un reale problema: non ci sono date, fatti, non si smaschera
nulla. Si dice solo, quello controlla la zona ovest, quell’altro la est,
spacciano droga (ma non dove e come). Insomma nulla che un avvocato appena
laureato non possa risolvere (stiamo ragionando dal punto di vista criminale
ovviamente). Il giornalismo d’inchiesta per noi è un’altra cosa. Anche la
magistratura e ci fa un po’ sorridere perchè, come detto nessuno aveva mai
parlato di mafia, ma dopo che il giornali e i media hanno sdoganato il termine
ecco che tutti si sono precipitati nei soliti “io l’avevo detto”, “eh, era
evidente” ecc. Inoltre quando oramai tutti parlavano di mafia ecco che arriva la
relazione del prefetto Gabrielli che invece dice che non si tratta di mafia. Ma
insomma, è mafia o non è mafia? mmm e chi lo sa… Quello che è certo è che in
tutta questa storia non ci sono morti ( e meno a male ), non si zittiscono
persone, non ci sono faide per la conquista di posizioni vacanti tutte cose
tipiche di un contesto mafioso, e non è vero come scrive Abbate che è perchè la
mafia è cambiata, basta vedere quello che accada Napoli in questi giorni…Oggi,
come detto, sono tutti lì a indignarsi e a schifarsi delle parole dello
squallido avvocato Naso a cui va tolto il saluto (se che se ne importa Naso, con
quello che prende…) però ad essere sinceri a noi sono anche altre le cose che ci
fanno schifo. Forse siamo folli, ma a noi fa schifo:
Che gli agenti dei servizi o altro corpo dello
stato, come emerso dalle intercettazioni, avvertivano e tenevano costantemente
informato Carminati, non risparmiando encomi, elogi e ammirazione.
Che era impossibile che finanza e carabinieri non
sapessero o non vedessero cose che per la loro evidenza (questi facevano tutto
alla luce del sole, nei bar, per strada, parlavano al cell) era davvero
difficile non vedere.
Che dopo l’esplosione del caso sono partiti i
consueti depistaggi (furti misteriosi e inquinamenti vari).
Che politici di ogni schieramento sapevano ma
nessuno di loro parlava.
Che tanto alla fine pagheranno i capri espiatori
(che se lo meritano, sia chiaro) da dare in pasto all’opinione pubblica, ma
forze dell’ordine colluse, servizi deviati e politici la faranno franca come
avviene sempre.
Che come evocato dall’avvocato Naso ci sono cose
che a confronto mafia capitale sembra una fiaba per bambini. Come quella della
brutta storia del generale Ganzer e del suo gruppo di gruppo di ufficiali e
sottufficiali dei Carabinieri del ROS (ci sono omicidi, spaccio di droga
‘ndrangheta e chi più ne ha ne metta) che ha è finita a tarallucci e vino con
una bella prescrizione (noi del fango ne parleremo a breve in un articolo
dedicato al caso).
Che giornalisti o sedicenti tali partecipano a
fabbricazioni di false intercettazioni (vedi caso Crocetta/Tutino) o manipolano
le trascrizioni. Per non parlare di quando vengono in possesso illecitamente e
dietro compenso o altra utilità di informazioni, documenti fascicoli segretati
che una volta resi pubblici, non solo rischiano di vanificare anni di lavoro di
delicate indagini, ma anche di far organizzare e allertare indagati e sospetti
ringraziando si prodigano per eliminare possibili tracce e prove.
Potremmo andare avanti a lungo. Ma ci sta venendo
da vomitare. L’avvocato Naso è stato offensivo ma il giornalista/conduttore
Massimo Giannini che ha parlato di rapporti incestuosi fra il ministro Maria
Elena Boschi e il padre no, lui lo difendiamo, perchè “è uno di noi” bisogna
tutelare la categoria… E poi si sa che la Boschi, Boldrini, e le
renzioidi possono/devono essere offese screditate e delegittimate. La Boldrini
era la stronza sotto scorta, Abbate l’eroe della carta stampa minacciato dal
perfido cecato. Il mondo va così due pesi e due misure, anzi a Naso si potrebbe
dire che è tutto un De-lirio.
Criminale con diritto alla difesa.
Non ha mai negato rapine e eversione nera e banditismo. Ma Carminati odia droga
e mafia. Al Cecato è negata una tutela giudiziaria decente. Icona mediatica, non
sta al gioco. Le ragioni del 416 bis secondo i legali, scrive Annalisa Chirico
il 30 Dicembre 2014 su “Il Foglio”. Anche i criminali hanno diritto alla difesa.
Quella che leggete è una difesa di Massimo Carminati. Il giornalista collettivo,
per definizione, è megafono della requisitoria e censore dell’arringa. Qui si
contraddice la pubblica accusa. Non è lesa maestà ma tributo alla giurisdizione.
Ci hanno raccontato che Carminati è un fascio cecato, dominus di una romanissima
cupola mafiosa, trafficante e pluriomicida. Di sicuro c’è un fatto: “Er Cecato”
è cecato veramente. Orbo di un occhio. Nell’epopea mitica del “re di Roma”
propalata dalla grancassa massmediatica, l’occhio lo avrebbe perso in uno
“scontro a fuoco” con la polizia. Prima bufala. L’unica arma che Carminati
indossa quel 20 aprile del 1981 è un passaporto falso. Al valico di Gaggiolo, in
provincia di Varese, Carminati è a bordo di una Renault 5 con due sodali in fuga
dalla retata anti Nar della magistratura romana. Quando l’auto si ferma e i tre
tentano di scappare, gli agenti della Digos sparano. Carminati è salvo per un
pelo: il bulbo oculare sinistro è spappolato, un frammento del proiettile gli
rimane conficcato nella testa. Il giovane, nato 23 anni prima da una famiglia
borghese ben insediata nella capitale, maturità classica e qualche esame alla
facoltà di Medicina, non è un neofita del crimine. Infiammato dall’ideologia
eversiva, estremista, dei Nuclei armati rivoluzionari, nel ’79 insieme a quattro
camerati mette a segno la rapina della Chase Manhattan Bank di piazzale Marconi
a Roma. Da allora il certificato penale di Carminati s’ingrossa tra rapine,
eversione, banda della Magliana, fino all’ultima clamorosa impresa: il furto nel
caveau della banca interna del Palazzo di giustizia a Roma. “Massimo ha un’alta
considerazione di sé”, sorride sornione l’avvocato Giosué Bruno Naso che lo
difende da trent’anni. La reputazione conta. Per questo, quando nel dicembre
2012 l’Espresso pubblica un articolo a firma di Lirio Abbate che svela in
anticipo l’inchiesta detta Mafia Capitale e attribuisce al Nero condanne per
droga e omicidi, Carminati s’infuria: “Finché mi dicono che sono il re di Roma
mi sta pure bene, come l’imperatore Adriano. Però sugli stupefacenti non
transigo. Lunedì voglio andare a parlare col procuratore capo e dirgli: se sono
il capo degli stupefacenti a Roma mi devi arrestare immediatamente”. Assistito
dall’avvocato Ippolita Naso, figlia di Giosué Bruno, cita per danni editore e
giornalista. L’articolo di “De-Lirio Abbate”, come lo ribattezza Naso pater,
alimenta l’ego di Carminati definito “arbitro di vita e di morte”, “unica
autorità in grado di guardare dall’alto quello che accade nella capitale”. Ma
poi l’articolista si spinge oltre e lo tira in ballo nel “business della
cocaina”. Il che, per il Carminati pensiero, equivale alla peggiore delle
infamie. E’ cresciuto nel mito volontaristico che non ammette dipendenze. L’uomo
vero è un soggetto nel pieno controllo di sé. La droga è robaccia per il “Mondo
di sotto”. Il casellario giudiziario di Carminati conferma la sua impostazione:
zero condanne per droga. Quanto al profilo del pluriomicida, in entrambi i
processi per l’assassinio del giornalista Carmine Pecorelli (presunto mandante
l’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti) Carminati è assolto. Il nome del
Nero rimbalza in “Romanzo Criminale”, nonché in diverse inchieste su servizi
segreti deviati e depistaggi di stragi. Sconta pure il carcere inseguito da
accuse poi falcidiate a colpi di archiviazioni e assoluzioni. “E’ la solita
mania tutta italiana di riscrivere la storia del paese in chiave giudiziaria –
commenta il legale Naso pater – Massimo non è un frate trappista ma con la mafia
non c’entra niente. Hanno tentato di coinvolgerlo nelle trame dei cosiddetti
‘misteri italiani’ privi di alcun esito giudiziario. Se non quello di rinverdire
il mito carismatico del Nero”. Una vita tra fiction e realtà. Fino all’ultimo
colpo di scena: Mafia Capitale. L’annuncio dell’“imminente scoperta” avviene nel
corso di un convegno del Partito democratico a opera del procuratore capo
Giuseppe Pignatone, magistrato stimatissimo che lo scorso sabato ha rilasciato
una corposa intervista al Sole 24 Ore per dettagliare sullo sviluppo
dell’inchiesta. Pignatone contesta il 416 bis perché è convinto che esista una
mafia autoctona, romanissima, dotata degli “indici rivelatori” della tipica
struttura associativa mafiosa. Pignatone vuole riuscire laddove gli inquirenti
fallirono nei confronti della banda della Magliana (per la quale l’aggravante
mafiosa fu esclusa dal giudice). “A quel punto – insinua maliziosamente Naso
pater – chi potrà negargli il posto di procuratore nazionale antimafia?”.
L’avvocato Naso filia ha coniato l’espressione “mafia parlata”: “Non ci sono
morti né feriti. Pullulano invece gli episodi di corruzione, estorsione… ma che
senso ha contestare il 416 bis?” L’imputazione mafiosa estende la gamma dei
mezzi investigativi disponibili, abbassa la soglia di gravità indiziaria,
consente una gestione dei detenuti più favorevole alla procura. Il ministero di
via Arenula ha disposto il 41 bis per l’indagato Carminati (non è ancora neanche
imputato), il che significa 23 ore in cella e una sola visita al mese per i
familiari. Chi lo conosce dubita che il “carcere duro” possa fiaccarlo nello
spirito ribaldo. Ma di certo una misura cautelare così rigida rende assai ardua
l’articolazione di una strategia difensiva. “Il 41 bis c’è anche a Rebibbia e a
Civitavecchia. Perché trasferirlo prima a Tolmezzo, in provincia di Udine, e poi
a Parma? Hanno sequestrato i conti suoi e dei familiari. Come farà a coprire
almeno le spese della difesa? – si domanda Naso pater – Non siamo messi nelle
condizioni materiali per difenderlo. Ma lo sa che hanno pedinato e intercettato
me e mia figlia per mesi? Persino durante i colloqui con il mio assistito, cosa
che è espressamente vietata dalla legge”. All’indomani dell’arresto avvenuto il
2 dicembre scorso, si consuma la prima “colossale buffonata”: un interrogatorio
di garanzia in cui Carminati dovrebbe rendere conto delle risultanze d’indagini
durate quattro anni e racchiuse in 80 mila pagine. Mentre i giornali ricamano
sulla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, manco fosse
un’implicita ammissione di colpa, gli avvocati che hanno ricevuto il malloppone
appena 12 ore prima dell’incontro con il gip, si tormentano: “Come facciamo a
consigliare al nostro assistito di rispondere se non abbiamo avuto il tempo di
vagliare le carte?”. L’ordinanza d’arresto di oltre 1.200 pagine, un compendio
d’intercettazioni telefoniche e ambientali, replica quasi testualmente l’istanza
dei pm “i quali, a loro volta, ricalcano l’ultima informativa dei carabinieri.
Il che vuol dire che non c’è più un controllo giurisdizionale sull’operato degli
investigatori”, sostiene Naso pater. Davanti al collegio del tribunale del
Riesame che potrebbe scarcerare Carminati ma non lo fa, Naso filia si scaglia
contro “i metodi di un’indagine ossessiva, quotidiana, mostruosa” e contro
un’imputazione, il 416 bis, che è “un calderone senza confini definiti in cui
rientra ogni tipo di condotta, secondo il pericoloso e subdolo schema
dell’argomentazione assiomatica”. Come un dogma. In effetti, le intercettazioni
andrebbero ascoltate oltre che lette. “Il tono conta – prosegue la giovane e
agguerrita Ippolita – E’ una manifestazione di spacconeria romana, un autentico
cazzeggio che sconfina nel turpiloquio. Come si può pensare che un mafioso
impartisca ordini imprecando seduto su una panchina con la gente che si volta a
guardarlo?”. L’ormai famigerata pompa di benzina è un palcoscenico a cielo
aperto. Di quale omertà parliamo? Carminati sa da tempo di essere pedinato e
intercettato. Con le telecamere installate presso il benzinaio di corso Francia
improvvisa siparietti da smargiasso rivolgendosi direttamente ai carabinieri:
“Che ne dite, oggi facciamo un’estorsione o un’usura?”. Quando telefona a Naso
filia, esordisce così: “Buongiorno, avvocato, sono il re di Roma”. Sembra una
barzelletta. Stando all’ipotesi accusatoria, mentre a Roma scorrono miliardi di
euro tra metropolitane e cantieri infiniti, Mafia Capitale si avventerebbe sul
bottino delle corruzioni municipali con funzionari disposti a vendersi per 400
euro… “Fateci delinquenti ma non cojoni”, confida un risentito Carminati
all’avvocato di una vita, Naso pater, all’indomani dell’episodio di
intimidazione denunciato da Lirio Abbate. “Ma davvero credono che per mettere
paura a un giornalista già scortato prendiamo un ventenne inesperto e lo
mettiamo a bordo di una Clio per speronare un’auto blindata?”. La reputazione
prima di tutto. “Forse ci siamo dimenticati che cos’è la mafia vera, come agisce
– commenta Naso pater – C’è indubbiamente un malcostume diffuso che riguarda
molte amministrazioni comunali. Ma è roba per “Striscia la Notizia” più che per
la procura di Roma”. Si spieghi meglio, avvocato. “Se volete c’è una cultura
mafiosa ma nessun metodo mafioso. E quella cultura mafiosa, se mi permette,
permea la realtà italiana a molti livelli: negli appalti, nell’università, nella
magistratura”. Attenzione che la incriminano. “Dico, e ripeto, che quando alcuni
incarichi direttivi in magistratura restano vacanti per mesi e anni perché i
capicorrente non si mettono d’accordo sulla spartizione dei posti, anche lì si
appalesa una logica spartitoria di stampo mafioso”. I legali sono pronti a dare
battaglia. Nessun giudizio abbreviato ma un processo vero, udienza per udienza.
Naso pater non esita a definire Carminati un “Robin Hood del XX secolo”: se
poteva aiutare qualcuno, non si risparmiava. Se occorreva sbloccare in
Campidoglio una pratica, che riguardasse gli affari suoi o di persone a lui
vicine, Carminati sapeva chi contattare. “Avete ridotto a questo stato la
politica per la quale tanti di noi sono morti? E adesso io vi uso”, era
l’atteggiamento sprezzante che il Nero riservava al mondo dei colletti bianchi e
dei politicanti all’ombra del Cupolone. Per il resto, conduceva una vita
morigerata e rigorosa con la sua compagna nella villetta di Sacrofano, una smart
e pochissime uscite, una grande passione per National Geographic, “Quark” e
SkyTg24. Banditi alcol e droghe. “Sa quante volte ha pagato le visite mediche
private a ex camerati e ai loro familiari?”, evidenzia Naso pater. E allora uno
si chiede come potesse mantenere un figlio ventenne a Londra e fare pure
beneficenza con le sole entrate del negozio della compagna. “Ricordiamoci che
del bottino del caveau è stata rinvenuta soltanto una minima parte”, si lascia
scappare l’avvocato. Il Nero le rapine non le ha rinnegate, se l’è appuntate al
petto come una medaglia al valore. Adesso che a 56 anni si ritrova per la prima
volta nella sua vita al 41 bis, sussurra impaziente al suo legale: “Fateci
fascisti ma non mafiosi”. Carminati invoca giustizia.
Per altri avvocati come i Naso, però, non è finita
bene.
Ora si racconta un fatto: un avvocato ha chiesto
il trasferimento del dibattimento per legittimo sospetto. Quando si parla di
“legittimo sospetto” ci si riferisce ad un presupposto applicativo dell’istituto
giuridico della rimessione dei processi. Quest’ultimo, attualmente contemplato
dall’art. 45 c.p.p., concretando una deroga a previsioni ordinarie in materia di
competenza, comporta, come noto, il trasferimento del processo da una ad altra
sede giudiziaria. Ratio ispiratrice del rimedio è la necessità di assicurare
l’imparzialità della decisione finale rispetto a fattori di turbativa
ambientale, capaci di incidere, dall’esterno, sulla regolarità processuale,
intaccando così la genuinità del verdetto definitivo. Di fatto l'istituto non è
stato mai applicato.
Anche perchè i magistrati, con l'ausilio della
stampa, sanno come far impedire la richiesta travisandone gli effetti.
Camorra, lesse proclama contro Cantone e
Cafiero de Raho: l’avvocato dei boss condannato a 5 anni e mezzo.
I giudici hanno assolto con la formula "per non aver commesso il fatto"
Francesco Bidognetti e l’altro esponente del clan di Casal di Principe, Antonio
Iovine. Come era già avvenuto nell'altro processo per diffamazione nei confronti
di Rosaria Capacchione e Roberto Saviano, scrive "Il Fatto Quotidiano" l'11
luglio 2016. “Un camorrista in toga”. Così il pm della dda di Napoli Sandro
D’Alessio definì Michele Santonastaso, ex difensore dei boss dei Casalesi
Francesco Bidognetti e Antonio Iovine, definì l’avvocato che il 13 marzo
2018 nell’aula del processo d’Appello Spartacus, il 13 marzo del lesse una
lettera-istanza per legittimo impedimento in cui venivano messi nel mirino
due giornalisti e due magistrati: Rosaria Capacchione e Roberto
Saviano, Raffaele Cantone (nella foto) e Federico Cafiero de Raho. Per la
diffamazione della giornalista de Il Mattino e ora senatrice Pd e per lo
scrittore Santonastaso è stato già condannato a un anno l’11 dicembre 2014, oggi
– a distanza di quasi un anno dalla requisitoria è arrivata la condanna per
diffamazione e calunnia nei confronti dell’attuale presidente dell’Autorità
nazionale anticorruzione e del procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero
de Raho. Il Tribunale di Roma lo ha condannato a 5 anni e sei mesi. I giudici
hanno assolto con la formula “per non aver commesso il fatto” lo stesso
Bidognetti e l’altro esponente del clan di Casal di Principe, Antonio Iovine.
Come era già avvenuto nell’altro processo. A Santonastaso i reati
contestati sono aggravati dal metodo mafioso. Il procedimento nato a Napoli è
giunto a Roma per competenza perché sia Cantone sia De Raho erano in servizio
alla Dda di Napoli all’epoca dei fatti. L’accusa aveva chiesto per tutti gli
imputati sei anni di reclusione. Il legale lesse a nome dei due boss (non
presenti in aula) una memoria in cui veniva messa in dubbio la serietà
dell’inchiesta chiedendo, quindi, il trasferimento del dibattimento per
legittimo sospetto. La lettera diffamatoria nei confronti dei magistrati
conteneva espressioni minacciose e accusava i pm “di essere in cerca di
pubblicità”. Nel documento venivano citati anche lo scrittore Saviano e
Capacchione. A Santonastaso inoltre un anno fa furono confiscati beni mobili e
immobili per 8 milioni di euro dai Carabinieri di Caserta e dagli agenti della
Dia di Napoli che notificarono anche una misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza della durata
di 4 anni. L’avvocato era stato arrestato due volte, nel settembre del 2010 e
nel gennaio del 2011, per avere commesso una serie di reati finalizzati ad
agevolare la fazione Bidognetti del clan dei Casalesi, il clan Cimmino e il clan
La Torre. Fu nell’udienza per chiedere la confisca dei beni – che l’11 dicembre
2014 – il pubblico ministero definì Santonastaso “camorrista in toga la cui
attività, iniziata negli anni ’90, ha avuto un’escalation culminata con la
lettura nell’aula del processo d’Appello Spartacus, il 13 marzo del 2008,
dell’istanza per legittimo impedimento in cui vengono messi nel mirino
due giornalisti e due magistrati, l’estremo tentativo dei Casalesi di
ricompattarsi come aveva fatto Cosa Nostra dopo l’omicidio di Salvo Lima”.
Le maldicenze dicono che i giornalisti sono le
veline dei magistrati. Allora, per una volta, facciamo parlare gli imputati.
Tribunale di Potenza. All’udienza tenuta dal
giudice Lucio Setola finalmente si arriva a sentenza. Si decide la sorte del dr.
Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber,
presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, conosciutissimo sul web. Ma
noto, anche, agli ambienti giudiziari tarantini per le critiche mosse al Foro
per i molti casi di ingiustizia trattati nei suoi saggi, anche con
interrogazioni Parlamentari, tra cui il caso di Sarah Scazzi e del caso Sebai, e
per le sue denunce contro l’abilitazione nazionale truccata all’avvocatura ed
alla magistratura. Il tutto condito da notizie non iscritte nel registro dei
reati o da grappoli di archiviazioni (anche da Potenza), spesso non notificate
per impedirne l’opposizione. Fin anche un’autoarchiviazione, ossia
l’archiviazione della denuncia presentata contro un magistrato. Lo stesso che,
anziché inviarla a Potenza, l’ha archiviata. Biasimi espressi con perizia ed
esperienza per aver esercitato la professione forense, fin che lo hanno
permesso. Proprio per questo non visto di buon occhio dalle toghe tarantine
pubbliche e private. Sempre a Potenza, in altro procedimento per tali critiche,
un Pubblico Ministero già di Taranto, poi trasferito a Lecce, dopo 9 anni, ha
rimesso la querela in modo incondizionato.
Processato a Potenza per diffamazione e calunnia
per aver esercitato il suo diritto di difesa per impedire tre condanne ritenute
scontate su reati riferiti ad opinioni attinenti le commistioni
magistrati-avvocati in riferimento all’abilitazione truccata, ai sinistri truffa
ed alle perizie giudiziarie false. Alcuni giudizi contestati, oltretutto, non
espressi dall’imputato, ma a lui falsamente addebitati. Fatto che ha indotto il
Giangrande per dipiù a presentare una istanza di rimessione del processo ad
altro Foro per legittimo sospetto (di persecuzione) ed a rivolgersi alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo. Rigettata dalla Corte di Cassazione e dalla Cedu,
così come fan per tutti.
Per dire: una norma scomoda inapplicata.
Processato a Potenza, secondo l’atto d’accusa, per
aver presentato una richiesta di ricusazione nei confronti del giudice di
Taranto Rita Romano in tre distinti processi. Motivandola, allegando la denuncia
penale già presentata contro lo stesso giudice anzi tempo. Denuncia sostenuta
dalle prove della grave inimicizia, contenute nelle motivazioni delle sentenze
emesse in diversi processi precedenti, in cui si riteneva Antonio Giangrande una
persona inattendibile. Atto di Ricusazione che ha portato nel proseguo dei tre
processi ricusati all’assoluzione con giudici diversi: il fatto non sussiste.
Questione rinvenibile necessariamente durante le indagini preliminari, ma
debitamente ignorata.
Ma tanto è bastato all’imputato, nell’esercitare
il diritto di difesa ed a non rassegnarsi all’atroce destino del “subisci e
taci”, per essere processato a Potenza. Un andirivieni continuo da Avetrana di
ben oltre 400 chilometri. Ed è già una pena anticipata.
L’avvocato della difesa ha
rilevato nell’atto di ricusazione la mancanza di lesione dell’onore e della
reputazione del giudice Rita Romano ed ha sollevato la scriminante del diritto
di critica e la convinzione della colpevolezza del giudice da parte
dell’imputato di calunnia. La difesa, preliminarmente, ha evidenziato motivi di
improcedibilità per decadenza e prescrizione. Questioni Pregiudiziali non
accolte. L’accusa ha ravvisato la continuazione del reato, pur essendo sempre un
unico ed identico atto: sia di ricusazione, sia di denuncia di vecchia data ad
esso allegata.
Il giudice Rita Romano,
costituita parte civile, chiede all’imputato decine di migliaia di euro di
danno. Imputato già di per sé relegato all’indigenza per impedimento allo
svolgimento della professione.
Staremo a vedere se vale la
forza della legge o la legge del più forte, al quale non si possono muovere
critiche. Che Potenza arrivi a quella condanna, dove Taranto dopo tanti
tentativi non è riuscita?
E anche stavolta, come decine
di volte ancora prima con accuse montate ad arte, non ci sono riusciti a
condannare il dr Antonio Giangrande. Il Dr Lucio Setola del tribunale di Potenza
assolve il dr Antonio Giangrande il 19 maggio 2016, alle ore 17, dopo
un’estenuante attesa dalla mattina da parte dell’imputato e dei sui difensori
l’avv. Pietrantonio De Nuzzo e l’avv. Mirko Giangrande.
La stessa cosa si ripete a
Taranto dove l’avv. Nadia Cavallo ha ripresentato una querela per diffamazione,
per un fatto già giudicato e da cui è scaturita assoluzione. La nuova querela
della Cavallo aveva prodotto un decreto penale di condanna emesso dal Gip
Giuseppe Tommasino senza contradditorio. La doverosa opposizione del difensore,
l’avv. Mirko Giangrande, per “ne bis in idem”, ossia non processato è condannato
per lo stesso fatto, portava al Giudizio Immediato presso il Tribunale di
Taranto da cui il 3 ottobre 2016 scaturiva ennesima sentenza di assoluzione.
Come si dice..."Cane non
mangia cane!". Toga non tocca toga e alla fine perdono sempre i cittadini.
Perché la
vera casta pericolosa non è quella della politica, è quella che non caccia i
tanti Scavo che ha in seno, scrive Alessandro Sallusti (la destra politica),
Sabato 14/05/2016, su "Il Giornale". A riprova che i magistrati non sono esseri
superiori, esenti dai limiti e vizi di noi comuni mortali, un importante
pubblico ministero di Roma, Francesco Scavo, titolare dell'inchiesta sui marò e
di quella sull'omicidio di Luca Varani, è stato processato dal Csm per molestie
sessuali nei confronti di alcune avvocatesse: apprezzamenti imbarazzanti a
sfondo sessuale, avance e «repentini palpeggiamenti». Dopo aver accertato i
fatti, che sanzione ha deliberato il Csm? Censura e trasferimento d'ufficio,
come giudice, al tribunale di Viterbo. Ora, qui non parliamo di un manager
sporcaccione o di un impiegato esuberante, ma di un magistrato. Cioè di un
professionista che avendo in mano le vite e i destini di altri uomini dovrebbe
dimostrare doti di equilibrio al di sopra di ogni sospetto. Doti evidentemente
incompatibili con il profilo psicologico di un molestatore seriale. Che
continuerà invece ad operare, non più come accusatore ma, peggio mi sento, come
giudice. Non voglio ironizzare in base a quali giudizi Francesco Scavo emetterà
le sue sentenze a carico di imputati magari difesi da giovani avvocatesse. Ma
dico che è come se un pilota trovato positivo al test antidroga, invece che
messo a terra venisse spostato a pilotare un aereo solo un po' più piccolo. Come
se un chirurgo alcolizzato fosse trasferito dal grande ospedale a uno di
provincia. Volereste su quell'aereo? Vi fareste curare in quell'ospedale? Penso
di no. E allora mi chiedo perché i cittadini di Viterbo debbano finire nelle
mani di un giudice poco equilibrato. E la risposta è una sola: la magistratura
italiana usa due pesi e due misure, a seconda che si tratti di noi o di loro, e
chissà quante volte accade perché il caso Scavo non è certo una eccezione. Se
Piercamillo Davigo, neo presidente dell'Associazione nazionale magistrati,
invece di dare dei ladri a tutti i politici e di considerare imprenditori e
cittadini colpevoli fino a prova contraria, facesse un bel po' di pulizia in
casa sua, il Paese ne avrebbe certamente maggiori benefici. Ma è come chiedere
al tacchino di anticipare il Natale. Perché la vera casta pericolosa non è
quella della politica, è quella che non caccia i tanti Scavo che ha in seno.
Storia di magistrati, di
malagiustizia e del popolo che paga sempre…Come un
magistrato viene beccato dalla polizia nei cessi di un cinema che fa un pompino
a un ragazzino ed esce dalla vicenda con una promozione che farà lievitare anche
gli stipendi dei suoi colleghi. Un costo da 70 milioni di euro all’anno…Il
“pompino” più caro della storia,
scrive Stefano Livadiotti (la
sinistra politica), giornalista del settimanale L’ ESPRESSO (tratto dal libro
“MAGISTRATI L’ULTRACASTA”). Un magistrato viene sorpreso in un cinema di
periferia, dove ha promesso soldi a un ragazzino per appartarsi con lui.
Scattano le manette e la sospensione dal lavoro. Poi, però, dopo tre gradi di
giudizio e grazie a un’amnistia, tutto è annullato. E il Consiglio superiore
della magistratura lo riabilita. Con una sentenza grottesca che fa impennare
gli stipendi di migliaia di suoi colleghi. Ecco i verbali segreti di tutta la
storia. Sono le 18 di un freddo pomeriggio di dicembre quando L.V., rispettabile
magistrato di corte d’appello con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
fa il suo ingresso nella sala dell’Ariel, un piccolo cinema all’estrema
periferia occidentale di Roma. Sullo schermo proiettano il film western La
stella di latta. Ma ad attirare Vostro Onore nel locale non sono certo le gesta
di John Wayne nei panni dello sceriffo burbero. No, a L.V., che ha ormai 41 anni
suonati, dei cow-boy non frega proprio un fico secco. Se si è spinto tanto fuori
mano è perché è in cerca di tutt’altro. Così, dopo aver scrutato a lungo nel
buio della platea, individua il suo obiettivo. E, quatto quatto, scivola sulla
poltroncina accanto a quella occupata dal quattordicenne I.M. Quello che succede
in seguito lo ricostruisce il verbale della pattuglia del commissariato di
Polizia di Monteverde che alle 19.15 raggiunge il locale su richiesta della
direzione. “Sul posto c’era l’appuntato di polizia G.P., in libera uscita e
perciò casualmente spettatore nel cinema, che consegnava ai colleghi
sopravvenuti due persone, un adulto e un minore, e indicava in una terza persona
colui che aveva trovato i due in una toilette del cinema. L’adulto veniva poi
identificato per il dottor L.V. e il minorenne per tale I.M. Il teste
denunciante era tale F.Z”. “L’appuntato G.P. riferiva che verso le 19,
mentre assisteva in sala alla proiezione del film, aveva sentito gridare dalla
zona toilette: “zozzone, zozzone, entra in direzione!”. Accorso, aveva
trovato il teste Z. che, indicandogli i due, affermava di averli poco prima
sorpresi all’interno di uno dei box dei gabinetti, intenti in atti di libidine.
Precisava, poi, lo Z. che, entrato nel vestibolo della toilette, aveva scorto i
due che si infilavano nel box assieme, richiudendovisi. Aveva allora bussato
ripetutamente, invitandoli a uscire, ma senza esito. Soltanto alla minaccia di
far intervenire la Polizia l’uomo aveva aperto, tentando di nascondere il
ragazzo dietro la porta.” “Il minorenne, a sua volta, raccontava che
verso le 18 era seduto nella platea del cinema intento a seguire il film quando
un individuo si era collocato sulla sedia vicina: poco dopo questi aveva
allungato un mano toccandogli dall’esterno i genitali. Egli aveva immediatamente
allontanato quella mano e l’uomo se n’era andato. Ma dopo dieci minuti era
ritornato, rinnovando la sua manovra. Questa volta egli aveva lasciato fare e
allora l’uomo gli aveva sussurrato all’orecchio la proposta di recarsi con lui
alla toilette, promettendogli del denaro. Egli s’era alzato senz’altro,
dirigendosi alla toilette, seguito dall’uomo. Entrati nel box, l’uomo gli aveva
sbottonato i calzoni, ed estratto il pene lo aveva preso in bocca.”
Adescare un ragazzino in un cinema è un fatto
che si commenta da solo. Che
a farlo sia poi un uomo di legge, o che tale dovrebbe essere, appare
inqualificabile. Ma non è solo questo il punto. Se i fatti si fermassero qui,
non potrebbero essere materia di questo libro. Invece, come vedremo, la storia
che comincia nella sala dell’Ariel giovedì 13 dicembre del 1973, per
concludersi ingloriosamente 8 anni dopo, va ben oltre lo squallido episodio di
cronaca. Per diventare emblematica della logica imperante almeno in una parte
del mondo della magistratura ordinaria (di cui esclusivamente ci occuperemo,
senza prendere in considerazione quelle contabile, amministrativa e militare).
Cioè, in una casta potentissima e sicura dell’impunità. Dove lo spirito di
appartenenza e l’interesse economico possono portare a superare l’imbarazzo di
coprire qualunque indecenza. Dove il vantaggio per la categoria finisce a volte
per prevalere su tutto il resto e l’omertà è la regola. Dove in certi casi
giusto la gravità dei comportamenti riesce a offuscare la loro dimensione
ridicola. Quel giorno, e non potrebbe essere altrimenti, V. viene dunque
arrestato. Vostro Onore cerca disperatamente di negare l’evidenza. S’arrampica
sugli specchi, raccontando di aver pensato che il ragazzino si sentisse male e
di averlo quindi seguito nel bagno proprio per assisterlo. Ma non c’è niente da
fare: l’istruttoria conferma la versione della polizia. Così, il Tribunale di
Grosseto rinvia a giudizio V. per “atti osceni e corruzione di minore”.
E, il 28 dicembre del 1973, si muove anche la sezione disciplinare del Csm,
l’organo di governo della magistratura, che lo sospende dalle funzioni.
V. sembra davvero un uomo finito.
Ma non è così. Il 21 gennaio del 1976, il verdetto
offre la prima sorpresa. Con il loro collega, i giudici toscani si dimostrano
più che comprensivi. Il tribunale della ridente cittadina dell’alta Maremma
ritiene infatti che, “atteso lo stato del costume”, l’atto compiuto da V. nella
sala del cinema vada considerato soltanto come contrario alla pubblica decenza.
Come, “atteso lo stato del costume”? Cosa succedeva all’epoca nei cinema
di Grosseto: erano un luogo di perdizione e nessuno lo sapeva? Boh. Andiamo
avanti: “Conseguentemente, mutata la rubrica nell’ipotesi contravvenzionale
di cui all’articolo 726 del codice penale, lo condanna alla pena di un mese di
arresto […] Per quanto poi riguarda la seconda parte dell’episodio, esclusa la
procedibilità ex officio, essendo ormai il fatto connesso con una
contravvenzione, proscioglie il V. per mancanza di querela dal delitto di
corruzione”. Ma il procuratore generale non è d’accordo, e questa è una
buona notizia per tutto il paese. E V., che pure dovrebbe fregarsi le mani,
neanche. Entrambi presentano ricorso. Si arriva così all’8 marzo del 1977,
quando a pronunciarsi è la corte d’appello di Firenze, che ribalta il precedente
giudizio. Ma lo fa a modo suo. Per i giudici di secondo grado, quelli di V. sono
atti osceni. Evviva. Però, siccome il primo approccio con il ragazzino è
avvenuto nella penombra e l’atto sessuale si è poi consumato nel chiuso del
gabinetto, il fatto non costituisce reato. V. se la cava quindi con una condanna
a 4 mesi, con la condizionale, per la sola corruzione di minori. E di nuovo, non
contento, ricorre, con ciò stesso dimostrando la sua incrollabile fiducia nella
giustizia. Assolutamente ben riposta, come dimostra il terzo atto della vicenda,
che va in scena due anni dopo, il 30 marzo del 1979: “La corte suprema,
infine […] annulla senza rinvio limitatamente al delitto di corruzione di
minorenne, a seguito dell’estinzione del reato in virtù di sopravvenuta
amnistia”. Amen. V. era definitivamente sputtanato davanti a tutti i
colleghi. Ma senza più conti in sospeso con la legge. E tanto bastava al Consiglio
superiore della magistratura (d’ora in avanti Csm), che il successivo
29 giugno revocava la sua sospensione, rigettando una richiesta in senso
contrario del procuratore generale della cassazione, perché “le circostanze
non giustificavano l’ulteriore mantenimento […] di una sospensione durata cinque
anni e mezzo”. A V. restava da superare solo un ultimo scoglio: il verdetto
della sezione disciplinare. Ed è proprio in quella sede che la storia assumerà i
toni più grotteschi. La sceneggiata finale, come racconta nel dettaglio la
sentenza finora inedita, scritta a macchina e lunga 12 pagine, si svolge il 15
maggio del 1981, quando si riunirono i magnifici 9 della giuria che deve
esaminare il dossier n. 294. Molti di loro faranno una carriera coi fiocchi. C’è
l’allora vicepresidente del Csm, che è addirittura Giovanni Conso, futuro
numero uno della consulta e ministro della giustizia, prima con Amato e poi
con Ciampi. C’è Ettore Gallo, che all’inizio degli anni novanta s’accomoderà
anche lui sul seggiolone di presidente della corte costituzionale. C’è Giacomo
Caliendo, che siederà poi nel governo di Silvio Berlusconi, con l’incarico di
sottosegretario alla giustizia. C’è Michele Coiro, che sarà procuratore generale
del Tribunale di Roma e poi direttore generale del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria. E ancora: i togati Luigi Di Oreste, Guido
Cucco, Francesco Marzachì e Francesco Pintor, e il laico Vincenzo Summa.
Chi pensa che in un simile consesso le parole siano misurate con
il bilancino è completamente fuori strada. Vista dall’esterno, la sede del Csm ha
perfino un che di lugubre, ma quando si riunisce la sezione disciplinare
l’atmosfera è più quella del Bagaglino. La sentenza offre un campionario
di spunti dalla comicità irresistibile. Come quello offerto dal medico di V.,
che lascia subito intendere quale incredibile piega potrà prendere la vicenda. “Veniva
anche sentito il medico curante, dottor G., che testimoniò di aver sottoposto
il V. a intense terapie nell’anno 1970 a causa di un trauma cranico riportato
per il violento urto del capo contro l’architrave metallico di una bassa porta.
Si trattava di ferita trasversale da taglio all’alta regione frontale, che il
medico suturò previa disinfezione. “ Vostro Onore, insomma,
aveva dato una craniata. E allora? “Benché fosse rimasto per dieci giorni
nell’assoluto prescritto riposo, il paziente accusò per vari mesi preoccupanti
disturbi, quali cefalee intense, sindromi vertiginose, instabilità dell’umore,
turbe mnemoniche. Le ulteriori terapie praticate diedero temporaneo sollievo, ma
vi furono frequenti ricadute, soprattutto di carattere depressivo, che si
protrassero fino al 1972 […] È emerso che la madre dell’incolpato è stata
ricoverata per 25 anni in clinica neurologica a causa di gravi disturbi.” Che
c’entra?”, direte voi. Tempo al tempo. Dopo quella del luminare, la seconda
chicca è la testimonianza dell’amico notaio. “All’odierno dibattimento sono
stati escussi sette testimoni, dai quali è rimasta confermata l’irreprensibilità
della vita dell’incolpato, prima e dopo il grave episodio, e soprattutto la
serietà dei suoi studi e del suo impegno professionale. In particolare,
il notaio dottor M. ha ricordato il fidanzamento del dottor V.con la sorella,
assolutamente ineccepibile sul piano morale per i quattro-cinque anni durante i
quali egli ha frequentato la famiglia. Il matrimonio non è seguito per ragioni
diverse dai rapporti tra i fidanzati, che sono anzi rimasti buoni amici.”
Par di capire, tra le righe, che V. non molestasse sessualmente la fidanzata. La
credibilità della qual cosa, alla luce della sua successiva performance con il
ragazzino, appare, questa sì, davvero solida. Nonostante le strampalate
deposizioni, gli illustri giurati sembrano decisi a
fare sul serio. E subito escludono in maniera categorica di poter credere alla
versione che il collega V., a dispetto di tutto, si ostina a sostenere. “I
fatti,” tagliano corto, “vanno assunti così come ritenuti dai magistrati
di merito dei due gradi del giudizio penale”. Poi, però, cominciano a
tessere la loro tela. “E tuttavia ciò che colpisce e stupisce, in tutta la
dolorosa e squallida vicenda, è la constatazione che l’episodio si staglia
assolutamente isolato ed estraneo nel lungo volgere di un’intera esistenza,
fatta di disciplina morale, di studi severi e di impegno professionale.”
Come diavolo abbiano fatto a stabilire che “l’episodio
si staglia assolutamente isolato”, i giurati lo sanno davvero solo loro. Ma
andiamo avanti. La prosa è zoppicante, però vale la fatica: “Tutto questo non
può essere senza significato e non può essere spiegato se non avanzando due
diverse ipotesi. O l’episodio ha avuto carattere di improvvisa e anormale
insorgenza, quasi di raptus, la cui eziologia va ricercata e messa in luce;
oppure se, al di sotto delle apparenze, sussiste effettivamente una natura
sessuale deviata o almeno ambigua, è doveroso stabilire perché mai essa si sia
rivelata soltanto e unicamente in quell’occasione, durante tutto il corso di
un’intera esistenza”. L’alto consesso propende, ça va sans dire, per la
prima delle due ipotesi. “Già […] i giudici penali avevano adombrato
suggestivamente, in presenza dei referti clinici, della deposizione del curante
e di quella del maresciallo S. che eseguì l’arresto, che la capacità di
intendere e di volere del V., al momento del fatto, doveva essere scemata a tal
punto da doversi ritenere ‘ridotta in misura rilevante’, e ciò – secondo i
giudici – “per una sorta di psicastenia, di una forma di malattia propria,
tale da alterare specialmente l’efficienza dei suoi freni inibitori contro i
suoi aberranti impulsi erotici’“. Poste le premesse, i giudici dei
giudici preparano il gran finale, citando il parere
pro veritate di due professori, scelti naturalmente dalla difesa di V. “Secondo
gli psichiatri […] l’episodio in esame, non soltanto costituisce l’unico
del genere, ma esso, anzi, ponendosi in netto contrasto con le direttive
abituali della personalità, è da riferirsi a quei fatti morbosi psichici che,
iniziatisi nel 1970, si trovavano in piena produttività nel 1973, all’epoca del
fatto. Durante il quale, pur conservandosi sufficientemente la consapevolezza
dell’agire, restò invece completamente sconvolta la ‘coscienza riflettente’,
cioè la rappresentazione preliminare degli aspetti etico-giuridici della
condotta da tenere e delle sue conseguenze. Il che ha reso inerte la volontà di
inibire quelle spinte pulsionali su cui il soggetto non riusciva più a esprimere
un giudizio di valore.” Tutta colpa, dunque, della “coscienza
riflettente”, che era andata in tilt. Ma come mai?
Chiaro: “Su tutta questa complessa situazione il trauma riportato nel 1970 ha
svolto un ruolo – secondo i clinici – di graduale incentivazione delle
dinamiche conflittuali latenti nella personalità, fino all’organizzazione della
sindrome esplosa nell’episodio de quo”. Vostro Onore, dunque, dopo la
zuccata è diventato scemo? Neanche per sogno. Lo è
stato, ma solo per un po’. “D’altra parte, poi, proprio l’alta drammaticità
delle conseguenze scatenatesi a seguito del fatto, unita alle ulteriori cure e
al lungo distacco dai fattori contingenti e condizionanti, hanno favorito il
completo recupero della personalità all’ambito della norma, come è testimoniato
dai successivi otto anni di rinnovata irreprensibilità.” Adesso
insomma Vostro Onore è guarito e può senz’altro rimettersi la toga. “Il che
comporta essersi trattato di un episodio morboso transitorio che ha compromesso
per breve periodo la capacità di volere, senza tuttavia lasciare tracce
ulteriori sul complesso della personalità.” Conclusione, in nome del
popolo italiano: “Il proscioglimento, pertanto, si
impone”. Addirittura. “La sezione assolve il dottor V. perché non
punibile avendo agito in istato di transeunte incapacità di volere al momento
del fatto”. Il procuratore se n’è fatta una ragione e non propone
l’impugnazione. Il futuro ministro non ha nulla da eccepire. Il collega che
siederà sullo scranno di presidente della consulta se ne sta muto come un pesce.
E, diligentemente, i giurati mettono la firma sotto una simile sentenza. Dove si
racconta la storiella di uno che ha sbattuto la testa e tre anni dopo è
diventato scemo e ora però non lo è più. A parte il fatto che una zuccata prima
o poi l’abbiamo presa tutti, magari pure Conso e Gallo, e qualcuno di noi da
piccolo è perfino caduto dalla bicicletta: ma non è che poi ci siamo messi
proprio tutti a dare la caccia ai ragazzini nei cinema di periferia. Il fatto
che la sezione disciplinare del Csm non sia esattamente un tribunale
islamico non è certo una notizia. Nel capitolo 3, intitolato Gli impuniti, ne
racconteremo davvero di tutti i colori. Ma il caso di V.è al di là di ogni
limite. Anche perché la sua storia non è rimasta sotto traccia come molte altre.
Al contrario, nel mondo della magistratura è diventata molto, ma proprio molto
popolare. Per un motivo semplicissimo, raccontato, nell’ottobre del 1994,
dall’avvocato ed ex parlamentare radicale Mauro Mellini, in Il golpe dei
giudici. Mellini sa bene quel che dice. Il libro lo ha infatti scritto quando
aveva appena lasciato il Csm, di cui era consigliere: “A conclusione
della vicenda V. non solo aveva ripreso servizio, ma era stato valutato
positivamente per la promozione a consigliere di cassazione, conseguendo però
tale qualifica con un ritardo di molti anni. E, avendo cumulato nel frattempo
molti scatti di anzianità sul suo stipendio di consigliere d’appello, si trovò
per il principio del trascinamento a portarsi dietro, nella nuova qualifica, lo
stipendio più elevato precedentemente goduto grazie a tali scatti e a essere
quindi pagato più di tutti i suoi colleghi promossi in tempi normali. Questi
ultimi, allora, grazie all’istituto del galleggiamento, ottennero un adeguamento
della loro retribuzione al livello goduto dal nostro magistrato”.
Come consigliere, Mellini aveva modo di accedere agli
archivi segreti del Csm. E così si era tolto la curiosità di fare due
conti. “Pare che tale marchingegno abbia comportato per lo stato un onere di
oltre 70 miliardi.” Tanto è costato ai cittadini italiani il caldo
pomeriggio del pedofilo in toga. Trasformato d’un colpo da reprobo a benefattore
dell’intera categoria. La domanda è inevitabile. Quando
hanno deciso di prosciogliere il collega, Lor Signori del Csm non avevano
a portata di mano un pallottoliere per fare due conti? O, al contrario, hanno
prosciolto V. proprio perché i conti li avevano fatti, eccome? La
risposta è arrivata nel 1993: il 29 settembre V. si è visto negare l’ultimo
passaggio di carriera, quello alle funzioni direttive superiori della
Cassazione. Eppure, i fatti sulla base dei quali è stato giudicato erano gli
stessi di prima. Sarà perché nel frattempo era stato abolito il galleggiamento?
E quindi nessuno avrebbe beneficiato di una sua ulteriore promozione?
PARLIAMO DI INGIUSTIZIA E MALAGIUSTIZIA.
Cos’è la Legalità: è la conformità alla legge.
Ancora oggi l’etimologia
di lex è incerta; i
più ricollegano effettivamente lex a legere, ma un’altra
teoria la riconduce alla radice indoeuropea legh- (il cui significato è
quello di “porre”), dalla quale proviene l’anglosassone lagu e, da qui,
l’inglese law.
Nella Grecia antica le leggi sono il simbolo della
sovranità popolare. Il loro rispetto è presupposto e garanzia di libertà per il
cittadino. Ma la legge greca non è basata, come quella ebraica, su un ordine
trascendente; essa è frutto di un patto fra gli uomini, di consuetudini e
convenzioni. Per questo è fatta oggetto di una ininterrotta riflessione che si
sviluppa dai presocratici ad Aristotele e che culmina nella crisi del V secolo:
se la legge non si fonda sulla natura, ma sulla consuetudine, non è assoluta ma
relativa come i costumi da cui deriva; dunque non ha valore normativo, e il
diritto cede il campo all'arbitrio e alla forza. La relazione che intercorre tra
il concetto di legge e il concetto di luogo è insito nell’etimologia del termine
greco nomos, che significa pascolo e che, progressivamente, dietro alla
necessaria consuetudine di legittimare la spartizione del “pascolo”, ha finito
per assumere questo secondo significato: legge. Ma nemein significa anche
abitare e nomas è il pastore, colui che abita la legge, oltre che il
pascolo; la conosce e la sa abitare. E nemesis è la divinità che si
accanisce inevitabilmente su coloro che non sanno abitare la legge.
Da qui il detto antico “qui la legge sono io”.
Conflittuale se travalica i confini di detto pascolo. Legge e luogo sono
intrinsecamente connessi. Infatti, la nemesi della legge è proprio quella
libertà commerciale che esige un’economia globale, che travalica tutti i
confini, che considera la terra come un unico grande spazio. Insieme ai paletti
di delimitazione degli stati sradica così anche la legge che li abita.
I greci, con Platone, avevano teorizzato l’origine
divina del nomos. Obbedire alle leggi della polis significava
implicitamente riconoscere il dio (nomizein theos) che si nasconde dietro
l’ethos originario.
La conclusione di entrambi i percorsi - quello
lungo e quello breve - dovrebbe condurre a definire la politica come scienza
anthroponomikè o scienza di amministrare gli esseri umani. Nómos
in greco significa "norma", "legge", "convenzione"; vuol dire "pascolo" e
nomeus vuol dire "pastore": il procedimento dicotomico sembra condurre
lontano dal nómos nel suo primo senso, a far intendere l'antroponomia
come l'arte di pascolare gli uomini.
Cicerone adotta l’etimologia di lex da legere,
non perché la si legge in quanto scritta, bensì perché deriva dal verbo
legere nel significato di “scegliere”.
“Dicitur enim lex a ligando, quia obligat
agendum”, Questa etimologia di “legge” si trova all’inizio della celebre
esposizione di Tommaso d’Aquino sulla natura della legge, presente nella Summa
theologiae.
Da qui il concetto di legge: “la legge è una
regola o misura nell’agire, attraverso la quale qualcuno è indotto ad agire o vi
è distolto. Legge, infatti, deriva da legare, poiché obbliga ad agire.”
Il termine italiano legge deriva da legem,
accusativo del latino lex.
Lex significava originariamente norma, regola di
pertinenza religiosa.
Queste regole furono a lungo tramandate a memoria,
ma la tradizione orale - che implicava il rischio di travisamenti - fu poi
sostituita da quella scritta.
Sono così giunte fino a noi testimonianze preziose
come le Tavole Eugubine, una raccolta di disposizioni che riguardavano sacrifici
ed altre pratiche di culto dell’antico popolo italico di Iguvium, l’attuale
Gubbio.
A Roma, in età repubblicana, vennero promulgate ed
esposte pubblicamente le Leggi delle Dodici Tavole, che si riferivano non più
solamente a questioni religiose: il termine lex assunse così il valore di norma
giuridica che regola la vita e i comportamenti sociali di un popolo.
Sul finire dell’età antica l’imperatore
Giustiniano fece raccogliere tutta la tradizione legislativa e giuridica romana
nel monumentale Corpus Iuris, la raccolta del diritto, che ha costituito la base
della civiltà giuridica occidentale.
Dalla riscoperta del Corpus Iuris sono state
costituite circa mille anni fa le Facoltà di Legge - cioè di Giurisprudenza e di
Diritto - delle grandi università europee, nelle quali si sono formati i
giuristi, ovvero gli uomini di legge di tutta l’Europa medievale e moderna.
La parola legge è divenuta sinonimo di diritto,
con il valore di complesso degli ordinamenti giuridici e legislativi di un
paese.
In questo senso oggi la Costituzione italiana
sancisce che la legge è uguale per tutti, e afferma la necessità per ogni
persona di una educazione al rispetto della legalità: una società civile deve
fondarsi sul rispetto dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini che trovano
nelle leggi le loro regole.
Per millenni, tuttavia, il concetto di legge è
stato collegato esclusivamente ad ambiti religiosi o sacrali, e per alcuni
popoli ancora oggi all’origine delle leggi vi è l’intervento divino.
Pensiamo agli ebrei, per i quali la Legge - la
Thorà nella lingua ebraica - è senz’altro la legge divina, non soltanto in
riferimento ai Comandamenti consegnati dal Signore a Mosè sul monte Sinai - la
legge mosaica - ma in generale a tutta la Bibbia, considerata come
manifestazione della volontà divina che regola i comportamenti degli uomini.
Anche i Musulmani osservano una legge - la legge
coranica - contenuta in un testo sacro, il Corano, dettato da Dio, Allah, al suo
profeta Maometto.
Una legalità fondata sulla giustizia è dunque
l’unico possibile fondamento di una ordinata società civile, e anche una delle
condizioni fondamentali perché ci sia una reale difesa della libertà dei
cittadini di ogni nazione.
Dura lex, sed lex:
la frase, tradotta dal latino letteralmente, significa dura legge, ma legge.
Più propriamente in italiano: "La legge è dura, ma è (sempre) legge" (e quindi
va rispettata comunque).
Chi vive ai margini della legge, o diventa
fuorilegge, si pone al di fuori della convivenza civile e va sottoposto ai
rigori della legge, cioè a una giusta punizione: in nome della legge è proprio
la formula con cui i tutori dell’ordine intimano ai cittadini di obbedire agli
ordini dell’autorità, emanati secondo giustizia.
Il giusnaturalismo (dal latino ius
naturale, "diritto di natura") è il termine generale che racchiude
quelle dottrine filosofico-giuridiche che affermano l'esistenza di un diritto,
cioè di un insieme di norme di comportamento dedotte dalla "natura" e
conoscibili dall'essere umano.
Il giusnaturalismo si contrappone al cosiddetto
positivismo giuridico basato sul diritto positivo, inteso quest'ultimo come
corpus legislativo creato da una comunità umana nel corso della sua evoluzione
storica. Questa contrapposizione è stata efficacemente definita "dualismo".
Secondo la formulazione di Grozio e dei teorici
detti razionalisti del giusnaturalismo, che ripresero il pensiero di Tommaso
d’Aquino, attualizzandolo, ogni essere umano (definibile oggi anche come ogni
entità biologica in cui il patrimonio genetico non sia quello di alcun altro
animale se non di quello detto appartenente alla specie umana), pur in presenza
dello stato e del diritto positivo ovvero civile, resta titolare di diritti
naturali, quali il diritto alla vita, ecc. , diritti inalienabili che non
possono essere modificati dalle leggi. Questi diritti naturali sono tali perché
‘razionalmente giusti’, ma non sono istituiti per diritto divino; anzi, dato Dio
come esistente, Dio li riconosce come diritti proprio in quanto corrispondenti
alla “ragione” connessa al libero arbitrio da Dio stesso donato.
*****
INGIUSTIZIA E MALAGIUSTIZIA, OSSIA GIUSTIZIA
NON UGUALE PER TUTTI.
Difficilmente si
troverà nel mondo editoriale un’opera come questa: senza peli sulla lingua (anzi
sulla tastiera). Nell’affrontare il tema della Giustizia non si può non parlare
dei tarli che la divorano e che generano Ingiustizia e Malagiustizia.
LA
MALAGIUSTIZIA,
oggetto della presente opera, è la disfunzione ed i disservizi
dell’amministrazione della Giustizia che colpiscono la comunità: sprechi,
disservizi, insofferenza che provocano sfiducia verso le istituzioni ed il
sistema. Quindi si può dire che la Malagiustizia è la causa dell’Ingiustizia.
L’INGIUSTIZIA
è l’effetto che la malagiustizia opera sui cittadini: ossia le pene, i sacrifici
e le sofferenze patite dai singoli per colpa dell’inefficienza del Sistema
sorretto e corrotto da massonerie, lobbies e caste autoreferenziali attinti da
spirito di protagonismo e con delirio di onnipotenza: giudicanti, ingiudicati,
insomma, CHE NON PAGHERANNO MAI PER I LORO ERRORI e per questo, sostenuti dalla
loro claque in Parlamento, a loro si permette di non essere uguali, come tutti,
di fronte alla legge!!!
Troppi giudici impreparati? Serve un
intervento legislativo per riformare l'accesso alla magistratura.
Sono diventati forse troppi gli errori giudiziari per non porsi
il problema di una riforma dei criteri di accesso all'esame da magistrato,
scrive Annamaria Villafrate su “Studio Castaldi”. Concorso in magistratura:
desiderio di molti alla portata di pochi? Probabilmente no. Dato che vi può
partecipare anche chi si è laureato a fatica e dopo una serie infinita di 18. E
le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Da diversi anni fanno notizia
anche sui media errori grossolani delle prove scritte degli aspiranti giudici,
una professione complessa che richiederebbe molto studio e impegno. In Italia
avvocati, giuristi e cittadini denunciano la gravissima situazione di incertezza
del diritto. Soggetti condannati per il reato di omicidio in primo grado,
magicamente assolti in appello. Sentenze con motivazioni e dispositivi spesso
frutto di un veloce copia e incolla. La giustizia italiana è affidata tal volta
a magistrati degni di grande rispetto, altre volte però a decidere delle sorti
di un giudizio vi sono magistrati che farebbero bene a rimettere mano allo
studio di manuali e codici di procedura. Che vi sia una grossa fetta di
magistrati dalla scarsa preparazione oramai è sotto gli occhi di tutti ed è
anche attestata dal quotidiano ribaltamento di sentenze di merito da parte della
Corte di Cassazione che fin troppo spesso è costretta a intervenire per
correggere errori talvolta "imbarazzanti". Proviamo soltanto ad accedere al CED
della Cassazione nella pagina in cui è possibile visualizzare le sentenze per
esteso (italgiure.giustizia.it/sncass/) e a digitare le parole virgolettate
"cassa la sentenza impugnata": rimarremo sorpresi di quante sentenze vengono
quotidianamente bocciate dalla Suprema Corte a conferma del fatto che i giudizi
di merito sono spesso, anzi troppo spesso, decisi in modo inaffidabile. Cosa
dire poi dei continui e destabilizzanti contrasti giurisprudenziali? Identiche
questioni giuridiche risolte con sentenze diametralmente opposte in diversi
ambiti territoriali e che costringono la Corte di legittimità a un surplus di
lavoro per fare chiarezza. Senza parlare del problema che si crea alla "certezza
del diritto" che sta sempre più somigliando a un miraggio. Il ruolo del
magistrato è senza dubbio molto delicato. Le sue decisioni possono incidere
profondamente sulla vita delle persone. Una sentenza penale errata o basata su
un'analisi superficiale dei fatti può privare un individuo della propria
libertà. Mentre una sentenza civile può incidere sugli equilibri privati di una
coppia o portare alla rovina economica un intero nucleo familiare, un'azienda o
un'impresa. Come possiamo dunque accettare che si commettano così tanti errori e
che ci sia così tanta incertezza? Un problema di questa portata si potrebbe
anche risolvere con due interventi da mettere in campo:
1) Redigere testi di legge più chiari e non
soggetti ad interpretazione. Il linguaggio giuridico è ancora troppo complesso e
solleva troppi dubbi interpretativi. E a peggiorare la comprensibilità delle
norme è poi la copiosa presenza di continui rinvii ad altri testi di legge e
l'assenza d'interpretazioni autentiche da parte del legislatore. Non è
infrequente che dopo l'emanazione di una nuova legge, decreto o regolamento, gli
addetti ai lavori manifestino dubbi in merito alla concreta applicabilità delle
nuove disposizioni alle fattispecie concrete.
2) Garantire un maggiore livello di preparazione
dei magistrati. Un simile risultato è conseguibile anche introducendo, per
legge, un filtro efficace per fare accedere al concorso solo i più meritevoli.
Possiamo davvero permetterci di consentire l'accesso all'esame anche studenti
che non abbiano un curriculum scolastico di tutto rispetto? Non è troppo
delicato il compito affidato a chi diventerà poi magistrato? Una maggiore
competenza della magistratura si può ottenere solo attraverso una preventiva
severa selezione.
Tutto questo nella speranza che si possa tornare a
ciò che accadeva in passato, quando, come scriveva Calamandrei, un avvocato non
doveva preoccuparsi di "insegnare ai giudici quel diritto, di cui la buona
creanza impone di considerarli maestri".
Quei 44 ergastolani ostaggio
dell'antimafia populista, scrive Giuseppe Rossodivita
il 5 settembre 2016 su "Il Dubbio". "Boss e stragisti al Congresso dei Radicali?
Provocazione spudorata". Così il titolo di un articolo su Il Fatto Quotidiano di
qualche giorno fa che, come rivendicato successivamente dalle colonne dello
stesso giornale, ha bloccato il trasferimento da parte del Dap (Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria), di 44 ergastolani presso il carcere di Rebibbia
per consentirgli di partecipare al 40° Congresso (da qualche ignorante chiamato
raduno) del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Bene,
l'Italia è salva, viva Il Fatto Quotidiano. Purtroppo, al di là delle
autocelebrazioni del giornale di Travaglio, non è così. La vicenda è invece
paradigmatica di una sottocultura che ha condizionato negativamente la crescita
di un paese che sul punto da anni non compie altro che passi indietro. Sulla
spinta di questa sottocultura populista e che fonda il proprio successo
sull'ignoranza, madre e padre delle paure di chi in questa condizione viene
mantenuto, l'Italia non solo non è salva, ma sta messa decisamente male. Allora
cerchiamo di fare un po' di informazione, quella che, come da prassi in questi
casi, è stata fatta scientificamente mancare. Il trasferimento dei detenuti
ergastolani, diversi ex 41 bis, era stato richiesto nell'ambito di un progetto
cui questi detenuti hanno aderito denominato "Spes contra Spem", che si potrebbe
tradurre con la frase per cui non basta avere speranza ma occorre essere
speranza, farsi speranza in prima persona, con il proprio agire quotidiano, come
ripetuto quasi ossessivamente negli ultimi anni da Marco Pannella. Con tutti
questi detenuti si sono tenuti diversi incontri, ai quali anche chi scrive ha
partecipato, quale Segretario del Comitato Radicale per la Giustizia Piero
Calamandrei che affianca Nessuno Tocchi Caino nella battaglia volta a far
accertare l'incostituzionalità dell'ergastolo cosiddetto "ostativo". Cos'è
l'ergastolo ostativo? È quell'ergastolo che esiste, ma che per finalità ora
editoriali, ora elettorali, viene negato che esista. Se chiedete ad un passante
per strada com'è l'ergastolo in Italia, vi risponderà che in Italia l'ergastolo
non c'è, perché tanto prima o poi tutti escono di galera. Ovviamente non è così,
ma far credere il contrario alimenta paure che poi determinano vendite di
giornali e consensi elettorali per chi si propone come salvatore della patria,
essendone invece il boia. L'ergastolo ostativo è quell'ergastolo che viene
comminato per aver commesso particolari tipi di delitti di mafia, che
impediscono di godere di qualsiasi beneficio penitenziario legato ad un percorso
di rieducazione e reinserimento. L'ergastolo ostativo è quell'ergastolo che
porterà queste persone, un migliaio circa, ad uscire di galera, come si usa dire
con cruda espressione, solamente "con i piedi in avanti". È la morte per pena,
molto simile alla pena di morte. A meno che non barattino la loro vita con
quella di qualcun'altro: potrebbero uscire vivi, gli ergastolani ostativi, solo
se "collaborando" facciano chiamate di reità nei confronti di altri. Solo a quel
punto le porte del carcere si potrebbero aprire. Ma "collaborare" nell'unico
modo oggi preso in considerazione dallo Stato, facendo cioè incarcerare altri,
non sempre è possibile, magari anche volendolo, per mille diverse ragioni, basti
pensare alle ritorsioni nei confronti di figli e familiari tipici della
criminalità organizzata. Senza contare che una "collaborazione" determinata da
motivi egoistici non morire in carcere non necessariamente risulta sincera o
veritiera, potendo rivelarsi calunniosa e non necessariamente restituisce alla
società una persona migliore: ma questo ai Travaglio d'Italia non interessa,
interessando loro solo la certezza della virile vendetta dello Stato, anche se
contraria alla Costituzione. Il punto però è che il problema di questi detenuti
è un problema del nostro Paese. Con il sistema attuale le mafie prosperano. È un
dato di fatto. La storia e la cronaca testimoniano che le mafie non si
sconfiggono solo a colpi di sentenze: per ogni mafioso condannato altre giovani
leve sono pronte a prenderne il posto, essendo cresciute nel loro mito. Ciò che
alimenta le mafie è una vera e propria sottocultura, che trae la sua forza dalle
deteriori condizioni economiche, sociali e culturali in cui larghe fette di
Paese vengono mantenute, anzitutto dalle mafie stesse, anche quando indossano il
"vestito buono" della politica politicante. I 44 detenuti iscritti al Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito sono stati assassini e
stragisti, ciascuno almeno venti se non trenta anni fa. Ora sono altro, lo sono
divenuti giorno dopo giorno, nei venti o trent'anni di reclusione che hanno
subito e vorrebbero poter esser testimoni e testimonial di una
dissociazione come quella che portò alla sconfitta del terrorismo che lo Stato
invece sino ad ora si ostina a non prendere in alcuna considerazione. Per lo
Stato o collabori o muori in carcere: questo è il modello fallimentare con cui
combattere i fenomeni mafiosi. Il messaggio culturale che questi 44 detenuti
potrebbero invece lanciare e avrebbero potuto lanciare dal Congresso del
Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito - è dirompente,
soprattutto nei loro territori di provenienza, soprattutto per quelle giovani
leve che oggi li considerano come esempi in quanto boss, killer o stragisti: la
cultura mafiosa è sbagliata, è sottocultura, c'è un altro modo per poter vivere
da uomini e donne in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia ed è un modo
che ripudia quella sottocultura mafiosa e sposa la legalità su cui solo si può
fondare la pacifica e civile convivenza, quella legalità che solo lo Stato può
garantire. Firmato ex boss ed ex assassini di mafia. Così, ancora una volta, la
sottocultura dell'antimafia populista e di facciata si è contrapposta ad
un'altra sottocultura, quella mafiosa. È il Paese, e non certo i Radicali o i 44
detenuti, ad aver perso un'occasione. Per ora. Perché essere speranza di lotta
alla mafia - come hanno voluto essere con il coraggio civile maturato in decenni
di detenzione questi 44 detenuti - significa non stare lì ad aspettare che
qualcun'altro combatta la mafia per loro o per noi, magari solo con quegli
strumenti messi in campo sino ad oggi e che hanno garantito alle mafie, come
alle antimafie di facciata, lunga vita e prosperità.
Giustizia digitale, chiusa per ferie,
scrive Guido Scorza il 22 luglio 2016 su “L’Espresso”. “A far data dal 21 luglio
e sino al 7 settembre 2016 sarà consentito il solo deposito in maniera cartacea
degli atti urgenti con esclusione del deposito telematico stante l’impossibilità
a riceverli da parte del personale amm.vo e del magistrato titolare in quanto
assenti per ferie”. Recita letteralmente così un avviso, firmato dal Presidente
della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli e rivolto a tutti i curatori
delle procedure fallimentari. A leggerlo verrebbe da ridere se il funzionamento
della Giustizia non fosse così importante sul piano economico e su quello
democratico. Una manciata di righe piene zeppe di contraddizioni che sembrano,
per davvero, lo scherzo di un burlone che ha rigirato il senso di una
comunicazione con la quale si intendeva dire l’opposto ovvero che, in estate,
per consentire a personale amministrativo ed a magistrati di prendere visione
degli atti, anche se fuori dall’ufficio, il loro deposito deve necessariamente
avvenire solo per via telematica. Eppure è tutto drammaticamente vero. Il
Presidente di una Sezione di un Tribunale importante come quello di Napoli è
costretto – perché è difficile credere che se non costretto, qualcuno sarebbe
riuscito a concepire una regola tanto apparentemente illogica – a mettere nero
su bianco che il tanto decantato processo civile telematico è chiuso per ferie e
che durante i mesi estivi si ritorna alla sana e vecchia carta. Ma più che il
divieto di procedere al deposito per via telematica, ciò che lascia davvero
senza parole è la sua motivazione: “stante l’impossibilità a riceverli da parte
del personale amm.vo e del magistrato titolare in quanto assenti per ferie”.
Impossibile resistere alla tentazione di leggere e rileggere questa motivazione
nella convinzione – o, almeno, nella speranza – di aver capito male e che il
senso sia esattamente l’opposto. Può essere difficile – e, forse, persino
impossibile - ricevere un atto depositato in forma cartacea ma come fa a
considerarsi impossibile, nel 2016, ricevere un atto trasmesso per via
telematica? Sarebbe intellettualmente disonesto però puntare l’indice contro il
Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli – che, per inciso,
non è certamente né il primo, né l’unico ad aver dovuto stabilire certe regole –
dimenticando che, evidentemente, se si arriva a certi tragicomici epiloghi è
perché, ad oltre tre lustri dall’entrata in vigore della prima disciplina sul
processo civile telematico, sistemi ed interfacce continuano ad essere
disegnati, progettati ed implementati in modo tale da complicare la vita agli
utenti del sistema giustizia anziché semplificarla. Che la giustizia digitale
debba chiudere per ferie prima e più di quella cartacea è, veramente, una
barzelletta dal retrogusto amaro. [Grazie a Matteo G.P. Flora per la
segnalazione]
La diseguaglianza della giustizia,
scrive Michele Ainis il 22 luglio 2016 su "La Repubblica". La Giustizia è un
treno a vapore. Ma non tutte le tratte ferroviarie sono lente, non tutti i
convogli procedono a passo di lumaca. Dipende dai macchinisti, dipende inoltre
dai binari: come mostra l'analisi dei dati pubblicata oggi su questo giornale,
la velocità dei tribunali cambia notevolmente da un angolo all'altro del nostro
territorio. E alle deficienze s'accompagnano, talvolta, le eccellenze. Solo che
gli italiani non lo sanno, non conoscono le performance dei diversi uffici
giudiziari. È un paradosso, giacché nella società online siamo tutti nudi come
pesci. Un clic in Rete e puoi scoprire usi e costumi del tuo vicino di casa, del
collega d'ufficio, del compagno di banco. Sono nude anche le amministrazioni
pubbliche, da quando un profluvio di decreti ha reso obbligatoria
l'"Amministrazione trasparente": quanto guadagna il Capo di gabinetto e dov'è
situato il gabinetto, nulla più sfugge ai controlli occhiuti dell'utente. Anzi:
il "decreto Trasparenza" del ministro Madia ha appena introdotto l'istituto
dell'accesso civico, permettendo a ciascun cittadino d'accedere - senza alcun
onere di motivazione - ai dati in possesso delle amministrazioni locali e
nazionali, dal comune di Roccacannuccia alla presidenza del Consiglio. Sennonché
troppe informazioni equivalgono di fatto a nessuna informazione. Dal pieno nasce
il vuoto, come mostra la condizione del diritto nella patria del diritto:
migliaia di leggi, migliaia di regole che si contraddicono a vicenda, sicché in
ultimo ciascuno fa come gli pare. Anche l'eccesso di notizie offusca le notizie,
le sommerge in una colata lavica. E spesso ci impedisce di trovare l'essenziale,
l'informazione di cui abbiamo bisogno per davvero. Quando c'è, naturalmente.
Perché talvolta manca proprio l'essenziale. Un esempio? La giustizia, per
l'appunto. Grande malata delle nostre istituzioni, su cui s'addensa - di nuovo -
un fiume di libri, analisi, commenti. Per lo più autoreferenziali, come i temi
su cui discetta la politica: di qua la separazione delle carriere fra giudici e
pm, oppure i tempi della prescrizione; di là un estenuante contenzioso sulla
legge elettorale. Ma è davvero questo che interessa ai cittadini? Un bel saggio
appena pubblicato dal Mulino (Daniela Piana, Uguale per tutti?, 226 pagg., 20
euro) rovescia l'usuale prospettiva. L'eguaglianza davanti alla legge - osserva
infatti la sua autrice - è il caposaldo dello Stato di diritto. Ne discende, a
mo' di corollario, che l'applicazione delle leggi sia sempre impersonale, dunque
garantita da giudici obiettivi e indipendenti, senza oscillazioni, senza
asimmetrie fra i tribunali. Ma non è così, non è questa la norma. Perché, di
fatto, in Italia vige una forte diseguaglianza nell'accesso alla giustizia,
nelle opportunità di tutela dei diritti. Dipende dalla discontinuità del nostro
territorio, dalla forbice socio-economica che divide Mezzogiorno e Settentrione.
Dipende da storture organizzative ma altresì comunicative, psicologiche.
Insomma, non basta misurare l'universo normativo per misurare la giustizia.
Conta piuttosto la percezione dei cittadini, che a sua volta deriva da fattori
extragiuridici, esterni alla dimensione del diritto. Quanto sia complicato, per
esempio, raggiungere i tribunali, orientarsi al loro interno, prelevarne
documenti. Come tradurli nella lingua che parliamo tutti i giorni. Il costo
d'ogni causa. La percentuale di successo dei diversi avvocati che operano nello
stesso territorio. Quando verrà fissata l'udienza per una procedura di divorzio
o per il recupero d'un credito. Quale sia la probabilità di soccombere in una
controversia civile, rispetto alle statistiche di quel particolare ufficio
giudiziario. I tempi dei processi del lavoro, delle liti condominiali, delle
cause di sfratto. Sono queste le informazioni essenziali, è questo che interessa
al cittadino prima di bussare al portone della legge. Se non so come funziona il
tribunale della mia città, non potrò avvalermene per tutelare i miei diritti.
Oppure dovrò farlo al buio, tirando in aria i dadi. Da qui una richiesta, anzi
un'ingiunzione in carta bollata: fateci sapere. Scrivete tutti questi dati sui
siti web dei tribunali, cancellando il sovrappiù che genera soltanto confusione.
O lo fate già? Magari ci siamo un po' distratti, meglio controllare. Con
un'indagine a campione fra tre tribunali di provincia, al Sud, al Centro, al
Nord. Messina: che bello, qui c'è un link su "Amministrazione trasparente". Ci
guardi dentro, però trovi soltanto l'indice di tempestività dei pagamenti ai
fornitori. Meglio che niente, ma per te che non sai ancora se intentare causa è
niente. Rieti: l'immagine d'un edificio anonimo, qualche sommaria informazione.
In compenso tutti i dettagli sulla festività del Santo Patrono. Parma: niente
anche qui, tranne una carrellata d'udienze rinviate. E un servizio
indispensabile: il Servizio di anticamera del Presidente del Tribunale. A questo
punto blocchi il mouse, però prima d'arrenderti non rinunci a visitare il sito
del palazzo di giustizia più famoso: Milano. Più che un tribunale, un tempio,
dove la seconda Repubblica (con Tangentopoli) ricevette il suo battesimo.
Strano, proprio lì manca una foto del palazzo, che resta perciò invisibile ai
fedeli. Tuttavia c'è una lieta sorpresa: il link con tutte le tabelle sugli
arretrati del tribunale milanese, nonché sulle politiche intraprese per
smaltirli. Peccato che i dati siano fermi al 2010, quando al governo c'era
ancora Berlusconi, quando il papa si chiamava Benedetto XVI. Ma dopotutto si
tratta d'un esercizio di coerenza: nella giustizia italiana è in arretrato pure
l'arretrato.
I giudici arroccati nelle loro “garanzie”
rendono la legge diseguale per tutti. Orlando sulla
prescrizione e un libro della politologa Piana, scrive Marco Valerio Lo Prete il
28 Giugno 2016 su "Il Foglio”. Ieri il ministro della Giustizia, Andrea Orlando,
in visita ad alcuni uffici giudiziari siciliani, ha detto che “non esiste un
nord e un sud nell’ambito della giustizia”. E quella che a una prima lettura
potrebbe apparire come una carezza buonista a tutto il sistema, contiene in
realtà un messaggio critico che gli addetti ai lavori hanno carpito. “Dalle
performance legate alle prescrizioni, emerge che nello stesso paese, con le
stesse leggi e spesso anche con le stesse condizioni materiali, ci sono uffici
che hanno, rispetto ai procedimenti sottoposti, il 30-40 per cento di
prescrizioni e altri che stanno sotto il 2 o l’1 per cento. E anche in questo
caso non sono le solite Trento e Bolzano, che vengono sempre citate come realtà
virtuose: sono spesso, invece, uffici del Mezzogiorno, uffici di frontiera che
però sono in grado di dare una risposta perché nel corso del tempo hanno
prodotto elementi di innovazione organizzativa”, ha detto Orlando. In altre
parole: cari magistrati, rimboccatevi le maniche, perché tante delle attuali
disfunzioni del pianeta giustizia non sono colpa del governo ladro ma dipendono
da voi. E’ questa una delle riflessioni al centro dell’ultimo libro della
politologa Daniela Piana, pubblicato dal Mulino e intitolato “Uguale per tutti?
Giustizia e cittadini in Italia”. Con linguaggio scientifico, quasi asettico, la
studiosa dell’Università di Bologna mette in dubbio che l’uguaglianza di fronte
alla legge sia oggi garantita a tutto tondo nel nostro paese. Con indagini sul
campo e dati alla mano, l’autrice sottolinea infatti che “il diritto garantisce”
ma “la funzione rende reale ed effettiva tale garanzia. Fra il diritto e la
funzione (rendere giustizia) intervengono diversi fattori”, che a loro volta
influenzano “quelle variabili che rendono diseguale o potenzialmente diseguale
l’accesso alla giustizia resa al cittadino e alla collettività”. Un procedimento
di diritto del lavoro viene definito nel distretto di Milano in 280 giorni in
media (meno di 10 mesi), contro i 1.371 giorni di media (quasi quattro anni) nel
distretto di Bari; allo stesso tempo, all’interno del distretto di Milano, una
causa di diritto della famiglia si chiude in 142 giorni a Busto Arsizio e 258
giorni a Milano, poi – nel distretto di Bari – in 447 giorni a Foggia e in 536
giorni a Trani. Per la politologa Piana “non trova riscontro nella realtà dei
fatti” l’ipotesi che “maggiore è il numero dei magistrati che lavorano in un
tribunale, maggiore la performance e minore il numero di giorni per definire i
procedimenti”. Infatti “ad Ancona la scopertura dell’organico togato è del 17
per cento, mentre a Belluno del 18 per cento. I tempi medi del primo ufficio
sono di 224 giorni, mentre nel secondo 326. Palermo ha una scopertura
dell’organico togato dell’11 per cento, mentre Milano del 16 per cento. I tempi
medi di Palermo sono 436, quelli di Milano 229”. Piuttosto sembra incidere di
più, secondo Piana, il personale amministrativo presente nei tribunali. Anche
qui, però, non è questione di “quantità”: “Il rapporto Cepej (del Consiglio
d’Europa, ndr) pubblicato nel 2014 rileva che solo il 2,5 per cento del
personale non togato (cioè del personale non appartenente al corpo dei
magistrati) è specializzato in management”. Nel resto d’Europa va diversamente:
il tentativo di offrire una risposta in termini di professionalità ed efficienza
ha spinto gli uffici giudiziari di altri paesi, come l’Olanda, ad avvalersi
sistematicamente di figure professionali specializzate in management e
accounting. D’altronde mentre il budget allocato complessivamente per il
comparto nel nostro paese è in linea con gli standard europei – l’1,5 per cento
del pil, come in Germania, il doppio del Belgio (0,7), poco meno di Francia
(1,9) e Paesi Bassi (2) –, noi ci caratterizziamo per una ripartizione delle
stesse risorse particolarmente generosa verso il solo sistema giudiziario (i
tribunali) e sparagnina invece nei confronti degli utenti (vedi per esempio il
patrocinio a spese dello stato). “I dati del Cepej mostrano che nel 2008
l’Italia spende 1,9 euro per cittadino per l’accesso alla giustizia contro una
media europea di 7,2”. Così non c’è da meravigliarsi se sui media hanno trovato
eco negli ultimi anni le proteste per l’eliminazione di tutte le sezioni
distaccate dei tribunali, come anche la cancellazione di 31 tribunali e di 31
procure, avviate dal governo Monti, mentre è passato quasi sotto silenzio il
fatto che “le recenti analisi dell’Osservatorio per il monitoraggio degli
effetti sull’economia delle riforme della giustizia istituito dal ministro della
Giustizia Orlando (…) hanno mostrato che la revisione della geografia
giudiziaria ha comportato un miglioramento generale dei tempi con cui vengono
definiti i procedimenti”. E’ l’organizzazione, bellezza! La politologa Piana lo
ripete e lo dimostra, senza addossare croci in maniera preconcetta, rilevando
che anche la politica preferisce annunciare il cambiamento senza poi seguire da
vicino “il governo del cambiamento”. La sorte della riforma Mastella docet: solo
nel 2015, a otto anni dall’entrata in vigore di quella legge, il Consiglio
superiore della magistratura ha stilato incentivi e meccanismi di valutazione
previsti dal testo per gli incarichi diretti e semidirettivi. Ecco spiegato
perché “l’Italia è un paese che si è lungamente qualificato per un alto grado di
garanzie ordinamentali e processuali e al contempo per un basso rendimento nella
risposta resa al cittadino”. Siamo il paese con le norme e le garanzie per i
giudici “più belle del mondo” ma allo stesso tempo il paese più condannato dalle
corti europee per la lunghezza dei processi e quello in cui sono peggiori gli
indicatori oggettivi e soggettivi sullo stato di diritto.
Una giustizia giusta, fino a prova
contraria, scrive Silvia Dalpane il 20 luglio 2016 su
“Il Dubbio”. Presentato il movimento fondato da Annalisa Chirico. Significativa
la testimonianza dell'infermiera di Piombino, vittima di un vero e proprio
processo mediatico. Fino a prova contraria. Un principio giuridico, un auspicio,
che dà il nome al nuovo movimento presieduto dalla giornalista Annalisa Chirico:
«Siamo stanchi di una giustizia ostaggio delle schermaglie politiche, che
pregiudica anche la qualità della democrazia». Alla presentazione in Piazza
Colonna la testimonianza più forte è stata quella di Fausta Bonino, l'infermeria
di Piombino vittima di un processo mediatico che l'ha trasformata in mostro.
Dopo 21 giorni in carcere con l'accusa, tremenda, di aver ucciso 13 pazienti in
corsia, è stata scarcerata dal Tribunale del Riesame di Firenze, che ha
sconfessato l'indagine della procura di Livorno: «Sono qui perchè spero che
cambi qualcosa. Sono stata sbattuta in galera con grande clamore. Non lo auguro
a nessuno, la mia vita è cambiata per sempre. Sono giunta peraltro all'amara
constatazione che se non si hanno soldi o supporto non se ne esce fuori, perché
non avrei potuto consultare i periti che sono stati fondamentali». Eloquenti i
dati raccolti dai promotori del movimento: in Italia ci vogliono in
media 600 giorni per arrivare al giudizio di primo grado nelle cause civili.
Soltanto Malta fa peggio di noi; in Francia ne bastano 300, in Germania 200. A
Foggia, Salerno e Latina il 40% dei processi si protrae da oltre tre anni. In
video-collegamento il presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione Raffaele
Cantone, che ha rimarcato quanto questa lentezza incida in termini di
competitività. L'Italia infatti è soltanto l'ottavo paese dell'Unione Europea
per investimenti provenienti dagli Usa, mentre logica vorrebbe che fosse almeno
sul podio: «Le classifiche internazionali vengono utilizzate per scegliere se
portare o meno i capitali in alcuni paesi. Gli imprenditori vogliono certezze
sulla durata delle controversie e prevederne gli esiti». Il giudice
costituzionale Giuliano Amato ha indicato dei possibili correttivi: «Ero ragazzo
quando ho sentito parlare per la prima volta di riforma della giustizia.
Bisognerebbe rafforzare i filtri che in campo penale precedono l'intervento
dell'inquirente e del giudicante. Qualunque illecito amministrativo diventa
automaticamente penale, anche perché i pm italiani hanno la capacità di
individuare potenziali irregolarità e fattispecie di reato che altrove non
esistono. Negli uffici arrivi di tutto, senza prima essere setacciato». L'ex
presidente del consiglio indica negli Usa l'esempio da seguire: «Siamo molto più
lenti di loro, che hanno soltanto due gradi di giudizio invece di tre. Puntano a
chiudere in fretta le controversie, mentre noi inseguiamo per anni la chimera
della verità assoluta. Spesso l'appello è più lungo del primo grado:
un'inciviltà difficile da comprendere e accettare». Dall'ex ministro è arrivato
anche un riferimento, forte, all'attualità: «Il caso Cucchi urla vendetta,
quelle immagini fanno male. Evidentemente all'interno di alcune categorie c'è
ancora oggi dell'omertà». Il confronto con il modello statunitense è stato
approfondito grazie all'intervento dell'ambasciatore americano a Roma, John R.
Phillips: «Gli investitori spesso non sbarcano in Italia per via di un sistema
legale ritenuto inaffidabile. Negli Usa e in molti altri paesi europei i
procedimenti viaggiano molto più spediti. Da noi è stata determinante la
quantificazione di un limite alla produzione degli incartamenti da parte degli
avvocati, che può essere derogato soltanto in casi eccezionali. Anche la
digitalizzazione ha rappresentato un evidente passo avanti rispetto al
cartaceo». Smaltimento degli arretrati e esaustività delle pronunce di primo
grado gli altri capisaldi di un modello al quale l'Italia è chiamata a
ispirarsi: «Negli Usa ci sono metodi alternativi per risolvere le dispute. Le
parti raggiungono un compromesso in tempi brevi e addirittura il 90% dei casi
viene archiviato senza processo. Rispetto all'Italia si arriva al grado
successivo di giudizio soltanto quando possono essere contestate questioni di
diritto e non di fatto. Mediamente la Corte Suprema è chiamata a pronunciarsi
soltanto 80 volte l'anno». Non è mancato un riferimento all'indagine della
Procura di Trani, che denunciò possibili interessi speculativi da parte di una
nota agenzia di rating: «Alcuni dirigenti di Standard & Poor's sono stati
accusati dopo avere declassato i conti italiani. La criminalizzazione dei
comportamenti negligenti ha rappresentato un grande deterrente per imprenditori
e amministratori delegati. Ecco perché si allontanano: in Italia i rischi sono
troppo alti». Per l'ex ministro della Giustizia Paola Severino l'Italia deve
compiere tanti progressi anche dal punto di vista culturale: «La corruzione
emerge a tanti livelli. Ancora oggi chi paga le tangenti viene considerato più
furbo degli altri, mentre sta commettendo un grave delitto. A Hong Kong hanno
insegnato ai bambini dell'asilo che corrompere è reato e hanno sgominato il
fenomeno. Da bambina mia madre mi fece restituire una mela e mi disse che si
vergognava di me, che l'avevo rubata. Tante famiglie dovrebbero imitarla. La
prevenzione e l'applicazione delle regole vengono prima della repressione». Il
presidente dell'Unione delle camere penali Beniamino Migliucci condivide i
principi ispiratori di Fino a prova contraria: «Bisogna recuperare alcuni valori
del processo liberale democratico: la presunzione d'innocenza, la separazione
delle carriere e il ragionevole dubbio. Troppo spesso si dà importanza ai
risultati delle indagini o alle sentenze di primo grado. Il giustizialismo
invece non è proficuo. L'opinione pubblica è influenzata molto dai media e va
formata in modo differente. È come con le malattie: quando riguardano gli altri
non ci si rende conto di cosa rappresentino nè come vadano affrontate». Un punto
ribadito da Giovanni Fiandaca, docente di diritto penale all'università di
Palermo: «Parte del sistema mediatico è molto appiattita sull'attività
giudiziaria. Alcuni giornalisti hanno un rapporto privilegiato con i magistrati
e quindi non possono essere sufficientemente critici. Prese di posizione
oggettivamente discutibili non vengono approfondite sul serio, con un approccio
intellettuale autonomo». Vi sono comunque esempi virtuosi. I 22 tribunali delle
imprese hanno risolto il 70% dei casi a loro sottoposti in meno di un anno.
«Rappresentano un'esperienza felicissima e hanno accorciato moltissimo i tempi
del diritto civile. Andrebbero estesi all'ambito penale», ha aggiunto la
Severino. Torino, grazie all'impegno del magistrato Mario Barbuto, ha smaltito
il 26% di arretrati, imponendosi come modello di organizzazione: «Prima della
legge Pinto alcuni processi si erano dilungati per 15 o addirittura 30 anni e
avevamo subito ben quindici condanne della Corte Europea. La vergogna mi ha
imposto un differente programma di gestione, improntato su una statistica
comparata di 24 parametri. L'Osservatorio ci ha consentito di studiare le
performances di 140 tribunali italiani e non sono mancate le sorprese». Smentiti
tanti luoghi comuni: «Non è vero che la giustizia è in crisi dappertutto. 28
uffici giudiziari superano le medie europee. Il pieno organico non è sinonimo di
maggiore efficienza e neppure gli indici di litigiosità o criminalità incidono
in modo determinante. Non vi è una questione meridionale: Marsala è il secondo
tribunale in Italia per velocità dei processi. E i carichi esigibili non sono
affatto una soluzione. D'altronde è come se gli ospedali esponessero un cartello
per annunciare che i medici cureranno soltanto i primi 150 pazienti e che tutti
gli altri dovranno arrangiarsi...».
Chirico: «Il mio corpo è uno strumento di
lotta...» Intervista di Errico Novi del 15 luglio 2016
su "Il Dubbio". «Marco è stato un grande maestro e mi ha insegnato a essere
sfacciata come le persone che hanno idee forti. Il privato è anche politico, non
concepisco l’ipocrisia della separazione tra le due vite». Bisogna essere
sfacciati per mettersi a parlare di giustizia dalla parte degli indagati, per
sfidare il mainstream forcaiolo. E ad Annalisa Chirico il coraggio non manca,
l’entusiasmo neppure né una splendida indole pannelliana che «mi porta a
considerare il mio corpo uno strumento di lotta: l’ho imparato da quel gigante
che è Marco Pannella, certo». E adesso questa giornalista che con un’intervista
a un togato del Csm è capace di far scoppiare un caso istituzionale da restare
nella storia di Palazzo dei Marescialli, presiede un movimento che «intende
promuovere una vera riforma del sistema giudiziario italiano». Si chiama “Fino a
prova contraria”, è una specie di bandiera con su impresso l’articolo 27 della
Costituzione e ha in programma un incontro per martedì prossimo a Palazzo
Wedekind intitolato “Cambiamo la giustizia per cambiare l’Italia”, con il
giudice costituzionale Giuliano Amato, il presidente dell’Anticorruzione
Raffaele Cantone, il professor Giovanni Fiandaca, il presidente del Consiglio
nazionale forense Andrea Mascherin e il numero uno delle Camere penali Beniamino
Migliucci, oltre ai giuristi, imprenditori e magistrati che Annalisa ha
coinvolto nella sua associazione.
Di questi tempi si rischia, a mettersi contro
il mainstream giustizialista.
«Be’ ci sono
polemiche persino per il fatto che alla presentazione interverrà Fausta Bonino,
l’infermiera di Piombino che i pm continuano a inseguire armati di manette fino
in Cassazione, e l’ex ergastolano Giuseppe Gulotta che si è fatto 22 anni di
carcere prima di vedersi dichiarato innocente. Noi comunque non ci proponiamo
come un’associazione di vittime della giustizia ma per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla patologia del processo mediatico, un caso tutto italiano che si
regge sulla commistione incestuosa tra giornalisti e magistrati».
Andate controvento.
«Sono contenta
del riscontro che abbiamo trovato già dal giorno del battesimo a Villa Taverna
con l’ex ministro della Giustizia Paola Severino, mi pare che siamo già riusciti
a conquistare una certa autorevolezza. Già ci riconoscono come movimento che si
batte per una giustizia più efficiente in funzione di un Paese più competitivo.
Sono soprattutto gli stranieri che hanno bisogno di essere rassicurati sul
funzionamento del processo, in Italia. Gli americani sono rimasti choccati dal
caso Amanda Knox. La grandissima parte dell’opinione pubblica Usa è rimasta
incredula nello scoprire che con il sistema processuale italiano si può essere
dichiarati innocenti dopo quattro anni di carcere. Ci sono altre vicende in cui
il collegamento con il sistema economico è ancora più netto».
Ad esempio?
«Il caso Ilva,
in cui un polo siderurgico di livello mondiale è già stato oggetto di sequestri
di beni alle persone nonostante, dopo diversi anni, si sia ancora alle battute
iniziali del processo».
Fai esempi che difficilmente possono intenerire
l’opinione pubblica assetata di condanne.
«E invece io
credo che già ora qualcosa tenda a cambiare. Ci sono episodi che segnano un
passaggio, lo fu il cosiddetto referendum Tortora che raccolse un consenso
fortissimo. Credo che oggi la battaglia in difesa delle garanzie per le persone
indagate, degli imputati, possa far breccia nell’opinione pubblica. Anche grazie
al fatto che il re, cioè la magistratura, è nudo».
A cosa ti riferisci.
«Agli episodi
che hanno spezzato l’incantesimo del magistrato infallibile: penso a quando si è
scoperto il valore degli immobili di Di Pietro, al capitombolo elettorale di
Ingroia, alla giudice Silvana Saguto coinvolta nello scandalo di Palermo sui
beni confiscati, a un caso come quello di Morosini che racconta in un’intervista
come la corrente Md intenda impegnarsi contro il governo sul referendum
costituzionale».
Quell’intervista c’è stata o no?
«Mi attengo
alla prima smentita di Morosini, in cui parlò di colloquio informale che lui
riteneva non avrebbe dovuto essere inteso come intervista».
Tu perché l’hai inteso come intervista?
«Perché a un
certo punto ho cominciato a prendere appunti sul taccuino, e davo per scontato
che lui avesse compreso la mia intenzione di riportare le sue parole. D’altronde
mi era parso che lui potesse essere interessato a rendere pubbliche quelle
considerazioni per giochi interni alla sua corrente».
E invece?
«E invece lui
pensava che prendessi appunti chissà perché. Dopo il comunicato dell’Anm e
l’intervento del guardasigilli ha pronunciato una smentita completa, per
mettersi in salvo. Io a quel punto, per la simpatia che ho nei suoi confronti,
sono rimasta silente».
Vi siete più sentiti?
«Come no. Siamo
rimasti in buoni rapporti».
Davvero? Non ti ha sbranato al telefono?
«No. Sa che non
ho infierito, né lo ha fatto il mio giornale, il Foglio».
I togati del Csm sono impreparati
all’esposizione mediatica?
«I magistrati
in generale usano la comunicazione benissimo. E ci riescono grazie al fatto che
quasi tutti, a cominciare dai giornaloni, ben si guardano dal far loro le pulci
come fanno con i politici».
Sei stata provocatoria con il libro Siamo tutte
puttane, continui a esporti in modo temerario: esagero se dico che in questo sei
un po’ pannelliana?
«Io mi
considero pannelliana, considero il mio corpo uno strumento di lotta, l’ho
imparato dai radicali, anche grazie al lavoro fatto all’Strasburgo quando Marco
era deputato europeo. Lui è stato un grande maestro e mi ha insegnato a essere
sfacciata come le persone che hanno idee forti. Il privato è anche politico, non
concepisco l’ipocrisia della separazione tra le due vite. Le cose che scrivo e
che porto avanti costituiscono un unico habitat umano con il modo in cui vivo e
le persone che conosco».
Ecco, ma prima o poi il Fatto ti toglierà la
pelle di dosso.
«Il Fatto si è
già occupato di me e dei miei fidanzati veri o presunti in varie occasioni. Ho
molta simpatia per Marco Travaglio, un uomo eccentrico e incline allo spettacolo».
A proposito di simpatie: con Chicco Testa vi
siete lasciati così male?
«Lasciati? Ma
che dici?»
Lo hai scritto tu sul Giornale di Sallusti.
«Macché. È qui
vicino a me mentre parlo al telefono. Quell’articolo aveva un tono letterario,
parla di Becoming, il memoir della Williams su come si risorge dopo una
separazione».
E se d’improvviso sparissi e ti limitassi a
scrivere senza apparire mai?
«Non potrei mai
scrivere semplicemente degli articoli. Porto avanti delle battaglie proprio
perché scrivo quello che Annalisa pensa».
Carceri "Negli ultimi 50 anni incarcerati
4 milioni di innocenti". Decine di innocenti rinchiusi
per anni. Errori giudiziari che segnano le vite di migliaia di persone e costano
caro allo Stato. Eccone un breve resoconto pubblicato da Ristretti Orizzonti,
che ha reso nota una ricerca dell'Eurispes e dell'Unione delle Camere penali,
scrive Romina Rosolia il 29 settembre 2015 su "La Repubblica". False
rivelazioni, indagini sbagliate, scambi di persona. E' così che decine di
innocenti, dopo essere stati condannati al carcere, diventano vittime di
ingiusta detenzione. Errori giudiziari che non solo segnano pesantemente e
profondamente le loro vite, trascorse - ingiustamente - dietro le sbarre, ma che
costano caro allo Stato. Eccone un breve resoconto pubblicato da Ristretti
Orizzonti, che ha reso nota una ricerca dell'Eurispes e dell'Unione delle Camere
penali italiane. Quanto spende l'Italia per gli errori dei giudici? La legge
prevede che vengano risarciti anche tutti quei cittadini che sono stati
ingiustamente detenuti, anche solo nella fase di custodia cautelare, e poi
assolti magari con formula piena. Solo nel 2014 sono state accolte 995 domande
di risarcimento per 35,2 milioni di euro, con un incremento del 41,3% dei
pagamenti rispetto al 2013. Dal 1991 al 2012, lo Stato ha dovuto spendere 580
milioni di euro per 23.226 cittadini ingiustamente detenuti negli ultimi 15
anni. In pole position nel 2014, tra le città con un maggior numero di
risarcimenti, c'è Catanzaro (146 casi), seguita da Napoli (143 casi). Errori in
buona fede che però non diminuiscono. Eurispes e Unione delle Camere penali
italiane, analizzando sentenze e scarcerazioni degli ultimi 50 anni, hanno
rilevato che sarebbero 4 milioni gli italiani dichiarati colpevoli, arrestati e
rilasciati dopo tempi più o meno lunghi, perché innocenti. Errori non in
malafede nella stragrande maggioranza dei casi, che però non accennano a
diminuire, anzi sono in costante aumento. Sui casi di mala giustizia c'è un
osservatorio on line, che da conto degli errori giudiziari. Mentre sulla pagina
del Ministero dell'Economia e delle Finanze si trovano tutte le procedure per la
chiesta di indennizzo da ingiusta detenzione. Gli errori più eclatanti. Il caso
Tortora è l'emblema degli errori giudiziari italiani. Fino ai condannati per la
strage di via D'Amelio: sette uomini ritenuti tra gli autori dell'attentato che
costò la vita al giudice Paolo Borsellino e alle cinque persone della scorta il
19 luglio 1992. Queste stesse persone sono state liberate dopo periodi di
carcerazione durati tra i 15 e i 18 anni, trascorsi in regime di 41 bis. Il 13
febbraio scorso, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riconosciuto un altro
grave sbaglio: è innocente anche Giuseppe Gulotta, che ha trascorso 21 anni, 2
mesi e 15 giorni in carcere per l'omicidio di due carabinieri nella caserma di
Alcamo Marina (Trapani), nel 1976. Trent'anni dopo, un ex brigadiere che aveva
assistito alle torture cui Gulotta era stato sottoposto per indurlo a
confessare, ha raccontato com'era andata davvero. Altri casi paradossali. Nel
2005, Maria Columbu, 40 anni, sarda, invalida, madre di quattro bambini, venne
condannata con l'accusa di eversione per dei messaggi goliardici diffusi in
rete, nei quali insegnava anche a costruire "un'atomica fatta in casa". Nel 2010
fu assolta con formula piena. Per l'ultimo giudice, quelle istruzioni
terroristiche erano "risibili" e "ridicole". Tra gli ultimi casi, la
carcerazione e la successiva liberazione, nel caso Yara Gambirasio, del
cittadino marocchino Mohamed Fikri, accusato e subito scagionato per l'omicidio
della ragazza. Sono fin troppo frequenti i casi in cui si accusa un innocente?
Perché la verità viene fuori così tardi? Perché non viene creduto chi è
innocente? A volte si ritiene valida - con ostinazione - un'unica pista, oppure
la verità viene messa troppe volte in dubbio. Forse, ampliare lo spettro
d'indagine potrebbe rilevare e far emergere molto altro.
ASSOLTI. PERO’…
Assolti? C’è sempre un però,
scrive Michele Ainis su “Il Corriere della Sera” l’11 novembre 2015. E go te
absolvo, sussurra il prete dietro la grata del confessionale. Ma se lo dice il
giudice allora no, non vale. In Italia ogni assoluzione è un’opinione, per
definizione opinabile o fallace; e d’altronde ogni processo è già una pena,
talvolta più lunga d’un ergastolo. Ultimo caso: Calogero Mannino. L’ex ministro
democristiano arrestato nel 1995 per concorso esterno in associazione mafiosa,
prosciolto 25 anni più tardi dalla Cassazione, dopo una giostra d’appelli e
contrappelli, dopo 22 mesi di detenzione, dopo la gogna e la vergogna. E adesso
assolto di nuovo in primo grado nel processo sulla trattativa Stato-mafia.
Reazioni: sì, però... C’è sempre un però, c’è sempre una virgola della sentenza
d’assoluzione che si lascia interpretare come mezza condanna (in questo caso
l’insufficienza delle prove), o magari c’è una dichiarazione troppo esultante
del prosciolto, un suo tratto somatico tal quale la smorfia di Riina, una
corrente d’antipatia che nessun verdetto giudiziario riuscirà mai a sedare.
Mannino sarà anche innocente, però non esageri, ha detto l’ex pm Antonio
Ingroia in un’intervista a Libero. Lui invece esagera, come fanno per mestiere i
romanzieri; e infatti ci ha promesso in dono un romanzo col quale svelerà le
intercettazioni di Napolitano. Peccato che pure stavolta ci sia di mezzo una
sentenza, oltretutto firmata dal giudice più alto. Giacché nel 2013 la Corte
costituzionale - per tutelare la riservatezza del capo dello Stato - impose
l’immediata distruzione dei nastri registrati, e dunque i nastri sono stati
inceneriti, anche se nessuno può incenerire la memoria di chi li ascoltò a suo
tempo. Come Ingroia, per l’appunto. Risultato: la Consulta ha sancito
l’innocenza «istituzionale» dell’ex presidente, l’ex magistrato ne dichiara la
colpa. Risultato bis: anche in questo caso non conta il giudizio, conta il
pregiudizio. Potremmo
aggiungere molte altre figurine a quest’album processuale. Potremmo
rievocare le maestre di Rignano: nel 2006 imputate di violenza sessuale sui
bambini, assolte per due volte in tribunale, però sempre colpevoli secondo i
genitori, tanto che hanno smesso d’insegnare. O altrimenti potremmo citare il
caso di Raffaele Sollecito: assolto anche lui per il delitto di Perugia, dopo un
ping pong giudiziario di 8 anni; qualche giorno fa vince un bando della Regione
Puglia per creare una start up, e s’alzano in coro gli indignati. Insomma, alle
nostre latitudini l’unica prova certa è quella che ti spedisce in galera, non la
prova d’innocenza. E allora la domanda è una soltanto: perché? Quale virus
intestinale ci brucia nello stomaco, trasformandoci in un popolo incredulo e
inclemente? Chissà,
forse siamo colpevolisti perché abbiamo perso l’innocenza: la nostra, non
la loro. Perché siamo vecchi e sfiduciati, dunque non crediamo più nei giudici
come nei partiti, come nei sindacati, come nelle chiese. Perché la giustizia ci
ha deluso, e in effetti la storia è costellata d’errori giudiziari. Però sono
più i dannati dei salvati: Dreyfus (Francia, 1894), Sacco e Vanzetti (Usa,
1927), Girolimoni (sempre nel 1927, ma in Italia), Valpreda (1969), Tortora
(1983). Altrettante vittime innocenti d’uno strabismo processuale, nonostante il
doppio grado di giudizio, nonostante il riesame in Cassazione. Domanda: ma se
una sentenza può sbagliare, perché a un certo punto diventa inappellabile?
Risposta: perché la verità assoluta non è di questo mondo, perché dobbiamo
contentarci di verità parziali, convenzionali. E perché il diritto tende alla
certezza, non alla comprensione filosofica. Quando ci rifiutiamo di prenderlo
sul serio, quando respingiamo i suoi verdetti, la nostra insicurezza diventa
ancora più acuta.
Errori giudiziari: una nuova vergogna.
Nella Legge di stabilità 2016 il governo ha dimezzato
i risarcimenti della legge Pinto per i processi troppo lenti. Rendendoli ancora
più difficili, scrive Maurizio Tortorella il 15 gennaio 2016 su "Panorama". I
radicali, grazie alla testa e alla penna di Deborah Cianfanelli, avvocato
spezzino da tempo impegnato nella difesa dei diritti civili, hanno appena
pubblicato uno studio che (come troppo spesso accade ai radicali) è passato in
assoluto silenzio. Ed è un peccato, perché lo studio descrive come processi
lenti e errori giudiziari in Italia siano ormai divenuti parte della nostra
bancarotta economica. Cianfanelli ha analizzato i risultati della
cosiddetta legge Pinto, la n. 89 del 2001, varata dal governo del
premier Giuliano Amato. La norma stabilisce una "corretta durata dei processi"
individuandola in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo grado,
in un anno per la Cassazione. Quando fu varata, 14 anni fa, la norma cercava di
fare argine a migliaia di richieste di risarcimento per la lentezza dei processi
penali e civili approdati presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. I
radicali stimano che il costo provocato dalla Legge Pinto sui conti pubblici sia
di circa un miliardo di euro l’anno, quasi il doppio di quanto calcola oggi il
governo. Alla cifra vanno poi aggiunti200 milioni circa per i risarcimenti da
ingiusta detenzione, originati all’incirca da altri 2 mila procedimenti l’anno.
Il numero di cause basate sulla legge Pinto è in continuo aumento: i ricorsi
erano 3.580 nel 2003, saliti a 49.730 nel 2010, a 53.320 nel 2011, a 52.481 nel
2012, a 45.159 nel 2013, l’ultimo anno con dati ufficiali. Se si tiene conto che
la media del rimborso liquidato è di ottomila euro, si arriva velocemente a
cifre stellari. Bene. Che cosa ha deciso di fare, il governo, di fronte a questo
disastro giudiziario ed economico? Forse intervenire per accelerare in qualche
modo i tempi medi del processo? Macché. I radicali denunciano che anzi la Legge
di stabilità 2016 (all’articolo 56 del titolo nono) ha introdotto
silenziosamente alcuni importanti modifiche alla legge Pinto, al solo scopo di
"renderne molto difficile se non meramente eccezionale la possibilità
d’accesso". Il problema è stato brutalmente risolto alla fonte, insomma: se la
legge Pinto costa troppo, rendiamo più difficili gli indennizzi. I trucchi
adottati sono molto insidiosi: per avere diritto a presentare ricorso,
l’imputato di un processo penale deve presentare l’istanza di accelerazione
delle udienze "almeno sei mesi prima del decorso del termine ragionevole di
durata". Quando il suo giudizio arriva in Cassazione, l’imputato deve fare
istanza "due mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata". La
legge stabilisce poi che è "insussistente" il pregiudizio da irragionevole
durata del processo nel caso d’intervenuta prescrizione del reato. "Ancora una
volta" scrive Cianfanelli "anziché cercare di porre in essere rimedi strutturali
in grado di riportare il sistema giustizia sui binari della legalità, si cerca
di aggirare l’ostacolo rendendo inaccessibile la strada al risarcimento del
danno". Parole sante. Anche perché, non contento, il legislatore ha praticamente
dimezzato i valori dei risarcimenti. L’ultima Legge di stabilità stabilisce
infatti che il giudice dovrà liquidare "una somma non inferiore a euro 400 euro
e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei
mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo". Per fare un
confronto, la Corte europea dei diritti dell’uomo, che non è certo il giudice di
prima istanza in materia, individua oggi il parametro dell’indennizzo in
mille-millecinquecento euro per ogni anno di processo Giustizia italiana, mala e
pidocchiosa.
Incubo carcere preventivo: quattro
milioni di innocenti. In
50 anni troppe vittime hanno subìto l'abuso della detenzione. E i pm insistono
nonostante le nuove regole. Il caso di Mantovani, scrive Andrea Camaiora
Mercoledì 11/11/2015 su “Il Giornale”. La carcerazione preventiva recentemente
inflitta all'ormai ex vicepresidente di Regione Lombardia Mario Mantovani offre
tristemente un nuovo spunto per affrontare l'annosa questione della carcerazione
preventiva. Qual è la situazione nel nostro Paese? Nel 2009, il numero dei
detenuti in custodia cautelare era di 29.809, pari al 46% del totale della
popolazione carceraria; il dato di oggi è di 18.622, il 34,5%. Questi dati
rivelano come troppe volte l'applicazione della custodia cautelare non
costituisca l'extrema ratio, così come previsto dalla nuova disciplina in merito
voluta dal Guardasigilli, Andrea Orlando, ma assuma connotati diversi, come
quelli di un'anticipazione della pena. In molte occasioni i destinatari di
misure cautelari personali vengono, dopo anni, assolti: i numeri parlano chiaro,
dal 1991, lo Stato ha pagato quasi 600 milioni di euro a più di 20 mila persone
per riparazione per ingiusta detenzione, anche per effetto di sentenze
definitive che hanno assolto persone che erano state arrestate. Negli ultimi 50
anni, 4 milioni, ebbene sì, 4 milioni di cittadini sono stati prima dichiarati
colpevoli, quindi arrestati e infine rilasciati perché innocenti. Dal 1991 al
2012 lo Stato ha dovuto spendere 600 milioni di euro per risarcire chi è stato
indebitamente arrestato. E il dato ulteriormente negativo è che questa dinamica
non accenna a diminuire, anzi aumenta. Nel 2014 le somme spese dallo Stato per
le riparazioni per ingiusta detenzione sono aumentate del 41% rispetto al 2013.
La nuova normativa è più che limpida sull'imposizione o meno della detenzione
carceraria. Per giustificare il carcere, il pericolo di fuga o di reiterazione
del reato non deve essere soltanto concreto ma anche «attuale». Il giudice non
può più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto.
Per privare della libertà una persona l'accertamento dovrà coinvolgere elementi
ulteriori, quali i precedenti, i comportamenti, la personalità dell'imputato.
Anche gli obblighi di motivazione si sono intensificati. Il giudice che decide
per il carcere non potrà infatti più limitarsi a richiamare gli atti del pm, ma
dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli
argomenti della difesa sono stati disattesi. Sono aumentati da 2 a 12 mesi i
termini di durata delle misure interdittive (sospensione dell'esercizio della
potestà dei genitori, sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio,
divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per consentirne
un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere. È
cambiata anche la disciplina del Riesame. Il tribunale della Libertà ha tempi
perentori per decidere e depositare le motivazioni, pena la perdita di efficacia
della misura cautelare. Che, salvo eccezionali esigenze, non può più essere
rinnovata. Il collegio del Riesame deve inoltre annullare l'ordinanza liberando
l'accusato quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non
abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede
di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della
Cassazione. Con questo quadro di riferimento, colpisce assai non una voce
critica rispetto al provvedimento subito da Mantovani: molte e autorevoli sono
state infatti le prese di posizione. Semmai ciò che si sente sempre più forte è
il silenzio, l'assenza di autocritica dei cantori della manetta facile, della
condanna in piazza e anche di coloro che, siamo in tanti, credono nel rigore e
nella serietà della magistratura. Il tutto perché c'è chi sta leggendo questo
articolo e chi - come Mantovani, ma non solo lui - si trova sottoposto a carcere
preventivo da circa un mese.
Giustizia: le mille balle
sulla prescrizione.
Cresce in modo inarrestabile. Per colpa della ex Cirielli, varata
da Berlusconi nel 2005. E della melina degli avvocati. Tutto falso: ecco perché,
scrive il 15 febbraio 2016 Maurizio Tortorella su "Panorama". A partire dalle
litanie dell'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario, e cioè dalla fine di
gennaio, siamo inondati di continui, alti lamenti sulla prescrizione, l'istituto
che brucia "inutilmente e vergognosamente" troppi processi penali. Sui giornali
si legge che le prescrizioni sono in continuo aumento: formano ormai un'ondata
inarrestabile, che anno dopo anno uccide un numero crescente di procedimenti,
sottraendo gli autori di reati alla giustizia. Per questo, si legge nei commenti
e nelle interviste, il Parlamento dovrebbe approvare al più presto una proposta
di legge che riduce grandemente la prescrizione. La riforma prevede
allungamenti, sospensive dopo la condanna in 1° e 2° grado. Il ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, si è perfino detto d’accordo con il procuratore
generale di Palermo, Roberto Scarpinato, per raddoppiare la prescrizione nei
reati corruttivi. Secondo la propaganda che picchia sui tamburi in questo
febbraio, la colpa di questa situazione disastrosa è tutta da attribuire (e come
dubitarne?) alla famosa, malfamata legge Cirielli, varata nel dicembre 2005
sotto il governo Berlusconi: una norma così vergognosa che perfino il suo
autore, il deputato Edmondo Cirielli, la rinnegò (e infatti viene rubricata come
"ex Cirielli"). Ovviamente, la responsabilità dell'ondata di prescrizioni ricade
anche sugli avvocati penalisti e sulle tattiche dilatorie che usano in
tribunale. Secondo i cantori del populismo giudiziario, i difensori, complici di
chi non vuole giustizia, usano la prescrizione come primo strumento in loro
possesso per “salvare" i clienti, ovviamente sempre colpevoli, e per arrivare
così al risultato di eludere la giustizia. Tutto vero? Al contrario, è tutto
falso (tranne qualche caso, che innegabilmente e probabilmente magari esisterà).
E a dimostrarlo sono i dati ufficiali del ministero della Giustizia. Basta
andare a cercarli e metterli in fila. Partiamo dalla legge ex Cirielli. Non ha
alcuna colpa. In realtà, i procedimenti finiti in prescrizione dal 2005 al 2012
sono andati diminuendo. La legge è andata in vigore alla fine del 2005, e
quell'anno si è chiuso con 183.224 reati prescritti. Nel 2012 la cifra era
calata a 123.078. È vero che poi nel 2013 e 2014 il dato è tornato ad aumentare
(per l'esattezza a 123.078 e a 132.296). Però è clamorosamente falso che da
dieci anni a questa parte ci sia un costante aumento delle prescrizioni. Perché
rispetto al 2005 siamo ancora sotto di oltre 50 mila reati. Passiamo allora agli
avvocati: sono loro i colpevoli? Nemmeno per idea. Sommando tutte le
prescrizioni intervenute dal 2005 al 2014, il totale è di 1.454.926 reati e
procedimenti prescritti. Sapete in quale fase processuale è andato in
prescrizione il reato? Nel 70,7% dei casi, durante le indagini preliminari: per
l'esattezza, in1.028.685 casi. Insomma, è accaduto quando gli avvocati non
possono praticamente agire, quando tutto o quasi è nelle mani del pubblico
ministero. Questa percentuale, semmai, dovrebbe far pensare quanti difendono
come intoccabile il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione
penale. Se oltre 1 milione di processi è abortito in dieci anni già prima del
rinvio a giudizio dell'imputato, un motivo ci sarà. I motivi sono
fondamentalmente due. O sono i pubblici ministeri che si accorgono troppo tardi
dei reati. O sono i pubblici ministeri che lavorano male, lasciando nei cassetti
i processi che importano poco loro.
L'eredità di Ermes ai rom
che lo avevano derubato.
Il suo "patrimonio" consiste unicamente in una casupola e un
magazzino sgarrupato del valore di poche migliaia di euro, scrivono Nino
Materi e Giuseppe De Lorenzo, Sabato 07/11/2015, su “Il Giornale”. Assegnata ai
due rom-ladri l'eredità di Ermes Mattielli. Cioè l'uomo che era stato derubato
(da quegli stessi due rom-ladri) per ben 20 volte. Diventa ancora più
tragicamente paradossale la storia del 63enne robivecchi vicentino, morto due
sere fa di infarto. Un malore provocato anche dallo stress per una vicenda
giudiziaria assurda. Lui condannato a 5 anni per essersi difeso da una coppia di
nomadi entrata in casa la sera del 13 giugno 2006 nella sua abitazione nel paese
di Arsiero (Vicenza). Mattielli spara, li ferisce. Viene incriminato per tentato
omicidio, mentre i due zingari se la cavano con una condanna a 4 mesi. Entrambi
restano liberi. Liberi di continuare a rubare. Ma ora, forse - e questa sarebbe
l'ennesima beffa - liberi addirittura di andare ad abitare nella catapecchia di
Ermes: la stessa baracca che loro - i rom manolesta - andavano periodicamente a
«ripulire» dei miseri averi di Mattielli. Ermes, oltre ai 5 anni di galera, si è
beccato infatti pure una condanna pecuniaria non indifferente: 135 mila euro di
risarcimento. Risarcimento a beneficio di chi? Ma dei nomadi che lo andavano
sempre a derubare, ovviamente. Ora Ermes è - speriamo per lui - passato a
miglior vita. Il suo «patrimonio» consiste unicamente in una casupola e un
magazzino sgarrupato del valore di poche migliaia di euro. I familiari di Ermes
hanno deciso di rinunciare a cotanti «beni». E così, come prevede la legge, gli
immobili passeranno allo Stato che poi provvederà a «girarli» ai nomadi
«danneggiati» da Mattielli, i quali potranno usarli come meglio credono:
venderli o andarci ad abitare. E giudicate voi se questo non è scandaloso. «Non
ci sono genitori, moglie, figli né fratelli o sorelle - spiega l'avvocato di
fiducia di Mattielli, Maurizio Zuccollo - credo abbia solo qualche cugino. Ma
questi potranno rifiutarsi di ricevere l'eredità, viste le modeste proprietà del
rigattiere e quel risarcimento da 135mila euro. Così, in assenza di eredi, lo
Stato diventerà proprietario dei beni di Ermes, adoperandosi per il pagamento
del dovuto ai rom». «L'art. 596 del codice civile - spiega al Giornale
l'avvocato Marco Tomassoni - enuncia che, in mancanza di altri successibili,
l'eredità è devoluta allo Stato italiano: l'acquisto avviene di diritto senza
bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia». Il secondo comma
dell'art. 586 prevede inoltre che lo Stato risponda dei debiti del defunto intra
vires (ovvero nei limiti di ciò che ha ricevuto dal defunto stesso) e che
«provveda alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e
legatari» che abbiano presentato dichiarazione di credito. Ovvero i due rom, che
potranno quindi andare dal notaio per togliere da morto quello che non erano
riusciti a rubare a Mattielli in vita. E spostando sullo Stato l'onere del
risarcimento. Alla luce di tutto questo bene ha fatto due sere fa Nicola Porro
ad aprire la sua trasmissione (Virus, Rai2) con la gigantografia di Ermes
Mattielli. Un uomo che in vita ha vissuto da «invisibile», ma la cui «presenza»,
ora, da morto, pesa sulla coscienza di tutti. L'ultima intervista Ermes l'aveva
rilasciata ad Alessandro Mognon del Giornale di Vicenza, diretto da Ario
Gervasutti. Parole che, lette oggi, alla luce di questi ultimi sviluppi,
appaiono ancora più amare: «Ho una gamba di legno, ma neppure l'invalidità
minima. Vivo con l'orto, le galline. Mi hanno messo alla carità. Andavo in giro
con l'Ape a raccogliere rottami, sbarcavo il lunario. Adesso devo pagare 135
mila euro. Ma chi li ha mai visti 135 mila euro? Io soldi non ne ho, l'ho detto
anche all'avvocato che non posso pagarlo. Vivo con poco più di 100 euro, me li
faccio bastare. Oggi ho mangiato quattro patate e du ovi». Racconta Mattielli
che per mesi aveva trovato davanti al cancello del magazzino lavatrici e
frigoriferi abbandonati: «Pensavo: “guarda 'sti cretini, mi tocca portare tutto
all'ecocentro”. Solo dopo ho capito che li mettevano i ladri per salirci sopra e
saltare la rete...». Fa vedere dove è successo tutto: «Ecco, li ho trovati qui».
Perché non ha sparato un colpo in aria per farli scappare? «Ho visto una luce,
ho sparato contro quella. Poi sono sbucati dal buio, erano a due metri da me, ho
preso paura. In dieci anni sono venuti 20 volte a rubare. Vengono qui a rubare,
da me che ho una gamba di legno. Cosa dovevo fare? Datemi uno stipendio e io
lascio spalancate porte e finestre. Dovevano stare a casa loro, quei due. E non
sarebbe successo nulla. Ma erano padroni loro, i ladri. A me giudici e avvocati
hanno chiesto di patteggiare, ho detto: “neanche morto”. Lo Stato ha pagato il
legale ai nomadi che mi hanno derubato, ai ladri». Ladri che ora, forse,
vivranno anche nella sua casa. Dopo averla derubata. Per anni. Benvenuti in
Italia.
Dopo la morte di Ermes sarà
lo Stato a risarcire i due ladri rom.
Secondo la legge i rom si
approprieranno della casa di Ermes. Intanto l'avvocato di Ermes attacca: "Era
preoccupato dal pignoramento", continua Giuseppe De Lorenzo. Ermes Mattielli è
morto d'infarto dopo il calvario giudiziario che lo aveva condannato a 5 anni e
4 mesi di galera. Gli unici ad uscire indenni (e più ricchi) da questa vicenda
sono i due ladri rom, che proprio dall'ex rigattiere attendevano i 135mila euro
di risarcimento che il giudice ha disposto. Li riceveranno dallo Stato. Sul
futuro dell’eredità, quello che è certo è che Ermes non aveva parenti stretti:
“Non ci sono genitori, moglie, figli né fratelli o sorelle - spiga l’avvocato di
fiducia di Mattielli, Maurizio Zuccollo - credo abbia solo qualche cugino”. Ma
questi potranno rifiutarsi di ricevere l’eredità, viste le modeste proprietà del
rigattiere e quel risarcimento da 135mila euro. Così, in assenza di eredi, lo
Stato diventerà proprietario dei beni di Ermes, adoperandosi per il pagamento
del dovuto ai rom. “L’art. 596 del codice civile - spiega a il Giornale
l’avvocato Marco Tomassoni - enuncia che, in mancanza di altri successibili,
l’eredità è devoluta allo Stato italiano: l’acquisto avviene di diritto senza
bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia”. Il secondo comma
dell’art. 586 prevede inoltre che lo Stato risponda dei debiti del defunto intra
vires (ovvero nei limiti di ciò che ha ricevuto dal defunto stesso) e che
“provveda alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e
legatari” che abbiano presentato dichiarazione di credito. Ovvero i due rom, che
potranno andare dal notaio per togliere da morto quello che non erano riusciti a
rubare a Mattielli in vita. E spostando sullo Stato l’onere del risarcimento.
Secondo l'avvocato del pensionato di Arsiero, Maurizio Zuccolo, l'infarto di
Ermes si inserisce in un momento di grossa preoccupazione per il rischio che la
sua casa - l'unica cosa di cui disponeva - gli venisse tolta per risarcire i
rom. "Era preoccupato per il futuro, aveva paura gli pignorassero la casa per
pagare i 135mila euro: era preoccupato come può esserlo chiunque si trovi in
quella situazione". Si può comprendere. Resta l'amarezza di una vicenda nata nel
segno di due rom delinquenti (ed ora più ricchi) e finita con la morte di un
onesto cittadino. Non può non indignare.
Una cosa è certa, però. Per
i poveri cristi vale “Colpevole fino a prova contraria”. Per gli intoccabili
vale "Innocente fino a prova contraria o fino all’archiviazione o alla
prescrizione".
Nel "palazzo dello
scandalo". Un giorno con i giudici indagati,
scrive Riccardo Lo Verso Mercoledì 23 Settembre 2015 su “Live Sicilia”. Da
Silvana Saguto a Tommaso Virga, passando per Lorenzo Chiaromonte e Dario
Scaletta. Alcuni hanno cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei
loro compiti, ma è negli uffici giudiziari palermitani che attenderanno il
giudizio del CSM sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Tommaso Virga
è nella sua stanza al primo piano del nuovo Palazzo di giustizia di Palermo. Due
rampe di scale lo separano dalla sezione Misure di prevenzione finita sotto
inchiesta. Siede alla scrivania dopo avere appeso la toga e tolto la pettorina,
il bavaglino bianco che un regio decreto del 1865 impone di indossare ai giudici
in udienza. Questioni di forma e decoro. Virga parla con i cancellieri e prepara
il calendario delle udienze della quarta sezione penale. Fa tutto ciò che deve
fare un presidente che si è appena insediato. Archiviata l'esperienza di
consigliere togato al Consiglio superiore della magistratura aspettava che si
liberasse una sezione a Palermo. Un incrocio, quanto meno insolito, ha fatto sì
che andasse a prendere il posto di Mario Fontana, chiamato a sostituire Silvana
Saguto, l'ex presidente delle Misure di prevenzione travolta dall'indagine in
cui è coinvolto lo stesso Virga. Che si mostra disponibile con il cronista che
bussa alla sua porta. “Nel rispetto del ruolo che ricopro non ho mai fatto
dichiarazioni”, dice il presidente chiarendo subito la sua intenzione di non
cambiare idea proprio adesso. Inutile chiedergli dell'indagine che lo coinvolge,
della credibilità della magistratura che vacilla, della perplessità legittima di
chi si chiede se questa storia possa intaccare la serenità necessaria per chi
deve amministrare la giustizia al di là di ogni ragionevole dubbio,
dell'opportunità di continuare a fare il giudice a Palermo. Perché tutti i
magistrati coinvolti nell'indagine sono e resteranno a Palermo. Alcuni hanno
cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei loro compiti, ma è negli
uffici giudiziari palermitani, nei luoghi dello scandalo, che attenderanno il
giudizio del Csm sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Virga è tanto
garbato quanto ermetico. Si limita a fare registrare un dato incontrovertibile:
“Sono al mio posto, a lavorare”. I suoi gesti e il tono della voce sembrano
rispondere alla domanda sulla serenità. Qualcuno degli addetti alla cancelleria
si spinge oltre le impressioni con una frase asciutta: “L'autorevolezza del
presidente Virga è fuori discussione”. Già, l'autorevolezza, al centro delle
discussioni che impegnano gli addetti ai lavori nell'apparente normalità di una
mattinata al Palazzo di giustizia. Apparente perché è profondo il solco
tracciato dalla domanda che anima ogni capannello che si forma nei corridoi o
davanti alle aule: può essere credibile una magistratura segnata da un'indagine,
fastidiosa oltre che grave visti i reati ipotizzati? Nello scandalo dei beni
confiscati sono coinvolti quattro magistrati. Uno è Tommaso Virga, gli altri
sono Silvana Saguto e Lorenzo Chiaramonte (vecchi componenti della sezione
Misure di prevenzione, azzerata con l'arrivo di Fontana) e il pubblico ministero
Dario Scaletta. Hanno ruoli diversi nella vicenda. Per tutti vale il principio
della presunzione di non colpevolezza su cui si basa il nostro stato di diritto.
La Saguto sarebbe il vertice del presunto sistema affaristico - i pubblici
ministeri di Caltanissetta ipotizzano i reati di corruzione, induzione alla
concussione e abuso d'ufficio - creato attorno alla gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla mafia. Un sistema che avrebbe finito per favorire
alcuni amministratori giudiziari piuttosto di altri. Fra i “favoriti” ci
sarebbero Gaetano Cappellano Seminara, il principe degli amministratori, e il
giovane Walter Virga, figlio del Tommaso di cui sopra. A detta dei pm nisseni,
il primo sarebbe stato nominato in cambio di consulenze assegnate al marito
della Saguto e il secondo per "ringraziare" Virga padre che, quando era
consigliere del Csm, avrebbe calmato le acque che si agitavano sull'operato
della Saguto. Un aiuto smentito nei giorni scorsi da Virga, tramite il suo
legale, l'avvocato Enrico Sorgi: “Durante il proprio mandato al Csm non
risultano essere stati avviati procedimenti disciplinari a carico della Saguto.
I fatti che formano oggetto della notizia diffusa sono del tutto privi di
potenziale fondamento”. Chiaramonte, invece, è indagato per abuso d'ufficio
perché non si sarebbe astenuto quando ha firmato l'incarico di amministratrice
giudiziaria a una persona di sua conoscenza. Infine c'è Dario Scaletta, pm della
Direzione distrettuale antimafia e rappresentante dell'accusa nei processi in
fase di misure di prevenzione. Scaletta avrebbe fatto sapere alla Saguto che era
stata trasferita da Palermo a Caltanissetta l'inchiesta su Walter Virga e cioè
il fascicolo da cui è partito il terremoto giudiziario. Il pubblico ministero ha
chiesto di non occuparsi più di indagini su Cosa nostra e di misure di
prevenzione. Tutti i magistrati, coinvolti nell'indagine a vario titolo e con
profili diversi, restano a Palermo. Silvana Saguto, appena avrà recuperato da un
infortunio fisico, andrà a presiedere la terza sezione della Corte d'assise.
Chiaramonte, ultimate le ferie, prenderà servizio all'ufficio del Giudice per le
indagini preliminari. Sarà il Csm a decidere se e quando trasferirli. Sul caso è
stato aperto un fascicolo, di cui si occuperà la Prima Commissione, competente
sui trasferimenti per incompatibilità ambientale e funzionale dei giudici. Il
Consiglio superiore della magistratura per tradizione non spicca in velocità. In
una giustizia spesso lumaca non fa eccezione il procedimento davanti
all'organismo di autogoverno della magistratura che somiglia molto, nel suo
svolgimento, ad un processo ordinario. A meno che non venga preso un
provvedimento cautelare urgente ci vorrà tempo prima di conoscere il destino dei
magistrati, forse più di quanto ne servirà ai pubblici ministeri di
Caltanissetta per chiudere le indagini o agli stessi indagati per chiarire la
loro posizione. Il “forse” è dovuto al fatto che le indagini affidate ai
finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Palermo sembrano essere appena
all'inizio e i pm non hanno alcuna intenzione, al momento, di sentire i
magistrati che avevano chiesto di essere interrogati. Oggi, però, son arrivate
le parole del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini durante il plenum. "Oggi
parlerò con il presidente della Repubblica", ha detto ribadendo la volontà di
"procedere con la massima tempestività e rigore".
Gli errori fatti dai giudici? Ecco quanto
ci sono già costati, scrive Franco Bechis, su “Libero
Quotidiano”. È una piccola città, composta da 22.689 cittadini italiani censiti
al 24 settembre 2014. E in questo momento assai vicina alle 24 mila
persone. Sono i perseguitati dalla giustizia italiana, cittadini mandati dietro
alle sbarre senza motivo dal 1992 ad oggi. Errori dei pubblici ministeri, che
hanno fatto scattare le manette ai loro polsi prendendo un abbaglio. Non un
errore casuale: una città. Probabilmente le vittime della giustizia sono ancora
di più, perché il tristissimo elenco numerico è compilato dal ministero
dell’Economia: i ventiquattromila sono quelli che dopo avere subito l’ingiusta
detenzione non si sono limitati ad accettare le scuse, ma hanno avuto la
possibilità di pagarsi un avvocato, fare ricorso e ottenere un risarcimento. Per
questo il loro elenco è conservato da Pier Carlo Padoan e non dal ministro della
Giustizia, Andrea Orlando: le casse dello Stato hanno dovuto pagare loro, per
l’errore e spesso la sciatteria dei magistrati, la bellezza di 567 milioni di
euro dal 1992 ad oggi. Ogni anno c’è un migliaio di casi così, qualche volta
anche il doppio. E il Tesoro è costretto a sborsare 20, 30, 40 perfino 55
milioni di euro l’anno per mettere una toppa ai guai combinati da magistrati
faciloni: è diventato un problema di finanza pubblica. Questo conto è assai
salato perché lo è il risarcimento a chi è stato in carcere ingiustamente anche
solo in custodia cautelare. Ma sale per le casse dello Stato accompagnato dai
risarcimenti per la legge Pinto sulla ingiusta durata dei processi, dalle
condanne continuamente ricevute dall’Unione europea per lo stesso motivo e per
l’incredibile ritardo con cui vengono pagati anche quei risarcimenti alle
vittime della mala giustizia. Oltre a quella piccola città - evidenziata nella
tabella qui in pagina - c’è anche un’altra cifra che fa tremare le vene ai
polsi: 30,6 milioni di euro che lo Stato ha dovuto pagare negli stessi anni a
100 vittime di errori giudiziari: casi in cui non solo hanno sbagliato pm, gip,
tribunali del riesame, ma anche le corti di primo e secondo grado e perfino la
Cassazione. Sentenze divenute definitive, e poi un nuovo evento, magari una
confessione improvvisa, svelano che il colpevole era invece innocente. I
risarcimenti dipendono dai mesi o anni di carcere ingiusto patito, ma queste
come le altre cifre sono la vera vergogna della giustizia italiana. Casi che
sembravano negli anni scorsi per lo meno ridursi, e che invece nell’ultimo
biennio sono tornati a lievitare. In tutto il 2013 erano 24,9 milioni i
risarcimenti pagati per ingiusta detenzione. In otto mesi e mezzo dell’anno
successivo si era già a 22,2 milioni di euro, e probabilmente l’anno si è chiuso
sopra i 29 milioni di euro. Da fonti ufficiose abbiamo appreso che la stessa
voce al 30 luglio 2015 era già arrivata a 20,9 milioni di euro di risarcimenti
pagati. Con quel trend quest’anno si chiuderà intorno ai 35 milioni di euro. Al
ministero custodiscono gelosamente la divisione per uffici giudiziari di questi
casi. Ma da fonti attendibili abbiamo saputo che ai vertici della classifica si
trovavano procure ben note alle cronache giudiziarie. I risarcimenti avvengono
normalmente 4-5 anni dopo gli errori, e fino al 2013 ai primi posti di questa
classifica del disonore c’erano gli uffici giudiziari di Potenza, poi
soppiantati nel 2014 e soprattutto nel 2015 dagli uffici giudiziari di Napoli.
Chissà se è l’effetto del passaggio da una procura all’altra di un pm
protagonista di indagini che hanno fatto molto discutere (e portato a scarsi
risultati processuali) come John Henry Woodcock. Ma il dato numerico è proprio
quello. Nella tabella del ministero esiste una voce in uscita, ma non una in
entrata. Chi ha compiuto quegli errori giudiziari non paga un centesimo di
quello che lo Stato deve versare. Spesso non paga nemmeno sotto il profilo
disciplinare, nonostante la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Il
fatto è che quasi sempre questi incredibili casi vengono trattati nascondendo la
polvere sotto classico tappeto di casa. I magistrati sbagliano, ma non pagano. A
settembre proprio questo sarà uno dei temi principali da affrontare sulla
giustizia. Il Nuovo Centrodestra ha depositato alcuni emendamenti a un disegno
di legge governativo che rendono obbligatoria l’azione disciplinare nei
confronti di qualsiasi magistrato abbia causato un risarcimento per ingiusta
detenzione o un errore giudiziario. Il Pd sta facendo resistenza, a difesa della
corporazione dei magistrati e fregandosene di quella città di vittime della
giustizia. Ma la battaglia è all’inizio.
Fbi, il grande inganno degli esami
truccati per incastrare gli imputati. Bufera sugli investigatori americani. I
controlli sospetti hanno ingiustamente mandato a morte 32 persone,
scrive Vittorio Zucconi su “La Repubblica”. Morire per un capello,
nell'illusione della pseudoscienza investigativa piegata agli imperativi della
politica e di indagini che devono produrre un colpevole a tutti i costi e
persino ucciderlo: è la morale raggelante della scoperta che l'Fbi ha
sopravvalutato, male interpretato o addirittura truccato per anni migliaia di
"prove" costruite sull'esame dei capelli. Prima che la genetica smentisse, con
gli esami del Dna, decine di sentenze rivelando l'innocenza dei condannati, il
Federal Bureau of Investigation aveva individuato nei capelli trovati sui luoghi
del delitto, più attendibili delle controverse impronte digitali, una della
direttissime per identificare i responsabili. Ma dopo un riesame minuzioso
condotto dalla Associazione Nazionale degli Avvocati Difensori, la Nacdl, e dal
"Progetto Innocenza", emerge che l'Fbi ha barato quasi sempre a favore
dell'accusa utilizzando l'esame microscopico dei capelli. Trentadue imputati
furono condannati a morte e quattordici di loro giustiziati, sulla base di
queste presunte prove truccate. L'espressione che l'inchiesta condotta sui
processi prima del 2000 e pubblicata ieri dai media americani come il Washington
Post è volutamente cauta, per non creare l'impressione che la massima agenzia
investigativa del governo federale e la sola nazionale bari al gioco terribile
della verità giudiziaria: l'Fbi ha overstated, si dice, ha esagerato, ha
sopravvalutato le evidenze probatorie cercate con il microscopio nei capelli e
nei peli sui luoghi del delitto, offrendo agli investigatori, all'accusa, alle
giurie popolari certezze che certezze non erano. Ma le parole non possono
cambiare i numeri che sono raggelanti. Nei 268 casi nei quali i capelli sono
stati usati contro l'imputato l'Fbi ha portato in dibattimento prove che non
erano prove, elementi fasulli. Nel 95 per cento dei casi studiati, l'errore è
andato a favore dell'accusa, contribuendo alla sentenza di colpevolezza.
Soltanto raramente l'errore, che sempre e comunque è possibile, ha portato
all'assoluzione. Sono dati, comunque parziali perché ancora le polizie e le
procure della repubblica rifiutano di aprire gli archivi su 1200 processi, che
tendono a confermare il classico sospetto di ogni avvocato difensore e di ogni
imputato, che la macchina investigativa, l'apparato della Giustizia siano
costruiti intenzionalmente non per portare alla determinazione della
colpevolezza o della non colpevolezza, ma per raggiungere a ogni costo una
sentenza di condanna. L'Fbi, che dopo i decenni della implicita, autocratica
certezza di infallibilità che il suo creatore e zar, J. Edgar Hoover aveva
creato con instancabile propaganda, ha risposto, insieme con il Ministero della
Giustizia, che il Bureau, come tutti i magistrati inquirenti e i tribunali "sono
fortemente impegnati a perfezionare e rendere ancora più accurate le analisi dei
capelli, così come l'applicazione di tutte le scienze forensi ". Mentre tutti i
condannati in processi basati sull'esame dei capelli saranno informati dei
possibili errori giudiziari. Un impegno che sarà di poco conforto per i
quattordici uomini già passati attraverso le camere della morte nei
penitenziari. La rivelazione, che si aggiunge alle vicende di detenuti, alcuni
addirittura da anni nei bracci della morte, scagionati completamente dai nuovi
test sul Dna, non certifica la fallibilità dei test sui capelli, ma fa di
peggio: insinua il dubbio che l'Fbi, come le Procure, le polizie, la pubblica
accusa giochino a carte truccate pur di ottenere prima l'incriminazione e poi la
condanna dell'accusato. E così giustificare davanti a elettori che chiedono
"giustizia" indagini e celebrazioni di processi, valutate positivamente soltanto
se portano a una condanna. I prosecutor, i magistrati dell'accusa, sono misurati
in funzione delle sentenze di colpevolezza che riescono a ottenere. Il principio
del dubbio pro reo, che deve valere nelle aule di giustizia quando il
procedimento è pubblico, non vige nei laboratori delle analisi scientifiche
dove, se questi dati sono concreti, sembra funzionare l'esatto opposto: nel
dubbio, si va contro il presunto reo. Un dubbio che apre un altro, amarissimo
capitolo nell'amministrazione della Giustizia anche nelle nazioni apparentemente
più garantiste e rispettose dei diritti dell'accusato e dell'imputato. Che siano
i soldi e non la scienza ha determinare l'esito di un procedimento. Nel sospetto
che anche le prove e gli indizi qualificati con la solennità della scienza siano
piegati alla soggettività di chi investiga e conduce l'accusa "nel nome del
popolo", la difesa deve ricorrere a controanalisi e controperizie capaci di
confutare, o almeno di mettere in discussione le conclusioni degli accusatori.
Un diritto che ha un enorme e ovvio limite nei costi: non tutti gli imputati
possono permettersi le batterie di contro analisi forensi e quelli che non
possono si devono affidare al lavoro di agenzie governativa teoricamente al di
sopra delle parti. Una semplice, quanto evidente spiegazione del perché sia
molto più facile mandare in carcere o al patibolo i poveri e sia più facile
scampare, per i ricchi. Eppure anche i meno ricchi pagano le tasse che
finanziano il lavoro dei funzionari governativi che li trascinano in carcere
tirandoli per i capelli.
Ed in Italia?
C'è l'Italia a 5 stelle. Casaleggio vuole
processi infiniti per tutti. Casaleggio: le prime tre cose che faremo al
governo. «Via prescrizione» Grillo: «Come? Ho 40 processi aperti».
Botta e risposta (a distanza) tra il guru e il comico. Tra i
primi punti: “Per la pubblica amministrazione sceglieremo sulla base della
fedina penale", scrive
Marta Serafini su “Il Corriere della Sera” il 18 ottobre 2015.
Inizia con Casaleggio che fa un giro per gli stand della piazza grillina di
Imola. Pochissime parole, circondato da un servizio d’ordine severissimo, il
guru del Movimento ha aggiunto qualche elemento in più rispetto a
quanto detto dal palco di sabato sera, quando ha spiegato che la squadra
di governo dei 5 stelle sarà scelta dagli iscritti. «Tra i primi punti del
nostro programma (che sarà
anch’esso votato dalla base come annunciato sabato sera,
ndr), c’è eliminare la corruzione con gli onesti». Un refrain del
Movimento dunque. Ma poi Casaleggio, dopo aver dribblato le domande
sull’abolizione del nome di Grillo dal logo, va oltre con un annuncio più
sostanzioso «Metteremo mano alla giustizia abolendo la prescrizione», dice a
voce bassissima. Una notizia che però non piace troppo a Grillo. Ai microfoni di
CorriereTv, il comico (anzi, l’Elevato come ha chiesto di essere chiamato ieri)
sbotta: «Come abolire la prescrizione? Io c’ho 40 processi». Poi scherza e, a un
cronista che gli chiede delle unioni civili, dice: «1,2,3 al mio tre ti
dimenticherai le domanda». Il tutto mentre una signora tenta di baciarlo e la
sicurezza la respinge in malo modo. È ancora Casaleggio a dare le risposte più
politiche, ossia «mettere persone oneste nelle amministrazioni». E Il primo
criterio sarà «la fedina penale», i sospettabili non sarà possibile sceglierli.
A scegliere persone e proposte, ancora una volta saranno gli attivisti,
attraverso la piattaforma «che è in grado di accogliere i contenuti, che possono
essere tanti e diversi». Il problema sarà piuttosto fare una sintesi, è
l’ammissione del guru che annuncia anche dei miglioramenti sulla piattaforma.
Sui tempi Casaleggio non si sbottona. Ma assicura che lo stesso sistema sarà
applicato anche per scegliere i candidati sindaco. Insomma,
si preannuncia vivace la seconda e ultima giornata della kermesse grillina. E
c’è anche una piccola contestazione, «chiedetegli ai grillini quanto hanno
pagato per l’affitto dell’autodromo!», dice un ragazzo in rollerblade e poi
scappa via. Mentre la piazza aspetta il gran finale di stasera con Alessandro Di
Battista. All’ora di pranzo, Grillo torna sul palco e grida: «Non siamo un
movimento siamo una finanziaria della Madonna». E poi ripete: «Siamo l’arca di
Noè, siamo la salvezza. E pensate quando la moglie di Noè gli diceva che cazzo
stai facendo?», scherza. Poi cita Bob Kennedy (il Pil non è indicatore di
benessere). Ma anche Willy il Coyote (“che corre anche quando non c’ha il
terreno sotto i piedi”) ma anche le amebe osservate da uno studioso giapponese
che ad un certo punto hanno iniziato a muoversi («Sono come me e Casaleggio»). E
il filo rosso della kermesse di Imola rimane l’utopia: «Non abbiamo bisogno di
leader e di guru. E nemmeno di Elevati. Abbiamo bisogno di un paese in cui i
nostri figli vogliano rimanere».
M5S, Casaleggio: "Se andiamo al governo
eliminiamo la prescrizione", scrive “Libero Quotidiano”. "La prima cosa da fare
è eliminare la corruzione con l'onestà, mettere mano alla giustizia ed eliminare
la prescrizione".
Lo ha detto Gianroberto Casaleggio rispondendo
dalla festa dei 5 Stelle a Imola ai giornalisti che gli chiedevano le prime tre
cose da fare se il Movimento
5 Stelle andasse al governo. Poi, ha
proseguito Casaleggio, "bisogna mettere persone oneste nelle amministrazioni
scelte in base alla fedina penale. I sospettabili - ha sottolineato - non sarà
possibile sceglierli". "Casaleggio? Pura follia" -
"La proposta di Casaleggio è pura follia. Con la lentezza dei processi in Italia
e con l'uso politico che si fa della giustizia nel nostro Paese, eliminare la
prescrizione vorrebbe dire tenere ogni singolo cittadino in ostaggio per tutta
la vita", è il commento di Elvira Savino,
deputata di Forza
Italia. "Le parole dello stratega della
comunicazione di Grillo - aggiunge Savino - dimostrano tutta la pericolosità del
Movimento 5 stelle, profondamente illiberale e fondato sul giustizialismo. Il
grillismo è un riadattamento ai tempi moderni di quel dipietrismo che
è già fallito e che tanti danni ha prodotto al nostro Paese". «I grillini
confermano la loro imbarazzante inclinazione al becero giustizialismo» aggiunge
la collega di partito Gabriella Giammanco.
Il fatto che qualcuno additi qualcun altro di
essere ladro è storia vecchia.
COLPA DEI PROCESSI
INDIZIARI...
Colpa dei
processi indiziari. Colpa dei processi
indiziari (se c'è chi sbaglia a indagare, a periziare, a sentenziare... e troppi
innocenti vengono spediti in carcere e uccisi psicologicamente sui media).
Gli sbagli della giustizia moderna denunciati dal dottor Imposimato già sei anni
fa...Colpa dei processi indiziari. Di Ferdinando Imposimato su “Albatros Volando
Controvento” del 28 dicembre 2015. Bisogna anzitutto partire da un dato. Nella
realtà processuale, nell’esame dei diversi casi giudiziari, esistono due verità
antitetiche: una verità reale e una processuale. Queste due verità non
coincidono quasi mai. L’obiettivo fondamentale del giudice consiste nel fare
emergere la verità storica, affinché tra questa e il giudizio finale vi sia una
perfetta coincidenza. Questo risultato, tuttavia, difficilmente viene raggiunto
per una serie di ragioni sia di ordine processuale che professionale. L’aspetto
drammatico del processo è che il giudice, nel conflitto tra le due verità, è
tenuto a seguire soltanto e semplicemente quella processuale. Questa
contraddizione può manifestarsi in due modi: il giudice può avere la convinzione
morale della colpevolezza della persona imputata nei confronti della quale però
manchino le prove o queste non siano sufficienti. In questo caso il giudizio non
può che essere di assoluzione. Nel secondo caso, il giudice può avere l’intima
convinzione dell’innocenza di una persona, ma le prove processuali –
testimonianze, riconoscimenti, perizie – depongono contro l’imputato. La
conseguenza è drammatica: la condanna di un imputato è “giusta” sul piano
processuale ma ingiusta su quello sostanziale. E’ la tragedia dell’Enrico VIII
di Shakespeare, nella quale il duca di Buckingham, condannato a morte per le
accuse calunniose dei suoi servi, non impreca contro i giudici ma ne accetta il
verdetto: “Non nutro rancore contro la legge per la mia morte: alla stregua
del processo essa doveveva infliggermela, ma desidero che coloro che mi hanno
accusato divengano più cristiani…”. Il giudice deve decidere solo in base
alle emergenze processuali. Anche se intuisce la verità reale, egli ha l’obbligo
di applicare la legge, quindi di tener conto delle risultanze processuali che
molto spesso, portano lontano dalla verità reale. Rispetto a quest’ultima, le
deviazioni sono dipendenti da diversi fattori: da errori dei testimoni nella
percezione della verità (si confonde una persona con un’altra), degli
investigatori nella ricerca delle prove, dei periti nella ricostruzione di un
fatto storico, del giudice nell’esercizio del metodo deduttivo con il quale si
risale da un fatto certo ad un altro fatto. Una deviazione assai frequente della
verità storica è quella che nasce da perizie medico legali e psichiatriche
errate. Nel caso di un delitto con autore ignoto e con molti sospettati,
l’affermazione da parte del perito medico legale che si tratta dell’opera di un
sadico, di un maniaco sessuale che ha certe caratteristiche fisiche e psichiche
(si presume in alcuni casi di definire l’altezza e la corporatura dell’ignoto
autore!!), unita alla conclusione del perito psichiatrico che la persona
soprattutto è un soggetto che ha quelle caratteristiche descritte dal medico
legale, producono come conseguenza pericolosa l’errore del giudice. Nella mia
non breve esperienza, non è stato infrequente l’errore dei periti psichiatrici
d’ufficio (cioè nominati dal giudice) nell’accertamento della “capacità di
intendere e/o di volere di un soggetto”. Sovente essi hanno affermato che il
soggetto rientrava in una certa categoria che era proprio quella nella quale il
pubblico ministero aveva collocato l’autore del delitto. Ma non è stato raro il
caso del privato che ha assecondato l’orientamento sbagliato della pubblica
opinione. I periti, insomma, compiono spesso il loro lavoro sotto la spinta di
fattori emotivi, di elementi extrascientifici che li conducono a conclusioni
lontane dalla verità. E questa è una delle cause più frequenti dell’errore
giudiziario. Non mi riferisco soltanto ai periti psichiatrici, ma anche a quelli
balistici, grafici, ai medici legali in genere. Le perizie, specialmente nei
grandi processi, sono un dato costante della ricerca della verità. Molto spesso allontanano
dalla verità perché compiute da persone che non sono in grado di far bene il
proprio lavoro – anche se solo raramente si tratta di persone in malafede.
Esempio classico: nell’esame ordinato per l’omicidio del giudice Emilio
Alessandrini ci fu un perito che affermò, con certezza assoluta, che l’arma che
aveva sparato il proiettile mortale contro il giudice era una certa pistola.
Siccome questa pistola proveniva da un certo terrorista, che era un uomo che
aveva commesso un altro omicidio, il giudice disse: “Questo è l’uomo che ha
ucciso Alessandrini”. Senonché, a distanza di quattro o cinque anni, venne fuori
il vero assassino che confessò, aggiungendo di aver sparato con un’altra
pistola. Altri periti, in seguito, confermarono che il primo aveva sbagliato.
Da allora mi resi conto che quell’uomo avrebbe potuto subire un ergastolo per
via di una perizia sbagliata, e che se non fosse venuto fuori il vero autore
dell’omicidio, quell’errore non sarebbe mai stato scoperto. Ma il problema è
che non sempre vengono fuori i veri autori di un crimine. Molto spesso, poi, il
giudice non è in grado – un po’ per incapacità, un po’ per superbia, un po’ per
gli errori altrui – di cogliere l’errore. Di qui le tragedie che si verificano: il
numero degli errori giudiziari è molto superiore a quello che viene normalmente
percepito nella realtà. Un’altra causa molto frequente di errore è
costituita dai riconoscimenti personali: è molto facile che siano sbagliati.
Nell’istruire il caso Moro, ricordo di aver ascoltato personalmente cinque o sei
testimoni che affermavano con assoluta certezza di aver visto in via Fani un
terrorista la cui descrizione corrispondeva a Corrado Alunni. Quest’ultimo,
inevitabilmente, ricevette un mandato di cattura per concorso nel sequestro e
nell’omicidio di Aldo Moro. Senonché, per sua fortuna, presto vennero fuori i
veri autori della strage di via Fani, che esclusero categoricamente che Alunni
fosse presente; in secondo luogo, non fu difficile appurare che egli, il
giorno del sequestro, era detenuto. Ecco, questa vicenda rappresenta il
classico esempio di errore compiuto dal giudice, ma provocato dall’errore
altrui: il giudice è infatti obbligato a tener conto delle testimonianze di
persone della società civile, disinteressate e che non conoscendosi tra loro
facciano il medesimo riconoscimento personale nel rispetto delle garanzie
stabilite dalla legge, quando per giunta affermano qualcosa “con assoluta
certezza”. Un altro caso, legato all’omicidio di Girolamo Tartaglione: una
ragazza confessò di essere responsabile dell’assassinio, chiamando in
correità altre due persone. Nel leggere il testo della confessione di questa
ragazza – molto precisa e dettagliata – mi resi conto che si trattava di un
falso, per un paio di particolari rivelatori. Non volli accettare quella
“verità” processuale, condivisa invece dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e
dal pubblico ministero. Non volli assecondare la tesi della stampa che parlava
di brillante soluzione del caso Tartaglione. Ero convinto, sulla base di due
dati oggettivi, che la verità processuale emersa fino a quel momento non fosse
corretta. Riuscii, col tempo, a convincere la donna a ritrattare e ad
affermare che aveva confessato il falso. Per fortuna, perché poco tempo dopo
vennero fuori i veri autori dell’omicidio (Valerio Morucci e Adriana
Faranda). Ebbene, questo esempio serve a dimostrare ciò che vado da sempre
ripetendo: la confessione non è “la madre di tutte le prove”, perché può
accadere che anch’essa sia fonte di errore. Che cosa può consentire di
capire quando qualcuno dica il vero e quando il falso? La professionalità di un
giudice o di un investigatore, indipendentemente dall’esistenza di altri
elementi che possano smentirlo. Uno dei più gravi fattori capaci di provocare
l’errore giudiziario è poi la presenza, nel nostro ordinamento, del principio
del libero convincimento del giudice (sancito dall’art.192 del codice di
procedura penale). L’esistenza di un fatto può essere desunta non soltanto dalla
prova, ma anche dagli indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti. In
realtà, l’art.192 afferma una regola – il fatto non può essere provato se non
attraverso la prova legale – che prevede una sola eccezione: la presenza di
indizi che abbiano le tre caratteristiche sopra accennate. Ma la realtà del
nostro ordinamento è purtroppo diversa: l’eccezione è diventata una regola. I
procedimenti sono ormai quasi tutti indiziari. Che cos’è un indizio? Un fatto
desunto dall’esistenza di un altro fatto. In pratica, il risultato di una
deduzione logica. E qui veniamo all’errore, perché troppo spesso l’indizio
non è altro che un sospetto che si è trasformato in un indizio, prima di
trasformarsi ulteriormente in prova. Questo è un grave vizio
dell’ordinamento giudiziario del nostro paese, capace di portare alle situazioni
processuali assurde e inaccettabili così frequenti nei tribunali italiani. Per
molti casi clamorosi – piazza Fontana, strage di Bologna, omicidio Chinnici,
comunque per il 60-70 per cento di fatti di straordinaria gravità – si sono
avute decisioni contraddittorie a livello di giudici di merito: non dunque in
Cassazione, ma tra il primo e il secondo grado di giudizio. Sentenze di condanna
rovesciate in pronunciamenti assolutori, sulla base degli stessi elementi in
punto di fatto. Molto spesso, un medesimo quadro probatorio è giudicato in
maniera differente: sugli stessi elementi si pronunciano in maniera opposta i
giudici di primo e quelli del secondo grado. Ma questo non può essere,
perché gli elementi di prova devono essere valutati in modo uniforme da tutti i
giudici. In caso contrario, si potrebbe parlare di un fatto arbitrario. Certo,
in presenza di ulteriori elementi che completino, migliorino, rettifichino un
certo quadro, d’accordo; ma quando questo quadro è esattamente lo stesso, allora
vuol dire che c’è qualcosa che non va. Un qualcosa rappresentato proprio dal
principio del libero convincimento del giudice, in virtù del quale alcuni
giudici considerano certi indizi né gravi, né precisi, né concordanti; altri
giudici, invece, si pronunciano in senso opposto. A questo punto, una serie
spaventosa di errori giudiziari diventa inevitabile. Per quel che mi
riguarda, credo purtroppo di aver quanto meno contribuito a commettere errori
giudiziari, nella mia veste di giudice istruttore, organo monocratico che –
secondo il vecchio rito penale – doveva ricostruire la verità nel corso della
fase più difficile, quella della verifica delle prove raccolte dalla polizia o
offerte dal pubblico ministero. Ma, potendo contare su una fortissima
personalità, non mi è mai capitato di venire influenzato dalla polizia o dal pm.
Molto spesso, anzi, mi è capitato di ricostruire un fatto in maniera decisamente
diversa da quella seguita dal pubblico ministero. Perché sono convinto che
anche quelle che sembrano verità elementari e pacifiche debbano sempre essere
verificate. Esistono rimedi concreti al problema dell’errore giudiziario? A
mio avviso, il vizio è ineliminabile. Al massimo lo si potrà ridurre, puntando
verso due distinte direzioni. Da un lato, la professionalità del giudice, vale a
dire la formazione del magistrato, la valutazione delle sue capacità, che non
consistono soltanto nella conoscenza tecnica del diritto, ma anche nel saper
ricostruire la verità attraverso la valutazione critica di tutte le prove. Una
maggiore professionalità che va però richiesta anche ai periti, per evitare
valutazioni errate capaci di pregiudicare il corretto andamento processuale e di
generare errori giudiziari. Dall’altro lato, il libero convincimento del
giudice: un principio da rivedere, prendendo spunto da altri sistemi (per
esempio, quello anglosassone) nei quali la deduzione logica non ha valore
probatorio, che è riservato invece esclusivamente a un elenco tassativo,
sancito dalla legge. Senza essere esterofili – perché anche gli ordinamenti
degli altri paesi sono caratterizzati da vizi di diverso tipo – ritengo che la
possibilità di trasformare in prova un semplice indizio – il più delle volte
privo di qualsiasi rilevanza probatoria – rappresenti un nodo che deve essere
risolto prima possibile. Il rischio che una persona possa essere arrestata sulla
base di elementi labili, che poi possono essere valutati o svalutati secondo
l’umore del giudice di turno, è una delle circostanze maggiormente deprecabili
del nostro sistema. Un dato che contribuisce ad affievolire la certezza del
diritto. Ma l’errore ha anche altre radici, delle quali si discute molto negli
ultimi anni. La più importante è l’interpretazione della legge contro
l’intenzione del legislatore, come conseguenza della violazione stessa del
principio dell’imparzialità del giudice. L’attività politica del giudice
all’inevitabile scontrarsi delle ideologie a scapito della verità e
dell’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. L’opinione di Cesare Beccaria
circa l’arbitrio lasciato ai giudici, dal principio del libero convincimento, di
orientarsi nell’interpretazione delle leggi recando le loro filosofie sociali e
politiche illuminate: “Il sovrano sarà il legittimo interprete delle leggi,
perché è il depositario delle libertà di tutti, non il giudice il cui ufficio è
solo l’esaminare se il tal uomo abbia fatto, o non, un’azione contraria alle
leggi. Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma che bisogna consultare lo
spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa
verità, che sembra un paradosso alle menti volgari più percosse da un picciol
disordine presente che dalla funeste ma remote conseguenze che nascono da un
falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata”. E poi
Beccaria traccia il quadro delle storture che derivano da un’interpretazione
legata alle opinioni soggettive dei giudici: “Le nostre congnizioni e
le nostre idee hanno una reciproca connessione: quanto più sono complicate,
tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo
ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso. Lo
spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o di una cattiva
logica del giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla
violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del
giudice con l’offeso, e da tutte quelle minute forse che cangiano le apparenze
di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo. Quindi veggiamo la sorte di un
cittadino (colpevole o innocente, nda) cangiarsi spesse volte nel
passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite dei miserabili essere vittime
dei falsi raziocinii, o dell’attuale fermento degli umori di un giudice, che
prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa
serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti
dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi per aver consultato
non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante instabilità delle
interpretazioni”. (C. Beccaria: “Dei delitti e delle pene”). Ludovico
Antonio Muratori espresse un giudizio analogo e ancora più pessimistico sulla
giustizia affermando che “misera è la condizione di chi deve litigare, egli
si crede di andare a picchiare alle porte della giustizia, né si accorge che va
a mettere il suo alla ventura di un lotto”. E questa condizione si ripete in
tutti i luoghi e in tutti i tempi. Il nostro compito è quello di combatterle
essendo sempre pronti a riconoscere l’errore. Prima di concludere mi viene alla
mente l’immagine del giovane arrestato dalla magistratura come “mostro di
Merano”. Il suo volto muto e disperato deve indurre alla riflessione. Luca
Nobile era stritolato nella macchina della giustizia e non aveva voce per
gridare la sua innocenza. Solo la ripetizione degli omicidi da parte del vero
assassino ha salvato l’innocente da una probabile condanna all’ergastolo. La
sua unica colpa fu quella di essere somigliante all’autore dei delitti.
I limiti strutturali del processo
indiziario, scrive Luca Cheli. La natura del processo
indiziario nel diritto penale italiano ha origine nella distinzione tra “prova
diretta o storica” e “indizio” in quanto elementi di prova. Cercando
di non complicare troppo le definizioni, a cui sono stati dedicati interi libri,
la prova diretta o storica è la rappresentazione diretta del fatto da provare
(tramite fotografia o testimonianza, per esempio), mentre l’indizio e un fatto
(certo nella sua esistenza, almeno in teoria) dal quale può essere
inferenzialmente dedotto il fatto da provare. Anche la prova diretta non è
automaticamente “verità sicura”, perché le testimonianze devono
essere valutate nella loro credibilità e le fotografie (per esempio) nella loro
autenticità. Tuttavia, se tre persone vedono da pochi metri di distanza Tizio
sparare a Caio e una delle tre persone riprende pure l’atto con il proprio
smartphone, si può dire, una volta verificato che i testimoni non hanno motivo
di mentire o di coalizzarsi contro Tizio e che il filmato ripreso non è stato
alterato in qualche modo, che la colpevolezza di Tizio è provata oltre ogni
ragionevole dubbio. Se invece il teste Uno riferisce di dissapori tra
Tizio e Caio, il teste Due di aver visto, poco prima del fatto, Tizio
vicino alla zona dove Caio è stato ucciso ed il teste Tre di aver sentito
una volta Tizio parlare di una vecchia pistola che suo nonno aveva sottratto ai
tedeschi in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale, allora siamo in
presenza di indizi. Questo perché nessuna delle tre testimonianze è diretta
rappresentazione del fatto da provare (che Tizio abbia sparato a Caio), ma
ognuna riporta un fatto noto e certo (ma su questo torneremo), dal quale si
potrebbe dedurre che Tizio abbia effettivamente sparato a Caio: perché ne aveva
il movente (dissapori), il mezzo (pistola del nonno) e l’opportunità (è stato
visto nelle vicinanze della zona del delitto poco prima che questo avvenisse).
In questo secondo caso il processo a Tizio per l’omicidio di Caio sarebbe un
processo indiziario. Ho volutamente presentato un caso di processo indiziario
molto “semplice” che probabilmente farà propendere la maggioranza dei
lettori per la “probabile” colpevolezza di Tizio. Ma persino così le cose
non sono affatto “semplici”. In effetti, cosa lega i tre fatti noti
(forniti dai tre testimoni) al fatto ignoto da provare (Tizio ha o non ha
sparato a Caio)? Essenzialmente la nostra (del lettore o del giudice fa poca
differenza) logica, ovvero il modo in cui la nostra mente ritiene che da certi
fatti ne debbano, con maggior o minore probabilità, derivare degli altri.
Insomma molti di noi penseranno che se Tizio ce l’aveva con Caio, se aveva una
pistola ed era pure stato visto vicino alla scena del crimine poco prima che lo
stesso avvenisse... deve essere con ogni probabilità colpevole. Il ragionamento
costitutivo alla base del processo indiziario presenta una certa analogia con la
formula che permette, nella geometria euclidea, di ottenere il valore di
uno dei tre angoli interni di un triangolo conoscendo l’ampiezza degli altri
due. In questa analogia si potrebbe dire che la prova diretta è costituita dalla
misurazione diretta dell’angolo di cui vogliamo conoscere l’ampiezza, mentre gli
indizi sono costituiti dal valore dell’ampiezza degli altri due angoli interni
del triangolo. Ora, nella geometria euclidea i due modi di ottenere il valore di
uno degli angoli interni sono equivalenti perché la somma dei tre vale sempre
180 gradi. Abbiamo cioè una regola certa, sicura ed invariante. Ma la realtà
delle cose, degli eventi, della vita non fornisce mai la rassicurante certezza
delle formule di Euclide. E allora cosa succede? Parlando con un linguaggio
diverso e meno aulico rispetto a quello dei tomi di giurisprudenza, dirò che
alla fine dei conti si va per “probabilità”, ma una probabilità non
quantificata e ben difficilmente quantificabile: un “mi pare”, “mi
sembra”, “credo”. Ovviamente nelle motivazioni i giudici togati usano
altre espressioni, ma chi ha letto qualche sentenza si ricorderà di espressioni
quali “è ragionevole ritenere”, “risulta credibile”, “questo
Giudice ritiene” e così via, che sostanzialmente sono la rappresentazione in
termini “giuridicamente corretti” (e presentabili) delle valutazioni a
spanna di cui sopra. Perché, sia chiaro, i giudici professionisti conoscono
senz’altro la procedura e gli aspetti tecnici del diritto meglio di un
dilettante, quale l’autore del presente articolo, tuttavia, quando si tratta di
applicare la “logica” in un processo indiziario alla fondamentale domanda
“colpevole o innocente”, essi non hanno più strumenti del cittadino
medio. E d’altronde di cittadini medi è formata la maggioranza (6 su 8) dei
membri delle Corti di Assise e di quelle di Appello del nostro Paese. Non per
caso, infatti, di “libero convincimento” del giudice parla il nostro
ordinamento: per quanto possano essere nobili le origini storiche di
quell’espressione, di fatto si parla sempre, in ultima analisi, di una
convinzione soggettiva e individuale. Infatti, cosa lega la pistola del nonno di
Tizio, la presenza del medesimo nelle vicinanze della zona del crimine e i suoi
dissidi con Caio all’omicidio di quest’ultimo? Non c’è nessuna regola dei
centottanta gradi, nessuna formula matematica: ci sono solo le nostre
considerazioni su cosa riteniamo più o meno probabile o ragionevole. La
pistola del nonno potrebbe essere un ferrovecchio arrugginito ed inutilizzabile
che Tizio non sa nemmeno più dove sia o che può aver buttato per inutilità dopo
averne parlato al teste Tre svariati mesi (o anni) prima del delitto, la
presenza di Tizio in prossimità del luogo del crimine una mera coincidenza e i
dissapori con Caio la rappresentazione amplificata post omicidio di piccole
beghe che ognuno di noi può avere. Una certa linea di pensiero, molto
sfortunatamente spesso in Italia fatta propria anche dalla Cassazione, sostiene
che gli indizi vanno considerati globalmente, con l’implicito corollario che se
anche ognuno di essi può essere spiegato diversamente, quando vengono
considerati collettivamente allora assumono un valore probatorio non solo
superiore ma addirittura determinante (in una delle peggiori sentenze recenti
della Cassazione, questo processo è stato definito “valutazione osmotica”).
Con buona pace dei Soloni più o meno variamente togati ed imparruccati di questo
mondo, per quanto la presenza di più indizi certamente rafforzi un possibile
quadro accusatorio rispetto ad un numero inferiore dei medesimi, ciò che essi
vanno a formare è una possibile rappresentazione degli eventi, mai l’unica e
spesso neppure la più probabile. Sì, certo, se a casa di Tizio dovesse essere
trovata una Luger P08 la cui rigatura della canna coincide con i segni
sulle pallottole estratte dal corpo di Caio, e magari pure un diario scritto di
proprio pugno da Tizio in cui questi esprime il proprio odio per Caio e lo
minaccia ripetutamente di morte, allora direi che la probabilità che Tizio sia
colpevole è alta. Ma quanto, in percentuale? Ottanta, ottantacinque, novanta,
novantacinque, novantanove per cento? Come potrei quantificarla? E se anche
potessi quantificarla, quale sarebbe la “soglia” probabilistica oltre la
quale sarebbe giusto condannare? E se, come spesso succede con le perizie,
quelle rigature sono solo compatibili con quelle sui proiettili? E se Tizio
avesse scritto frasi simili sul suo diario anni prima nei confronti di Sempronio
e Calpurnia, senza mai aver poi fatto loro alcun male? Quanto cambierebbero le
mie probabilità? Il punto fondamentale, alla fine di tutto, è che non abbiamo
alcuna regola certa e matematica; pensiamo di avere una logica, ma anche questa,
in ultima analisi, quanto si distingue dalle nostre sensazioni ed impressioni?
Un’ultima parola la riservo alle famigerate prove scientifiche, che dovrebbero
quantomeno portare qualche saldo elemento numerico-quantitativo nella nebbia
probabilistica (ma sarebbe meglio dire “possibilistica”, visto che si
parla di probabilità non propriamente quantificabili). Purtroppo, nella realtà
delle perizie e consulenze tecniche come esse oggi sono in Italia, la prevalenza
di espressioni qualitative quali “compatibilità”, “non
incompatibilità”, nonché spesso “opinioni d’esperto” non
suffragate da studi quantitativi, non fa che aggiungere altra foschia al già
indistinguibile paesaggio della verità fattuale. Gianrico Carofiglio,
nella sua opera “L’arte del dubbio” definisce il risultato di un processo
come “individuazione di verità accettabili nella prospettiva dell’adozione
di decisioni preferibili”. Verità accettabili, decisioni preferibili. E’
un linguaggio che mi suona tremendamente “politico”. Se dovessi decidere
di condannare qualcuno a pene detentive, io vorrei avere verità certe e
decisioni giuste, altrimenti non me la sentirei mai. Ma certo capisco che se uno
ragiona in termini di mantenimento dell’ordine nella società (e questo è un
ragionamento politico), allora si può ambire a verità credibili per la società
stessa e a decisioni preferibili per l’effetto che esse hanno sulla stabilità
della società medesima. Però sia chiaro che stiamo parlando di stabilità e
controllo della società, non di giustizia per la vittima, per i famigliari,
eccetera, eccetera. Abbandoniamo quindi una certa retorica facile a sentirsi sui
giornali e in TV e chiediamoci semplicemente se in realtà non abbiamo bisogno
del processo indiziario per scopi di ordine sociale e quindi, in ultima analisi,
di stabilità dello Stato. Possiamo anche rispondere positivamente, ma a quel
punto non stiamo più facendo giustizia, ma solo politica.
L'INGIUSTIZIA NON E' UNA UTOPIA: E' REALTA'.
GIUSTIZIA INGIUSTA. Boom di
innocenti in cella anche nel 2015.
La top ten degli errori giudiziari dell’anno. Quattro milioni arrestati
ingiustamente In compenso dal ’98 al 2014 gli inquirenti riconosciuti colpevoli
sono solo quattro, scrive Luca Rocca il 30 dicembre 2015 su “Il Tempo”. Milioni
di persone incarcerate ingiustamente, migliaia le vittime di errori giudiziari,
centinaia di milioni di euro per risarcire chi, da innocente, ha subìto i
soprusi di una giustizia letteralmente allo sfascio. I numeri che descrivono il
penoso stato del nostro sistema giudiziario non lasciano scampo e immortalano
uno scenario disastroso a cui nessun governo è riuscito, finora, a porre
rimedio. Il sito errorigiudiziari.com, curato da Valentino Maimone e Benedetto
Lattanzi, ha messo in rete i 25 casi più eclatanti del 2015 di cittadini
innocenti precipitati nella inestricabile ragnatela della malagiustizia
italiana. Casi che contribuiscono a rendere il panorama del nostro impianto
giudiziario, come certificano più fonti (Unione Camere Penali, Eurispes,
Ristretti Orizzonti, ministero della Giustizia), più fosco di quanto si pensi.
INNOCENTI IN CARCERE.
Se
dall’inizio degli anni ’90 gli italiani finiti ingiustamente dietro le sbarre
sono stati circa 50mila, negli ultimi 50 anni nelle nostre carceri sono passati
4 milioni di innocenti. E se nell’arco di tempo che va dal 1992 al 2014 ben
23.226 cittadini hanno subìto lo stesso destino, per un ammontare complessivo
delle riparazioni che raggiunge i 580 milioni 715mila 939 euro, i dati più
recenti attestano che la situazione non accenna a migliorare. Come comunicato
dal viceministro della Giustizia Enrico Costa, infatti, dal 1992, anno delle
prime liquidazioni, al luglio del 2015 «è stata sfondata la soglia dei 600
milioni di euro» di pagamenti. Per la precisione: 601.607.542,51. Nello stesso
arco di tempo, i cittadini indennizzati per ingiusta privazione della libertà
sono stati 23.998. Nei primi sette mesi del 2015, inoltre, le riparazioni
effettuate sono state 772, per un totale di 20 milioni 891mila 603 euro. Nei 12
mesi del 2014, invece, erano state accolte 995 domande di risarcimento, per una
spesa di 35,2 milioni di euro. Numeri che avevano fatto registrare un incremento
dei pagamenti del 41,3 per cento rispetto al 2013, anno in cui le domande
accettate furono 757, per un totale di 24 milioni 949mila euro. In media lo
Stato versa circa 30 milioni di euro all’anno per indennizzi. I numeri a livello
distrettuale riferiti ai risarcimenti per ingiusta detenzione collocano al primo
posto Catanzaro con 6 milioni 260mila euro andati a 146 persone. Seguono Napoli
(143 domande liquidate pari a 4 milioni 249mila euro), Palermo (4 milioni
477mila euro per 66 casi), e Roma (90 procedimenti per 3 milioni 201mila euro).
ERRORI GIUDIZIARI.
Nel 2014 è stato registrato un boom di pagamenti anche per quanto riguarda gli
errori giudiziari per ingiusta condanna. Dai 4.640 euro del 2013, che fanno
riferimento a quattro casi, si è passati a 1 milione 658mila euro dell’anno
appena trascorso, con 17 casi registrati. La liquidazione, infatti, è stata
disposta per più di 1 milione di euro per un singolo procedimento verificatosi a
Catania, e poi per altre 12 persone a Brescia, due a Perugia, una a Milano e
l’ultima a Catanzaro. Dal 1992 al 2014 gli errori giudiziari sono costati allo
Stato, dunque al contribuente italiano, 31 milioni 895mila 353 euro. Ma il
ministero della Giustizia, aggiornando i dati, ha certificato che fino al luglio
del 2015 il contribuente ha sborsato 32 milioni 611mila e 202 euro.
MAGISTRATI «IRRESPONSABILI». La
legge sulla responsabilità civile dei magistrati è stata varata la prima volta
nel 1988 e modificata, per manifesta inefficacia, solo nel febbraio di
quest’anno. I dati ufficiali accertano che dal 1988 al 2014 i magistrati
riconosciuti civilmente responsabili dei loro sbagli, con sentenza definitiva,
sono stati solo quattro. Secondo l’Associazione nazionale vittime errori
giudiziari, ogni anno vengono riconosciute dai tribunali 2.500 ingiuste
detenzioni, ma solo un terzo vengono risarcite. Stefano Livadiotti, nel libro
«Magistrati, l’ultracasta», scrive che le toghe «hanno solo 2,1 probabilità su
100 di incappare in una sanzione» e che «nell’arco di otto anni quelli che hanno
perso la poltrona sono stati lo 0,065 per cento».
Piangono e strillano. Così
i magistrati hanno ottenuto il massimo.
Hanno
ottenuto il massimo che potevano dopo 28 anni di tradimento del voto popolare
espresso a grandissima maggioranza nel referendum promosso dai radicali e dopo
che, nel 2011, scrive Rita Bernardini su “Il Tempo” il 27 febbraio 2015. "Il
pianto frutta": nessuno meglio dei magistrati italiani sa mettere in pratica
questo antico modo di dire della saggezza popolare. Frignano per poi piangere
fino a singhiozzare perché con la legge appena approvata sulla responsabilità
civile, le toghe nostrane ritengono di non essere più indipendenti, di essere
sottoposte a continui ricatti e costrette ad autocontenersi per il timore di
essere chiamate in causa. La verità è che hanno ottenuto il massimo che potevano
dopo 28 anni di tradimento del voto popolare espresso a grandissima maggioranza
nel referendum promosso dai radicali e dopo che, nel 2011, la Corte di Giustizia
Europea aveva condannato l’Italia per i limiti posti alla responsabilità civile
dei giudici nell'applicazione del diritto europeo. Oggi al Governo e in
Parlamento sono tutti protesi a rassicurare i magistrati che strillano e battono
i piedi minacciando sfracelli. Da una parte il Parlamento è arrivato ad
appiccicare alla legge una relazione d’accompagnamento in cui si spiega che per
"negligenza inescusabile" si intende un travisamento "macroscopico ed evidente"
dei fatti; dall’altra il Governo che, con il ministro della Giustizia, s’inventa
il "tagliando", affermando di essere pronto a cambiare la legge entro sei mesi
se ci saranno abusi. Ma quali abusi si possono temere se saranno giudici a
giudicare altri giudici? In realtà, già quando fu promosso quel referendum,
insieme al compianto Enzo Tortora, i radicali avevano ammonito che occorreva
urgentemente affrontare le questioni della separazione delle carriere, degli
incarichi extragiudiziari, dei distacchi dei magistrati nell’amministrazione
pubblica, dell’automaticità delle carriere, del principio (falso perché
impossibile da attuare) dell’obbligatorietà dell’azione penale, della
correntocrazia nel Csm, insomma, una riforma organica della Giustizia che
affermasse concretamente la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario. Oggi, con oltre cento magistrati distaccati presso gli uffici
legislativi dei ministeri, c’è poco da stare tranquilli: c’è sempre una manina
pronta a pinzare alle leggi l’interpretazione autentica, oppure un’intimidazione
per la quale l’esecutivo si ritiene costretto a promettere revisioni nel caso in
cui gli effetti delle leggi non assicurino, come è stato fino ad oggi,
l’impunità delle toghe, i loro privilegi, le loro carriere. Grande assente da
questo film – e ho motivo di dubitare che entrerà in scena – è l’illegalità
palese dell’amministrazione della Giustizia che colpisce, come denunciava il
Commissario per i diritti umani Alvaro Gil-Robles 10 anni fa, il 30 per cento
della popolazione italiana per tempi irragionevoli trascorsi in attesa di una
decisione giudiziaria, in violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo; Convenzione che, secondo il Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa viene sistematicamente violata dall’Italia fin dal 1980. Noi
che la lotta per la responsabilità civile dei magistrati l’abbiamo per anni
fatta-vissuta-vinta assieme ad Enzo Tortora con il calvario che quest’uomo
perbene ha dovuto subire, siamo raggiunti da un’infinita tristezza quando
vediamo che Renzi twitta esultante la foto di Tortora e tutti i media lo
ritwittano raggianti. Quando nell’83 abbiamo sposato la causa di Tortora
l’abbiamo fatto contro tutto e tutti perché era unanime il coro che definiva
Enzo un camorrista, "cinico mercante di morte£. Non c’è da meravigliarsi,
dunque, se oggi – pressoché isolati – Marco Pannella e i radicali fanno proprio,
nell’impegno politico quotidiano, il messaggio che il Presidente Emerito
Napolitano ha inviato al Parlamento nell’ottobre del 2013 sulle infami carceri e
sulla débâcle della giustizia italiana: non siamo bizzarri oggi, così come non
lo eravamo più trent’anni fa al fianco di Enzo Tortora. Mi auguro che questa
volta ci si aiuti ad aiutare il Paese e coloro che abitano il nostro territorio
a non subire per troppo tempo ancora le conseguenze di una democrazia
perennemente tradita nei suoi connotati costituzionali.
Da Enzo Tortora alla
hostess ecco tutti gli sbagli delle toghe.
C’è Manolo
Zioni, rimasto un anno in cella per colpa di un tatuaggio. Il vero rapinatore
confessò ma non venne creduto. Ignazio Manca in carcere oltre un anno per non
aver fatto niente, scrive Mau. Gal. su “Il Tempo il 26 febbraio 2015. I "padre"
di tutti gli errori giudiziari fu il processo a Enzo Tortora. Un errore che
segnerà per sempre la vita del presentatore televisivo e, per alcuni, ne decretò
anche la prematura scomparsa. L’elenco dei volti noti finiti nelle maglie
dell’ingiustizia all’italiana è lungo. Si va da Gigi Sabbani a Serena Grandi. Se
Tortora venne arrestato nell’83, in favore di telecamere nel giugno del ’70 fu
la volta di Lelio Luttazzi, ammanettato con Walter Chiari per droga. E l’8
aprile 1994 toccò a Leonardo Vecchiet, medico della Nazionale. Ma ci sono anche
tanti sconosciuti, nomi anonimi, che hanno subito il danno nell’indifferenza
generale. Il record spetta a Giuseppe Gulotta, che ha scontato 22 anni per un
duplice omicidio mai commesso. Anche i casi e le storie più recenti (tutti sono
denunciati quotidianamente dal sito specializzato "Errorigiudiziari.com") sono
numerosi. E, spesso, fanno venire i brividi. C’è Manolo Zioni, rimasto un anno
in cella per colpa di un tatuaggio. Il vero rapinatore confessò quasi subito, ma
non venne creduto. Il giovane romano venne, per sua fortuna, scagionato da una
perizia su una macchia sulla pelle. Assolto, otterrà un risarcimento di circa 80
mila euro per i suoi 351 giorni dietro le sbarre. Marin H., invece, aveva già
scontato un anno per il reato di sfruttamento della prostituzione. Ma questa
volta non era recidivo. Lui non c’entrava, anche se le "ragazze" lo accusavano.
Alla fine, ha ottenuto 51 mila euro. E che dire dell’ex vicesindaco di
Montesilvano Marco Savini, che ha impiegato ben otto anni per vedere
riconosciuta la sua estraneità ai fatti. Travolto (è proprio il caso di dirlo)
dall’inchiesta "Ciclone" nel 2007, con le pesanti accuse di associazione per
delinquere, truffa e corruzione, ha fatto 98 giorni in cella e ora attende un
rimborso. La vita di Luigi Vittorio Colitti è stata distrutta quando aveva solo
diciotto anni. Fu accusato di aver aiutato il nonno ad uccidere il vicino di
casa, un consigliere comunale e provinciale dell’Italia dei Valori. Ci sono
voluti due processi e quattordici mesi di prigione prima che venisse giudicato
innocente. Ora chiede mezzo milione di euro. Ignazio Manca ha trascorso in
carcere oltre un anno. E non aveva fatto niente. Era accusato di riciclaggio e
ricettazione e venne condannato in primo grado a quattro anni di reclusione. Il
fatto che il fratello si fosse assunto ogni responsabilità, così scagionandolo,
non ha sfiorato la mente di chi lo stava giudicando, facendogli sorgere un
"ragionevole dubbio". All’epoca dei fatti si trovava in ospedale e solo per
questo fu assolto in appello: avrà 150 mila euro. Uno dei casi più eclatanti e
strazianti fu quello della hostess Elena Romani, ritenuta l’assassina della
figlia Matilda. Una bambina. Mentre la piccola moriva, però, lei non era neanche
in casa. Ciò non ha impedito che dovesse affrontare tre gradi di giudizio prima
di dimostrare la sua innocenza. Adesso vuole 80 mila euro. Ma il procuratore
generale della Corte d’appello non è d’accordo: sostiene che con il suo
comportamento abbia giustificato i sospetti su di lei. Pasquale Capriati,
accusato di tentata rapina e tentato omicidio, ha dovuto attendere quasi un
quarto di secolo: solo dopo 23 anni (6 mesi in cella e due ai domiciliari) si è
capito che si trattava di uno sbaglio. Prosciolto, ha chiesto allo Stato 516
mila euro per ingiusta detenzione. E l’avvocato barese Sergio Mannerucci ha
dovuto subire una settimana in prigione e due anni di odissea giudiziaria per
far capure che non c’entrava niente con la truffa all’Inps di cui era stato
accusato. Errori pagati con la privazione della libertà dagli indagati. E con i
soldi da noi contribuenti.
Dodici casi di ordinaria
ingiustizia.
Accuse senza prove, perizie sbagliate, rapine mai fatte, così si
può finire in carcere da innocenti, scrive Andrea Ossino su “Il Tempo” il 30
dicembre 2015.
Cinque anni per droga Ma il colpevole non era lui.
Per 5 anni hanno creduto
fosse un narcotrafficante internazionale. W.U., quarantenne residente a
Frosinone, ha visto crescere le sue due gemelline da dietro le sbarre. Non è
riuscito a stare vicino alla sua famiglia nei momenti di difficoltà. Tutto
questo perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Era stato
arrestato nel 2010, mentre era all'aeroporto di Capodichino, a Napoli. La Dda
partenopea lo aveva fermato insieme ad altre 30 persone perché risultava aver
avuto contatti con la fidanzata di un uomo che faceva parte di un'organizzazione
criminale dedita al narcotraffico. Il legale dell'uomo, Francesco Galella, è
riuscito però a dimostrare che quelle telefonate che provavano come tale «Biggy»
cedesse e ricevesse stupefacenti, non erano riconducibili al suo assistito. W.U.
è quindi stato assolto e adesso chiede allo stato 500 mila euro. Una cifra che
non gli potrà mai risarcire gli anni persi, ma almeno gli consentirà di rifarsi
una vita dignitosa.
Accusati senza prove di una truffa milionaria.
Accusati di associazione a
delinquere finalizzata alla truffa, Pio Maria Deiana, Carlos Luis Delanoe e
Carmelo Conte, sono stati assolti dal tribunale di Terni perché il fatto non
sussiste. Era il 2005 quando i tre indagati cercarono di acquistare una squadra
di calcio, la Ternana, e Villa Palma, un luogo dove poter avviare una
fondazione. L'affare non andò in porto perché vennero arrestati prima che la
filiale di una banca concedesse loro un prestito di 100 milioni di euro sulla
base di una fidejussione di 400 milioni di dollari di una banca brasiliana.
Proprio la fidejussione li fece finire sul banco degli imputati, dal quale
dovettero assistere alla sfilata dei testimoni eccellenti: dall’ex presidente
del Coni di Terni, Massimo Carignani fino all'ex sindaco di Terni, Paolo
Raffaelli. Grazie ai teste e alle perizie capaci di dimostrare la veridicità
della fidejussione e la limpidezza dell'operazione finanziaria, la corte di
Terni li assolse sottolineando che i 3 erano stati reclusi ingiustamente per 6
mesi. Adesso chiedono di essere risarciti.
In cella a 16 anni per una perizia sbagliata.
Una perizia sbagliata lo aveva
condotto in cella quando aveva 16 anni. Sulla sua testa una pesante accusa: aver
ucciso il padre. Per questo motivo Luca Agostino aveva trascorso 113 giorni in
carcere. Il padre, Cosimo, era stato ucciso con tre colpi di arma da fuoco il 24
febbraio del 2010. Luca era stato arrestato insieme al fratello maggiore,
Vincenzo. La perizia non lasciava spazio a dubbi: sulle mani del ragazzo era
presente polvere da sparo. Neanche la testimonianza del fratello reoconfesso,
grazie al quale era stata trovata anche l'arma del delitto, aveva convinto gli
inquirenti milanesi. Poi i consulenti del giudice e quelli della procura
arrivano a una conclusione unanime: «i risultati delle operazioni peritali
appaiono compatibili con le dichiarazioni rese dai tre soggetti presenti al
momento dell’omicidio». A scagionarlo definitivamente una conversazione in
carcere con il fratello: «Vincenzo esprime sorpresa e rabbia verso il fratello
quando apprende che Luca potrebbe aver toccato la pistola e risultare perciò
positivo alla prova dello Stub». Adesso Luca è stato risarcito: 24mila e 300
euro.
Medico condannato Ma salvò un detenuto.
Ha chiesto un milione di euro
per ingiusta detenzione. Una cifra a sei zeri che comunque non potrà mai
ripagarlo del torto subito. Alfonso Sestito, cardiologo del Policlinico Agostino
Gemelli di Roma è stato assolto con formula piena. Secondo gli inquirenti
avrebbe scritto una falsa perizia. Un documento che avrebbe consentito la
liberazione di un detenuto e che sarebbe stato «richiesto» dall'avvocato Marco
Cavaliere, condannato a tre anni di carcere. Così il medico aveva dovuto
trascorrere quindici giorni agli arresti domiciliari e, dal febbraio del 2013,
era stato costretto a non allontanarsi dalla Capitale. Nel corso del processo,
il legale del dottore è riuscito a dimostrare che grazie a quella perizia,
l'imputato avrebbe salvato la vita al paziente, il detenuto Carmine Buongiorno.
Così l'uomo è stato assolto dall'accusa di falso. Adesso Alfonso Sestito, dopo
aver chiesto di essere risarcito, è in attesa del pronunciamento del giudice.
Sei mesi in cella per una rapina mai fatta.
Per un anno è stato detenuto
ingiustamente, trascorrendo anche 6 mesi all'interno di un penitenziario.
Claudio Ribelli, secondo l'accusa, avrebbe rapinato una donna puntando un
coltello alla gola del figlio. Magro il bottino ottenuto: 100 euro e una piccola
collana d'oro. Il ventottenne sardo era finito nel carcere di Buoncammino, a
Cagliari, perché la vittima affermava di averlo riconosciuto. Erano in due i
complici che nel 2010 avevano rapinato la donna. Il primo, Pierpaolo Atzeni, è
stato condannato a scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione. Il presunto complice,
Claudio Ribelli, è invece stato assolto e la Corte d'appello di Cagliari ha
stabilito che lo Stato gli corrisponda 91.082 euro come riparazione per ingiusta
detenzione. Del resto le telecamere di una stazione di servizio che avevano
immortalato la scena del crimine avevano ripreso il complice scagionando
Ribelli. Adesso l'operaio sardo cerca di rifarsi una vita nonostante abbia
trascorso 6 mesi in una cella di 4 metri per 4 priva di acqua calda,
riscaldamento e pavimento, insieme ad altri 5 detenuti.
Tentato omicidio. Ma il marito aveva mentito.
Anche in Sicilia, nel 2015, è
stato riconosciuta una riparazione per ingiusta detenzione. Ad Elena Khalzanova
infatti sono stati dati 38mila euro. Era stata assolta due anni fa, nel luglio
del 2013, dopo essere stata accusata di aver tentato di uccidere il marito. Ma
secondo la corte di Catania, i 18 giorni di galera e i 286 giorni di arresti
domiciliari affrontati da Elena, ingegnere russo di 59 anni ed ex direttore di
una fabbrica della marina militare sovietica, non valgono neanche 40 mila euro.
Elena era stata accusata di voler uccidere il marito – avrebbe tentato di
soffocarlo con un cuscino – per impossessarsi dell'eredità. Ma l'unico testimone
che la accusava era proprio la vittima. Durante il processo le sue testimonianze
sono però state ritenute «incoerenti e contraddittorie e come tali non
meritevoli di credito». A causa di presunte violazioni anche il Consolato
generale della Federazione russa a Palermo aveva seguito il caso.
Accusato di corruzione Prosciolto dopo 6 anni.
Dante Galli al momento del suo
arresto lavorava come dirigente dell'ufficio urbanistica di Pietrasanta, in
provincia di Lucca. Il 31 gennaio del 2006 però aveva perso tutto. Era stato
arrestato insieme al sindaco Massimo Mallegni e a numerosi politici, funzionari
e imprenditori. Sulla sua testa pesava un'accusa importante: corruzione. Dopo
aver ottenuto gli arresti domiciliari ha dovuto affrontare un maxi processo nel
corso del quale fortunatamente era tornato a piede libero. Il suo incubo è
terminato dopo sei anni. Il 2 aprile del 2012. Il tribunale di Firenze non ha
avuto dubbi: Galli è stato prosciolto da ogni accusa e deve essere risarcito per
tutte quelle settimane trascorse tra il carcere e gli arresti domiciliari.
Adesso pronuncia parole felici, si dichiara sereno, ma nessuno potrà mai
cancellare l'esperienza vissuta, la perdita della libertà e della dignità
professionale. Adesso all'uomo è stato riconosciuta l'ingiusta detenzione. Il
politico però non ha fatto sapere a quanto ammonta.
Per i pm era un boss. Scagionato a 70 anni.
Il suo nome gli è costato 3
anni e 11 mesi da scontare agli arresti domiciliari. Ma Beniamino Zappia non era
il boss della mafia italo-canadese e adesso deve essere risarcito. Una vicenda
che inizia il 22 ottobre del 2007, quando la Dia di Roma arresta l'uomo
accusandolo di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli inquirenti
pensano infatti sia il tramite tra le cosche agrigentine e quelle canadesi
legate ai fratelli Rizzuto di Montreal, credano che i boss si siano serviti di
lui per infiltrarsi negli affari d'oro relativi alla costruzione del ponte sullo
stretto di Messina. Così lo arrestano insieme ad altre 18 persone. Complice il
suo nome e la sua fedina penale non proprio immacolata, Zappia viene recluso a
San Vittore, poi a Roma e ancora a Benevento e Secondigliano. Nel 2008, ormai
70enne, viene trasferito in regime di carcere duro. Poi i dubbi, la concessione
degli arresti domiciliari nel maggio del 2010 e infine la sentenza. Il 23
novembre del 2012 viene assolto perché il fatto non sussiste.
Un anno di detenzione. Ma i testimoni lo salvano.
Una detenzione durata ben
351 giorni e un indennizzo di 100 mila euro, pari a 235 euro al giorno. Manolo
Zioni, romano, quando aveva 22 anni era stato accusato di aver messo a segno 3
rapine, tutte compiute tra l'agosto e il settembre del 2010, in zona Pineta
Sacchetti, nella Capitale. Nonostante Alessandro Rossi, un rapinatore già in
stato di detenzione, avesse ammesso di aver compiuto anche i colpi contestati a
Zioni, i giudici non gli credono. Nessun testimone lo riconosce e allora viene
disposta una perizia sulle immagini riprese dalle telecamere. Il rapinatore,
quello vero, aveva un diamante tatuato sul collo. Manolo Zioni invece solo una
macchia sulla pelle. Così il ragazzo viene rimesso in libertà e dopo 20 giorni
viene assolto per non aver commesso il fatto. L'imputato viene risarcito, ma non
è di certo un santo. Così lo scorso giugno è stato fermato nuovamente. In zona
Primavalle avrebbe gambizzato un uomo, un personal trainer di 35 anni con cui
aveva un debito in sospeso.
58 euro per ogni giorno incolpato ingiustamente.
Lo stato gli ha dato 23
mila euro. Ogni giorno che ha trascorso in carcere vale appena 58 euro. E in
cella Alberto Vitulo ha trascorso ben 13 mesi. Spaccio di sostanze stupefacenti.
Questa l'accusa sostenuta dagli inquirenti di Cavarzere, in provincia di
Venezia. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato il 28 ottobre del 2008.
L'operazione dei carabinieri aveva sgominato una banda di neofascisti accusati
di trafficare stupefacenti. In pratica l'associazione avrebbe portato la cocaina
dal Sudamerica per poi rivenderla nelle piazze di spaccio del Veneto. Alberto
Vitulo, secondo l'accusa, avrebbe gestito il traffico nell’area del rodigino.
Alla fine l'uomo è stato assolto. Misero il risarcimento ottenuto e sentenziato
dalla Corte d'appello di Venezia. Ma i giudici hanno motivato l'ingiusta
detenzione in carcere spiegando anche che Vitulo, originario di Cavarzere,
avrebbe contribuito colposamente all’emissione e al prolungamento della misura
cautelare a suo carico, omettendo di fornire agli inquirenti alcun chiarimento
in merito al comportamento che gli veniva contestato.
Vicesindaco «truffatore». Ma era una menzogna.
Un calvario giudiziario durato
ben 8 anni. L'avvocato Marco Salvini, quando aveva solo 32 anni, aveva dovuto
trascorrere anche 98 giorni in regime di arresti domiciliari. La vicenda che
risale al 2007 lo ha visto accusato di associazione per delinquere, truffa e
corruzione. Adesso chiede un risarcimento per il torto subito, per la libertà
privata, per la reputazione persa in un paese, Montesilvano (provincia di
Pescara), dove le voci corrono velocemente, specialmente se un processo dura più
di 8 anni, soprattutto se l'avvocato Marco Salvini, al momento dell'arresto, era
anche il vicesindaco di Montesilvano. La sua vita è cambiata radicalmente prima
di essere assolto, prima di uscire a testa alta dall'inchiesta Ciclone, quella
che nel 2007 lo ha condotto in braccio alla giustizia. Ora crede ancora nel
sistema giudiziario. Un sistema capace anche di assolvere e di risarcire per il
danno subito. Adesso l'uomo attende le motivazioni della sentenza e si appresta
a chiedere un corposo risarcimento.
In galera 156 giorni per un errore di calcolo.
Quella lunga fedina penale non
gli è stata certo d'aiuto. Luigi Aiello in ogni caso è stato detenuto 156 giorni
di troppo, per un errore di calcolo. Adesso è stato risarcito. Dall'errore
commesso dai giudici ne era scaturito anche un secondo, questa volta commesso da
Aiello. L'uomo infatti aveva una complessa vicenda giudiziaria che grazie alle
leggi, e ai numerosi soggiorni in carcere, lo aveva costretto a scontare gli
ultimi 5 anni e 8 mesi agli arresti domiciliari. Lui però, durante l'ultimo
periodo, era andato in Spagna. Quando era tornato, dopo alcuni mesi, era dunque
stato arrestato e condannato a un ulteriore anno di reclusione. Mentre stava
scontando i suoi giorni in galera i suoi legali si erano accorti dell'errore.
Conti alla mano, la Corte d'appello di Trento aveva accolto la sua richiesta di
ingiusta detenzione: 40mila euro. Adesso l'uomo sta affrontando gli altri
processi a suo carico e presto saprà se gli verrà riconosciuta una seconda
ingiusta detenzione.
Dal 2000 l'Associazione Culturale "ARTICOLO
643" tutela le vittime di "errori
giudiziari, ingiusta detenzione e lungaggini processuali".
Sono un gruppo di professionisti (avvocati, docenti
universitari, etc.) che si dedicano assiduamente alle delicate tematiche della
Giustizia. Da anni mettiamo a disposizione dei cittadini competenze specifiche
nei delicati istituti della revisione processuale e della riparazione per
ingiusta detenzione. Il loro portale è divenuto un efficace veicolo di
informazione per gli addetti ai lavori e un punto di riferimento per le
centinaia di persone che ogni anno sono vittime di errore giudiziario o di
ingiusta detenzione.
Altro esempio di spendita di passione a favore
delle vittime dell’ingiustizia terrena è il lavoro di due giornalisti validi e
coraggiosi che gestiscono il sito web ErroriGiudiziari.com che al 26 ottobre
2015 contava su 658 casi presenti nel
loro archivio. Questo sito nasce dall’idea di due giornalisti che da anni si
occupano di errori giudiziari e ingiusta detenzione. Nel 1996, dopo aver
realizzato il capitolo “Giustizia-Ingiustizia” per il Rapporto Italia Eurispes,
pubblicano il libro “Cento volte ingiustizia – Innocenti in manette”, una
raccolta di errori giudiziari dal Dopoguerra ai giorni nostri. Da allora hanno
continuato a raccogliere e archiviare casi e storie di vittime di errori della
giustizia, che ora danno vita a Errorigiudiziari.com, il primo archivio italiano
sugli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni.
Benedetto Lattanzi (Roma,
1966), giornalista, lavora per un’agenzia di stampa nazionale.
Valentino Maimone (Roma,
1966), giornalista, scrive di attualità e salute per diversi periodici nazionali
e per il web.
Legge Pinto, stretta sui risarcimenti.
Rischiano anche quelli per ingiusta detenzione? Scrivono il 16 settembre 2015:
Giudici, la carriera prima di tutto. Il direttore del quotidiano romano
“Il Tempo”, Gian Marco Chiocci, interviene con un editoriale sul tema della riforma
della giustizia, degli
errori giudiziari, dell’ingiusta
detenzione e
della responsabilità
dei magistrati. A poca distanza dalla
pubblicazione di dati aggiornati sugli innocenti in carcere nel nostro Paese, le
sue parole non sono affatto tenere: il sottosegretario alla Giustizia, Enrico
Costa, sta facendo un’opera meritoria di
trasparenza nel tentativo di cambiare le cose. Ma le prospettive, stando al
ragionamento di Chiocci, non sono affatto rosee: le riforme possibili, viste le
resistenze della categoria dei magistrati, sono in realtà decisamente
improbabili. Esattamente due anni fa “Il Tempo” mandò in stampa un’inchiesta
devastante sulle
ingiuste detenzioni, argomento tornato oggi di moda per il tentativo del governo
di farla pagare a chi sbaglia, cioè ai magistrati eventualmente colpevoli d’aver
mandato in galera un innocente. A scanso di equivoci e pie illusioni diciamo
subito che nonostante Enzo Tortora, il referendum dei radicali, i mille
tentativi di provare a regolamentare un’anomalia solo italiana, quest’ultimo
esperimento, lodevole nelle intenzioni e rivoluzionario sulla carta, certamente
non vedrà la luce. Il sottosegretario alla giustizia Costa, nel rendere noti i
dati della vergogna (tra errori giudiziari e ingiuste detenzioni in 22mila sono
stati risarciti, oltre 600 i milioni di euro che lo Stato ha tirato fuori come
indennizzo) ha sollecitato l’applicazione della «responsabilità dei magistrati»
attraverso l’avvio, in automatico, ai titolari dell’azione disciplinare,
dell’ordinanza che accoglie l’istanza di riparazione per il carcere ingiusto. In
altre parole, nelle intenzioni del sottosegretario, a differenza del passato ove
non vi era alcun obbligo di trasmissione, una volta ottenuto l’indennizzo, il
fascicolo verrà preso, impacchettato e girato ai titolari dell’azione
disciplinare che valuteranno se e come comportarsi con il magistrato che ha
trattato il caso in questione. Fino ad oggi su 22 mila errori giudiziari
accertati, hanno pagato solo 8 giudici. Con questo sistema in tanti potrebbero
rischiare inciampi di carriera. Ecco perché la rivoluzione sognata da Costa non
si farà mai.
MORIRE DI CARCERE.
Roma. La vita tra parentesi. In carcere,
scrive il 4 maggio Gian Carlo Capozzoli su “L’Espresso”. Quando supero il
cancello della terza casa di Rebibbia, a Roma, ho come la sensazione di essere
tornato a casa. Come quando trovi vecchi amici, voglio dire, che non vedi da un
po’ e hai piacere a rivederli, ritrovarli, e loro a rivedere te. Non mi piace
ritrovare qui, quelli che sono diventati i miei amici, nel corso del tempo.
Ovviamente. Quando mi capita di pensarci, li immagino (indistintamente) fuori, a
riprendere in mano, lentamente, la loro vita. Le loro abitudini, fuori. O che
meglio ancora, cambiamo, hanno cambiato invece radicalmente la loro vita
precedente, ricominciando da capo, da zero. Il personale della polizia
penitenziaria è però quasi tutto lo stesso, e ci riconosciamo dopo tanto tempo
passato a sopportarmi benevolmente, quando, in accordo con il Dipartimento di
Amministrazione Penitenziaria, con la Direttrice Passannante, e con il personale
dell’area educativa la dottoressa Azara e la dottoressa De Cristofaro, avevo
realizzato un laboratorio culturale. L’idea di fondo del progetto era partire
dal teatro e dalle questioni poste in essere dalla cultura stessa, per
riproporre quel principio di rieducazione della pena, sancito dalla
Costituzione. La terza casa è un istituto a custodia attenuata che rende
completamente diversa questa esperienza progettuale rispetto a quella realizzata
in altri istituti, semplicemente perché è diversa la vita all’interno.
Semplicemente nel senso di una maggiore libertà di movimento e di spostamento e
di incontro. Non è per nulla semplice, mi rendo conto. Ma è una differenza
sostanziale, che si avverte, si nota, fin da subito, a partire dal rapporto
professionale, ma in qualche modo di vicinanza, stabilito all’interno
dell’istituto tra detenuti e personale. Le direttive ministeriali, le condanne
quasi alla fine, la vita stessa all’ interno, rendono l’atmosfera meno pesante.
Anche i cancelli da superare per entrare, sono minori rispetto a quelli di altri
istituti. Il numero dei detenuti ospitati non è eccessivo, e un numero adeguato
di assistenti, permette di controllare il tutto, con estrema vigilanza, ma con
discrezione. La disciplina è rigida, come i controlli, naturalmente. Ma è
discreta. Quando entro, sta piovendo nel grande cortile all’ interno. Incontro
la direttrice per le disposizioni da seguire, e mi licenzia in breve, presa da
carte da firmare e ordini da dare. Ho avuto modo di conoscerla profondamente
questa piccola donna con un carattere forte. Ho avuto modo di apprezzarne la
gentilezza e la disciplina. Ho avuto modo anche di incontrare questa maggiore
libertà di cui godono i detenuti qui. Libertà di muoversi tra i lunghi corridoi.
Di godere di qualche ora d’aria in più. Di svolgere qualche ora in più con le
proprie famiglie. E non è poco. Sembra una cosa normale, e invece non lo è. È
proprio straordinario che si dia una reale possibilità di recupero, quindi di
libertà, attraverso il lavoro. Il lavoro, qui, è pensare ad un futuro prossimo
fuori, è immaginare altre prospettive, altre possibilità di vita. È potersi
pensare liberi. Liberi anche da quel passato che li ha condotti sulla loro via
criminale. Prima di licenziarmi, la direttrice mi mostra un foglio pieno delle
attività che i detenuti possono svolgere durante il periodo della loro
detenzione. Il teatro ha ripreso la sua attività, ed ora una nuova compagnia di
volontari, professionisti, viene per le prove della prossima messa in scena.
Quando li incontro, stanno costruendo delle maschere, oggetti scenici dello
spettacolo. Ben oltre la retorica di avere una maschera, togliersi la maschera,
mettersi una maschera, vedo uomini attenti a questo incontro con qualcosa che ha
a che fare con l’arte. Si può vedere il gioco con i colori delle maschere. O
l’attenzione nella costruzione artigianale di una figura. Il tempo è un tempo
che scorre lento, impiegato con attenzione e intenzione. E gioco. Li lascio
lavorare, mentre seguo un gruppo di ragazzi attorno ad una insegnante. Lei è una
signora magra, piccola, adulta. Sorride e comprende, già con lo sguardo. Li
segue, lei e alcuni suoi colleghi, nel loro percorso scolastico e educativo.
Nella sala teatro, mi affaccio a guardare alcuni degli strumenti di una piccola
band composta da detenuti e agenti e volontari, e pensata dall’Ispettore
Colleferro e un suo amico musicista, Paolo. Hanno suonato assieme oltre divise e
ruoli. La sala dove ho incontrato spesso le suore, oggi è chiusa. Ma non fatico
a credere che le suore non facciano mancare, come sempre, il loro supporto umano
e religioso a questi uomini. Al piano terra, da qualche anno ormai, è stato
aperto un forno in cui sono impiegati alcuni detenuti alla produzione e alla
fabbricazione di pane e altri prodotti che vengono poi distribuiti in tutto il
quartiere. S. aveva questa faccia da bonaccione già quando lo avevo conosciuto.
In realtà è fiero e astuto. Quando ci incontriamo è un misto di imbarazzo e
piacere. Lavora lì, ora. Ha il viso provato e spento dagli anni della
carcerazione, ma parla orgoglioso del suo nuovo impiego e della fiducia che gli
è stata accordata. Controlla l’orologio mentre parliamo per sfornare e infornare
il prossimo giro di impasti o pane caldo. Lo lascio sicuro tra i suoi nuovi
strumenti di lavoro. Fuori, nel cortile, vedo avvicinarsi una figura familiare.
Mi sembra ingrassato rispetto a qualche anno fa, ma il suo modo di camminare è
rimasto lo stesso. Cammina con le mani penzolanti di lato e i piedi che, mentre
cammina, sembra che lo conducano da qualche altra parte, in giro. Così senza una
meta. Ha la testa sempre un po’ reclinata di lato come se fosse pesante tenerla
dritta. Fissa. Quando mi è vicino vedo che ha i capelli un po’ più brizzolati e
le rughe del viso accentuate. Ci salutiamo. Mi chiede come sto e mi dice che sta
meglio. Mi dice che vorrebbe uscire o che vorrebbe essere quantomeno trasferito.
Mi dice della sua città, che è un po’ anche la mia. Mi descrive vicoli e piazze,
precisamente, come se fossero esattamente davanti a lui, ora. Mi parla dei suoi
amici. Mentre parla, ha questo modo di accarezzarsi il viso, come per togliersi
le rughe profonde. Quando lo avevo conosciuto mi era sembrato un tic. Ora
continua, ma con meno forza. Con meno rabbia. Mentre passeggiamo nel cortile
interno, mi accorgo che questo luogo è pieno di questa esperienza di questo
incontro. Lui era stato Ariel su questo campo di pallone, e se ne ricorda. E mi
ricordo anche io. Mi era sembrato subito Ariel, nella Tempesta di Shakespeare,
proprio per quest’aria spaesata e confusa. Qui tutti sono spaesati e confusi.
Lui lo sembra un po’ più degli altri, anche se a differenza degli altri, ha
anche una cultura. Mi dice di alcuni suoi amici che fanno teatro e dell’ultimo
film che ha visto. Gli occhi stretti in una piccola fessura non nascondono una
certa sofferenza. Le labbra sono secche. Ma non è trascurato. Piuttosto sembra
stanco. Mi sembra stanco anche in questo suo camminare. Sorride quando
ripensiamo al tempo passato anche con i ragazzi dell’Università, a giocare e a
impegnarci nella cura del testo di Shakespeare. Sono passati tre anni. Tre anni
di cambiamenti, di progetti, di aspettative. Lui mi parla di cose avvenute tre
anni fa come se fossero accadute ieri, la settimana scorsa. Un mese fa, al
massimo. Parliamo come due vecchi amici quando si accorge che è tardi per andare
a scuola. Almeno vuole finire quel percorso che fuori ha lasciato a metà.
Nonostante questo istituto sia una sorta di modello da seguire in fatto di
efficienza e limitatezza della custodia, quando sono finalmente fuori mi resta
la domanda su quale necessità abbiamo, come società dico, di pensare ad un
luogo, il carcere, che serve solo a mettere la vita tra parentesi.
Edoardo Albinati: «C’è un modo legale per
evadere dal carcere: diventare scrittore». Edoardo
Albinati fa parte della giuria del Premio Goliarda Sapienza e insegna lettere in
carcere, a Rebibbia, scrive Eugenio Murrali il 4 Maggio 2018 su "Il Dubbio".
Il Premio Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” amplia le sue prospettive. La
fondatrice e curatrice Antonella Bolelli Ferrera ha voluto che alla gara vera e
propria fosse affiancato un laboratorio di scrittura. Sessanta i partecipanti
che hanno interagito con la scrittrice- editor Cinzia Tani e diversi scrittori-
tutor tra cui Maria Pia Ammirati, Gianrico Carofiglio, Erri De Luca, Paolo Di
Paolo, Nicola Lagioia, Dacia Maraini. Al Salone del Libro di Torino, il 10
maggio, sarà proclamato il vincitore. Edoardo Albinati fa parte della giuria
del Premio Goliarda Sapienza e insegna lettere in carcere, a Rebibbia.
Che cosa può significare per le persone
detenute la scrittura?
«Da una parte
c’è un’attività che sia le persone detenute sia quelle libere svolgono:
scrivere. Cosa diversa è la scuola che nel carcere è strutturata come nel mondo
esterno. Nell’istituto tecnico- informatico in cui insegno faccio, appunto, il
professore di lettere: spiego la grammatica, la Divina Commedia, e così via.
Come professore di lettere sono chiaramente più vicino al tema della scrittura
rispetto agli altri colleghi, per cui mi è successo di avere studenti che se la
cavavano a scrivere ed erano buoni lettori».
E al di là della scuola?
«L’attività
dello scrivere narrativa o poesia è molto individuale. Avendo partecipato a
molti di questi premi di prosa o di poesia, penso che se si riesce a “evadere”
almeno un poco dallo stretto tema carcerario – che può diventare soffocante,
ripetitivo, anche perché la vita carceraria è il contrario della varietà, è la
monotonia – allora capita di leggere testi interessanti. In generale la
scrittura è una delle pochissime attività disponibili, perché chiunque può
praticarla, anche se all’interno di una cella dove si sta in quattro o sei, nei
ritagli di tempo.
Ritagli?
«In realtà la
vita del detenuto è molto povera di tempo. È una routine molto impegnativa che
fa sì che uno divida la propria giornata tra la cella, la socialità, l’aria, gli
avvocati. Nella cella gli spazi spirituali e individuali sono molto ristretti.
Se uno ha le forze di ricavare in tutto questo bailamme di rumori, odori e
faccende, uno spazio per scrivere, anche solo un diario o una lettera, non c’è
dubbio che svolga una delle poche attività umane possibili in carcere. È
un’attività che io consiglio di svolgere comunque ai miei studenti, anche se non
ci sono scopi letterari».
Questo rientra in quello scopo rieducativo di
cui parla l’articolo 27 della Costituzione?
«No, non
rieducativo, semplicemente riflessivo. Scrivere una lettera non è rieducativo,
ma ti costringe a un poco di concentrazione, a esprimere te stesso. La realtà
carceraria non ha nulla né di educativo né di rieducativo. La scuola potrebbe
avere in parte questo ruolo ma preferisco sempre parlare di “istruzione”.
L’educazione la danno i genitori, quando la danno».
Alcuni dei racconti che saranno pubblicati non
parlano della vita carceraria. La scrittura aiuta a uscire dalle sbarre?
«È interessante
anche la scrittura esperienziale, ma rischia di essere ripetitiva. Mentre è
differente, quando si lascia spazio all’immaginazione, alla fantasia, o quando
si raccontano episodi della vita libera. Spesso i detenuti, prima di essere
carcerati, hanno vissuto una vita spericolata, se riescono a raccontarla può
essere coinvolgente. Per loro, però, capita sia difficile, perché narrarla a
volte significa rivelarsi, in un certo senso anche autoaccusarsi, se si tratta
di una vita delinquenziale. C’è una certa cautela se si è fatta una vita fuori
dalla legge, è una difficoltà oggettiva».
Lei ha insegnato anche nelle scuole ordinarie.
Quali sono le risorse particolari della scuola in carcere, in cosa si
differenzia dalle altre?
«La differenza
fondamentale, anche se può sembrare strano che sia solo questa, consiste
nell’insegnare a persone adulte, come in una scuola serale. Sono adulti che
spesso hanno alle spalle una vita intensa, difficile, avventurosa, hanno fatto
tutto e il contrario di tutto. Gli svantaggi sono logistici: ci si trova in
celle e non in aule scolastiche, fa molto freddo, i detenuti sono legati anche
agli impegni giudiziari, per esempio, quindi possono doversi assentare per dei
processi. È stimolante avere nella stessa classe persone di provenienza,
istruzione di lingua molto diverse. Bisogna tentare un discorso che possa
coinvolgere tutti. Un lato positivo è che non ci sono le famiglie, che guastano
la vita dell’insegnante nel mondo esterno. Inoltre non ci sono telefonini né
altre interferenze esterne. È chiaro, poi, che parlare di Machiavelli a un uomo
che ha vissuto, ha conosciuto e ha praticato la violenza è più significativo che
parlarne a un ragazzino di 15 anni. I grandi temi della vita sono stati vissuti».
In questo periodo quanti ne segue?
«Essendo quasi
la fine dell’ano scolastico sono rimasti in pochi. Si parte con classi molto
affollate, anche di 20 o 30 persone, che poi si rimpolpano e si riducono a
secondo delle vicende di ciascuno».
Lei tende ad affezionarsi o a mantenere un
distacco?
«C’è una giusta
misura. Non si può familiarizzare troppo, altrimenti si finisce per diventare
come degli assistenti sociali, dei confessori, o delle mamme surrogate. È
inevitabile però che ci sia una vicinanza con persone con cui passi magari due o
tre anni. Il fatto che siano adulti rende più simile, pur nella diversità, la
tua esperienza alla loro. Ci sono dei temi comuni: delusioni, speranze,
frustrazioni, il tempo che passa. Non credo però nell’empatia totale, perché
sarebbe rischiosa per tutti. Spesso si è di fronte a persone dai caratteri o
molto forti o molto deboli».
Ci sono tante iniziative legate alle attività
artistiche in carcere. Non si rischia di andare alla ricerca della “verità”
sostituendo la vita all’arte?
«No, non è
questo il rischio. Ce n’è un altro: quello di far pensare all’esterno che il
carcere sia un posto piacevole, dove si fanno il teatro, il cineforum. Le
iniziative, benvenute e sacrosante, sono sporadiche. Non devono far dimenticare
la vita della cella, l’imbarbarimento quasi inevitabile della reclusione. Per
qualche singolo individuo queste attività possono rappresentare una strada, come
è stato per alcuni attori degli spettacoli di Fabio Cavalli. Ci sono esperienze
positive, ad esempio un mio studente che si sta per laureare in ingegneria. Però
si tratta di eccezioni in un panorama che resta desolante».
Il suo giudizio finale sul carcere non è
positivo?
«Come potrebbe
esserlo? È una punizione».
E non può essere un percorso di rinascita?
«No, non è un
percorso di niente. Magari non si trova nulla di meglio, ma è un modo per
mettere fuorigioco persone che hanno fatto del male alla società. Che crei un
effettivo miglioramento delle condizioni che ci finiscono dentro è fuori di
discussione che accada. Sia detto una volta per tutte. E io non sono un
abolizionista del carcere, perché non ho idea di cosa si potrebbe creare di
diverso dalla detenzione, ma so che così come è nel nostro Paese è del tutto non
educativa, non rieducativa. Chi entra ha buone probabilità di uscire peggiore».
Detenuti e scrittori, una finestra sulla
prigione. Il 10 maggio cerimonia finale della settima
edizione del premio “Goliarda Sapienza”, scrive Eugenio Murrali il 4 Maggio 2018
su "Il Dubbio". Una finestra nella prigione, una finestra sulla prigione. Al
settimo anno di attività, il Premio Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” si
trasforma e amplia le sue prospettive. La fondatrice e curatrice Antonella
Bolelli Ferrera ha voluto che alla gara vera e propria fosse affiancato un
laboratorio di scrittura articolato in quindici incontri condotti con il metodo
dell’e-learning – ovvero la teledidattica – per un totale di trenta ore di
lezione tenute da noti autori della letteratura italiana. Questa sperimentazione
è stata approvata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e ha
previsto l’allestimento di aule dotate di tecnologia adeguata negli istituti che
hanno partecipato: Casa di reclusione di Saluzzo, Casa Circondariale di Santa
Maria Capua Vetere, Casa di reclusione di Rebibbia e Casa circondariale
femminile di Rebibbia. Sessanta i partecipanti che hanno interagito con la
scrittrice- editor Cinzia Tani e gli scrittori- tutor Maria Pia Ammirati,
Gianrico Carofiglio, Pino Corrias, Serena Dandini, Erri De Luca, Paolo Di Paolo,
Nicola Lagioia, Dacia Maraini, Massimo Lugli, Antonio Pascale, Romana Petri,
Federico Moccia, Giulio Perrone, Andrea Purgatori, Marcello Simoni. Gli
scrittori hanno tenuto il loro dialogo dall’Università telematica eCampus.
Spiega Antonella Bolelli Ferrera: «Per le persone detenute partecipanti è stato
anche un momento di socialità, perché potevano avere uno scambio tra di loro e
con i partecipanti degli altri istituti e gli scrittori all’esterno. Erano
entusiasti, interessati. Molti di loro ci hanno chiesto libri da leggere, hanno
discusso con noi di letteratura». Tra i tutor, Erri De Luca e Nicola Lagioia
hanno preferito tenere l’incontro all’interno di un istituto, collegandosi da lì
con gli altri, per avere un contatto più concreto con i partecipanti. «A Saluzzo
– racconta Ferrera – ci aspettavano con trepidazione e i detenuti che facevano i
corsi di cucina hanno preparato un rinfresco, emozionatissimi all’idea di
conoscere Nicola Lagioia. La partecipazione era volontaria, non tutti hanno un
grande retroterra culturale, eppure tutti erano preparatissimi». Al Salone del
Libro di Torino, il 10 maggio, sarà proclamato il vincitore alla presenza della
madrina del premio, Dacia Maraini, degli scrittori e giornalisti Pino Corrias,
Erri De Luca, Paolo di Paolo, Andrea Purgatori, Nicola Lagioia e del presidente
della giuria, Elio Pecora. I sessanta racconti nati dalla penna dei detenuti
sono quasi tutti di carattere strettamente autobiografico, “storie incredibili”,
commenta la curatrice. I quindici migliori sono diventati finalisti del Premio
Goliarda Sapienza. Un’altra novità è che quest’anno la giuria non è composta
soltanto da note personalità del giornalismo e della letteratura, ma anche da un
nutrito numero di studenti delle scuole superiori, da alcuni gruppi di grandi
lettori indicati dalle librerie. Inoltre è stato stipulato un accordo
con Vatican News, media partner del premio: gli ascoltatori hanno potuto votare
sulla piattaforma della testata e sono stati così numerosi che si è ritenuto
necessario creare un premio ad hoc, il Premio Vatican News. A Torino sarà
presentata l’antologia Avrei voluto un’altra vita. Racconti dal carcere
pubblicata da Giulio Perrone Editore. Il volume curato da Antonella Bolelli
Ferrera raccoglierà i quindici racconti finalisti. A proposito del contributo
che il concorso può dare alla rieducazione dei detenuti di cui parla l’articolo
27 della Costituzione spiega la curatrice: «Molti dei partecipanti delle scorse
edizioni continuano a scrivermi o a farmi chiamare da parenti, segno che
l’esperienza è stata positiva. In alcuni casi ho saputo che alcune persone, una
volta uscite dal carcere, hanno ricombinato qualche guaio e sono tornate dentro.
Ci sono però esempi virtuosi che porto nel cuore. Si tratta di persone,
certamente predisposte, che il concorso ha aiutato, perché poi, continuando a
scrivere, a leggere, hanno intrapreso un percorso di consapevolezza e
autocritica».
Carceri, cresce il rischio "suicidio" tra
gli agenti. Un terzo degli uomini della Penitenziaria
soffre di depressione e stati d'ansia gravi. In tre anni si sono tolti la vita
17 agenti, scrive Nadia Francalacci il 6 aprile 2018 su "Panorama". Il 35,45%
degli agenti della Polizia penitenziaria si troverebbe in una condizione di
elevato rischio “suicidio” per la presenza di un forte stato depressivo,
ansia, alterazione della capacità sociale e forti sintomi somatici. Il dato che
emerge da un questionario sullo stress correlato al lavoro, compilato nelle
scorse settimane da 600 agenti che prestano servizio all’interno delle carceri
italiane, è davvero sconvolgente. Solo nel 2017, gli uomini della polizia
penitenziaria che si sono tolti la vita in servizio, prima di recarsi sul luogo
di lavoro o appena terminato il turno, sono stati sei. Altrettanti hanno
compiuto lo stesso drammatico ed estremo gesto l’anno precedente e 5 nel 2015.
In tre anni, diciassette uomini, si sono uccisi perché si sono sentiti
abbandonati e sopraffatti dal disagio lavorativo.
Il problema dei detenuti psichiatrici. Molto dello
stress lamentato dagli agenti, nel questionario, dipenderebbe dalla chiusura
degli ospedali psichiatrici. Con la chiusura degli OPG, infatti, è aumentata la
presenza di questi detenuti negli istituti penitenziari causando nuove criticità
e problematiche di gestione sia del detenuto con problemi psichici che del
ristretto esasperato dalla coesistenza con il soggetto malato. Tra le cause
anche, carenza di personale, formazione scadente e dirigenti poco attenti e
preparati. Ma, se quasi un terzo degli agenti della penitenziaria dichiara un
disagio al limite della sopportazione, il 65% lamenta una situazione di forte
malessere.
Pochi agenti, troppi detenuti. Un primo aspetto,
all’origine dei disagi, dell'esasperazione e del malessere degli agenti, risulta
essere il carico di lavoro da tutti percepito come eccessivo, difficile da
sostenere. Un punto sicuramente di facile comprensione, considerando
il sovraffollamento carcerario e l’organico degli operatori di polizia,
inadeguato sia sotto il profilo numerico che di età: agenti sempre più anziani a
dover contrastare un numero sempre crescente di detenuti. Dall’indagine è emerso
che a creare stress e ansia anche le pause dell’orario di lavoro che risultano
non sono sufficienti e gli straordinari che, negli ultimi anni, hanno la
tendenza a diventare ordinari. “In generale i lavoratori hanno un controllo
molto scarso sulla gestione del proprio lavoro - spiega a Panorama.it, Angelo
Urso, Segretario Generale della Uilpa Penitenziari - questa scarsa autonomia non
riguarda solo le modalità operative, ma anche tempi e ritmi che delineano un
contesto rigido e privo di margini di flessibilità”. Altrettanto critica sarebbe
la mancanza di chiarezza del ruolo che l’agente è chiamato a svolgere.
Gli incarichi "abusivi" degli agenti. “Una
percentuale piuttosto importante degli agenti ha dichiarato di non sapere come
svolgere il proprio lavoro, di non avere chiari compiti e responsabilità -
prosegue Urso - un problema che è consequenziale alla carenza di personale e che
li costringe, ogni giorno, a dover ricoprire più ruoli ed incarichi in più
settori, talvolta anche di responsabilità maggiori rispetto al grado di servizio
dell’agente”. Infatti, sarebbero 9 lavoratori su 10 a lamentarsi di una
condizione di scarsità di personale. Questo genererebbe stanchezza che
porterebbe, la maggior parte degli agenti, al timore di sbagliare, con possibili
conseguenze sia per la sicurezza del carcere, sia per gli operatori che hanno
rilevanti responsabilità anche di carattere penale. Ansia e forti stati
depressivi sarebbero generati anche dalla gestione dei detenuti stranieri oltre
che dai soggetti con problemi di carattere psicologico.
Una formazione inadeguata. “Con la chiusura degli
Ospedali psichiatrici giudiziari è aumentata la presenza dei detenuti con
problemi psichiatrici nei normali istituti penitenziari – puntualizza Angelo
Urso – anche in questo caso la formazione ricevuta dagli agenti per fronteggiare
queste situazioni, è ritenuta dagli stessi insufficiente”. Il 94,5% degli
intervistati considera questo uno dei fattori più critici, per la difficoltà di
far fronte alle crisi anche violente che hanno frequentemente questi detenuti.
“La durata della vita lavorativa si allunga. Si va in pensione più tardi e sono
pochi i giovani che subentrano- prosegue il segretario generale Uilpa- uno degli
aspetti più delicati è, infatti, il turno di notte. Circa l’85% degli
agenti dichiarano una maggiore e sempre crescente difficoltà di adattamento
ai turni avvicendati, comprensivi di quello notturno, soprattutto per gli
operatori più anziani”. A generare il malessere che nel 35% dei casi, ha portato
ad un disagio pesante e dai risvolti allarmanti tra gli agenti, c’è anche la
poca esperienza e capacità di gestione degli eventi critici da parte dei
dirigenti e commissari.
I dirigenti sono "distratti" e poco preparati. Gli
agenti dichiarano che di fronte alle difficoltà che si trovano ad affrontare
quotidianamente nei settori carcerari, il supporto di dirigenti e, talvolta, dei
colleghi è scarso. In effetti, i dati, fanno emergere rapporti critici con
addirittura segnalazioni di molestie, prepotenze e vessazioni. “In generale
viene lamentato un approccio distante e poco comprensivo delle problematiche di
chi lavora in prima linea - continua Urso- e i momenti di comunicazione sono
scarsi o del tutto assenti. Sono carenti anche le risposte della direzione alle
problematiche dei detenuti. Non a caso quasi la metà degli agenti afferma
che “le richieste vengono regolarmente ignorate”, mettendo così il personale
nella stressante condizione di non avere delle risposte da dare”.
Ma dall’indagine effettuata tra gli agenti, c’è un
aspetto inquietante: il 73% del personale di polizia penitenziaria denuncia di
non sentirsi tutelato dalla direzione e teme che “le responsabilità non
sarebbero adeguatamente identificate se qualcosa dovesse andare male”. In
sostanza, temono atteggiamenti “pilateschi” da parte dei vertici del carcere.
Strutture fatiscenti e divise poco dignitose. Non
poteva non emergere dal sondaggio anche le condizioni fatiscenti nelle quali gli
uomini e le donne della Penitenziaria, sono costretti a lavorare. Quindi,
carceri prive dei requisiti igienico-sanitari minimi e strutture non sicure
sotto il profilo costruttivo. Persino le divise, secondo il 72% dei
lavoratori, non permetterebbero di presentarsi in maniera dignitosa ed
autorevole. “E’ necessario un potenziamento del personale e l’ottimizzazione
delle procedure operative per ridurre i carichi di lavoro e quindi stati di
stress critici tra gli agenti- conclude Angelo Urso- occorre porre attenzione
alla formazione in quanto è uno strumento indispensabile per mettere gli
operatori in grado di affrontare le situazioni critiche che sono inevitabili nel
lavoro carcerario. Analogamente, però, è indispensabile anche quella per i
commissari finalizzata a superare le gravi e fondamentali carenze del management
che gli agenti hanno denunciato nel sondaggio”.
Quindici anni di morti e suicidi nelle
nostre carceri, scrive Barbara Alessandrini su
“L’Opinione” del 21 ottobre 2015.
Mancano solo due mesi al termine degli Stati Generali dell’esecuzione penale, il
semestre di lavoro e confronto tra operatori penitenziari, magistrati, avvocati,
docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell’associazionismo civile
inaugurato a maggio per volontà del ministro della Giustizia, Andrea Orlando. È
ovviamente presto per verificare se i 18 tavoli tematici impegnati in
un’imponente mole di lavoro approderanno alla definizione di un nuovo e organico
modello di esecuzione della pena individuando soluzioni materialmente utili al
reinserimento, della tutela della dignità e del recupero dei detenuti e ad
abbattere il muro culturale e politico contro cui regolarmente si schianta il
disegno ed il senso che la Costituzione ha assegnato alla detenzione. Intanto,
però, gli istituti di pena italiani seguitano ad inghiottirsi vite umane: 2459
decessi di cui 877 suicidi dal 2000 al 5 ottobre 2015. Sono i dati aggiornati
contenuti nel dossier “Morire di carcere, dossier 2000-2015. Suicidi, assistenza
sanitaria disastrata, morti per cause non chiare, overdose” curato
dall’Osservatorio permanente sulle morti in carcere, di cui pubblichiamo i dati,
indegni per un paese civile. Numeri che dovrebbe dare la misura della prova cui
sono chiamati gli Stati Generali delle carceri e delle ciclopiche dimensioni
della sfida cui sono chiamati: riuscire a dare un decisiva spinta a capovolgere
le tendenze attuali della politica nei confronti della pena detentiva e
ricondurre l’esecuzione penale entro l’alveo dei principi sanciti dal dettato
costituzionale e della giurisprudenza europea, di restituirle quel fine
rieducativo e quella funzione risocializzante e di ricostruzione e proiezione
del detenuto verso il reinserimento, insomma quel rispetto della dignità umana
che i passati decenni pervasi di giustizialismo e di pulsioni punitive nei
confronti di indagati e detenuti tanto hanno contribuito ad erodere. Non ci si
deve stancare di ripetere che si tratta di un traguardo operativo e culturale
insieme, che sarà raggiunto soltanto quando l’opinione pubblica si avvicinerà al
mondo della detenzione e comprenderà che la certezza della pena significa
innanzitutto riconoscerle le finalità rieducative ed eliminare dalla sua
dimensione quello che già Platone nel “Protagora” definiva con efficacia il
“desiderio di vendicarsi come una belva”. Tanto più alla luce delle
‘utilitaristiche’ ricadute virtuose che una pena volta al rispetto della dignità
ed al reinserimento comporta in termini di sicurezza collettiva e calo delle
recidive (il 68 per cento dei ristretti in condizioni meramente afflittive
commette nuovi reati una volta fuori dal carcere mentre solo il 19% di chi ha
avuto accesso a percorsi riabilitativi e formativi torna a delinquere). Solo
quando gli elementari principi costituzionali e della civiltà giuridica, quindi
della civiltà, faranno parte del bagaglio comune e verrà ritrovato e
riconosciuto il senso reale dell’esecuzione penale la prospettiva
dell’appuntamento elettorale cesserà progressivamente di premiare politiche
intrise di quel populismo penale responsabile di irrigidimenti sanzionatori e di
una visione della pena tiranneggiata dal carattere meramente afflittivo,
punitivo e retributivo. Gli Stati Generali rappresentano dunque il primo faro
acceso da decenni sulle storture del nostro sistema penitenziario per portare
all’attenzione del dibattito pubblico e politico in modo maturo lo stato di
illegalità in cui versa il nostro sistema carcerario e le condizioni disumane e
degradanti a cui sono costretti i detenuti. “Sei mesi di ampio e approfondito
confronto - spiega da mesi Orlando - che dovrà portare certamente a definire un
nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più
dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto”. Che riescano ad aprire
una breccia nell’imperante cultura e non si risolvano in una sfilata ad effetto
che ha tenuto impegnati molti addetti ai lavori per una manciata di mesi,
grossomodo gli stessi che è durato quell’Expò situato proprio accanto al carcere
di Opera dove gli Stati Generali sono stati inaugurati, questo rimane, per
adesso, soltanto un auspicio. L’immagine e la realtà del nostro sistema
carcerario rimane, nel frattempo, spettrale e sebbene la minaccia delle sanzioni
della Cedu abbia agito da propulsore per la presa in carico di un’emergenza che
non era più differibile, i metodi con cui la si è fronteggiata hanno molto il
segno dell’improvvisazione e della disumanità. Alcune misure come l’aver dato
attuazione alla legge 67/2014 che regola la depenalizzazione e le pene detentive
non carcerarie favoriscono senz’altro lo sfollamento degli istituti di pena. Ma
ricordiamo che il contributo decisivo alla deflazione del sovraffollamento
carcerario è stato dato dalla sentenza di incostituzionalità da parte della
Consulta sulla Legge Fini- Giovanardi che ha decriminalizzato le droghe leggere
e di conseguenza dato il via allo sfoltimento progressivo (le pene non superano
i sei anni di detenzione) delle carceri di una buona parte di quel 40% di
detenuti accalcati per anni per detenzione di sostanze stupefacenti leggere.
Quel che si è invece fatto per affrontare l’emergenza
illegalità/sovraffollamento delle nostre carceri, sempre sotto i riflettori
della Cedu, è stato ricorrere ad inumani trasferimenti forzati, con la
“deterritorializzazione” di molti detenuti dal loro istituto carcerario al fine
di ottenere per ciascun ristretto lo spazio individuale minimo (3mq al netto
degli arredi) stabilito dagli standard della Cedu: Una mera redistribuzione
contabile lungo le carceri dello stivale realizzata a costo di amputare dignità,
relazioni affettive e percorsi riabilitativi avviati nell’istituto di pena di
origine. Sono solo alcune delle criticità che investono ancora il nostro sistema
detentivo ed è di tutta evidenza che l’emergenza, che pone sul tavolo la
razionalizzazione degli spazi detentivi, l’accesso ad attività lavorative,
l’effettivo diritto alla salute, il disagio psichico, il miglioramento delle
condizioni degli operatori penitenziari, le donne ed i minori con le loro
esigenze di psicologiche e pedagogiche, il processo di reinserimento del
condannato, è tutt’altro che superata. La pena rimarrà sempre, come è giusto che
sia, l’aspetto più rigido e duro della giustizia, ma non le si deve permettere
di uscire dal dettato costituzionale mortificando i diritti del singolo fino a
spingerlo al suicidio o portandolo a morire in carcere nell’indifferenza
politica, come accade invece nel nostro sistema penitenziario. I dati sullo
stillicidio di morti e di suicidi all’interno degli istituti di pena dal 2000 ad
oggi sono l’eloquente prova che al momento lo Stato merita soltanto
un’inappellabile condanna.
Anno 2000, Suicidi 61,
Totale morti 165;
Anno 2001, Suicidi 69,
Totale morti 177;
Anno 2002, Suicidi 52,
Totale morti 160;
Anno 2003, Suicidi 56,
Totale morti 157;
Anno 2004, Suicidi 52,
Totale morti 156;
Anno 2005, Suicidi 57,
Totale morti 172;
Anno 2006, Suicidi 50,
Totale morti 134;
Anno 2007, Suicidi 45,
Totale morti 123;
Anno 2008, Suicidi 46,
Totale morti 142;
Anno 2009, Suicidi 72,
Totale morti 177;
Anno 2010, Suicidi 66,
Totale morti 184;
Anno 2011, Suicidi 66,
Totale morti 186;
Anno 2012, Suicidi 60,
Totale morti 154;
Anno 2013, Suicidi 49,
Totale morti 153;
Anno 2014, Suicidi 44,
Totale morti 132;
Anno 2015 (*), Suicidi
34, Totale morti 88; Per un totale di 877 suicidi e 2.459 morti
(*) Aggiornamento al 5
ottobre 2015
Dossier
“Morire di Carcere” 2015 (Aggiornamento
al 5 ottobre 2015)
Non li uccise la morte ma due
guardie bigotte. Aldrovandi, Bianzino, Sandri, Uva, Cucchi...scrive di Davide
Falcioni venerdì 22 giugno 2012. "Non mi uccise la morte ma due guardie bigotte
mi cercarono l'anima a forza di botte". Fabrizio De André - Un Blasfemo (dietro
ogni blasfemo c'è un giardino incantato) Non al denaro, non all'amore né al
cielo (1971). Per cercare l'anima a Federico Aldrovandi ci si misero in 4. Luca
Pollastri, Enzo Pontani, Paolo Forlani e Monica Segatto. Quattro poliziotti.
C'era chi teneva e chi picchiava. Chi picchiava lo fece talmente forte che due
manganelli si spezzarono sul corpo di Federico, che ostinatamente resisteva a
quelle sferzate e tentava di ribellarsi, finché non venne immobilizzato. Morì
verso l'alba per asfissia da posizione, con il torace schiacciato sull'asfalto
dalle ginocchia dei poliziotti. Successivamente i quattro poliziotti descrissero
Federico come un "invasato violento in evidente stato di agitazione". Da ieri
quello che per anni è stato chiamato "Caso Aldrovandi" potrà essere chiamato
"omicidio Aldrovandi". La Corte di Cassazione di Roma ha confermato le condanne
a 3 anni e 6 mesi di reclusione a Pollastri, Pontani, Forlani e Segatto,
responsabili di omicidio colposo per aver ecceduto nell'uso della forza. La vita
di un ragazzo di 18 anni vale 3 anni e 6 mesi di reclusione. Comprensibilmente
in molti hanno giudicato la pena troppo tenera, ma va considerata anche la
verità storica che finalmente è stata definita. Una sentenza stabilisce che un
ragazzo è stato ammazzato da alcuni poliziotti. Per un paese come l'Italia, dove
queste cose vengono spesso occultate, è un fatto importante. Ma il caso di
Federico Aldrovandi non è isolato. Come documentato dall'Osservatorio
Repressione dal 1945 sono decine i cittadini uccisi per mano delle forze
dell'ordine, che spesso hanno represso nel sangue manifestazioni di protesta.
Senza considerare la repressione giudiziaria: oltre 15mila sono i denunciati dai
fatti del G8 di Genova ad oggi: un tentativo, evidentemente, di trasformare
lotte politiche in fatti di comune delinquenza. Per ragioni di spazio ci
concentreremo sugli uomini morti a seguito di un fermo di polizia. Se siano
stati uccisi, o se la morte sia sopraggiunta per altre ragioni, a noi non è dato
saperlo con certezza. Nel caso di Aldrovandi possiamo, sentenza alla mano,
parlare di omicidio: la stessa cosa non si può dire (almeno, non con rigore
giornalistico) per altre situazioni che però destano preoccupazione, tra
tentativi di depistaggio e insabbiamenti. Sempre per ragioni di sintesi,
partiremo da Genova 2001, dai giorni torridi del luglio di 11 anni fa che videro
la morte del giovane Carlo Giuliani. Carlo aveva 23 anni. Manifestava, insieme a
migliaia di compagni, all'assemblea del G8 di Genova, in una città blindata e
ferita da disordini e scontri continui. Carlo morì a Piazza Alimonda, ucciso da
un colpo sparato dal carabiniere Mario Placanica, che si trovava all'interno di
un Land Rover di servizio. Carlo venne colpito subito dopo aver afferrato da
terra un estintore. Una ricostruzione affidabile della vicenda, con immagini da
punti di vista differenti, è stata effettuata da Lucarelli nella
trasmissione Blu Notte. Dopo aver esploso il colpo, diretto allo zigomi di
Giuliani, il mezzo dei Carabinieri passò ben due volte sul corpo del ragazzo. Il
carabiniere Placanica è stato prosciolto dall'accusa di omicidio colposo:
avrebbe sparato, secondo i giudici, per legittima difesa. L'11 luglio del 2003
all'interno del carcere Le Sugheri di Livorno venne ritrovato il corpo di
Marcello Lonzi, 29 anni, in un lago di sangue. Secondo la giustizia italiana il
ragazzo sarebbe morto per cause naturali (il caso è stato archiviato) ma le foto
del carcere e all'obitorio mostrerebbero chiarissimi segni di pestaggio. La
madre di Marcello, Maria Ciuffi, ha condotto per anni una battaglia per la
verità sulla morte del figlio. Riccardo Rasman morì il 27 ottobre del 2006 a
Trieste. Nella sua casa di via Grego fecero irruzione le forze dell'ordine. Il
ragazzo, affetto da sindrome schizofrenica paranoide, dovuta a episodi di
nonnismo subìti durante il servizio militare, era in uno stato di particolare
felicità: il giorno dopo avrebbe iniziato a lavorare come operatore ecologico.
Ascoltava musica ad alto volume, lanciando un paio di petardi dal balcone.
Qualcuno chiamò il 113 denunciando il baccano, arrivarono due volanti, gli
agenti entrarono a casa dell'uomo, lo immobilizzarono e ammanettarono a seguito
di una colluttazione. Come per Aldrovandi, Riccardo Rasman sarebbe morto per
asfissia: benché fosse ancora ammanettato i poliziotti continuarono a
schiacchiargli la schiena impedendogli la respirazione. Il 14 ottobre del 2007
fu la volta di Aldo Bianzino, falegname, in una cella del carcere di Perugia.
Venne arrestato due giorni prima insieme alla compagna per coltivazione e
detenzione di piantine di canapa indiana. Aldo era in buona salute: morì,
ufficialmente, per cause naturali (a seguito di una malattia cardiaca). Una
perizia medico legale effettuata dal dottor Lalli e richiesta dalla famiglia
rivelerà, invece, la presenza di 4 ematomi cerebrali, fegato e milza rotte, 2
costole fratturate. Ne seguì un processo conclusosi con l'archiviazione ma,
grazie all'insistenza di amici e familiari e all'apertura di un blog, negli
ultimi mesi si sta tentando di riaprire le indagini. Neanche un mese dopo, l'11
ottobre 2007, nell'autogrill di Badia al Pino verrà ucciso Gabriele Sandri,
tifoso della Lazio. Ad ammazzarlo un colpo di pistola esploso dall'agente di
polizia Luigi Spaccarotella, che in quel momento si trovava dall'altra parte
della carreggiata. Il poliziotto verrà condannato in tutti e tre i gradi di
giudizio per omicidio volontario. Giuseppe Uva morirà il 15 giugno del 2008.
Venne fermato dai Carabinieri insieme ad un amico, che raccontò: “Avevamo
bevuto. Mettemmo le transenne in mezzo alla strada. Una bravata”. Li portarono
via, li misero in due stanze diverse. L'amico sente le grida di Giuseppe
nell’altra stanza. Chiama il 118. Chiede aiuto. Poi sono gli stessi carabinieri
a chiamare i sanitari e richiedono il trattamento sanitario obbligatorio per
Uva. Giuseppe muore in ospedale dopo essere rimasto oltre tre ore in caserma.
Sotto processo è un medico accusato di avergli somministrato un farmaco che
avrebbe fatto reazione con l’alcool che aveva in corpo. La sorella Lucia disse:
"Era pieno di lividi. Aveva bruciature di sigaretta dietro il collo e i
testicoli tumefatti”. “Mi hanno spiegato che Pino ha dato in escandescenze, che
è andato a sbattere contro i muri, ma quelle ferite non si spiegano
così”. “Giuseppe – rivela la sorella – aveva anche sangue nell’ano”. Venne
violentato? Il 24 giugno del 2008 Niki Aprile Gatti, 26 anni, muore nel carcere
di massima sicurezza di Sollicciano (Firenze). Era stato arrestato a seguito di
un'indagine su una società di San Marino responsabile di una truffa informatica.
Venne trovato impiccato a un laccio nel bagno del carcere. Tutto avrebbe fatto
pensare a un suicidio, ma la mamma di Niki non ci sta e, ancora una
volta, scrive su un blog: "L’utilizzo di un solo laccio è di per sé idoneo a
causare la morte per strangolamento di una persona. Ma certamente non idoneo a
sorreggere il corpo di Niki, del peso di 92 chili. Inoltre non si comprende come
possa essere stata consumata l’impiccagione quando nel bagno non vi era
sufficiente altezza tra i jeans e il piano di calpestio del pavimento". Il 25
luglio del 2008 muore nel carcere Marassi di Genova Manuel Eliantonio, 22 anni.
Era stato in discoteca e, a seguito di un controllo di Polizia, gli rilevarono
tracce di alcol e stupefacenti. Per questo venne fermano, tentò la fuga ma venne
acciuffato e incarcerato. Dopo sette mesi de detenzione per resistenza a
pubblico ufficiale e a meno di un mese dal rilascio muore. L'autopsia parla di
intossicazione da butano ma non spiega i lividi sul suo corpo. Carmelo Castro è
morto in carcere il 28 marzo del 2009, a soli 19 anni. Era stato arrestato per
aver fatto il palo in una rapina. Tre giorni dopo aver varcato il portone del
carcere di Piazza Lanza si è suicidato legando un lenzuolo allo spigolo della
sua branda. Così è stato scritto nella relazione di servizio e questo ha
confermato anche il gip Alfredo Gari che ha già respinto una prima richiesta di
riapertura delle indagini presentata dalla famiglia del ragazzo. Ma la madre
Grazia La Venia non ci sta: "Mio figlio non può essersi suicidato, non era in
grado nemmeno di allacciarsi le scarpe da solo, figuriamoci attaccare un
lenzuolo alla branda e impiccarsi". Al suo fianco ora si schiera l’associazione
Antigone, che ha denunciato: "Nel corso delle indagini preliminari non è stato
disposto il sequestro della cella, né del lenzuolo con il quale Castro si
sarebbe impiccato a questo, si aggiunga che non è stato sentito nessuno del
personale di polizia penitenziaria intervenuto, né il detenuto che avrebbe
portato il pranzo a Castro e che sarebbe l’ultima persona ad averlo visto ancora
da vivo". Il 21 luglio del 2009, Stefano Frapporti, operaio di 48 anni, sta
tornando da lavoro in sella alla sua bicicletta quando viene fermato da due
carabinieri in borghese per un'infrazione stradale. Portato in carcere perché
sospettato di spaccio non uscirà mai vivo dalla cella. Ufficialmente morirà
suicida, ma tra gli amici da anni è in vigore una battaglia per chiedere
chiarezza. Il 58enne Franco Mastrogiovanni morirà il 4 agosto del 2009 dopo 4
giorni di trattamento sanitario obbligatorio e dopo essere rimasto legato più di
80 ore a un lettino, alimentato solo di flebo e sedato con farmaci
antipsicotici. Il video della sua agonia fece il giro del mondo. Tutti conoscono
la storia di Stefano Cucchi, geometra di 31 anni morto nel reparto carcerario
dell'Ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009. Stefano era accusato di
detenzione di stupefacenti. Morì di edema polmonare dopo 8 giorni di agonia, nei
quali perse 7 chili. Sul suo corpo, le cui foto sconvolsero l'Italia, venne
rilevata una vertebra fratturata, la rottura del coccige, sangue nello stomaco e
altri traumi sparsi ovunque. Gli agenti di polizia penitenziaria che lo ebbero
in custodia sono tuttora indagati per lesioni e percosse (è caduta l'accusa
di omicidio colposo), mentre i medici sono indagati per abbandono di incapace. E
la lista potrebbe essere ancora lunga, se contenesse anche i nomi dei detenuti
che si sono tolti la vita negli ultimi anni, spesso a causa delle condizioni
disumane in cui versano le carceri. La soluzione del caso Aldrovandi dovrebbe
indurre a far chiarezza anche su tutti gli altri. Verso i quali, come abbiamo
visto, troppo spesso è prevalsa la superficialità di giudizio quando non un
assurdo spirito cameratesco. Si ringrazia l'Osservatorio sulla Repressione.
Botte dietro le sbarre, i
troppi casi Uva nelle carceri italiane.
Da Lucera a Siracusa, da Pordenone a Ivrea. Molti i casi controversi di morte o
lesioni in carcere. Un detenuto: «La mia faccia era trasformata, gonfia come un
pallone, era un viso irriconoscibile», scrive Carmine Gazzanni il 20 Aprile 2016
su “L’Inchiesta”. Due assoluzioni per una brutta faccenda che ancora non risulta
affatto chiara. Lucia Uva, sorella di Giuseppe, assolta dall'accusa di aver
diffamato poliziotti e carabinieri che lo avevano in custodia. Questi ultimi a
loro volta assolti venerdì 15 aprile dall'accusa di aver seviziato l'operaio 40
enne. Rimane un enorme cono d’ombra: gli ematomi e le tumefazioni sul corpo di
Giuseppe Uva rimangono, almeno per ora, senza una concreta spiegazione. «Non si
può che pensare tutto il male del mondo sulla vicenda Uva. Non siamo ciechi: è
evidente che la verità sia un’altra. Ne vanno di mezzo anche le istituzioni, che
perdono la credibilità» dice a Linkiesta Giuseppe Rotundo, uno che ha rischiato
di finire esattamente come Uva, Stefano Cucchi e tanti altri che sono morti
dietro le sbarre. «Sono un miracolato. Io quella notte dovevo morire», ricorda
ancora. È il 2011 e Giuseppe è detenuto al carcere di Lucera, in provincia di
Foggia. Quel giorno ha un diverbio con alcuni agenti della polizia
penitenziaria. «Sapevo – racconta a Linkiesta – che sarei andato incontro ad un
rapporto disciplinare. Mai però avrei immaginato che mi avrebbero pestato». Il
giorno dopo due dottoresse con le quali aveva fissato da tempo una visita
medica, addirittura non lo riconosceranno. «La faccia era trasformata, gonfia
come un pallone, era un viso irriconoscibile» dirà una delle due dottoresse al
pm che ha indagato e ottenuto il rinvio a giudizio degli agenti, grazie alla sua
tempestività di inviare subito in carcere qualcuno che fotografasse Rotundo.
Foto inequivocabili: lividi su braccia, gambe e schiena, tagli sulla faccia,
piede gonfio, occhio sanguinante. Ora il processo è in fase dibattimentale e
tutti, sia guardie che detenuto, sono imputati e persone offese. Ma gli agenti
non sono a giudizio per tortura. Impossibile, dato che in Italia non esiste una
legge che punisca questa tipologia di reato. Meno “fortunato” è stato Alfredo
Liotta, sulla cui storia pure aleggiano pesanti ombre che purtroppo, visti i
tempi giudiziari e la prescrizione che si avvicina per gli imputati, rischiano
di non essere mai più diradate. È il 26 luglio 2012 quando il suo corpo viene
ritrovato ormai senza vita in una cella del carcere di Siracusa. All’inizio si
dirà che Alfredo è morto per un presunto sciopero della fame. Peccato però che
di tale sciopero non ci sia alcuna traccia nel diario clinico. Tanto che il
legale di Antigone, l’associazione che si occupa della tutela dei diritti umani
in carcere, presenta un esposto. Più di qualcosa infatti non torna. Perché, ad
esempio, di fronte al grave dimagrimento di Alfredo, che già da un mese prima
«non riusciva più a stare in posizione eretta», non sono stati disposti neanche
quei minimi accertamenti come la misurazione del peso o il monitoraggio dei
parametri vitali? Arriviamo così a novembre 2013: la Procura di Siracusa iscrive
ben dieci persone nel registro degli indagati tra direttrice del carcere,
medici, infermieri e perito nominato dallo stesso tribunale. Sono passati quasi
quattro anni dalla morte di Liotta, ma la Procura non ha ancora provveduto alla
chiusura delle indagini. Indagini che, invece, forse verranno presto archiviate
per Stefano Borriello, un caso di cui Linkiesta si è già occupata. Una morte
improvvisa, senza alcuna ragione. Tanto che, anche qui, la Procura di Pordenone
ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Aveva
dunque nominato un perito medico per accertare le «cause della morte» e
«eventuali lesioni interne o esterne» riportate dal giovane. Dopo un silenzio
durato ben otto mesi, il consulente del pm ha reso noto che Stefano sarebbe
morto per una banale polmonite batterica e che, a fronte di questa patologia, in
modo inspiegabile, nessuna cura poteva essere apprestata. Ma è possibile – si
chiedono da Antigone – che un ragazzo muoia in carcere per una semplice
polmonite batterica e che dinanzi a questo evento non si decida di individuarne
i responsabili? Anche perché, ovviamente, la polmonite non nasce dal nulla: ha
sintomi ben precisi, ha un decorso di diversi giorni e, soprattutto, se
correttamente diagnosticata ci sono terapie risolutive. Non è un caso allora che
per un fatto analogo, ci dicono ancora da Antigone, lo scorso mese di marzo a
Roma è stata chiesta la condanna per omicidio colposo per il medico del carcere
ritenuto responsabile della morte di un giovane, avvenuta nel carcere romano di
Rebibbia proprio per polmonite: «una diagnosi tempestiva gli avrebbe salvato la
vita». Ma non è finita qui. Perché accanto a episodi più noti saliti alla
ribalta delle cronache, ci sono casi di violenza dietro le sbarre di cui spesso
poco o nulla si sa. È gennaio quando alla sede del Difensore civico del Piemonte
arriva una lettera a firma «R.A.» in cui viene denunciato un episodio di
violenza che si sarebbe verificato presso la Casa circondariale di Ivrea e di
cui l’autore della missiva sarebbe stato teste oculare. «Il giorno sabato 7
novembre scorso – si legge nella lettera – ho assistito al maltrattamento di un
giovane detenuto, probabilmente nordafricano di cui non conosco il nome. Verso
le ore 20.15 sono stato attratto da urla di dolore e di richieste di aiuto e
sono uscito dalla mia cella nel corridoio che consente di vedere la “rotonda”
del piano terra. Ho visto tre agenti picchiare con schiaffi e pugni il giovane
che continuava a gridare chiedendo aiuto e cercava di proteggersi senza reagire.
Alla scena assistevano altri agenti e un operatore sanitario che restavano
passivi ad osservare. Il giovane veniva trascinato verso i locali
dell’infermeria mentre continuava a gridare». R.A., a questo punto, segnala il
fatto al magistrato di sorveglianza di Vercelli e alla direttrice della Casa
circondariale. Una denuncia importante, quella di R.A., cui è seguito un esposto
presentato dallo stesso Difensore civico, e un procedimento aperto alla Procura
di Ivrea. Per ora contro ignoti. Ignoti che, si spera, un giorno abbiano un
volto, un nome e un cognome.
LA STORIA DELL’AMNISTIA.
Storia dell’amnistia da Togliatti ai
giorni di Tangentopoli, scrive Massimo Lensi il 14
Aprile 2017 su "Il Dubbio". La chiedevano i Papi, ci aiutò a uscire dal
fascismo, Marco Pannella ne ha fatto per anni il suo campo di battaglia, ma dopo
Mani Pulite è scomparsa dall’orizzonte politico e culturale italiano. A Pasqua
si terrà a Roma la Quinta marcia per l’Amnistia, organizzata dal Partito
Radicale. Marco Pannella coniò un’efficace espressione per spiegare l’importanza
della clemenza. Egli la invocava per la Repubblica, per rientrare nella legalità
e porre fine alle violazioni della Costituzione nella gestione del sistema
penitenziario, nella durata dei processi, nell’utilizzo della prescrizione
nascosta conseguente all’applicazione discrezionale dell’obbligatorietà
dell’azione penale da parte dei magistrati. “Amnistia per la Repubblica” era lo
slogan di Pannella. La storia dei provvedimenti di clemenza di un Paese
racconta, infatti, più cose di quanto si possa immaginare. L’amnistia e
l’indulto – a volte anche il provvedimento di grazia – sono atti politici a
tutto tondo. La clemenza porta sempre con sé un’attenzione particolare ai
rapporti tra Stato e magistratura, tra esecuzione della pena e reinserimento
sociale, tra eventi di particolare rilievo e opinione pubblica, ed è
accompagnata sempre da una tendenza a un particolare intento di riscrittura
della storia, riscontrabile nei dispositivi legislativi: accertare la verità,
farla dimenticare o renderla del tutto illeggibile. Stéphane Gacon nel suo libro
“L’Amnistie” (2002) classificava la clemenza di Stato in tre tipologie
differenti: l’amnistia perdono, atto di generosità tipico dei regimi totalitari;
l’amnistia- rifondazione, che interviene per riunificare un Paese diviso;
l’amnistia- riconciliazione che segue la fine dei regimi dittatoriali. L’Italia
repubblicana ha concesso una trentina di provvedimenti di clemenza, tra amnistie
e indulti. L’ultima amnistia è del 1990, mentre nel 2006 fu approvato l’ultimo
indulto. Terminate le drammatiche vicende politiche e militari che portarono
alla caduta del regime fascista, lo strumento dell’amnistia fu utilizzato tra il
1944 e il 1948 per vanificare la vigenza della normativa penale del regime,
il codice Rocco, nei confronti dei delitti politici commessi durante la
Resistenza, o nel periodo successivo. E’ interessante notare come, all’epoca, il
tentativo del legislatore fu di chiudere con il periodo dittatoriale e la sua
legislazione penale, al fine di far nascere lo stato “nuovo” e far sì che questo
trovasse in sé la propria legittimità giuridica e non nelle leggi dello Stato
precedente. Un tentativo che, però, rimase tale. Per Piero Calamandrei, infatti,
mancò sul terreno giuridico della forma “lo stabile riconoscimento della nuova
legalità uscita dalla Rivoluzione”. Ed è altrettanto vero che i provvedimenti di
amnistia di quel periodo ebbero in comune una natura delegittimante nei
confronti della Resistenza, in quanto le azioni commesse durante la lotta
antifascista vennero considerate alla stregua di reati comuni, anche se motivati
da eccezionali contingenze. Si restava a tutti gli effetti all’interno del
recinto dell’art. 8 del codice penale, che definisce come delitto politico:
“ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto
politico del cittadino. È altresì considerato politico il delitto comune
determinato in tutto o in parte da motivi politici”.
Il decreto presidenziale n. 4/1946, conosciuto con
il nome di “amnistia Togliatti”, all’epoca guardasigilli della Repubblica, tentò
di consegnare all’oblio non solo i reati connessi all’attività partigiana, ma
anche i reati legati alla collaborazione con l’esercito tedesco di occupazione,
pur con numerose eccezioni e sollevando numerose polemiche. L’uomo dalla
stilografica con l’inchiostro verde (cioè Togliatti) scommise sul futuro per
mettere fine a un possibile ciclo di rese dei conti, ma fu accusato, in nome
della sua proverbiale “doppiezza”, di aver aperto le porte del carcere ai
fascisti e ai repubblichini imprigionati subito dopo la Liberazione. Sta di
fatto che, forse anche a causa di un’interpretazione distorta del testo del
decreto (scritto, invero, con un linguaggio giuridico assai poco limpido), tra i
7061 amnistiati, 153 erano partigiani, e 6.908 fascisti.
Negli anni ’ 50 e ’ 60 i provvedimenti di clemenza
furono nove, di cui cinque strettamente connessi sia a fatti politici legati
alla scia lunga del dopo- guerra, sia ai movimenti della fine degli anni ’ 60,
con l’attribuzione di reati commessi in occasione di agitazioni e manifestazioni
studentesche e sindacali (amnistia del ’ 68). Tutti e cinque questi
provvedimenti comportarono la concessione sia di amnistia, sia di indulto. Il
primo fu nel 1953 (7.833 amnistiati) e l’ultimo nel 1970 (11.961 amnistiati);
gli altri furono concessi nel 1959 (7.084 amnistiati), nel 1966 (11.982
amnistiati) e nel 1968 (315 amnistiati). Dopo il 1970 non ci furono più amnistie
per fatti politici.
L’amnistia del ’ 68 fu particolarmente importante
perché ebbe come oggetto esclusivamente reati politici e sociali. Il
senatore Tristano Codignola del Partito Socialista nel presentare il
provvedimento al Senato disse: “Appare quindi evidente che, nell’interesse
stesso della democrazia, nell’accezione aperta e progressiva voluta dalla nostra
Costituzione, occorre procedere di pari passo alla realizzazione di profonde
riforme strutturali e alla creazione di un clima maggiormente democratico ed
antiautoritario nel Paese”. Con l’amnistia del ’ 68, si chiuse finalmente il
ciclo legato alla guerra di Liberazione, si aprì però il capitolo che precedette
gli anni di piombo. E per la prima volta nel 1970 fecero capolino nell’amnistia
il riferimento ai reati in materia tributaria e nell’indulto il riferimento a
reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di monopolio. La
giovane Italia del primo dopo- guerra diventava maggiorenne e i reati comuni, al
posto di quelli politici, iniziarono a catturare sempre più l’attenzione del
legislatore: un’attenzione che, come vedremo, costerà cara.
Nel 1982 e 1983 furono approvati due provvedimenti
di sola amnistia ed esclusivamente per reati finanziari. Il clima iniziò a farsi
pesante e il parlamento venne accusato di difendere corrotti e concussi tanto
che, dopo qualche anno, il 6 marzo del 1992, il Parlamento operò una revisione
costituzionale modificando profondamente la ratio dell’articolo 79 della
Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto. Nel testo voluto
dai Padri Costituenti amnistia e indulto erano concessi dal Presidente della
Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere, approvata a
maggioranza semplice. La modifica introdotta nel 1992 fece sì che questi
provvedimenti di clemenza potessero essere concessi solo con una legge
deliberata in ogni articolo e nella votazione finale dalla maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera. L’innalzamento del quorum necessario
all’approvazione del provvedimento fu deciso sull’onda dell’emotività suscitata
nella piazza dallo scandalo di “Mani Pulite” per evitare il ripetersi di
amnistie “concesse a cuor leggero”. Erano i tempi del lancio delle monetine
davanti all’Hotel Raphael e la piazza esigeva una svolta nel rispetto della
penalità. Fu in quel periodo che prese il via una prima trasformazione dei
modelli istituzionali che lentamente portò al trasferimento dei sistemi di
controllo sociale dalle forme di protezione a quelle della punizione. La grande
crisi economica degli anni successivi portò a compimento questa operazione di
trasformazione. L’insicurezza sociale che ne è scaturita si è, infatti, rivolta
al sistema penale, nella forma dell’esercizio delle funzioni repressive. Il
numero dei reati inseriti del codice penale ha continuato a crescere insieme
alla domanda di penalità, portando in pochi anni a raddoppiare il numero di
detenuti delle carceri italiane: dai 30mila degli anni Novanta ai quasi 60mila
dei nostri giorni. Il mutamento delle relazioni sociali e di potere e il
tramonto di un certo tipo di welfare hanno condannato qualsiasi progetto di
amnistia in fondo al cassetto delle priorità. Le carceri italiane hanno così
cominciato a conoscere il sistematico sovraffollamento e i trattamenti inumani e
degradanti riservati alla popolazione detenuta.
A ben vedere, quindi, la richiesta di amnistia (e
indulto) sostenuta con forza dal Partito Radicale non è per un provvedimento
clemenza. Quella che si chiede non è la amnistia- amnesia; è, invece, la
richiesta di una amnistia politica per porre fine al sovraffollamento cronico e
inumano delle nostre carceri e alla intollerabile lentezza dei processi, che
hanno fatto meritare allo stato italiano plurime condanne dalle Corti europee.
In altre parole, un’amnistia per porre le radici di una Giustizia (più) Giusta.
ESEMPI SCOLASTICI. SONO ASSOLUTAMENTE
INNOCENTI. NICOLA SACCO E BARTOLOMEO VANZETTI.
Sacco e Vanzetti.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. «Io dichiaro che ogni stigma ed ogni onta
vengano per sempre cancellati dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.»
(Il proclama del 23 agosto 1977, con il quale l'allora governatore del
Massachusetts Michael Dukakis assolveva i due anarchici italiani dal crimine a
loro attribuito, esattamente 50 anni dopo la loro esecuzione sulla sedia
elettrica).
Ferdinando Nicola Sacco (Torremaggiore, 22
aprile 1891 – Charlestown, 23 agosto 1927) e Bartolomeo Vanzetti
(Villafalletto, 11 giugno 1888 – Charlestown, 23 agosto 1927) sono stati due
attivisti e anarchici italiani. Sacco di professione faceva l'operaio in una
fabbrica di scarpe. Vanzetti, invece, che gli amici chiamavano Tumlin, dopo aver
a lungo girovagato negli Stati Uniti d'America facendo molti lavori diversi,
rilevò da un italiano un carretto per la vendita del pesce; ma fece questo
lavoro per pochi mesi. I due furono arrestati, processati e condannati a morte
con l'accusa di omicidio di un contabile e di una guardia del calzaturificio
«Slater and Morrill» di South Braintree. Sulla loro colpevolezza vi furono molti
dubbi già all'epoca del loro processo; a nulla valse la confessione del detenuto
portoghese Celestino Madeiros, che scagionava i due. I due furono giustiziati
sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927 nel penitenziario di Charlestown,
presso Dedham. A cinquant'anni esatti dalla loro morte, il 23
agosto 1977 Michael Dukakis, governatore dello Stato del Massachusetts,
riconobbe ufficialmente gli errori commessi nel processo e riabilitò
completamente la memoria di Sacco e Vanzetti.
L'incontro. Nicola Sacco viaggia sulla motonave
«Romanic» verso gli Stati Uniti d'America e giunge a Boston il 12 aprile
del 1909; Bartolomeo Vanzetti, invece, raggiunge New York su «La Provence» il 19
giugno 1908, quando ha vent'anni; i due non si conoscono. Vanzetti, al processo,
descriverà così l'esperienza dell'immigrazione: "Al centro immigrazione ebbi la
prima sorpresa. Gli emigranti venivano smistati come tanti animali. Non una
parola di gentilezza, di incoraggiamento, per alleggerire il fardello di dolori
che pesa così tanto su chi è appena arrivato in America". Poi, in seguito
scriverà: "Dove potevo andare? Cosa potevo fare? Quella era per me come la Terra
Promessa. Il treno della sopraelevata passava sferragliando e non rispondeva
niente. Le automobili e i tram passavano oltre senza badare a me".
Sacco nacque a Torremaggiore, in provincia di
Foggia, il 22 aprile del 1891 da una famiglia di produttori agricoli e
commercianti di olio e vino. Trovò lavoro in una fabbrica di calzature
a Milford dove, nel 1912, sposò Rosina Zambelli, con la quale andò ad abitare in
una casa con giardino ed ebbe un figlio, Dante, e una figlia, Ines. Lavorava sei
giorni la settimana, dieci ore al giorno. Nonostante ciò, partecipava
attivamente alle manifestazioni operaie dell'epoca, attraverso le quali i
lavoratori chiedevano salari più alti e migliori condizioni di lavoro. In tali
occasioni teneva spesso dei discorsi. A causa di queste attività fu arrestato
nel 1916.
Vanzetti nacque a Villafalletto, in provincia di
Cuneo, l'11 giugno del 1888, primogenito dei quattro figli di Giovanna Nivello
(1862-1907) e Giovanni Battista Vanzetti (1849-1931), modesto proprietario
terriero e gestore di una piccola caffetteria. Pur non vivendo in ristrettezze
economiche, a spingerlo a emigrare negli Stati Uniti furono soprattutto
l'improvvisa e tragica morte dell'amata madre, che lo portò quasi alla follia, e
probabilmente una consuetudine familiare (anche il padre era stato emigrante per
un breve periodo, dal 1881 al 1883 in California). Fece molti lavori, accettando
tutto ciò che gli capitava. Lavorò in varie trattorie, in una cava, in
un'acciaieria e in una fabbrica di cordami, la Plymouth Cordage Company. Spirito
libero e indipendente, era un avido lettore soprattutto delle opere
di Marx, Darwin, Hugo, Gorkij, Tolstoj, Zola e Dante. Nel 1916 guidò uno
sciopero contro la Plymouth e per questo motivo nessuno volle più dargli un
lavoro. Più tardi, nel 1919, si mise in proprio facendo il pescivendolo fino al
momento dell'arresto.
Fu in quell'anno, il 1916, che Sacco e Vanzetti si
conobbero ed entrarono entrambi a far parte di un gruppo anarchico
italo-americano. Allo scoppio della Grande Guerra, tutto il collettivo fuggì
in Messico per evitare la chiamata alle armi, poiché per un anarchico non c'era
niente di peggio che uccidere o morire per uno Stato. Nicola e Bartolomeo fecero
ritorno nel Massachusetts al termine del conflitto, non sapendo però di essere
stati inclusi in una lista di sovversivi compilata dal Ministero di Giustizia,
così come di essere pedinati dagli agenti segreti statunitensi. Nella stessa
lista era incluso anche un amico di Vanzetti, il tipografo Andrea Salsedo,
originario dell'isola di Pantelleria. Questi, il 3 maggio del 1920, fu trovato
sfracellato al suolo alla base del grattacielo di New York dove al
quattordicesimo piano aveva sede il Boi (Bureau of Investigation), dove Salsedo
era tenuto illegalmente prigioniero ormai da lungo tempo, insieme a Roberto
Elia. Vanzetti organizzò un comizio, su invito di Carlo Tresca, per protestare
contro la vicenda, comizio che avrebbe dovuto avere luogo a Brockton il 9
maggio, ma insieme a Sacco fu arrestato prima, perché trovati in possesso
entrambi di una rivoltella e Vanzetti di alcuni appunti da destinarsi alla
tipografia per l'annuncio del comizio di Brockton. Pochi giorni dopo furono
accusati anche di una rapina avvenuta a South Braintree, un sobborgo di Boston,
poche settimane prima del loro arresto; in tale occasione erano stati uccisi a
colpi di pistola il cassiere della ditta (il calzaturificio «Slater and
Morrill») e una guardia giurata.
Verdetto condizionato. A parere di molti, alla
base del verdetto di condanna, da parte di polizia, procuratori distrettuali,
giudice e giuria vi furono pregiudizi e una forte volontà di perseguire
una politica del terrore suggerita dal ministro della giustizia Palmer e
culminata nella vicenda delle espulsioni. Sotto questo aspetto, Sacco e Vanzetti
erano considerati due agnelli sacrificali, utili per testare la nuova linea di
condotta contro gli avversari del governo. Erano infatti immigrati italiani con
una comprensione imperfetta della lingua inglese; erano inoltre note le loro
idee politiche radicali. Il giudice Webster Thayer li definì senza mezze parole
due bastardi anarchici. Il Governatore del Massachusetts Alvan T. Fuller, che
avrebbe potuto impedire l'esecuzione, rifiutò infine di farlo, dopo che
un'apposita commissione da lui istituita per riesaminare il caso riaffermò le
motivazioni della sentenza di condanna.
Si trattava di un periodo della storia
statunitense caratterizzato da un'intensa paura dei comunisti, la paura
rossa del 1917-1920. Né Sacco né Vanzetti si consideravano comunisti e Vanzetti
non aveva nemmeno precedenti con la giustizia, ma i due erano conosciuti dalle
autorità locali come militanti radicali coinvolti in scioperi, agitazioni
politiche e propaganda contro la guerra.
Dall'ultimo discorso di Vanzetti alla corte prima
della pronuncia della sentenza. Sacco e Vanzetti si ritenevano vittime del
pregiudizio sociale e politico. Vanzetti, in particolare, ebbe a dire
rivolgendosi per l'ultima volta al giudice Thayer: «Io non augurerei a un cane o
a un serpente, alla più bassa e disgraziata creatura della Terra — non augurerei
a nessuna di queste creature ciò che ho dovuto soffrire per cose di cui non sono
colpevole. Ma la mia convinzione è che ho sofferto per cose di cui sono
colpevole. Sto soffrendo perché sono un anarchico, e davvero io sono un
anarchico; ho sofferto perché ero un Italiano, e davvero io sono un Italiano
[...] se voi poteste giustiziarmi due volte, e se potessi rinascere altre due
volte, vivrei di nuovo per fare quello che ho fatto già.» (dal discorso di
Vanzetti del 9 aprile 1927, a Dedham, Massachusetts)
La protesta. Quando il verdetto di morte fu reso
noto, si tenne una manifestazione davanti al palazzo del governo, a Boston. La
manifestazione durò ben dieci giorni, fino alla data dell'esecuzione. Il corteo
attraversò il fiume e le strade sterrate fino alla prigione di Charlestown. La
polizia e la guardia nazionale li attendevano dinanzi al carcere e sopra le sue
mura vi erano mitragliatrici puntate verso i manifestanti.
L'intervento del governo italiano. Il caso di
Sacco e Vanzetti scosse molto l'opinione pubblica italiana di allora e anche il
governo fascista prese posizione e si mosse attivamente a sostegno dei due
connazionali, nonostante le loro idee politiche. Anche Benito Mussolini riteneva
il tribunale statunitense «pregiudizialmente prevenuto» nel giudicare Sacco e
Vanzetti e, a partire dal 1923 fino all'esecuzione della condanna a morte
nel 1927, i funzionari del Ministero degli Esteri, l'ambasciatore italiano
a Washington e il Console italiano a Boston operarono presso le autorità
degli Stati Uniti per ottenere prima una revisione del processo e poi la grazia
per i due italiani. Lo stesso Mussolini un mese prima dell'esecuzione scrisse
direttamente una lettera in cui chiedeva all'ambasciatore statunitense
a Roma Henry Fletcher di intervenire presso il Governatore del Massachusetts per
salvare la vita dei due condannati a morte.
Intellettuali pro Nick e Bart ed epilogo. Molti
famosi intellettuali, compresi George Bernard Shaw, Bertrand Russell, Albert
Einstein, Dorothy Parker, Edna St. Vincent Millay, John Dewey, John Dos
Passos, Upton Sinclair, H. G. Wells e Arturo Giovannitti (il quale fu
protagonista di un caso simile) sostennero a favore di Nick e Bart (come
venivano chiamati) una campagna per giungere a un nuovo processo. Perfino
il premio Nobel francese Anatole France invocò la loro liberazione sulle pagine
del periodico "Nation", paragonando l'ingiustizia da loro subita a quella
di Alfred Dreyfus. Purtroppo tutte queste iniziative non produssero alcun
risultato rilevante per la grazia dei due condannati. Il 23 agosto 1927 alle ore
00:19, dopo sette anni di udienze, i due uomini vennero uccisi sulla sedia
elettrica a distanza di sette minuti l'uno dall'altro (prima toccò a Sacco, poi
a Vanzetti). La loro esecuzione innescò rivolte popolari a Londra, Parigi e in
diverse città della Germania. Una bomba di probabile matrice anarchica,
nel 1928 devastò l'abitazione del giudice Webster Thayer, il responsabile della
condanna di Sacco e Vanzetti; il giudice era assente e la bomba non colpì
l'obiettivo, ferendo però la moglie e una domestica. I corpi dei due anarchici
furono cremati e le due urne contenenti le ceneri furono trasportate da Luigina
Vanzetti in Italia, dove sono custodite nei cimiteri dei loro comuni
d'origine: Torremaggiore per Sacco e Villafalletto per Vanzetti; le ceneri di
quest'ultimo sono conservate nella tomba dove riposano i genitori, le sorelle e
il fratello. I due comuni hanno dedicato ciascuno una via ai due anarchici. e
una scuola a Bartolomeo Vanzetti. Nel 2016 Amnesty International ha lanciato una
campagna per i diritti umani nel mondo, in memoria di Sacco e Vanzetti e
caratterizzata dalla canzone Here's to You dedicata da Joan Baez ai due
anarchici nel 1971.
Il proclama di Dukakis. Il 23 agosto 1977,
esattamente 50 anni dopo l'esecuzione, il governatore del Massachusetts Michael
Dukakis emanò un proclama che assolveva i due uomini dal crimine, affermando:
«Io dichiaro che ogni stigma e ogni onta vengano per sempre cancellati dai nomi
di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti». Questa dichiarazione non significò però
il riconoscimento dell'innocenza dei due italiani (negli ultimi cento anni,
nessun condannato a morte statunitense è stato riabilitato dopo l'esecuzione).
PRESUNTO COLPEVOLE.
03/05/12. Si conclude “Presunto colpevole”, il
programma di Rai 2 che ha come tema portante la malagiustizia e quegli errori
giudiziari. Nell’ultimo appuntamento, in onda giovedì 3 maggio, alle ore 23.10,
vengono raccontate altre storie. La prima, dal titolo “Morire d’ingiustizia”,
riguarda più personaggi dell’amministrazione comunale dell’Isola d’Elba
(Livorno). Si tratta del giudiziario che prese il nome di “Elbopoli”. Una
vicenda durata anni e che alcuni dei protagonisti non sono riusciti a vedere
conclusa. La seconda storia vede protagonista un maresciallo dei Carabinieri di
Genova, un vero eroe che combatteva i narcotrafficanti. Ma la sua vita è stata
distrutta da un pentito e da chi non ha letto attentamente le carte in cui il
suo nome neanche compariva. Ci ha messo 14 anni per dimostrare la sua innocenza.
Un altro maresciallo è protagonista della terza ed ultima storia del programma.
Questa volta siamo nel nord est. Al centro della storia storie di droga e di
tossici e piccoli spacciatori usati per prendere i pesci più grandi. Il
maresciallo però non c’entra nulla. Ma non ci crede nessuno.
18/04/12. Quinta puntata di “Presunto colpevole”,
che racconta tre nuove storie di errori giudiziari. La prima riguarda Angelo
Cirri. Aveva sulle spalle qualche furto d’auto, per cui aveva già pagato il
conto, ma ciò è bastato per accusarlo di ben quattro rapine. D’altronde Angelo
era il colpevole ideale. Ma non era così. E in carcere ci resta quattro anni da
innocente. Anche Filippo di Benedetto, protagonista della seconda storia non era
un incensurato. Per questo viene accusato di una rapina mai commessa. E si fa 18
mesi in galera pur non avendo commesso il fatto. Giulio Petrilli infine non ha
nulla a che fare con le rapine. Lui si è ritrovato addosso l’accusa di
terrorismo e partecipazione a banda armata.
04/04/12. Quarta puntata per “Presunto colpevole”,
che denuncia altri casi di malagiustizia. La prima storia, dal titolo “Muro di
gomma”, vede protagoniste Anna Maria Manna e Anastasia Montariello, incensurate,
incarcerate con un’accusa infamante: pedofilia. Distrutta una reputazione per il
nulla. Perché le due donne, quei bambini, non li conoscevano nemmeno. La seconda
storia, dal titolo emblematico “Mi hanno rubato i figli”, racconta di Joy
Idugboe: il suo calvario dura oltre due anni. L’accusano di sfruttamento della
prostituzione. Prima cosa, le portano via i figli. Ma lei non c’entra niente e
rischia di morire di dolore. “Identità rubata” è la terza storia. Fabrizio
Bottaro è vittima di un errore, un errore che lo porterà in carcere come
rapinatore. Ma Fabrizio era innocente.
28/03/12. Antonio Francesco Di Nicola è il
protagonista della prima storia dal titolo “Maledetto soprannome”. Antonio
Francesco fa il camionista e ha la "sfortuna" di aver ereditato il soprannome da
suo padre e da suo nonno. Ne nasce un malinteso che lo porterà a viaggiare verso
l’inferno. Resta coinvolto in traffici di droga. Ma lui non c’entrava nulla. La
seconda storia parla della vicenda di Francesco Spanò accusato di associazione a
delinquere di stampo mafioso. Spanò va in galera. Peccato che di vero non ci sia
niente. “L’infamia peggiore” è il titolo della terza incredibile vicenda: Marco
Matteucci viene accusato d’aver abusato della sua bambina. E diventa “il
mostro”. Matteucci non potrà vedere la sua piccola per sette lunghissimi anni.
Chi mai glieli potrà ridare? In studio Fabio Massimo Bonini.
20/03/12. Antonio Francesco Di Nicola è il
protagonista della prima storia dal titolo “Maledetto soprannome”. Antonio
Francesco fa il camionista e ha la "sfortuna" di aver ereditato il soprannome da
suo padre e da suo nonno. Ne nasce un malinteso che lo porterà a viaggiare verso
l’inferno. Resta coinvolto in traffici di droga. Ma lui non c’entrava nulla. La
seconda storia parla della vicenda di Francesco Spanò accusato di associazione a
delinquere di stampo mafioso. Spanò va in galera. Peccato che di vero non ci sia
niente. “L’infamia peggiore” è il titolo della terza incredibile vicenda: Marco
Matteucci viene accusato d’aver abusato della sua bambina. E diventa “il
mostro”. Matteucci non potrà vedere la sua piccola per sette lunghissimi anni.
Chi mai glieli potrà ridare? In studio Fabio Massimo Bonini.
14/03/12. La drammatica storia di Giuseppe
Gulotta. Il suo calvario è durato ben 36 anni, di cui 21 trascorsi tra le mura
di una cella. Arrestato all’età di soli 18 anni e accusato di avere partecipato
alla strage di due carabinieri, massacrati a colpi di pistola, è stato assolto
per non aver commesso il fatto. Oggi, di anni, ne ha 54 ma chi potrà
restituirgli la sua vita? Nella seconda storia il caso di Roberto Giannoni,
impiegato di banca portato via all’alba, in manette, dalla sua casa. Non ci
tornerà più per sei anni. L’accusa, associazione a delinquere di stampo mafioso.
Non era vero nulla. Nella terza storia, invece, è la volta di Maurizio
Lauricella, un’esistenza finita il giorno in cui è stato messo prima agli
arresti domiciliari, poi in carcere, quello duro, all’Ucciardone di Palermo. Che
aveva mai fatto? Niente, assolutamente niente. Ma suo fratello, ogni volta che
veniva arrestato, dava false generalità. Nessuno s’è mai preso la briga di
controllare.
PRESUNTO COLPEVOLE: LA MALAGIUSTIZIA
RACCONTATA SU RAI2, scrive martedì 17 settembre
2013 Marco Leardi su Davide Maggio. Presunto Colpevole. Di “malagiustizia” si
parla (anche) in tv. Parte stasera, alle 23.45, la seconda edizione di “Presunto
colpevole”, il programma di Rai 2 che racconta le vergogne del nostro sistema
giudiziario. Processi infiniti, facili archiviazioni e casi in cui la certezza
della pena ha trovato una dubbia applicazione: il format, condotto in studio
da Fabio Massimo Bonini, si soffermerà su alcune storie diventate tragicamente
emblematiche. Un’occasione per riflettere su un tema quantomai attuale.
Presunto Colpevole – Il caso di Anna Paglialonga.
Nella prima puntata, in particolare, verrà affrontata la vicenda di Anna
Paglialonga, una donna di 48 anni, che vive a Capua e che lavora al Sert. Il 21
aprile del 2008 Anna è stata arrestata con un’accusa infamante: aver aiutato un
camorrista a uscire di galera. Gli uomini della procura di Caserta hanno
eseguito 23 ordinanze di custodia cautelare verso alcuni componenti del clan
Belforte. Ma perché viene accusata proprio Anna? Un collaboratore di giustizia
afferma: “il documento l’ha fatto firmare una certa Annarella” un nomignolo. Al
Sert di Capua, però, ci sono almeno altre quattro persone che si chiamano Anna,
ma la giustizia prende Anna Paglialonga, la quale quel giorno Anna non era
neppure in Italia. In carcere la donna trova solidarietà e amicizia. Il suo
compagno Enzo De Camillis, ha deciso di raccontare la storia in un documentario
per dimostrare che Anna è estranea ai fatti. Il 9 maggio 2008, Anna finalmente
può abbracciare di nuovo Enzo e sua figlia, ma prima di avere la sentenza di
assoluzione definiva devono passare quattro anni.
PRESUNTA COLPEVOLE. ANNA PAGLIALONGA.
“Scambiata per camorrista, la mia vita
distrutta”, la storia di Anna diventa una fiction. La
storia assurda di Anna Paglialonga, irreprensibile dipendente dell’Asl,
scambiata per una collusa con il mondo della camorra. Un calvario durato cinque
anni e che adesso è pronto a diventare una fiction con Luisa Ranieri
protagonista, scrive il 17 settembre 2013 Gennaro Marco Duello su Fanpage.
Questa è la storia assurda di Anna Paglialonga, dipendente amministrativa di 51
anni scambiata per una camorrista del clan Belforte. Una storia che è culminata
con l'arresto, nell'ambito di una maxi operazione della Polizia di Stato,
coordinata dalla Dda di Napoli, di 23 persone, tutte accusate a vario titolo di
associazione per delinquere di stampo mafioso. Anna lavorava al Sert, il
Servizio per le tossicodipendenze dell'Asl, e fu accusata di aver favorito
elementi di spicco del clan Belforte, tramite permessi falsi e certificazioni
che avrebbero fatto godere loro di permessi speciali, evadendo dal regime
detentivo. Un calvario giudiziario durato diciannove giorni di reclusione, con
un processo terminato con l'assoluzione definitiva soltanto dopo cinque anni.
Tutto cominciò il 21 aprile del 2009, quando la donna fu arrestata e condotta
presso il carcere femminile di Pozzuoli. In un solo istante mi è crollato il
mondo addosso. Non riuscivo a realizzare cosa stesse accadendo. Mi sono
ritrovata in una cella, in compagnia di sette detenute, che mi chiedevano,
incuriosite, il motivo del mio arresto. Ero spaventatissima. Le mie compagne di
cella hanno subito cercato di rincuorarmi e, comprendendo il mio disagio, mi
hanno invogliato a reagire. Non volevo né bere né mangiare, ero distrutta. La
storia di Anna Paglialunga diventerà una fiction, "Diciannove giorni di massima
sicurezza", dove il ruolo da protagonista sarà interpretato da Luisa Ranieri,
mentre questa sera su Rai 2, a partire dalle 23.45, si parlerà proprio del suo
caso nella trasmissione "Presunto Colpevole". Da questa storia è in fase di
pre-produzione, "Colpevole d'innocenza", un film che sarà firmato da Enzo de
Camillis e che prevede la partecipazione di Giancarlo Giannini.
PRESUNTO COLPEVOLE. OSCAR SANCHEZ.
Presunto Colpevole – il caso di Oscar Sanchez. La
seconda storia, invece, riguarda lo spagnolo Oscar Sanchez, che per un atto di
gentilezza è finito nei guai. A causa di una perizia sbagliata e di indagini
fatte in fretta, l’uomo è stato portato in Italia. Attraverso immagini,
testimonianze e ricostruzioni, Presunto colpevole ricostruirà le vicende di
malagiustizia, provando a restituire – per quanto possibile – la dignità a chi è
stata negata. L’appuntamento è alle 23.45 su Rai2.
L'inferno di uno spagnolo innocente liberato dopo
2 anni a Poggioreale. La stampa iberica dà risalto alla vicenda e sottolinea
come il cittadino iberico sia stato accusato per errore di essere il capo di un
giro di narcotrafficanti. Determinante, per ribaltare il caso, una ostinata
inchiesta giornalistica di El Periodico, scrive Giovanni Marino su La Repubblica
il 22 marzo 2012. Oscar Sanchez è piccolo e decisamente poco avvenente. Fa il
"lavacoches", il lavamacchine, insomma. E da qualche ora è felicissimo di poter
riprendere il suo modesto lavoro, la sua vita senza sfarzi, con qualche
normalissimo stento, ordinaria e in bianco e nero.
IL MOMENTO DELLA SCARCERAZIONE. Felice come può
esserlo un uomo che ha attraversato l'inferno rischiando di non uscirne più.
Oscar è stato rinchiuso dentro una affollata cella del carcere napoletano di
Poggioreale per circa due interminabili anni. Detenuto ma innocente. Considerato
dalla giustizia spagnola prima e da quella italiana poi, un narcotrafficante. Un
errore giudiziario. Non era lui. Ma un boss sudamericano che gli aveva rubato
l'identità e, di fatto, anche la vita.
LA CAMPAGNA A FAVORE DI OSCAR. Estradato dalla
Spagna all'Italia, Oscar ha visto chiudersi alle sua spalle la porta della
libertà il 18 maggio del 2010. Condannato a 14 anni. Roba da narcos. Lui,
catalano di Montgat, lontano anni luce da qualsiasi trama mafiosa. E sarebbe
finita lì perché Oscar non sa nulla di avvocati e carte bollate. E di soldi per
pagarsi un principe del foro non ne ha. Ma in suo soccorso è arrivato il buon
giornalismo, quello fatto di pignoleria, costanza, voglia di andare sino in
fondo e di alzarsi spesso e volentieri dalla sedia dell'ufficio e dal monitor di
un computer. E' ciò che hanno fatto i colleghi di El Periodico, riuscendo a
ribaltare una finta verità sino alla scarcerazione, alla libertà e alla
riconosciuta innocenza di questo cittadino spagnolo di 46 anni. Senza la
pervicacia e la capacità dei giornalisti di El Periodico Sanchez, che pure si
era sempre inutilmente dichiarato innocente, sarebbe marcito in cella. A poco
erano valse anche le dichiarazioni dei suoi datori di lavoro di Montgat, non
distante da Barcellona, che avevano spiegato come Oscar non si fosse mosso da lì
quando, secondo gli inquirenti, si sarebbe invece spostato a Roma per coordinare
i traffici del gruppo tra Spagna e Italia, un nucleo collegato alla camorra.
Finalmente, adesso, prevale la verità: l'identità di Sanchez era stata usurpata
da un capoclan uruguayano, Marcelo Roberto Marin, 42 anni, che aveva usato una
carta di identità rubata a Oscar per registrarsi in un albergo romano. E che,
beffa del destino, proprio come il catalano, in una prima perizia è risultato
soffrire di disfemia, che poi sarebbe balbuzie. Cosa che ha inizialmente tratto
in inganno e contribuito allo scambio di persona. In realtà non era e non è
così: Oscar non capisce un accidenti di italiano e quindi in quei frangenti
sembrava avere disturbi nel linguaggio. Una nuova perizia fonica ordinata dalla
magistratura italiana ha infine confermato l'errore di persona e ora Sanchez è
stato prosciolto con formula piena e messo in libertà. Ma dietro quest'ultimo
esame tecnico fondamentale ci sono ancora i colleghi di El Periodico che sono
andati a scovare il padrino uruguayano recluso in un carcere delle Canarie e
hanno messo a confronto la sua voce con quella del povero Oscar. Timbri,
tonalità, inflessioni, totalmente differenti. Il lavacoches di Montgat è libero.
E al giornale catalano ha affidato il suo sofferto racconto della detenzione.
Pestato dai colleghi di cella. Sfregiato con una "N" di Napoli su una spalla per
punirlo delle sue simpatie calcistiche interiste e juventine. Sbeffeggiato
perchè non conosce la nostra lingua. Umiliato. Un inferno. Da dimenticare in
fretta pensando che, nonostante tutto, alla fine la verità vince sempre. Anche
due anni dopo.
Scoprì un caso di malagiustizia a Napoli
premio internazionale per giornale spagnolo. Con un
gruppo di cronisti (tra cui un italiano) svelarono un errore che ha tenuto
ingiustamente in carcere un lavavetri. Uscito dopo due anni da Poggioreale
grazie alla loro inchiesta, scrive Giovanni Marino il 24 gennaio 2013 su "La
Repubblica". E' andato al Periodico de Catalunya, con la sua squadra di reporter
formata da Antonio Baquero, l'italiano Michele Catanzaro e Angela Biesot, il
prestigioso "Premio internazionale di giornalismo Re di Spagna".
LA STORIA/L'inferno di uno spagnolo innocente. Il
riconoscimento si deve alla pervicace, approndita e lunga indagine giornalistica
che ha letteralmente tirato fuori dal carcere un innocente lavavetri: Oscar
Sanchez. Dopo due anni di cella, tutti trascorsi a Poggioreale. Il cittadino
ibeico era stato accusato per errore di essere il capo di un gruppo di
pericolosi narcotrafficanti. Ma i reporter hanno messo in luce quanto tutto ciò
fosse assolutamente destituito di ogni fondamento. E Oscar il lavavetri è
tornato in libertà. Nella motivazione del premio attribuito al giornale si legge
tra l'altro: "L'ostinato lavoro di questi cronisti ha dimostrato che la ricerca
della verità e per le indagini condotte in prima persona con rigore e tempo da
dedicarvi sono l'essenza del buon giornalismo". Come non essere d'accordo?
Complimenti a giornale e giornalisti premiati.
PRESUNTO COLPEVOLE. FABRIZIO BOTTARO.
Assolto lo stilista in carcere per
errore. L'avvocato: "Classico furto d'identità". Dopo
dieci mesi è finito il calvario di Fabrizio Bottaro, designer di moda romano,
arrestato per una rapina mai commessa. La persona offesa, titolare di una
società di recupero di automobili, si sarebbe inventato tutto, scrive La
Repubblica il 15 luglio 2011. E' durato dieci mesi il calvario di Fabrizo
Bottaro, 40 anni, designer di moda romano, detenuto in carcere per una rapina
che non ha mai commesso. "Un classico caso di furto d'identità", sostiene il suo
avvocato, Fabrizio Merluzzi. I giudici della VI sezione penale hanno fatto
decadere le accuse nei suoi confronti e trasmesso gli atti alla Procura affinché
proceda nei confronti del soggetto che lo aveva denunciato. Al collegio del
tribunale sono bastate poche udienze per capire che che L. N. (titolare di una
società di recupero di autovetture), presente nel processo come persona offesa,
ha riferito agli agenti del commissariato Viminale una versione completamente
falsa dei fatti e assolutamente priva di riscontro. Secondo il decreto di
giudizio immediato, Bottaro il 22 luglio dello scorso anno, insieme con un'altra
persona, si era fatto consegnare da un terzo un'auto minacciandolo con la frase:
"scendi dalla macchina o ti faccio saltare la testa". La vicenda è legata,
probabilmente, a un tentativo di frode ai danni della società assicurativa in
relazione alla sparizione del veicolo. "Alla luce di quanto emerso si ipotizza
- scrivono i giudici - che lo stesso L. N. possa aver ideato una falsa
rapina". Inoltre la Polstrada di Trieste, impegnata in indagini sul riciclaggio
di autovetture all'estero, ha accertato che l'auto in questione, una Bentley,
era stata a suo tempo sottoposta a fermo amministrativo ed era a rischio di
confisca. Secondo gli agenti, probabilmente, il 22 luglio del 2010 quella
berlina extralusso era da tempo sparita oltrefrontiera. Dal canto suo, Bottaro è
stato completamente scagionato perché il fatto non sussiste, ma la vicenda non
finisce sicuramente qui. "Per un anno - spiega il difensore dello stilista -
il mio assistito è stato messo fuori dal mondo. In più, quando è finito a Regina
Coeli, gli è stato impedito di incontrare il suo difensore. Le carte dicono che
tra Bottaro e L. N. non c'è stata neppure una telefonata. Non solo, ma non c'era
nemmeno un solo elemento che potesse giustificare la celebrazione di un
processo. Chi avrebbe dovuto valutare con attenzione questa situazione, non lo
ha fatto per niente".
PRESUNTO COLPEVOLE. ANGELO CIRRI.
Tre anni e quattro mesi in carcere: era
innocente. La toccante storia di Angelo Cirri,
condannato a otto anni e liberato solo dopo il casuale ritrovamento della
refurtiva a casa del vero rapinatore. Lo Stato gli pagherà quasi 400 mila euro:
"Rivoglio la mia vita, non i soldi", scrive Annalisa Chirico il 13 gennaio 2014
su "Panorama". "Rivorrei la mia vita, non il risarcimento". Invece riavrà, con i
tempi lenti dello Stato italiano, soltanto il secondo. Nessuno potrà
restituirgli i tre anni, quattro mesi e ventinove giorni trascorsi dietro le
sbarre di Regina Coeli e di Rebibbia. Il protagonista di una storia che rievoca,
senza la finzione cinematografica ma con la disperante crudezza della realtà,
l’Alberto Sordi nei panni del ‘Detenuto in attesa di giudizio’, si chiama Angelo
Cirri. Oggi ha quarantasei anni, cinque figli e una moglie che lo ha aspettato
senza mai dubitare della sua innocenza. "Quella sera io ero con lei a casa come
tutte le sere. Ma la sua testimonianza valeva zero". Tutto comincia il 9 aprile
2004, quando Cirri, poco prima di mezzanotte, viene raggiunto nel suo casale
romano. Sente il cane che abbaia, esce fuori e trova i carabinieri armati: "Mi
hanno messo in macchina e mi hanno portato via". Arriva a stretto giro il primo
riconoscimento: una donna, che è stata rapinata quella stessa sera davanti alla
sua porta di casa, identifica in lui il responsabile del furto. Cirri, che è
ancora incensurato, viene arrestato. Nell’ordinanza di custodia cautelare il gip
rinviene il pericolo di reiterazione del reato. Nei mesi successivi a quella
denunciante si aggiungono altre dodici persone offese per un totale di otto
rapine. "Ancora oggi mi chiedo come si possa puntare il dito contro una persona,
accusarla di un reato così grave senza esserne davvero sicuri", commenta l’uomo
che, da innocente, si ritrova ad essere il colpevole per forza. Il 25 giugno
2004 arriva l’incidente probatorio, e di quelle otto rapine gliene vengono
addebitate quattro. L’avvocato Marco Cinquegranagli prospetta la possibilità di
chiedere un patteggiamento o un rito abbreviato. Cirri rifiuta: "Io sapevo di
non aver commesso alcun reato. Volevo il processo". Il processo viene celebrato,
tre udienze in tutto. Il tempo di sentire le persone rapinate, tutte colpite in
modo particolarmente violento, con insulti, calci e percosse. Il difensore
chiede di acquisire i tabulati telefonici dei cellulari rubati in modo da
verificare se fossero eventualmente riconducibili alla disponibilità di Cirri.
Il pm è d’accordo, il giudice respinge. Il 20 ottobre 2005 la quinta sezione
collegiale del tribunale di Roma, presieduta da Mario Bresciano, lo condanna, al
di là di ogni ragionevole dubbio, a tredici anni di carcere. Per Cirri è un
colpo durissimo e inatteso. Tenta il suicidio: prima con i lacci di scarpa, poi
con il taglierino dei barattoli di pelati. Se lo ficca nello stomaco. Lo
ossessiona l’idea che non potrà più rivedere più la sua famiglia. Ha lasciato la
moglie che era incinta, ormai ha partorito. Ma lui è in cella. Il 6 novembre
2006 arriva la sentenza d’appello, gli anni di carcere si riducono a otto. "Le
risultanze processuali – si legge nel dispositivo emesso dalla Corte d’appello
di Roma – confortano il giudizio di responsabilità cui è pervenuto il tribunale.
I riconoscimenti dell’imputato da parte delle persone offese paiono
intrinsecamente attendibili e risultano peraltro avvalorati da numerosi
ulteriori elementi indiziari". Eppure alcune vittime dicono di aver notato un
accento dialettale campano, Cirri parla romanesco doc. Sul luogo del primo furto
viene rinvenuto un mozzicone Sax; nella casa di Cirri, dove non vengono trovate
né l’arma né la refurtiva, c’è un pacchetto di sigarette dello stesso marchio.
Dall’esame del dna si evince che non si tratta della stessa persona. Intanto
sono decorsi i termini di custodia cautelare, Cirri viene liberato ma dopo la
condanna in appello, su consiglio dell’avvocato, si costituisce nuovamente. E’
il 16 gennaio 2008, rimarrà in carcere fino al 28 ottobre di quell’anno. La
svolta avviene agli inizi di ottobre quando un compagno galeotto gli urla:
"Angelo, accendi la tv su RaiTre". Il telegiornale riporta l’arresto di
Antonio de Pasquale, nel cui appartamento hanno ritrovato un’arma e la refurtiva
degli stessi delitti addebitati, da oltre quattro anni, a Cirri. De Pasquale,
che attualmente sconta un ergastolo per omicidio, confesserà di essere stato lui
l’autore dei furti. "La cosa bella è che da quel giorno ne sono passati non so
quanti altri, interminabilmente. Leggevo sui giornali che quell’uomo era il
responsabile e che l’accusato era stato scarcerato. Invece mi hanno liberato
soltanto il 28 ottobre". Quando esce dalla prigione, Cirri cade per terra. "Ho
sentito l’aria. Mi si sono piegate le gambe. Non mi sembrava vero". Invece era
vero. Ora lo Stato gli deve 399mila euro a titolo di riparazione per errore
giudizio, secondo quanto stabilito dalla Corte d’appello di Perugia nell’ottobre
2013. "Rivorrei la mia vita, non il risarcimento".
PRESUNTA COLPEVOLE. ANASTASIA MONTANARIELLO.
Malagiustizia a Taranto: «La mia vita
valutata 20mila euro». Anastasia Montanariello, 39
anni, di Palagiano, è una vittima: accusata dagli zii per vecchi rancori,
arrestata per pedofilia è stata assolta e risarcita. «Riaffiorano i ricordi di
quei mesi nell'inferno e le discriminazioni sul lavoro. Ci sono voluti cinque
anni perchè la verità venisse fuori», scrive il 9 Febbraio 2009 Giacomo Rizzo su
La Gazzetta del Mezzogiorno. «La mia vita è stata valutata 20.000 euro».
Arrestata, condotta in carcere, denigrata, offesa e guardata con sospetto. L’at
ro c e sospetto: quella donna è pedofila. Ma era tutto falso. Falso, come le
dichiarazioni di alcuni zii, che la accusavano solo per sfogare vecchi rancori.
Falso, come il moralismo della gente, che giudica senza sapere. Assurdo, come lo
Stato ripaghi un errore che ti rovina l’esistenza. Un errore che diventa una
pistola puntata alla tempia. Un incubo che ti toglie il fiato. E, ogni giorno,
cerchi di lavare la vergogna per un orrore che non hai commesso. Anastasia
Montanariello, 39 anni, di Palagiano, è una delle vittime della malagiustizia.
Il suo calvario è durato sette anni. Fu arrestata il 25 maggio del 2000
nell’ambito del blitz denominato “Giglio” con accuse terribili: atti sessuali
con minori e corruzione di minori. Prima il carcere, la foto sui giornali,
l’umiliazione, una famiglia che fa scudo ma teme lo sguardo da santa
inquisizione di un paese sbigottito. Poi gli arresti domiciliari, la libertà per
l’assenza di esigenze cautelari, il processo, i testimoni, l’assoluzione
piena. La sentenza è passa in giudicato ed è arrivata la causa per l’ingiusta
detenzione. Lo Stato ha monetizzato anche la sofferenza: 20.000 euro. Tanto vale
la privazione della libertà personale. Ma, a distanza di due anni, Anastasia
Montanariello - assistita nel procedimento giudiziario dall’ avv. Rosario
Orlando - non ha ancora incassato nemmeno un centesimo. «Prima ti distruggono,
poi ti danno l’obolo - dichiara alla “Gazzetta” -. E io non riesco ad avere
neanche quello. E’ saltata fuori una sorta di imposta che non è stata pagata,
nel senso che il 50% spetterebbe alla cancelleria, e il restante 50%, non è uno
scherzo, nessuno sa veramente a carico di chi sia. Così il risarcimento è ancora
bloccato. Ho solo una strada, pagare io la tassa: 400 euro». Chi l’ha
accusata? «Fu solo la falsa testimonianza dei miei zii a dare inizio all'incubo,
spinti da un rancore familiare che ha radici profonde». Era stata riconosciuta
anche da uno dei bambini che avrebbero subito le violenze? «I bambini hanno
visionato decine di foto. Era logico che potessero sbagliare. Le riporto uno
stralcio della sentenza: “esiste il ragionevole dubbio che alle feste a luci
rosse partecipasse una ragazza somigliante all'imputata, e tale dubbio non è
stato rimosso a causa della mancanza di riscontri esterni». Riesce a non pensare
a quello che le è accaduto? «Quando si parla di errori giudiziari o di episodi
di violenza ai danni di bambini la ferita si riapre, inevitabilmente.
Riaffiorano i ricordi di quei mesi nell'inferno degli arresti, le
discriminazioni sul lavoro. Ci sono voluti cinque anni perchè la verità venisse
fuori, una verità parziale però, perchè nonostante si sappiano i nomi delle
persone che mi hanno coinvolta in questa mostruosità, non so ancora oggi se
arriverà il processo anche per loro».
PRESUNTO COLPEVOLE. ANTONIO FRANCESCO DI
NICOLA.
In carcere da innocente, risarcito.
Camionista fermato per un soprannome sbagliato nelle intercettazioni,
scrive Pietro Guida su Il Centro il 24 luglio 2011. Sette mesi di galera da
innocente. Lo Stato lo risarcisce con cinquantamila euro, ma il segno della
sofferenza del carcere rimane come un marchio a fuoco. «Solo la fede, la
devozione per Santa Maria Goretti e il sostegno di mia figlia mi hanno permesso
di andare avanti. Non porto rancore per la giustizia, ma per i modi della
giustizia». A parlare è Antonio Francesco Di Nicola, autotrasportatore di San
Benedetto dei Marsi, finito in cella a causa delle intercettazioni tra altre
persone che lo chiamavano in causa, ma con un soprannome che non era il suo,
bensì di un altro. Nelle telefonate si parlava di un certo Francesco detto
Broccolone e si sosteneva che aveva trasportato dalla Spagna 22 chili di droga
nel periodo dal 30 maggio al 3 giugno 2005. Ma il soprannome di Di Nicola è
Cozzolino e in quel periodo si trovava da tutt'altra parte. Lui è stato
arrestato per traffico internazionale di droga. L'ultimo capitolo della
drammatica storia del camionista marsicano, difeso dagli avvocati Roberto
Verdecchia e Sara Capoccetti, è stata scritto dalla Corte d'Appello di Roma.
All'uomo è stata riconosciuta una somma di 50mila euro di risarcimento per
ingiusta detenzione. «Quella mattina stavo rientrando da un viaggio nello
stabilimento dove lavoro», racconta Di Nicola, «avevo appena salutato i cani da
guardia quando entrò un'Alfa 156 con due persone a bordo. La dobbiamo arrestare,
faccia allontanare i cani: mi hanno detto. Sono andato a casa e dissero a mia
moglie che dovevano portarmi all'Aquila. Un dramma. Inizialmente ho ottenuto i
domiciliari. Ma pochi giorni dopo, il 12 dicembre 2007, mi hanno prelevato
intorno alle 9.30 sostenendo che dovevo essere ancora interrogato. Da allora a
casa non sono più tornato». Nel carcere dell'Aquila è cominciata la sua odissea.
«Ho perso 25 chili» racconta Di Nicola. «Un giorno», ricorda, «mi hanno messo in
cella con un ragazzo di Celano. Dopo quattro mesi ho iniziato a fare il cuoco
del carcere. Una volta mi sono imbattuto anche in Sandokan, Francesco Schiavone,
uno dei capi del clan dei Casalesi. La mia famiglia mi ha sempre difeso». «Ma in
molti ci hanno voltato le spalle», interviene la figlia Domenica, che si è
occupata di tutte le questioni burocratiche riguardanti la vicenda, «e non è
stato facile». Lei porta sul braccio un tatuaggio con una frase di Jovanotti: «A
te che sei la sostanza dei giorni miei». La stessa scritta se l'è fatta tatuare
anche il padre. Il 5 luglio la svolta. «Ero sulla brandina della cella e davanti
agli occhi ho immaginato la figura di Santa Maria Goretti che avevo tanto
supplicato. Ho sempre avuto fede. Dopo due giorni sono arrivati quattro agenti
penitenziari e mi hanno detto che ero libero, non ai domiciliari, proprio
libero. Mi sono sentito male». Poi la parola fine al caso giudiziario. «Quando
abbiamo vinto il processo per ingiusta detenzione mi sono tornati in mente i
giorni di sofferenza in carcere», afferma Di Nicola, «oggi sento solo la
necessità di dire grazie al mio avvocato e a mia figlia. Anche lei e l'altro mio
figlio possono tornare a camminare a testa alta e dimenticare tutta questa
storia. Nessuno mi ridarà sette mesi di libertà».
PRESUNTO COLPEVOLE. CARMINE FORCELLA.
La storia: il carabiniere che non si
lasciò fregare, scrive Marco Guggiari il 20 novembre 2012 su "Il Corriere di
Como". Carmine Forcella era troppo scomodo per i
criminali. Mafia e ’ndrangheta tentarono di incastrarlo. Carmine Forcella è un
gigante buono. Oggi si fatica a immaginarlo con la divisa dell’Arma che ha
vestito per oltre trent’anni. L’ha onorata con straordinaria operatività e con
grande fiuto investigativo. Un giorno i pentiti di ’ndrangheta e di mafia hanno
deciso che doveva pagarla. Hanno tentato di incastrarlo e per lui è iniziata la
battaglia più dura. Vinta. Ma il prezzo è stato alto. Ne parliamo in lungo e in
largo. Sul tavolo c’è il libro che ha scritto: “Io non ho paura”, nel quale
racconta tutta intera la sua vicenda. Ma su date e fatti, questo è
impressionante, non ha bisogno di aprire una sola pagina. Sono tutti impressi a
fuoco nella mente. Una qualità che ha contribuito a salvarlo. Quando il piccolo
Carmine nacque, ultimo di undici figli, a Collotti, minuscola frazione di Atri,
in provincia di Teramo, la levatrice arrivò sulla biga trainata da un cavallo.
Era il 1946 e i tedeschi se n’erano appena andati. Quel bambino giocava con il
coperchio di una gavetta militare abbandonata e faceva il contadino. A
diciassette anni la svolta, il viaggio a Roma con una valigia di cartone per
diventare carabiniere. Dopo il corso fu assegnato a Piadena, nel Cremonese.
«Arrivai la sera del 29 settembre 1965 con il treno mosso ancora da una
locomotiva a vapore. La nebbia si tagliava a fette». Il resto erano nugoli di
zanzare. La stazione dell’Arma era composta da due carabinieri, uno dei quali
era lui, più il comandante. Lì Forcella conobbe la futura moglie, Aurora,
un’insegnante. «Mi aiutò molto nella preparazione al corso sottufficiali. La mia
base culturale era scarsa. Il primo tema che Aurora mi diede da fare era un
commento al film “Il posto delle fragole”. Quando lo lesse, riempì il foglio di
segnacci rossi e blu… Ciononostante mi impegnai per classificarmi tra i primi
cinquanta e arrivai 15°». Un traguardo importante era tagliato. Dopo un breve
periodo come istruttore a Firenze, arrivò la destinazione di Milano. Il 20
maggio 1972 Carmine capitò per la prima volta a Como: «Era una giornata
splendida. Dissi in cuor mio: “Da qui non mi muovo più”». Una settimana più
tardi prendeva servizio nel nucleo radiomobile del capoluogo lariano. Una rapina
all’ufficio postale di Bregnano seguita dall’intuizione di Forcella che un
informatore avesse la pista giusta per l’ottimo maresciallo Luciano Arrigucci
gli valse ben presto il passaggio al nucleo investigativo. Tante le azioni sul
campo, assieme ad altri colleghi bravi come Severino Traglia e Mario De Luca.
Tra queste, in occasione di un’altra rapina, la cattura di un bandito armato di
pistola con un gran cazzotto che gli costò anche la frattura di una mano. «Erano
gli anni della crisi energetica petrolifera. Finiva il contrabbando classico con
le bricolle – rievoca oggi – Gli spalloni si riciclavano nel traffico di
stupefacenti». Era anche l’epoca dei sequestri di persona: Erika Ratti, Diego
Bruga, Giovanni Stucchi, Cristina Mazzotti? «Andai nel carcere di Parma a
parlare con uno dei rapitori di Stucchi nella speranza che dicesse dov’era il
corpo dello sfortunato industriale. Non lo rivelò perché un “fine pena mai”
garantisce comunque la vita. Non così per chi “canta”». Intanto Carmine Forcella
approdò alla polizia giudiziaria della Procura, dove operò dal 1976 al 1985.
Fece il concorso e divenne maresciallo. La vita stava per riservargli una prima
grande prova: la morte della moglie dopo settanta giorni di malattia. La
figlioletta della coppia, Simona, aveva soltanto quattro anni. Al papà chiese:
«Se troveranno la medicina per la mamma, potrà tornare con noi??». Poi verrà il
trasferimento a Cantù e, in breve, il comando del nucleo operativo radiomobile:
«In otto anni e mezzo il bilancio fu di 750 arresti». Era forte la squadra, era
ottimo il metodo, era bravo Forcella, che diventerà maresciallo maggiore
aiutante, con i gradi rossi. Troppo bravo, alla luce di quanto poi accadde.
Scovò arsenali di armi, arrestò giovani bombaroli, pescò falsari e rapinatori,
smascherò una moglie assassina che parlava al passato del marito che, in teoria,
non doveva sapere morto. Stroncò trafficanti di droga, risolse casi di morti
ammazzati. Fino alla grande mazzata. «Un pentito dei Fiori di San Vito (la
grande operazione anti-’ndrangheta, ndr) – racconta – decise che mi doveva
gambizzare perché a causa mia lui e i suoi non lavoravano più. Cercò il mio
indirizzo di casa e quello della scuola di mia figlia. Arrestato, decise di
gambizzarmi con le parole». Risultato: il 15 giugno 1994, al mattino presto,
Carmine Forcella subì una perquisizione domiciliare e personale. L’accusa era
pesante come un macigno: associazione mafiosa. Si aprì così il precipizio di un
girone infernale. Venne meno la stima di molti. Anche i superiori scaricarono
quel maresciallo prima tanto osannato e delle cui brillanti operazioni contro la
criminalità organizzata si erano avvantaggiati. Più pentiti ora lo accusavano.
Lui ingaggiò la lotta più difficile, durata sei anni, dal 1994 al 2000, quando
venne prosciolto da ogni accusa e l’incubo finì: «Andai in pensione fin dal
1994. Contrastai tutto e tutti. Io non ci stavo a essere sacrificato sull’altare
del pentitismo. Non dubitai quasi mai del risultato finale. Ebbi pace solo
quando trovai giustificazione alle prime dichiarazioni di chi mi accusava:
eliminare chi gli dava fastidio». Oggi Carmine Forcella può andare a testa alta
e si è tolto anche lo sfizio di querelare chi lo aveva calunniato e di scrivere
qualche letterina a chi si era subito liberato di lui, o peggio aveva
contribuito ad accreditarne malefatte inesistenti. «Ho dovuto riconoscere il
diritto di dubitare a chi mi stava di fronte – dice oggi onestamente – Ma ho
anche avuto manifestazioni di solidarietà. Ne cito due. Il pretore Luigi Volpez,
quando ero fresco accusato, mi disse: “Adesso andiamo in piazza a prendere
l’aperitivo”. Non è cosa da tutti. E il maggiore dei carabinieri, Pietro Di
Censo, comandante della compagnia di Cantù, venne a Milano, mi abbracciò e mi
baciò davanti a tutti. Come a dire: “Questa è una persona seria”».
PRESUNTO COLPEVOLE. DINO TRAPPETTI.
Uccise due figli neonati: esce dal
carcere dopo 11 anni. Pontedera: il primo corpicino
venne trovato in una discarica, del secondo non si è mai trovata traccia.
Verusca Montorzi era stata condannata prima all'ergastolo e poi a 16 anni di
carcere ma per l'indulto e la buona condotta ora è fuori e si è stabilita a
Pisa, scrive Sabrina Chiellini il 3 luglio 2014 su Il Tirreno. I vicini la
vedono entrare e uscire di casa, un appartamento a Pisa. Non sanno che dietro
quel volto, dentro quelle mura, c’è un segreto terribile. È una donna molto
riservata, non parla volentieri della sua vita. I capelli lunghi, magra e curata
nell’abbigliamento. Verusca Montorzi, 43 anni, di Pontedera, è tornata libera
dopo undici anni di carcere. Era stata condannata in secondo grado, nel novembre
2006, a sedici anni di reclusione per avere ucciso due bambini appena partoriti.
Il primo di quei due cuccioli d’uomo, almeno, ha un nome e una tomba. Si chiama
Angelo Faustino, venne trovato il 15 febbraio 2001 su un nastro per la
separazione dei rifiuti nella discarica di Pontedera. Quel nome glielo dette la
città, ufficialmente, quando si fermò, commossa, sconvolta, per celebrare il
funerale. Il secondo corpicino non è mai stato trovato: nel 2002, a gennaio,
Verusca andò insieme al compagno Dino Trappetti, geometra oggi cinquantenne,
all’ospedale di Terni. L’operaia aveva i classici sintomi di un’emorragia post
partum ma lei negò l’evidenza. Dall’ospedale i medici, prelevando parti di
placenta, segnalarono il caso alla Procura della Repubblica e le successive
indagini dei carabinieri del comando provinciale di Pisa si conclusero con
l’arresto della madre pontederese, nell’aprile 2003. Attraverso l’esame del Dna
si riuscì a mettere in relazione i due episodi. Prima l’indulto, poi i benefici
previsti dal riconoscimento della buona condotta: i sedici anni della condanna
in appello sono diventati dieci. Verusca, che ha un’altra figlia di 16 anni
avuta in precedenza da Dino, è fuori. Può pensare a ricostruirsi una vita
lontano dal carcere. Ha deciso di non tornare a vivere a Pontedera, dove abita
la figlia data in affidamento a una zia e che può frequentare la madre solo in
presenza degli assistenti sociali, così come stabilito dal tribunale. «Verusca
non è a Pontedera – dice la sorella che ha avuto in affidamento la nipote –
abita a Pisa e di più non posso dire». La casa popolare in cui la coppia
Montorzi-Trappetti viveva, in via Amendola, nel quartiere di Oltrera, è stata
assegnata a un’altra famiglia. E Verusca, che ha lasciato il carcere da poco
tempo, si è stabilita in un’abitazione nella disponibilità di un’altra sorella,
infermiera, a Pisa. Con loro vive una parente, da anni legata alla famiglia
Montorzi. È con quest’ultima quando la raggiungiamo per telefono e la sua
reazione è nervosa. «Sono uscita dal carcere ma non voglio parlare. Fate il
vostro lavoro ma state attenti. Non mi cercate ancora o vi denuncio». In primo
grado di giudizio, in tribunale a Pisa, era stata condannata il 9 maggio 2005
all’ergastolo insieme al convivente, poi assolto al processo in Corte d’Assise
d’Appello a Firenze. Non vuole parlare del suo passato, né dell’esperienza in
carcere. La morte dei due neonati aveva sconvolto Pontedera e travolto due
famiglie, quella della donna e quella del geometra. Secondo la Procura della
Repubblica di Pisa la donna si sbarazzava dei bambini praticando una aberrante
forma di controllo delle nascite. Non ricorreva all’aborto, negava anche a se
stessa le gravidanze, per poi togliere la vita alle creature inermi. Dopo
l’arresto di Verusca e quello del convivente l’altra figlia minorenne è stata
seguita da uno psicologo e dai servizi sociali. Non è stato semplice raccontarle
la verità. Il padre era rimasto in carcere per due anni, nove mese e sette
giorni accusato, messo sotto accusa per un reato gravissimo. Il più terribile
per un genitore. Ma si è sempre dichiarato innocente e ha sempre sostenuto di
non essersi accorto delle gravidanze: cosa che era accaduta anche al datore di
lavoro di Verusca. Quando Dino Trappetti, una volta assolto, ha potuto lasciare
il carcere di Sollicciano il rapporto con la figlia nata dalla relazione con
l’operaia pontederese era ormai compromesso. Ancora oggi i due non si
frequentano. Forse quando diventerà maggiorenne la giovane sceglierà se cercare
di nuovo il padre o se rimuovere tutto. Fatta eccezione per la sua
partecipazione a una sfilata di moda dopo un corso di formazione che aveva
seguito in carcere, Verusca, aiutata dalla famiglia, ha alzato un muro intorno a
sé. Molti non sanno. Altri hanno rimosso. L’operaia nel corso degli anni ha
interrotto anche i rapporti con i due avvocati che l’avevano difesa ai processi.
Tanto che era lei stessa, come altri detenuti, a inoltrare al giudice di
sorveglianza le richieste per essere ammessa ai benefici previsti per ogni sei
mesi di pena trascorsi in cella sulla detenzione rimanente. Uscita dal carcere,
ha subito cercato un contatto sia con l’ex convivente che con la prima figlia
che l’uomo aveva avuto da un’altra relazione, Sara. A quest’ultima si è
presentata con un nome di fantasia e poi le ha svelato la sua vera identità
ottenendo però una risposta fredda. «Non so se ci sia stata una vera
rieducazione – si sfoga Sara – e se Verusca abbia scontato la pena con se
stessa. Ii toni usati con me e le modalità con cui mi ha contattato mi portano
ad avere qualche dubbio. Come ho detto anche a lei, non porto rancore e credo
che tutti meritino una seconda possibilità. Ma credo anche che lei debba stare
lontano da noi».
LE TAPPE DELLA VICENDA. Un delitto atroce. Il 15
febbraio 2001 il cadavere di un neonato viene trovato tra i rifiuti
nell'impianto Geofor a Gello di Pontedera, lungo il nastro trasportatore. È
morto da ore, stritolato dalla macchina che compatta l'immondizia. Per Pontedera
il lutto è immenso, il 21 febbraio al funerale del “bambino solo” partecipa
tutta la città; gli viene imposto il nome postumo di Angelo Faustino (san
Faustino è il patrono, e si festeggia proprio il 15 febbraio). La salma viene
sepolta nel cimitero comunale dove da allora è curata con grande affetto da
molte donne. Il secondo bambino. Un secondo corpicino, nato e ucciso pochi mesi
dopo, non è mai stato ritrovato; ma, in qualche modo, la sua morte ha permesso
una svolta nelle indagini. L’indagine. A portare gli inquirenti sulla strada
della madre killer è proprio il secondo episodio avvenuto, alla fine del
dicembre 2001, all'ospedale di Terni. Qui una donna arriva con una emorragia
post partum. Il bambino però non c'è; e dall'ospedale parte una denuncia per
abbandono di minore nei confronti della donna. Anche questo neonato, il cadavere
del quale non è mai stato trovato, potrebbe essere morto a Pontedera.
Dell'uccisione dei due bambini venne accusata in un primo momento soltanto la
madre, Verusca Montorzi, operaia, che oggi ha 42 anni. Viene arrestata nella sua
casa di Pontedera, il mattino del 14 aprile 2003. Poi l'attenzione degli
inquirenti si sposta sul compagno della donna, padre dei bambini, Dino
Trappetti, geometra di Terni. Si è sempre proclamato innocente e all’oscuro di
tutto; anche delle gravidanze. I round giudiziari. Entrambi gli imputati vengono
condannati in primo grado - in tribunale a Pisa - alla pena dell'ergastolo.
L'uomo è poi assolto in secondo grado. Per la donna la pena è stata ridotta a
sedici anni di reclusione.
PRESUNTO COLPEVOLE. SANDRO VECCHIARELLI.
Altri casi di malagiustizia al centro del
programma di Rai 2, scrive il 20/03/2012 Famiglia
Cristiana. Nuovi casi di malagiustizia sotto i riflettori di “Presunto
colpevole”, in onda stasera alle 23.40 su Rai 2. La prima storia ha come
protagonista Dino Trappetti, geometra di Terni, in un attimo diventato “il
mostro di Firenze”. Due anni, nove mesi e sette giorni. Tanto è rimasto in
carcere Trappetti dopo essere stato condannato all’ergastolo, accusato di avere
ucciso, insieme alla convivente, operaia di Pontedera, i due neonati. Ma, come
poi verrà stabilito dopo indagini accurate, i bambini erano stati uccisi solo
dalla loro madre dopo il parto. Trappetti era all’oscuro di tutto, perfino delle
gravidanze. “La ragazza del lago” è il titolo del secondo caso. Sandro
Vecchiarelli fu accusato della morte di Chiara Bariffi, la 32enne di Bellano
trovata in fondo al lago di Como, tre anni dopo la sua scomparsa avvenuta
all’alba del primo dicembre 2002. A indicare il punto esatto dove cercare
Chiara, fu una sensitiva. 583 giorni durerà il calvario giudiziario di
Vecchiarelli che risulterà innocente. La vicenda di Gennaro Scarciello chiude la
seconda puntata del programma. Accusato ingiustamente di associazione a
delinquere di stampo mafioso e riciclaggio di denaro sporco, dopo sei anni di
odissea, è stato assolto. “Mi sono separato da mia moglie, ho perso la stima e
l’affetto dei miei figli e, dopo tre anni di cure psichiatriche, disperato, ho
tentato anche il suicidio”.
Omicidio Bariffi: ecco la verità. Nuovi
elementi e intercettazioni. La sensitiva era stata minacciata,
scrive il 22 aprile 2008 Stefano Cassinelli su Il Giorno. Arresti inattesi
quelli di Sandro Vecchiarelli e Massimo Barili accusati da anni dell’omicidio
volontario di Chiara Bariffi scomparsa nel 2002. Oggi pomeriggio i due saranno
sottoposti a interrogatorio di convalida nel carcere di Monza dove sono stati
condotti dopo l’arresto avvenuto sabato mattina all’alba. I carabinieri hanno
spiegato che all’arresto si è giunti attraverso le indagini, gli esiti delle
perizie tecniche e quelli dell’autopsia. Resta il fatto che gli inquirenti erano
in possesso di questi riscontri, unitamente ad alcune testimonianze, già da
tempo. Allora come si spiegano questi arresti, quali elementi nuovi possono
essere giunti nelle mani del pm Luca Masini per chiedere e ottenere l’arresto?
UNA CIRCOSTANZA temporale è importantissima in
questo frangente: la morte di Francesco Bariffi padre di Chiara che lottava per
arrivare alla verità da anni. Francesco Bariffi è deceduto, dopo essere stato
investito da un’auto, nel febbraio scorso. Dopo circa due mesi da quella morte
scattano gli arresti. Una delle possibili novità nell’inchiesta potrebbero
essere arrivate proprio da intercettazioni telefoniche recenti in cui i due
indagati si sarebbero lasciati andare dopo anni di estrema prudenza. Ma già
quando Francesco Bariffi era ricoverato in ospedale a Lecco l’avvocato Mario
Bonati aveva incontrato il pubblico ministero Luca Masini come spiega Luciana
Bariffi, madre di Chiara: «Il pm aveva detto al nostro avvocato che presto ci
sarebbero state delle importanti novità che avevano nuovi elementi. Purtroppo
però mio marito non ha potuto vedere quello che è accaduto». Restano tanti punti
oscuri in questa drammatica vicenda, tra questi il ruolo svolto dalla sensitiva
bresciana Maria Rosa Busi. I carabinieri voglio capire come la sensitiva è stata
in grado di individuare il luogo in cui si trovava la macchina con il cadavere
di Chiara.
«NON C’È MOLTO da dire - afferma Maria Rosa Busi -
ho spiegato da subito come facevo a saperlo: sono una sensitiva. Adesso si vuole
infangare il mio nome dicendo che sapevo qualcosa, ho dimostrato il mio valore
non ho problemi. Sono stata messa in contatto con la famiglia da una giornalista
Rai che avevo conosciuto in occasione di un altro ritrovamento effettuato grazie
a me. Non ero mai stata sul lago di Como e non conoscevo nessuno in zona. I
carabinieri non mi hanno mai creduto e non hanno voluto cercare dove avevo
indicato da me. La famiglia di Chiara ha trovato dei sub volontari che hanno
voluto fare le ricerche nella zona che avevo indicato e hanno trovato l’auto e
il corpo. Questa è la storia semplice. Ci sono i giornalisti, i sub e la mamma
di Chiara che possono testimoniare com’è andata». Maria Rosa Busi è
legittimamente indispettita e afferma: «Ho ricevuto anche delle minacce, i
carabinieri lo sanno perchè gli ho dato il numero di telefono da cui era
arrivata la telefonata intimidatoria. Mi hanno chiamato anche per un
riconoscimento. Quindi sono tranquilla. Avevo promesso ai genitori di Chiara che
gli avrei fatto avere una tomba su cui piangere e ho mantenuto la parola data.
Per tutto questo non ho mai chiesto una lira».
UN CASO DELICATO e oggi in carcere a Monza i due
arrestati saranno messi sotto torchio e la procura metterà sul tavolo tutti gli
elementi che hanno portato all’arresto di Vecchiarelli e Barili. Proprio
Vecchiarelli si è sempre professato innocente e in più occasioni ha avuto modo
di ribadire che era legato a Chiara Bariffi da una sincera amicizia.
Vecchiarelli era al funerale di Chiara Bariffi vicino ai genitori che fino
all’arresto faticavano a credere nella colpevolezza dell’uomo e mamma Luciana
afferma: «Sapere che due persone che Chiara considerava amiche l’hanno uccisa mi
fa doppiamente male».
Ecco perché Vecchiarelli è stato assolto
dalle accuse. Le motivazioni della Corte d’Appello di
Como, scrive Andrea Morleo il 13 febbraio 2010 su Il Giorno. NON É STATO LUI ad
uccidere Chiara Bariffi la notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2002.
Questa la sentenza emessa il 27 novembre scorso dalla Corte d’Appello di Como
nei confronti di Sandro Vecchiarelli (difeso dall’avvocato Marcello Perillo del
Foro di Lecco), che era stato arrestato il 19 aprile del 2008 con l’accusa di
omicidio. A distanza di poco meno di due mesi, si conoscono le motivazioni di
quella sentenza. «La lunga e articolata istruttoria dibattimentale - si legge
nel documento a firma del presidente Alessandro Bianchi - non ha consentito di
raccogliere a carico di Vecchiarelli prove sufficienti di colpevolezza in ordine
al delitto di omicidio contestatogli, ma anzi ha privato di consistenza e di
significato molti degli elementi indiziari». Troppe zona d’ombra, insomma,
continuano ad avvolgere la ricostruzione dei fatti. A cominciare dal fatto che
«manca l’assoluta certezza che, quando finì nel lago, Chiara fosse viva: anche
sotto l’aspetto scientifico questa eventualità raggiunge almeno la percentuale
del 70%». L’assunto accusatorio che Chiara quella sera si sentì male a causa di
un mix tra alcool, hascisc e gli psicofarmaci che assumeva «resta invece
sfornito di qualsiasi prova». I giudici della Corte confermano anche «l’estrema
debolezza del movente» perché «nessuna voce nel processo ha riferito di una
relazione sentimentale tra i due».
NESSUNA CERTEZZA nemmeno sulle modalità con le
quali l’auto si inabissò nel lago e sull’individuazione del punto esatto in cui
ciò avvenne. Per i giudici le lacune non sembrano essere colmate dalla
deposizione di Mirko Cola. Come non sono state decisive per i giudici le
deposizioni dei teste Micaela Melesi, Alberto Facchinetti e Maurizio Venini per
verificare se effettivamente nelle prime ore del 1° dicembre 2002 Chiara e
Sandro avessero fatto colazione insieme. Così conclude la Corte «l’intero quadro
indiziario nel suo complesso si è rivelato inconsistente». Il mistero sulla
morte di Chiara Bariffi rimane pertanto tuttora avvolto da tanti, troppi
interrogativi insoluti.
Otto anni per smontare il castello di
accuse nel caso del corpo sparito, scrive Venerdì
15/04/2011 "Il Giornale". Il processo è stato il processo delle suggestioni. Ma
l’imputato è stato un imputato vero. Almeno dal 2002 al 2010. Tanto è durato
l’incubo in cui, tra sospetti, carcerazioni e accuse mediatiche, è piombato
Sandro Vecchiarelli di Dervio, un paesino nel Lecchese. Indicato, a torto, come
responsabile di un omicidio volontario, quello di Chiara Bariffi, una ragazza di
Bellano, e dell’occultamento del suo cadavere. «Non posso nascondere che Chiara
mi piacesse ma siamo sempre stati solo amici». E, in verità, non si dovrebbe
venire accusati di omicidio solo per avere avuto una buona amicizia con una
ragazza tragicamente e morta in modo rocambolesco quanto misterioso e ritrovata
cadavere nell’auto in fondo al Lago di Como. No, non si dovrebbe. Ma se
nell’ordinanza di custodia cautelare che porta Sandro Vecchiarelli nel carcere
di massima sicurezza di Monza ci sono un sfilza di magari e di probabilmente,
allora tutto può cambiare. Anche la vita di un uomo innocente può cambiare.
Tanto da diventare per 584 giorni la vita di un uomo dietro le sbarre che, in
560 fogli, già, quasi uno per ogni giorno di detenzione annota, in un vero e
proprio memoriale, ricordi e dettagli, anche minimi che possano aiutare a
dimostrare la sua innocenza. Un memoriale che il suo legale, Marcello Perillo,
ha voluto rendere noto solo dopo che tutte le testimonianze hanno rivelato la
loro inconsistenza davanti ad una Corte.
PRESUNTO COLPEVOLE. TITO RODRIGUEZ.
Scrive Rai.it il 27 settembre 2013. Le storie
di Pio Ragni, Tito Rodriguez e Fulvio Passananti sono al centro della settima
puntata di “Presunto colpevole”, il programma che racconta storie di
“malagiustizia”. La seconda storia è quella di Tito Rodriguez. Tito aveva
lasciato la sua patria, l’Ecuador, per costruirsi una vita in Italia. E ci era
riuscito. Lavora nell’edilizia, aveva costruito una sua piccola impresa a
Genova. Dopo circa vent’anni nel nostro Paese si sentiva a casa. Poi, tutto è
crollato. Tito aveva una moglie e due figlie, ma si è innamorato di una ragazza
molto più giovane di lui, come succede a tanti. Ha avuto altri due bambini,
sembrava che tutto andasse per il meglio. Poi tutto è cambiato. Le cose, con la
sua nuova compagna, non funzionavano più come prima. Sono arrivate le accuse:
violenze, percosse sulla donna e sui figli. Non c’erano prove, non c’erano
referti medici. Solo voci. Eppure Tito è stato arrestato e sbattuto in cella. In
una mattina, è diventato un presunto colpevole e ha passato cinque mesi in
galera e un mese e mezzo agli arresti domiciliari.
PRESUNTO COLPEVOLE. EMANUELE NASSISI.
IN CARCERE MA DA INNOCENTE LA STORIA DI
EMANUELE NASSISI, scrive il Luglio 2011 Piazza
Salento. Parabita. Per i carabinieri, la parola “auto” significava “droga”;
“sutta la porta”, così chiamato il punto di ritrovo di tutti i parabitani, era
invece la porta di casa dello spacciatore. Errori di interpretazione delle
intercettazioni e Emanuele Nassisi, è finito in cella senza sapere perchè. I
capi d’imputazione li ha conosciuti solo dal giornale. Notti insonni, sul letto
a castello, a pochi centimetri dal soffitto, in attesa di sapere qualcosa in
più. Di poter finalmente venir fuori da quell’incubo. Emanuele Nassisi, un
ragazzo di Parabita, viveva la sua vita come tanti trentenni coetanei del suo
paese, quando, per uno sbaglio nell’interpretazione di alcune intercettazioni,
all’improvviso si è visto stravolgere la vita. I carabinieri hanno fatto
irruzione nella sua abitazione all’alba. Poi, dopo una perquisizione, senza
nessuna spiegazione, lo hanno spedito in prigione, in custodia cautelare. «Sono
stato portato in carcere il sabato e fino al martedì successivo nessuno mi ha
detto niente. All’inizio pensavo fosse uno scherzo – racconta Emanuele – poi, ho
iniziato a pensare che tutto si sarebbe risolto nel più breve tempo possibile,
alla fine non ci volevo credere. Leggendo il giornale ho capito di cosa mi
stavano accusando: associazione a delinquere, spaccio internazionale di droga e
di armi. Ho provato tanta rabbia nel constatare che era tutto falso». Nassisi è
molto conosciuto in paese, artista della pietra leccese, le sue opere le esporta
in tutto il mondo, è socio in tante associazioni (pure quella dei carabinieri),
è stato impegnato anche in politica. «Tutti sanno bene chi sono – continua – non
ho mai avuto problemi con nessuno. A mettermi nei guai sono state le
intercettazioni delle telefonate avute con Massimo Donadei, per la compravendita
dell’auto. Ed hanno legato la mia attività lavorativa in tutto il mondo con
chissà quale giro internazionale di droga. Solo dopo tanto tempo il giudice ha
ammesso l’errore». Due mesi hanno lasciato il segno. «I compagni mi hanno
trattato bene – si sfoga Nassisi – ho conosciuto altre persone che come me
stavano dentro da innocenti, vittime dello stesso errore. Stare lì non è bello,
vedersi chiuso dietro le sbarre mi ha segnato. Ora, di notte, anche il rumore e
i lampeggianti del camion dei netturbini mi fanno rivivere la stessa paura. Ed
anche la vista dei Carabinieri ora mi turba». Per questa triste vicenda è stato
costretto a rimandare il matrimonio, si sarebbe dovuto sposare il 25 giugno.
«Potete immaginare cosa significa spostare data per la chiesa e il ristorante.
La mia famiglia mi è stata vicina, anche se i miei permessi per incontrarli
erano ridotti, perchè ritenuto pericoloso – dice Nassisi -, inoltre ho perso
tanti clienti, avevo dei lavori da consegnare urgentemente, e hanno provveduto
in altro modo, sarei dovuto partire anche in Brasile ed è saltato anche quel
lavoro. Ho subito un danno all’immagine ed ora devo recuperare». L’avvocato
Luigi Suez sta già provvedendo a chiedere un risarcimento.
PRESUNTO COLPEVOLE. FILIPPO DI BENEDETTO.
Seregno: è accusato di rapina. Innocente,
passa in cella 18 mesi, scrive Il Cittadino MB,
Venerdì 20 Aprile 2012. Seregno - Finisce dietro le sbarre per un errore
giudiziario: è stato scambiato per un bandito. Ma prima di essere liberato passa
diciotto mesi in carcere. Filippo Di Benedetto, 26 anni, seregnese, la sua
amarezza l'ha sfogata in settimana davanti alle telecamere di "Presunto
colpevole", trasmissione in onda su Rai Due dedicata proprio agli sbagli della
giustizia. Il 27 gennaio del 2010 viene commessa una rapina a un supermercato di
Arosio (Como). Il delinquente è particolarmente violento: minaccia due cassiere
con un coltello e scappa con 700 euro in contanti. A marzo Di Benedetto si trova
circondato dai carabinieri: «Sono le 6.30 del mattino - racconta davanti alle
telecamere di Rai Due - quando mi hanno detto che dovevo andare con loro per la
rapina di Arosio. Ma io non c'entravo nulla». Di Benedetto all'inizio è
tranquillo, convinto che si tratti di un errore. Eppure nella sua foto
segnaletica le cassiere riconoscono il bandito, lui finisce in cella. Qui
conosce qualcuno che sa il nome del vero colpevole: si tratta di Biagio
Carlomagno residente a Mariano Comense. Questi ammette la propria colpa e
scagiona il ventisettenne, ma il seregnese viene comunque condannato a 7 anni e
9 mesi di reclusione. Alla fine sconterà solo, si fa per dire, un anno e mezzo
di carcere. Solo una perizia antropometrica, ovvero la misurazione delle ossa di
Di Benedetto e di Carlomagno e una comparazione con le immagini delle telecamere
del supermercato, lo scagioneranno del tutto. Finalmente il ventisettenne viene
dichiarato innocente e può tornare libero nella sua Seregno.
PRESUNTO COLPEVOLE. FRANCESCO SPANO'.
ALL’INFERNO E RITORNO. STORIA DI UN
BANALE, DRAMMATICO ERRORE GIUDIZIARIO, scrive il 17
gennaio 2010 Claudio Cordova su Strill. C’è un uomo. Si chiama Francesco Spanò e
ha 39 anni. Francesco Spanò è nato a Taurianova, ma vive a San Ferdinando, un
paese di 4500 anime che si affaccia sul golfo di Gioia Tauro. Lo arrestano
nell’ambito dell’operazione “Maestro”. L’operazione Maestro è di quelle che,
solitamente, vengono definite “brillanti”. Il blitz del Raggruppamento Operativo
Speciale dei Carabinieri scatta all’alba del 22 dicembre 2009. In manette
finiscono 27 indagati. L’indagine, condotta dalla Procura della Repubblica di
Reggio Calabria, ricostruisce gli equilibri mafiosi della Piana di Gioia Tauro.
Quella di Gioia Tauro è una zona calda, dove gli affari portano, assai spesso, a
fatti di sangue, dove, sempre in nome degli affari, le alleanze cambiano
facilmente. I legami, anche quelli che sembravano indissolubili, si spezzano in
pochi istanti: come accade il 1° febbraio del 2008, quasi due anni fa, quando
viene assassinato Rocco Molè, il reggente dell’omonimo clan da sempre alleato
all’altra cosca storica di Gioia Tauro, la famiglia Piromalli. Alla base
dell’assassinio di Rocco Molè, infatti, vi sarebbero proprio gli intrighi
riguardanti le spartizioni degli affari e del denaro. Soprattutto degli affari e
del denaro del porto di Gioia Tauro: e gli inquirenti ipotizzano che dietro
tale, clamoroso, omicidio vi sia proprio la famiglia Piromalli. Ma torniamo
all’operazione “Maestro”. Oltre al reato di associazione a delinquere di stampo
mafioso, gli inquirenti ipotizzano anche l’associazione per delinquere
finalizzata all’introduzione in Europa di ingenti quantitativi di merce
contraffatta, con l’aggravante della transnazionalità, ed altri reati doganali.
I Carabinieri sequestrano beni per cinquanta milioni di euro. L’indagine
colpisce, in particolare, i presunti affiliati alla cosca Molè. Tra gli
arrestati c’è anche Francesco Spanò, 39 anni, originario di San Ferdinando.
Spanò finisce in carcere, come gli altri indagati, il 22 dicembre: trascorre in
carcere il Natale, il Capodanno e l’Epifania. Trascorre in carcere gran parte
delle festività natalizie. Ma c’è un particolare. Francesco Spanò con l’indagine
“Maestro”, con la cosca Molè, con la ‘ndrangheta, non c’entra nulla. Cosa che,
peraltro, Francesco Spanò afferma fin da subito. Nel corso dell’interrogatorio
di garanzia, Spanò, infatti, nega di aver mai intrattenuto alcun tipo di
rapporto con individui ritenuti affiliati alla cosca Molè. Gli avvocati di
Spanò, Giuseppe Bellocco e Mario Virgillito, il 5 gennaio depositano un’istanza
di revoca della misura cautelare. Sulla scorta di una nota del ROS dei
Carabinieri, anche il pubblico ministero che cura l’indagine dà parere
favorevole: il Gip Domenico Santoro ordina l’immediata scarcerazione di Spanò.
C’è stato un errore. Il 30 novembre del 2007 gli investigatori ascoltano
un’intercettazione telefonica. Da un capo del filo c’è Antonino Molè, classe
1989. Dall’altra parte, invece, c’è un soggetto identificato come “Ciccio”.
Nella conversazione Molè indica al proprio interlocutore di aver suonato per
errore a Domenico, “soggetto – come si legge nel dell’ordinanza di revoca della
misura cautelare – presente nello stabile ed evidentemente conosciuto da
entrambi gli interlocutori”. Il “Domenico” altri non è che Domenico Stanganelli,
cugino di Antonino Molè, che dimorava proprio insieme con “Ciccio”. Ma quel
“Ciccio” non è Francesco Spanò. E’ scritto nel decreto di revoca della misura
cautelare: “…i successivi accertamenti in proposito delegati dal PM hanno
evidenziato come utilizzatore dell’utenza … coinvolta nelle conversazioni poste
a fondamento della richiesta, intercorse tra Antonino Molè, classe 1989, e il
soggetto denominato Ciccio, debba ritenersi altro soggetto, diverso da Francesco
Spanò”. Uno scambio di persona. No, Francesco Spanò non doveva finire in
carcere. C’è stato un errore. Un errore che verrà risarcito economicamente in
virtù delle leggi che regolamentano l’ingiusta detenzione in carcere, ma che,
sicuramente, segnerà per molto tempo la vita di Francesco Spanò, sbattuto in
prima pagina da tutti i media, e dei suoi familiari, costretti a trascorrere,
come dice il fratello della vittima, “un Natale buio”. Quella di Spanò è una
storia calabrese. Una storia brutta. Una storia che non deve intaccare la
fiducia nelle Istituzioni, nella Magistratura e nell’Arma dei Carabinieri che,
giorno dopo giorno, lottano, con coraggio e dedizione, soprattutto in territori
come quelli della Piana di Gioia Tauro, contro la criminalità organizzata.
Sangue e manette fanno vendere più copie. Ma quella di Francesco Spanò è una
storia che l’onestà impone di raccontare. Per fornire una voce a chi non ce
l’ha. Per restituire la dignità rubata a un essere umano, trattato come un
criminale. Come qualcosa che non è.
PRESUNTO COLPEVOLE. JOSE' VINCENT PIERA RIPOLL.
Scambiato per narco, in cella 8 mesi.
Disavventura di un medico: furto del passaporto e arresto, scrive Luigi
Ferrarella il 5 luglio 2011 su "Il Corriere della Sera". Svegliarsi un giorno,
nella propria casa di professionista e marito e padre spagnolo, e trovare la
polizia che viene a prenderti per farti scontare in Italia 15 anni di carcere
per traffico di droga, in forza della sentenza definitiva di un processo al
quale nemmeno avevi mai saputo d'essere stato sottoposto in tre gradi di
giudizio. Tu che urli «ma ci deve essere un errore, sarà uno scambio di
persona»; e loro che, con in mano il mandato di cattura europeo e lo sguardo da
«dicono tutti così», ti estradano dalla Spagna in Italia. Nel carcere di Opera.
Condannato definitivo. Ad impazzire in cella con la prospettiva di doverci
restare 15 anni come narcotrafficante colombiano (anche se tu sei spagnolo),
operante in Italia (anche se non ci sei mai stato), soprannominato nelle
intercettazioni «el Gordo» (cioè «il Ciccione» e di carnagione olivastra, anche
se tu sei magro e di pelle più chiara), con una figlia (anche se hai un figlio).
Otto mesi in cella così: prima che l'errore - colossale nella sua genesi e
assurdo nell'inerzia burocratica del suo imparabile rotolare - venga a galla e
convinca ora la giustizia italiana a risarcirlo, si fa per dire, con 85.000 euro
a ristoro di 248 giorni di detenzione dal 17 aprile al 21 dicembre 2009.
L'allora 42enne osteopata spagnolo non lo sa, ma in Italia il 6 aprile 2005 si
parla anche di lui: il gip Maurizio Grigo, su richiesta del pm Mario Venditti,
in un'indagine sul narcotraffico internazionale emette ordini d'arresto per 134
persone, tra le quali appunto Josè Vincent Piera Ripoll, alias «Gordo», alias
«Paulo George Da Silva Sousa». Non lo saprà mai perché nessuno glielo dirà mai:
le notifiche, cruciali per il corretto instaurarsi di un giudizio, falliscono
tutte, e così è da «contumace» e «latitante» che a sua insaputa va incontro al
treno processuale che lo condanna a 15 anni in Tribunale il 17 gennaio 2007, in
Appello il 4 dicembre 2007 e in Cassazione il 29 aprile 2008. L'8 agosto partono
il mandato di cattura europeo e l'estradizione dalla Spagna. Nel carcere di
Opera è vicino ad ammattire. Studia il processo che non ha conosciuto e legge
che decisivo, per identificarlo nel «Gordo», fu l'incrocio tra le
intercettazioni dei narcos e un controllo al casello di Carmagnola l'8 agosto
2000, quando i carabinieri di Monza identificarono, insieme a un italiano
coinvolto nei traffici (M.B.), anche una persona che il passaporto indicava
appunto «Piera Ripoll Vincent Josè, nato a Gandia (Spagna) il 31.10.1963», poi
riconosciuto al Motel Ritz di Varedo il 26 settembre in un altro momento topico
dell'indagine antidroga. Solo che non è lui. Ed è proprio a Opera, per un caso
che ha il sapore del miracolo, che lo spagnolo scopre la ragione. Proprio lì c'è
anche M.B., in detenzione domiciliare essendo diventato collaboratore di
giustizia. E quando lo incontra, avvisa subito i carabinieri che lo spagnolo è
lì per sbaglio: era l'osteopata dal quale si era recata la moglie di M.B. e al
quale costui aveva rubato il passaporto, per poi consegnarlo al narcotrafficante
«el Gordo» col quale era in affari. Ma per gli avvocati Simone Briatore, Stefano
Fratus e Antonino Gugliotta resta un'impresa perfino procurarsi quel passaporto
per confrontare le foto: dal carcere non riescono ad averlo, e solo grazie a un
carabiniere di Monza, S.M., finalmente diventa possibile il paragone che parla
da solo, per quanto diversa è la faccia del magro spagnolo da quella del
corpulento e olivastro «el Gordo» che girava col suo passaporto. Non basta
ancora: il 17 dicembre 2009 la Corte di Appello gli nega la scarcerazione, ma
per fortuna il Tribunale del Riesame il 21 dicembre 2009 accoglie il ricorso e
libera lo spagnolo, che il 25 marzo 2010 vede la Cassazione finalmente annullare
la condanna a 15 anni e aprire all'assoluzione in Appello il 27 ottobre «per non
aver commesso il fatto», definitiva in Cassazione l'11 gennaio 2011. E ieri
anche i giudici milanesi Carfagna-Maiello-Nova, competenti sulla richiesta di
ingiusta detenzione, appaiono basiti dalla storia, a giudicare da come decidono
di alzare a 85.000 euro l'indennizzo che le tabelle di legge fermerebbero a
58.000. Neanche i soldi che lo spagnolo ha dovuto spendere in avvocati (47.000)
e ha perso in reddito (16.000 nel 2008) nel 2009 e 2010.
PRESUNTO COLPEVOLE. BRUNO DEL MORO.
I miei 14 anni da incubo: condannato pur
essendo innocente, scrive il 13 gennaio 2011 Il
Tirreno. Cosa vuol dire vivere quattordici anni con la spada di Damocle di una
condanna per un reato mai commesso? Lo racconta in un'intervista Bruno Del Moro,
l'autista Atl che è stato assolto in appello dopo essere stato condannato a 4
anni e mezzo per un colpo alle poste di Roma del 1996. Del Moro parla di un
incubo attraversato in tutto questo tempo, i problemi della famiglia, le
difficoltà economiche e la solidarietà dei colleghi che non hanno mai smesso di
credere nella sua innocenza. L'intervista completa nell'edizione di domani.
Un'intercettazione e un riconoscimento errato: ecco come si finisce nei guai.
Del caso Del Moro si occuperò martedì prossimo anche la rubrica "I Soliti
ignoti" de "La vita in diretta", la trasmissione di Rai 1. Ma come può succedere
che un innocente finisca invischiato in una vicenda giudiziaria come questa. Lo
spiega il legale di Bruno Del Moro, l'avvocato Mario Maggiolo: «Quando vennero
commesse le rapine alle poste di Roma, nel 1996, si cercò un basista, e furono
messi sotto sorveglianza i telefoni di molti dipendenti - sottolinea il legale -
e da uno di questi risultarono molte telefonate ad un pregiudicato, la cui
convivente abitava a Livorno. Da questa utenza risultò una chiamata al telefono
di Del Moro. Era - spiega Maggiolo - la figlioletta della donna che conosceva la
figlia dell'autista». A quel punto Del Moro si ritrovò comunque in mezzo
all'indagine e la polizia di Roma chiese una sua foto all'anagrafe: arrivò
un'immagine in bianco e nero di un uomo con i baffi: un teste lo riconobbe come
uno dei banditi. Ma il bandito aveva capelli e baffi neri, mentre Del Moro li
aveva rossi: «E così - conclude Maggiolo - alla fine siamo riusciti a dimostrare
la sua innocenza».
«Senza la famiglia e i colleghi dell'Atl
non avrei superato questa prova terribile», scrive
Roberto Cestari il 14 gennaio 2011 su Il Tirreno. Bruno Del Moro l’autista Atl
assolto in appello dopo un’odissea giudiziaria durata 14 anni LIVORNO. Il primo
giorno di libertà ha una sapore speciale, per chi è stato 14 anni sotto la spada
di Damocle di un'accusa gravissima, una rapina, e una condanna per un fatto non
commesso. Ieri Bruno Del Moro, l'autista Atl assolto dalla corte di appello di
Roma per il colpo alle poste della capitale del 1996, ha accettato di parlare di
questi anni difficili. E lo ha fatto proprio al circolo Atl di via delle Galere,
tra i compagni di lavoro che lo festeggiavano. E la settimana prossima, martedì
alle 18, Del Moro e il suo avvocato, Mario Maggiolo, parleranno di questa
vicenda a "La vita in diretta", la trasmissione pomeridiana di Rai 1. Qual è il
primo pensiero dopo l'assoluzione? «La fine di un incubo, ma anche che non sono
il solo cui sono capitate cose simili». Come è iniziata la storia, che cosa ha
provato quando la polizia è venuta a cercarla? «All'inizio, era il 1997, ci
risi sopra, pensavo ad un errore: ma come io che andavo a fare le rapine a Roma
dopo essere sceso dal bus. E anche alla polizia mi dissero di stare tranquillo,
che c'era certo un errore. Poi, un giorno, scesi dal bus a fine turno e c'era la
polizia in borghese che mi aspettava. "Lei è in arresto" mi dissero, e in quel
momento mi crollò il mondo addosso». E poi cosa successe? «Mi accompagnarono a
casa e trovai mia moglie Lisanna. Le dissi che erano due rappresentanti venuti
per il negozio e che dovevamo parlare, e che quindi doveva portare da qualche
parte nostra figlia Alessia, che allora aveva solo 9 anni. Quando la bambina fu
in un'altra stanza, le dissi "Mi arrestano". E vidi che il mondo era crollato
addosso anche a lei». E per lei ci fu il carcere. «Sì, mi portarono alle
Sughere. Io avevo una paura tremenda: nei film quando mostravano le carceri si
vedevano le cose più tremende e io, incensurato, non sapevo cosa mi aspettasse.
Invece, le cose sono andate meglio del previsto». In che senso? «Nel senso che
gli altri detenuti non mi hanno dato problemi, e gli agenti della Penitenziaria
sono sempre stati umani». Parlava di quello che era successo con gli altri
detenuti, qualcuno le chiedeva della rapina? «No, in carcere ognuno si fa i
fatti suoi e non chiede agli altri perché è detenuto». Poi ci fu la prima
liberazione. «Sì, dopo un mese tornai a casa, ma poi si presentò la polizia
postale di Roma e mi arrestarono nuovamente. Feci altri 5 mesi alle Sughere e un
mese a Rebibbia, a Roma». E la famiglia come ha reagito? «Mia moglie mi è
stata sempre accanto, e ha cercato di mantenere tranquilla nostra figlia, che
però qualche problema alla fine lo ha accusato. Alessia non parlava mai di
quello che mi era successo, salvo una volta: "Non ti faranno niente, perchè non
hai fatto niente di male"». Poi ci sono stati i 13 mesi di arresti domiciliari.
Come avete fatto per i soldi? «Male, perché ero stato sospeso dal lavoro. Ma la
famiglia e i colleghi ci sono rimasti accanto e ci hanno aiutato, anche dal
punto di vista economico: gli autisti Atl, che voglio ringraziare per tutto
quello che hanno fatto per me e la mia famiglia, hanno anche raccolto dei soldi
per permetterci di tirare avanti. E devo ringraziare anche l'azienda, che appena
ha potuto, mi ha fatto tornare al lavoro». Arriviamo al 2004, al processo di
Roma: cosa ha provato al momento della sentenza di condanna? «Mi sembrava
impossibile: come, io che sono innocente dovevo fare quattro anni di carcere?
Perché non mi avevano assolto, in che mondo ero?». E in attesa
dell'appello? «Andavo a lavorare per non pensare, perché pensavo cose davvero
brutte». Con che spirito è andato all'appello? «Fiducia zero, a quel punto non
sapevo proprio come sarebbe andata a finire». Invece il giudice ha letto il suo
nome e la parola assolto. Cosa è successo allora? «Mi sono messo a piangere,
non riuscivo a fare altro. E un altro imputato mi ha detto "Non devi piangere,
devi ridere", ma...». Ma cosa? «Ero incredulo, non capivo se fosse vero o no:
così ho chiamato un avvocato e gli ho chiesto: "Ma è vero che ci hanno assolti
tutti?" e quando lui mi ha detto di sì ho cominciato a rendermi conto che era
vero». Cosa è stata la prima cosa che ha fatto da uomo libero? «Ho dormito
fino alle quattro del pomeriggio, per la prima volta senza incubi». E adesso
come si sente? «Meglio, anche se non mi sento ancora del tutto tranquillo. La
paura è restata, dovrò imparare a conviverci. Ma almeno sono pulito da
quell'accusa infamante, e questo è l'importante. Ma aggiungo una cosa: è toccato
a me dimostrare di essere innocente, non a loro che fossi colpevole. Questo ci
deve insegnare che nessuno è al riparo da certe situazioni». Adesso chiederà un
risarcimento? «Se ne occuperà l'avvocato Maggiolo, ma in questo momento non mi
interessa più di tanto: l'importante è essere uscito da questa
situazione». Programmi a breve? «Forse un viaggio, magari un last minute, e
poi vorrei finalmente pensare alla pensione: sono 38 anni che lavoro, ho
cominciato a 14 anni e da allora non ho mai smesso».
PRESUNTO COLPEVOLE. EMMANUEL ZEBAZE SOKENG.
Assolto dall'accusa di associazione a delinquere
finalizzata alla truffa.
PRESUNTA COLPEVOLE. JOY IDUGBOE.
Brescia, finisce il calvario di Joy: sei
mesi in cella per un’omonimia, scrive il 13 gennaio
2012 Tempi. Joy Idugboe, nigeriana 42enne residente a Brescia, ha passato sei
mesi in carcere per sfruttamento della prostituzione, reato che non ha mai
commesso. Incarcerata nel 2007 per delle intercettazioni dove veniva accusata
una persona con il suo stesso nome, le hanno tolto anche l’affidamento dei figli
e solo in questi giorni è arrivato il risarcimento di 48 mila euro. Era solo un
caso di omonimia, Joy Idugboe non era colpevole di sfruttamento della
prostituzione e riduzione in schiavitù, ma la procura di Napoli ci ha messo più
di due anni per assolverla, tre per ridarle l’affidamento dei figli e solo in
questi giorni è arrivato il risarcimento pari a 48 mila euro. E intanto la
nigeriana 42enne, allora residente in una casa popolare di Brescia, ha passato
sei mesi in carcere, lontana dal compagno e dai due figli. Come scrive Avvenire,
il calvario giudiziario della donna inizia circa cinque anni fa, quando una
prostituta sporge denuncia per riduzione in schiavitù e sfruttamento. I
magistrati autorizzano le intercettazioni telefoniche e attribuiscono la voce
intercettata a Idugboe. Che per l’ordine di custodia cautelare finisce in
carcere il 26 giugno 2007, prima a Brescia e poi a Pozzuoli. Subito l’avvocato
della donna, Giuseppina Coppolino, si muove per farla uscire: «Già agli esordi
della vicenda era emerso senz’ombra di dubbio che la mia assistita fosse vittima
di un caso di omonimia». Ma il Gip del tribunale di Napoli non è convinto e
rigetta l’istanza. E mentre i figli di Joy vengono affidati a una comunità, il
28 novembre 2007 l’imputata chiede per l’ennesima volta l’esame della voce. Dopo
l’esame viene scagionata ma rilasciata solo il 13 dicembre 2007. L’assoluzione
definitiva arriva il 3 luglio 2008 e la restituzione dei figli il 16 settembre
2009. L’avvocato di Joy commenta così: «Una vicenda incresciosa, per la quale ho
scritto al presidente della Repubblica. Pronta la sua assicurazione: indagherà
il Consiglio superiore della magistratura».
PRESUNTO COLPEVOLE. MASSIMO MALLEGNI.
L’eccezione di Mallegni: «Io, arrestato
da innocente fermerò le manette facili». Il candidato
di Forza Italia incontra gli avvocati, scrive il 3 Marzo 2018 "Il Dubbio". «La
carcerazione preventiva è un abominio. Forza Italia propone di rivederla in
profondità, nel quadro di una riforma della giustizia che assicuri il diritto a
un giusto processo». Sarà un caso, ma uno dei pochissimi candidati che
affrontano con argomentazioni dettagliate il tema giustizia è uno che si è
fatto, da innocente, un po’ di carcere: si tratta di Massimo Mallegni, ex
sindaco di Pietrasanta, che ha dovuto affrontare qualcosa come 7 diversi
procedimenti penali, per uscirne puntualmente prosciolto. Corre per il
centrodestra in Toscana, al Senato, e due giorni fa ha incontrato gli avvocati
della Versilia a Lucca per esporre il programma del suo schieramento in campo
penale e civile. «Le imprese non investono in Italia perché sono terrorizzate
dai tempi della nostra giustizia. Ma non si tratta solo della difficoltà nel
veder soddisfatto un credito: fanno paura anche odissee giudiziarie come quella
di cui sono stato vittima, che è durata 17 anni. E da ex imputato, innocente,
comprendo la necessità di intervenire sulla carcerazione preventiva e sul
processo in generale, così come la comprendono le oltre 20mila persone che dal
2001 ad oggi sono state incarcerate e poi risarcite per ingiusta detenzione. Un
detenuto su 3 vive nel limbo della carcerazione preventiva». Mallegni ha
assicurato agli avvocati che Forza Italia metterebbe in campo anche «la
separazione delle carriere della magistratura inquirente da quella giudicante e
una nuova disciplina delle intercettazioni».
Dieci anni dopo Massimo Mallegni torna a
San Giorgio. Il sindaco di Pietrasanta fa visita con i
vertici regionali di Forza Italia al carcere di Lucca dove, nel gennaio 2006,
venne condotto dopo l'arresto, scrive il 31 gennaio 2016 Il Tirreno. Massimo
Mallegni, sindaco di Pietrasanta, è tornato a far visita al carcere San Giorgio
di Lucca. E non in una data scelta a casa: cadono, infatti, i dieci anni
dall'operazione di polizia giudiziaria che portò Mallegni - anche allora primo
cittadino della Piccola Atene - a essere arrestato, insieme ad altri
amministratori, dirigenti comunali e imprenditori. Una vicende che ebbe eco
nazionale e che, dal punto di vista processuale, si è conclusa con l'evaporare
di quasi tutti capi di accusa. Mallegni rimase nel carcere San Giorgio per 39
giorni in carcerazione preventiva. Dopo, ne avrebbe trascorsi ai domiciliari
altri 117, ancora nello stesso regime. Oggi, dieci anni dopo, Mallegni è
vicecoordinatore regionale vicario di Forza Italia e ha riconquistato il suo
posto di sindaco di Pietrasanta. Oggi, dieci anni dopo, Mallegni è tornato al
San Giorgio da uomo libero e innocente – con tanto di sosta a quella che fu la
sua cella – per il sopralluogo istituzionale con la delegazione di Forza Italia
guidata dal Coordinatore regionale Stefano Mugnai e dalla responsabile nazionale
comunicazione del partito onorevole Deborah Bergamini e di cui hanno fatto parte
anche l’altro Vicecoordinatore regionale Jacopo Ferri, il Vicepresidente del
Consiglio regionale della Toscana Marco Stella e il Coordinatore provinciale di
Fi a Lucca nonché Sindaco di Altopascio Maurizio Marchetti. Perché? «Perché la
storia di Mallegni, che lui oggi ci mette generosamente a disposizione, è
paradigmatica del come non si fa, ovvero di come non va esercitata la giustizia
secondo Forza Italia», spiega Mugnai. «E perché – concorda l’intera pattuglia
azzurra – il recupero e la riabilitazione di chi ha commesso reati non può
passare dalle bugie di un Renzi che, mentre si riempie la bocca condannando la
pratica diffusa della carcerazione preventiva, poi nel suo governo premia chi di
quell’istituto ha fatto presupposto per la propria carriera». Giustizia giusta,
giustizia certa: questo chiede Forza Italia. E giustizia indipendente: «Dopo
quindici anni di peripezie giudiziarie – ricordano in Forza Italia – Mallegni
oggi è non solo libero, ma anche innocente. Il suo arresto, alla fine i fatti lo
dimostrano, ha avuto come unico risultato quello di restituire Pietrasanta alla
sinistra. Per un periodo, certo. Abbiamo ben recuperato», è la stoccata azzurra.
Ma poi, affinché la pena detentiva abbia il senso previsto dalla costituzione e
punti concretamente al reinserimento sociale, serve un ascolto maggiore –
proprio come è accaduto oggi al San Giorgio – delle voci, esigenze, esistenze
anche, della popolazione carceraria tutta intera: operatori, a cominciare dalla
polizia penitenziaria, e detenuti. «Restituire dignità a chi vive in carcere per
lavoro o per pena – affermano Mugnai e gli altri esponenti di Forza Italia –
deve rappresentare una priorità nazionale, attraverso il recupero in uso di
strutture capaci di alleggerire la pressione antropica nelle celle e di
garantire dunque condizioni di vita decorose oltre che maggiore e miglior
sicurezza, ma anche regionale, con un’attenzione speciale alla sanità carceraria
e ai bisogni di assistenza e cura di operatori e detenuti. Perché la pena, di
qualunque entità, non porti con sé la rinuncia alla dignità della persona
umana».
Mallegni riabilitato dopo 10 anni di
persecuzione. Archiviate anche le ultime accuse. Per
il primo cittadino azzurro ora decade pure la Severino, scrive Mariateresa
Conti, Giovedì 10/12/2015, su "Il Giornale". Un calvario giudiziario lungo oltre
10 anni. Una cinquantina di accuse che gli son costate anche carcere e arresti
domiciliari. Accuse crollate, svanite come bolle di sapone attraverso ben cinque
processi. E adesso, finalmente, la fine dell'incubo, con l'assoluzione dalle
ultime lievi accuse rimaste in piedi pur essendo prescritte e che pure l'estate
scorsa hanno rischiato, per una solerte applicazione della legge Severino poi
sanata, di costargli la poltrona. È finito l'incubo del sindaco azzurro di
Pietrasanta (Lucca) Massimo Mallegni. La corte d'Appello di Firenze lo ha
prosciolto dall'ultima accusa rimasta in piedi (ma già abbondantemente
prescritta). Una vicenda giudiziaria che ha dell'incredibile per come si è
sviluppata ed emblematica dei tempi fiume della giustizia. Una storia a tratti
kafkiana. Mallegni, primo sindaco forzista nel 2000 (poi rieletto nel 2005 con
il 60% di consensi) di Pietrasanta, storica roccaforte rossa della Versilia in
mano alla sinistra da trent'anni, viene arrestato nel 2006. Accuse pesanti di
tutti i generi nei suoi confronti, dalla corruzione all'abuso. Tra i suoi
accusatori Antonella Manzione, all'epoca capo dei vigili urbani, oggi a palazzo
Chigi come responsabile dell'ufficio legislativo, voluta a tutti i costi da
Renzi nonostante le perplessità della Corte dei conti. E pm di quell'inchiesta,
Domenico Manzione, ora sottosegretario agli Interni, fratello della sua
accusatrice.Resta in carcere 39 giorni, Mallegni, nel 2006. Poi gli vengono
concessi i domiciliari, che poco cambiano. Ma poi, man mano, comincia la
riscossa di Mallegni, visto che i processi assolvono, da tutto, lui e gli altri
imputati. La riscossa culmina qualche mese fa, quando Mallegni viene rieletto
sindaco di Pietrasanta. Ma la mazzata è dietro l'angolo. Il prefetto di Lucca,
ad appena 28 ore dalla rielezione a sindaco di Mallegni col 55% di preferenze,
gli notifica la sospensione dall'incarico in virtù della legge Severino. A
Pietrasanta, e non solo, è rivolta. Mallegni protesta, ricorda di essere stato
lui stesso a presentare appello per essere assolto completamente da quelle
accuse ormai prescritte. Bisogna attendere il 16 luglio perché il tribunale di
Firenze sani la situazione congelando la sospensione in attesa della sentenza
d'appello. Sentenza d'appello che finalmente è arrivata annullando per
prescrizione i tre reati superstiti: abuso d'ufficio, violenza privata (ai
vigili urbani) e corruzione per atto dovuto. Mallegni esulta: «Finalmente oggi
possiamo festeggiare. Dopo dieci lunghi anni di un processo-bufala che ha messo
in ginocchio l'intera comunità di Pietrasanta per anni, me e la mia famiglia,
sputtanando amministratori e dirigenti. La Severino è evaporata, i carichi
pendenti definitivamente scomparsi». «È stata una vicenda pesantissima - dice il
sindaco di Pietrasanta al Giornale - sotto ogni punto di vista. Trentanove
giorni in carcere in isolamento, 120 ai domiciliari. Roba impressionante.
Fortunatamente ho trovato dei magistrati giudicanti perbene che hanno avuto
voglia di leggere le carte e di riconoscere la mia innocenza. La politica -
aggiunge - ha responsabilità enormi, la giustizia va riformata urgentemente, e
si deve intervenire subito».
Il caso Mallegni: storia di una
persecuzione senza fine, scrive il 10 luglio 2015
Giampaolo Rossi su "Il Giornale". Del caso Mallegni parlammo in quest’articolo
di un anno fa che v’invito a leggere, rileggere e rileggere ancora… anche più di
tre volte. Perché la storia che lì è raccontata non è semplicemente un clamoroso
errore giudiziario, definizione asettica con cui i media raccontano la
distruzione di vite, famiglie e carriere professionali compiute da magistrati
che non pagano mai. No, quello che successe a Massimo Mallegni fu qualcosa di
più: fu il manifestarsi plateale e sfacciato di un’Italia feudale in cui il
potere di pochi può stravolgere le regole della democrazia, della volontà
popolare e dei diritti altrui. Un sindaco (ottimo amministratore eletto per ben
due volte dai suoi cittadini) portato via in manette dal Consiglio comunale,
costretto a farsi sei mesi tra galera e arresti domiciliari, per cinquantuno
capi d’accusa (dall’associazione a delinquere, alla corruzione) per i quali
risultò del tutto innocente; accuse partite da una denuncia per mobbing fatta
dal suo Comandante dei Vigili Urbani, Antonella Manzione. Il suo arresto (ed è
questa la cosa più sconvolgente) fu richiesto al GIP ed ottenuto, dal fratello
di lei magistrato (Domenico Manzione) che aveva condotto le indagini; arresto
risultato persino illegittimo, come decretò la Cassazione. Quindi, prendetevi
tutto il tempo che volete ma leggetevi l’articolo che spiega anche altre chicche
di questa Italia; solo così potrete capire l’assurdo di quello che sto ora per
raccontarvi. Perché la storia non è finita qui…
PAUSA LETTURA. L’avete letto? Bene, ora ditemi,
innanzitutto: come vi sentite? Che siate di destra o di sinistra, avete anche
voi in bocca un retrogusto di indignazione e frustrazione? Avete anche voi
l’idea di non vivere in un paese civile ma nella Corea del Nord di Kim Jong-un
dove una casta autoritaria e i suoi famigli possono decidere la libertà (e
quindi anche la vita) di uomini e donne? Vi ho detto che la storia non finiva
qui. Tenetevi forte.
TO BE CONTINUED…Riabilitato dalla sua vicenda
giudiziaria Massimo Mallegni è tornato a fare politica. Alle ultime
ammnistrative, quelle del mese scorso, si è candidato nuovamente sindaco nella
sua Pietrasanta e nuovamente ha vinto. La sera dei risultati, una folla di
duemila cittadini l’ha accompagnato nella sede del Comune da dove quattro anni
prima era stato portato via ingiustamente in manette e lì ha ricevuto la fascia
tricolore dal sindaco uscente (di sinistra), un atto di riconoscimento che fa
onore. Massimo Mallegni quella sera ha pianto di gioia. “Come ti senti
Massimo?”, gli ho chiesto; “come uno che ritorna alla vita” mi ha risposto. Dal
giorno dopo, col suo fare da imprenditore versiliese, ha cominciato a lavorare
per comporre la Giunta, sbrigare pratiche e governare la “Piccola Atene” (com’è
chiamata la perla d’arte e di artisti della Versilia). Una settimana fa un nuovo
colpo di scena: il Prefetto di Lucca l’ha sospeso da sindaco per la Legge
Severino. Com’è possibile? Presto detto: oltre ai cinquantuno reati da cui è
stato assolto, ce n’era un cinquantaduesimo caduto in prescrizione; un abuso
d’ufficio per “istigazione al rilascio di Passo Carrabile” (non ridete che è
tutto tragicamente vero!). Chi conosce i riti giudiziari sa che funziona così:
quando un castello di accuse è clamorosamente smontato in sede processuale, per
non ammettere l’errore, ti appioppano un reato minore in prescrizione così che
comunque il sospetto che qualcosa hai fatto possa rimanere. Ne parlammo in
quest’altro articolo relativo ad un altro clamoroso caso di ingiustizia, quello
di Mauro Rotelli. In teoria alla prescrizione si può ricorrere in appello ma
tutti sanno che, chi esce da una persecuzione giudiziaria di anni, è distrutto
psicologicamente ed economicamente e il livello di frustrazione è tale che
difficilmente ricorrerà in appello pur di scappare da quel girone infernale.
UNO STRANO RINVIO. Invece Massimo Mallegni in
appello c’è voluto andare. L’udienza era stata fissata al 30 giugno (quindici
giorni dopo le elezioni) ma, Sim Sala Bim, la Procura generale di Firenze, l’ha
spostata di dodici mesi (un anno!!!). È allora che entra in scena il Prefetto
che, su questo rinvio, pensa bene di applicare la Legge Severino sospendendo
Mallegni dall’incarico di sindaco. Si, avete capito bene: quella legge che non
si applica a De Magistris e a De Luca (amministratori di sinistra condannati per
reati gravi) si applica al sindaco di centrodestra di un piccolo comune toscano
per un reato ridicolo prescritto. La decisione lascia allibiti perché comunque
vada l’appello, Mallegni tornerebbe a fare il sindaco essendo il suo reato
prescritto. Quindi perché continuare a perseguitare un uomo già ingiustamente
perseguitato e calpestare la volontà dei cittadini che per la terza volta lo
hanno scelto come sindaco? La cosa più stupefacente è che questo Stato che ha
rimandato di un anno l’Appello, c’ha messo un giorno (28 ore) per leggersi le
pratiche e sospendere il sindaco. Lo so cosa state pensando, voi maligni: che se
Mallegni fosse stato di sinistra nella Toscana rossa, delle cooperative rosse,
dei banchieri rossi e di qualche magistrato rosso, non sarebbe stato sospeso; e
forse neppure mai perseguitato. Ma siete voi che pensate male. Rimane il
problema fondamentale: c’è un pezzo di magistratura di questo Paese che sembra
incompatibile con la democrazia.
L’ULTIMO COLPO DI SCENA. Infine, qualche giorno
fa, di fronte all’imbarazzo per l’accaduto, l’udienza di appello di Mallegni è
stata anticipata al 10 settembre prossimo (di ben nove mesi, incredibile vero?),
appena si rientrerà dalle vacanze. In Italia la democrazia può aspettare, le
ferie del magistrato, no.
«Perseguitato dai Pm, riparto dal carcere
per andare in Parlamento». Intervista di Errico Novi
del 2 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Il caso di Massimo Mallegni. Sette
procedimenti penali. L’ultimo è durato 12 anni, si è concluso a novembre con la
definitiva assoluzione, come in tutti gli altri casi. «Alcuni mesi fa la Rai ha
dedicato uno speciale alla mia vicenda e l’ha paragonata a quella di Tortora»,
dice Massimo Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta, candidato al Senato da Forza
Italia, nella circoscrizione Toscana, dopo un’incredibile odissea giudiziaria.
La sua campagna elettorale è iniziata due giorni fa davanti al carcere di Lucca.
«Ci ho passato 40 giorni dentro: sono ripartito proprio da lì dove tutto
sembrava finito. Un innocente, in quei momenti, vive una condizione difficile da
descrivere Cominci a capire dove sei quando leggi l’ordinanza cautelare e
ricostruisci i confini della sciocchezza che ti hanno costruito addosso».
Imprenditore anche lui. «E mi hanno indagato un minuto dopo l’inizio del mio
impegno politico». Sette procedimenti, l’ultimo è durato 12 anni e si concluso
pochi mesi fa in Cassazione: assolto come tutte le altre volte. Le analogie con
Silvio Berlusconi ci sono: l’ex sindaco di Pietrasanta e capolista in Toscana
per Forza Italia Massimo Mallegni scova altre due analogie. «Alcuni mesi fa la
Rai ha dedicato uno speciale alla mia vicenda: il titolo era “dopo il caso
Tortora, il caso Mallegni”». L’altro rimando è al calvario di Ottaviano Del
Turco: «Avessi avuto l’età che aveva lui quando lo arrestarono, non starei
ancora qui a ricominciare tutto».
E invece riparte dal carcere di San Giorgio,
dove l’hanno tenuta dopo l’arresto nel 2006.
«Proprio dove
tutto sembrava finito. E invece sono andato a iniziare la campagna elettorale
proprio lì davanti. Ci ho passato 40 giorni dentro, poi altri 120 ai domiciliari».
Cosa passa per la testa a un innocente in 40
giorni di carcere?
«È una
condizione difficile da descrivere. Potrei dire di sconcerto, ma è di più,
all’inizio non riesci a capire nulla. Sei una persona perbene, hai ottenuto un
mandato dalla tua comunità, improvvisamente ti sbattono in galera come un
delinquente. Cominci a capire dove sei finito quando leggi le 163 pagine
dell’ordinanza cautelare e ricostruisci i confini della sciocchezza che ti hanno
costruito addosso».
C’è chi l’ha attaccata persino quando rifiutò
la prescrizione.
«Al settimo
procedimento, partito con 51 capi d’imputazione, dopo essere stato assolto per
48 di questi, mi sono rifiutato di lasciar finire prescritte le ultime 3 accuse.
Si trattava di cose ridicole, come l’istigazione al rilascio di
un’autorizzazione per un passo carrabile. A chi ebbe da dire sulla mia scelta
risposi che avrebbero dovuto sciacquarsi la bocca. Alla fine sono stato assolto
anche da quelle ultime 3 contestazioni».
In molti punti il programma del centrodestra
sulla giustizia pare fatto apposta per evitare che ricapitino vicende come la
sua.
«Noi vogliamo
dare alla giustizia gli strumenti necessari per operare, a cominciare dagli
organici: abbiamo la metà dei magistrati tedeschi nonostante le nostre sedi
giudiziarie siano il doppio che in Germania. E soprattutto, non è possibile che
la carcerazione preventiva sia utilizzata come avviene oggi, e come è capitato
al sottoscritto. Fatti salvi i casi in cui c’è la flagranza di reato, si viene
processati e si mette piede in un istituto di pena solo dopo una condanna
definitiva. Lo diceva pure il centrosinistra, salvo poi arruolare Domenico e
Antonella Manzione, fratello e sorella, i grandi accusatori a cui devo il mio
calvario».
Cosa pensa del muro alzato dai pm di fronte
alla proposta di Forza Italia sull’abolizione del ricorso della Procura in caso
di assoluzione in primo grado?
«Premetto che
una riforma della giustizia non può prescindere dall’opinione degli operatori
del diritto: magistrati e avvocati. Ma se mi assolvono tu non puoi continuare a
perseguirmi. Non è possibile che in Italia incomba su qualsiasi indagato l’onere
dell’inversione della prova: per come è strutturato il nostro ordinamento, sei
sempre tu che devi dimostrare l’infondatezza delle contestazioni mosse dallo
Stato, che si tratti di un Tribunale penale o di una cartella di Equitalia. Non
è possibile».
E invece il “principio” è stato consacrato
anche dal nuovo Codice antimafia: sequestri preventivi agli indiziati di
corruzione, che devono provare la liceità dei beni se non vogliono vederseli
portare via.
«Un’assurdità
che non è sfuggita al presidente della Repubblica: ha promulgato la legge ma ha
raccomandato al Parlamento di monitorarne gli effetti. Se quella norma fosse
stata in vigore quando venni arrestato nel 2006, con accuse di corruzione e
concussione, mi avrebbero sequestrato tutto».
A proposito di operatori del diritto: gli
avvocati sono ascoltati abbastanza quando di tratta di definire provvedimenti
sulla giustizia?
«Se guardiamo
agli scioperi che hanno indetto negli ultimi mesi si direbbe il contrario.
Questo fine settimana sarò all’inaugurazione dell’anno giudiziario delle Camere
penali, e dirò una cosa: se il governo perde settimane per confrontarsi con i
sindacati dei lavoratori prima di un presentare un nuovo contratto collettivo, è
giusto che stia a sentire coloro che come gli avvocati hanno la competenza in
materia di giustizia. Poi non è detto che gli equilibri del Parlamento
consentano di portare a casa tutte le proposte, ma almeno ci si è provato».
Lei finirà per occuparsi di giustizia, una
volta eletto senatore di Forza Italia.
«Preferirei
occuparmi di cultura: qui in Versilia, come in tutta Italia, c’è una ricchezza
che può essere ancora più valorizzata. Vorrei dedicarmi a cose piacevoli, ecco».
Cosa può dire a chi come Ottaviano Del Turco ha
vissuto un calvario simile al suo ma non ha potuto ricominciare con la politica,
nonostante sia stato assolto praticamente da tutto?
«Io ho avuto un
paio di colpi di fortuna. Sono stato colpito solo di striscio dalla legge
Severino, che mi è costata una sospensione di quindici giorni. Ma soprattutto ho
avuto la ventura di essere stato arrestato a 36 anni. Se fossi finito nella
cella di un carcere all’età in cui ci è finito Ottaviano, e lo chiamo per nome
perché sono socialista anch’io, lo conosco, ecco, se avessi avuto la sua età non
avrei mai potuto riscattarmi e tornare in campo. Avrei avuto 72 anni. Ma dalle
ingiustizie non sei esce mai del tutto illesi».
PRESUNTO COLPEVOLE. PIO RAGNI.
Capaccio, Pio Ragni è innocente: assolto
dopo 8 anni di processi ed il carcere il geometra
Ersac accusato di corruzione, scrive Alfonso Stile l'11 maggio 2012 su Stile TV.
Assolto perché il fatto non sussiste. Pio Ragni è innocente. Il funzionario
capaccese (ora in pensione) dell’Ersac fu accusato, nel 2004, di aver
falsificato alcune certificazioni Aima dopo essere stato corrotto attraverso il
regalo di un prezioso orologio d’oro. Un’inchiesta, iniziata nel giugno del
2004, che portò Ragni in carcere per 17 giorni ed agli arresti domiciliari per i
successivi 6 mesi. Ma l’altro ieri, dopo 8 lunghi anni di processi, i giudici
della V sezione penale del Tribunale di Napoli, presieduta dal
magistrato Donzelli, lo hanno assolto da ogni accusa, appunto, con l’art. 530
del Codice di procedura penale “perché il fatto non sussiste”. All’epoca, i
carabinieri del Nucleo Politiche Agricole di Roma fecero irruzione in casa Ragni
alla ricerca del costoso orologio, prova schiacciante che avrebbe dovuto
incastrarlo, ma non fu mai trovato. Ragni (nella foto), geometra di Capaccio
Capoluogo e fratello di Nicola Ragni (noto politico capaccese), ha sempre
proclamato la sua innocenza dal primo giorno, professandola in tutte le sedi,
rinunciando finanche alla prescrizione del reato affinché i giudici accertassero
i fatti e la verità. Ad accusarlo fu il collega d’ufficio, Barbato, poi
sconfessato dai giudici perché, si è scoperto, essere avverso e poco ben
disposto nei confronti di Ragni. Da allora, un calvario lungo 8 anni, l’onta
della detenzione a Fuorni, dei domiciliari e l’accusa infamante di essere il
regista del business delle “arance d’oro” mai prodotte ma certificate all’Unione
Europea in cambio di Rolex e Baume&Mercier d’oro massiccio. Oggi, invece, Pio
Ragni può finalmente staccarsi di dosso quell’etichetta di funzionario corrotto
ingiustamente affibbiatagli: i giudici, infatti, hanno accertato che non
ricevette mai regali né compilò mai certificati falsi, in quanto non erano di
sua competenza, come confermato da diversi testimoni chiave chiamati in causa.
Anzi, le prove raccolte dalla difesa, retta dall’avv. Michele Tedesco, hanno
consentito di dimostrare l’assoluta correttezza di Ragni, che, al contrario,
rilasciava documentazioni regolari ed inerenti i suoi incarichi. Pio Ragni ha
rilasciato un'intervista esclusiva alla nostra emittente: un estratto (cliccare
sull'icona della telecamera per vederlo) andrà in onda nel TgStile di oggi,
mentre la versione integrale sarà trasmessa mercoledì prossimo 16 maggio, alle
ore 21:15, nell'ambito del format "Prisma - Storie, fatti e misteri" condotto da
Angela Sabetta. L’arresto, una famiglia distrutta, la carcerazione in regime di
41 bis, e poi l’assoluzione… ma chi ti ridà la tua vita di prima, i genitori
morti, il lavoro perso?
PRESUNTO COLPEVOLE. MAURIZIO COMINO.
Il caso Maurizio Cimino - Il caso Mattino5.
Accusato ingiustamente di appartenere ad una associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: assolto!
PRESUNTA COLPEVOLE. MONICA BUSETTO.
Delitto Pamio, Monica Busetto condannata
a 25 anni in appello. La Corte d'Assise d'Appello di
Venezia si è espressa mercoledì sull'ex operatrice socio-sanitaria veneziana
accusata di aver ucciso Lido Taffi Pamio nel 2012 a Mestre, scrive il 17 ottobre
2018 la Redazione di Venezia Today. Venticinque anni di reclusione. E' la
sentenza stabilita mercoledì mattina dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia
nei confronti di Monica Musetto, l’ex operatrice socio-sanitaria accusata, in
concorso con Susanna «Milly» Lazzarini, di aver ucciso la vicina di casa Lida
Taffi Pamio. La vittima, colpita a coltellate e strangolata con il cavo del
decoder, è morta il 20 dicembre del 2012 nel suo appartamento in viale Vespucci
a Mestre. Busetto, che si è sempre dichiarata innocente, era accusata di
omicidio volontario aggravato dall’efferatezza e crudeltà e dai futili motivi
e in primo grado era stata condannata a 24 anni e sei mesi. La pena, con il
primo appello, si era poi aggravata nell'ergastolo. La Cassazione
successivamente aveva cancellato la sentenza limitatamente all’aggravante dei
futili motivi e rinviato la decisione ai giudici della Corte d’Assise d’Appello
che, adesso, hanno escluso l’aggravante. A Busetto, rappresentata dagli avvocati
Alessandro Doglioni e Stefano Busetto, non sono state riconosciute le attenuanti
generiche. La difesa annuncia un nuovo ricorso in Cassazione.
Colpo di scena: la Cassazione toglie
l’ergastolo a Monica Busetto. Rinviato il procedimento
in Corte d’Assise d’Appello contestando l’aggravante dei futili motivi di Rubina
Bon, scrive il 28 aprile 2018 la Nuova Venezia. L’omicidio di Lida Taffi Pamio,
uccisa nel dicembre 2012 nel suo appartamento in via Vespucci, ha riservato
l’ennesimo colpo di scena, arrivato dopo la mezzanotte di ieri dalla Corte
di Cassazione: per Monica Busetto, accusata di omicidio volontario aggravato
dall’efferatezza e crudeltà e dai futili motivi, i giudici romani hanno
annullato la sentenza di ergastolo della Corte d’Assise d’Appello limitatamente
all’aggravante dei futili motivi. Il giudizio è stato rinviato alla Corte
d’Assise d’Appello in diversa composizione che su ciò si dovrà pronunciare. In
primo grado l’operatrice sociosanitaria, che si è sempre detta innocente, era
stata condannata a 24 anni e 6 mesi. In virtù del riconoscimento
dell’aggravante, in secondo grado era arrivato l’ergastolo. «I motivi del
ricorso in Cassazione erano legati alle carenti, contraddittorie e insussistenti
motivazioni della Corte d’Assise d’Appello», spiega l’avvocato Alessandro
Doglioni che difende l’imputata assieme al collega Enrico Busetto, «Per questo a
mio parere i giudici di secondo grado dovrebbero riprendere in mano tutta la
sentenza e rivalutare il processo nella sua interezza». Tutto si gioca
sul movente del delitto. Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado si
legge: «In primo grado era rimasto ignoto il movente. Ora, però, le indicazioni
provenienti dalla Lazzarini consentono di colmare tale lacuna: la Busetto (...)
ha aderito alla richiesta di aiutarla a finire Taffi Pamio utilizzando il
“pretesto” per farla finita con quella donna che la “sputtanava” e non le stava
simpatica». «Difficile limitare la questione ai futili motivi, va presa in
considerazione la questione dell’attendibilità della Lazzarini», chiarisce
l’avvocato Doglioni.
Susanna “Milly” Lazzarini, rea confessa
dell’omicidio Taffi Pamio, dopo quattro interrogatori davanti alle pm Lucia
D’Alessandro e Alessia Tavarnesi in cui si era addossata la colpa, aveva tirato
in ballo Busetto, sostenendo che fosse stata lei a finire l’anziana con una
coltellata al collo. Tra le altre prove a carico di Busetto, il dna della
vittima trovato su una catenina rinvenuta a casa dell’operatrice sociosanitaria.
«Una contaminazione» per la difesa. Entro 30 giorni saranno depositate le
motivazioni della sentenza e gli avvocati imposteranno la strategia difensiva in
vista del nuovo processo che verosimilmente non sarà celebrato prima
dell’inverno. Nei prossimi giorni i difensori effettueranno i conteggi sulla
pena già scontata. Non è escluso che tra alcuni mesi Monica Busetto possa uscire
di cella. Ma l’ipotesi al momento sembra piuttosto lontana. Ieri intanto i suoi
difensori sono andati a trovarla a Verona. Quando li ha visti, Monica ha pensato
di essere libera. Capita la situazione, si è sfogata: «Non ce la faccio più».
PRESUNTO COLPEVOLE. GIUSEPPE LA MASTRA.
Il calvario del maresciallo assolto
dall’accusa di mafia e di nuovo sotto processo, scrive
Simona Musco il 25 Agosto 2017 su "Il Dubbio". Per la procura generale che ha
chiesto una nuova inchiesta, due indagini per concorso esterno, due
archiviazioni e una assoluzione non sono ancora sufficienti. Due indagini per
concorso esterno, due archiviazioni e un’assoluzione. Ma il «calvario»
giudiziario di Giuseppe La Mastra, maresciallo dei carabinieri ora in servizio
al nucleo radiomobile di Palagonia (Ct), è lontano dalla parola fine. A
raccontarlo è lui stesso, in un esposto indirizzato al procuratore generale
della Cassazione, al Csm e al Presidente della Repubblica e firmato anche dal
suo avvocato, Giuseppe Lipera, col quale si chiede a chi di dovere di verificare
il comportamento dei magistrati in quello che viene considerato un «inspiegabile
accanimento giudiziario». La Mastra, nell’arma dal 1991, negli ultimi 10 anni è
stato comandante della stazione di Catenanuova, Comune ad alta intensità
delinquenziale. «Ho sempre svolto le mie delicatissime funzioni con il massimo
della professionalità, sprezzo del pericolo, dedizione assoluta alla legge e
alla magistratura», racconta il maresciallo. Che si sente stretto nella morsa di
una giustizia ingiusta, fatta di accuse pesantissime. «L’onta dell’arresto, una
lunga e inspiegabile indagine per il reato di concorso esterno in associazione
mafiosa, poi sfociata in archiviazione, ed un processo dinanzi al Tribunale di
Enna: ecco ciò che è stato riservato ad un servitore dello Stato come me»,
afferma La Mastra. È un collaboratore di giustizia a tirare in ballo La Mastra,
accusandolo di essere vicino al clan Cappello. Una dichiarazione che, a maggio
2012, sfocia in un’indagine della Dda di Caltanissetta per concorso esterno e in
una perquisizione al comando dei carabinieri da lui diretto. «Purtroppo la Dda
di Caltanissetta non ha fatto chiarezza in tempi ragionevoli: non solo ho dovuto
convivere per oltre due anni con questa terribile ed infondata accusa, ma,
difficile a credersi, dopo una prima archiviazione, ha dovuto assistere ad una
inspiegabile riapertura di indagini, basata su cosa non è stato dato sapere»,
racconta il maresciallo. Anche la seconda indagine si chiude con
un’archiviazione, giungendo alla conclusione che La Mastra non ha mai favorito
la mafia. Ma durante la perquisizione vengono trovate nell’armadio destinato ai
reperti di reato alcune cartucce ed alcune munizioni. Il comandante viene così
arrestato e sospeso dal servizio, finendo a processo davanti al Tribunale di
Enna. L’accusa è di aver detenuto illegalmente quelle munizioni e di aver
rifiutato atti del suo ufficio in relazione alle stesse. Il processo si è chiuso
ad ottobre, con un coro unanime: La Mastra non ha commesso quel reato. Ne è
convinto il pm Augusto Rio, che ha chiesto l’assoluzione, e ne sono convinti i
giudici, che hanno ritenuto infondata l’accusa. Ma il calvario non è finito. Il
sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Caltanissetta, Fabio
D’Anna, ha infatti proposto appello, riaprendo «la mia personalissima quanto
immeritata “via crucis” giudiziaria» . La Mastra parla di «stranezze» nell’atto
di impugnazione proposto dalla Procura generale di Caltanissetta. «Non è un
appello come tutti gli altri», dice il militare. Viene chiesta la rinnovazione
dell’istruttoria, ritenendo insufficiente l’attività della Procura di Enna nel
processo di primo grado. Dall’accusa di concorso esterno alla fine del processo
sono passati intanto cinque anni. «Mi sento un vero e proprio perseguitato –
spiega Questo è francamente troppo, specie per un maresciallo dei carabinieri
che, per altro, in questi anni, ha dovuto convivere con l’atroce e prematura
scomparsa della propria moglie, portata via da una lunga ed invincibile
malattia». Nei motivi d’appello, la Procura generale accusa i giudici di primo
grado di essersi appiattiti sulle dichiarazioni di La Mastra durante il
processo. Il Tribunale ha evidenziato che le munizioni erano nell’armadio
destinato ai reperti di reato, punto principale, secondo i giudici, per ritenere
la non configurabilità del reato, che escluderebbe la detenzione delle munizioni
a titolo personale. Quella stanza, inoltre, durante i giorni in cui La Mastra
era assente, era a disposizione degli altri militari, per cui «se solo ci fosse
stato un fine illecito non le avrei mai custodite in quell’armadietto ed in
quella stanza», ha spiegato lo stesso maresciallo. Che lasciava la chiave in
ufficio, allontanandosi spesso a causa della malattia della moglie. «La
detenzione delle munizioni da parte del La Mastra non assume i caratteri
dell’illegalità – si legge nella motivazione – tale detenzione, infatti, si
inquadra nell’esercizio delle funzioni rimesse al La Mastra». Munizioni
custodite non a titolo personale «ma per ragioni di ufficio», nella
disponibilità di «chiunque avesse avuto titolo per richiederle, visionarle o
prelevarle». Non sussiste, per i giudici, nemmeno l’accusa di mancata adozione
di atti d’ufficio, dato che nessun accertamento è stato fatto per verificare
l’effettiva mancanza di atti giustificativi della detenzione delle cartucce.
Inoltre nel corso delle indagini furono man mano rinvenuti tutti gli atti
pertinenti a ciascuna arma, con il conseguente dissequestro. Posizione non
condivisa dalla procura generale, che invece escluderebbe l’accesso a terzi a
quella stanza se non per consultare atti d’ufficio. Per La Mastra si tratta
invece di una sorta di «persecuzione giudiziaria», di «fango» che ha portato
l’uomo a dubitare delle «ragioni che stanno alla base di tale inspiegabile
accanimento». Una vicenda che gli è costata due giorni nel carcere militare di
Santa Maria Capua Vetere, due mesi di arresti domiciliari a Castel di Iudica e,
dopo la scarcerazione, anche il divieto di dimora in Catenanuova. «Questa storia
non ci convince – commenta l’avvocato Lipera – probabilmente qualcuno sta
tentando di riparare alla brutta figura fatta con le indagini a suo carico.
Questa impugnazione non si comprende: non c’è parte civile, c’è un’assoluzione
su conforme richiesta del pm. Hanno distrutto la sua vita: la sospensione dal
servizio è durata diversi anni, con conseguenze economiche anche rilevanti e il
blocco della carriera. Fosse capitato ad un magistrato il processo sarebbe stato
molto più veloce. Invece è un carabiniere e deve passare le pene dell’inferno».
PRESUNTO COLPEVOLE. GIOVANNI CAMASSA.
Venne condannato il 48enne Giovanni
Camassa. Oggi possibili nuove indagini,
scrive Stefania Congedo su TGnorba il 18 novembre 2017. A distanza di 15 anni
potrebbe riaprirsi il caso dell’omicidio di Angela Petrachi, la donna di 31 anni
rinvenuta brutalmente seviziata in un boschetto in agro di Borgagne, frazione di
Melendugno il 26 ottobre del 2012. Un delitto per il quale è stato condannato in
via definitiva Giovanni Camassa, un agricoltore di 48 anni. I giudici della
Corte d’Assise d’Appello di Lecce hanno infatti accolto, dopo averla rigettata
una prima volta, l’istanza depositata dal nuovo avvocato difensore di Camassa,
avvocato Ladislao Massari, per lo svolgimento di indagini genetiche autorizzate,
necessarie per comprendere attraverso l’analisi dei reperti e le tracce
biologiche rinvenute sul luogo del delitto, se ci siano profili genetici
incompatibili con Camassa. Reperti che oggi alla luce delle nuove tecnologie
potrebbero portare a ricavare il profilo biologico dell’assassino e, nel caso
questo non combaciasse con quello dell’agricoltore melendugnese, ad una
possibile revisione del processo. Camassa ha sempre negato di essere l’autore
del delitto. Si tratta del primo caso di indagini difensive genetiche
autorizzate finalizzate alla revisione di un processo.
Angela Petrachi. Il Delitto di Melendugno. La
condanna di Giovanni Camassa è un errore giudiziario?
Il caso del delitto di Angela Petrachi, che ha
sconvolto non solo Melendugno e la provincia di Lecce, ma anche tutta Italia. Di
lei si è interessato il programma di Rai3: “Chi La Visto?
Se ne occupa Antonio Giangrande, noto autore di
saggi pubblicati su Amazon, tra cui “Giustiziopoli, disfunzioni che colpiscono
il singolo”, “Malagiustiziopoli, disfunzioni che colpiscono la collettività”,
oltre che “Tutto su Lecce, quello che non si osa dire”. Libri che raccontano
questa Italia alla rovescia. Giangrande per una scelta di libertà si pone al di
fuori del circuito editoriale. Libri dettagliati che fanno la storia, non la
cronaca, perché fanno parlare i testimoni del loro tempo.
«Sono orgoglioso di essere diverso. In un mondo
caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi
sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che
cazzo di vita è? Faccio mia l’aforisma di Bertolt Brecht. “Ci sedemmo dalla
parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini
che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi,
ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli
che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili.” Rappresentare con
verità storica, anche scomoda, ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!»
Continua Antonio Giangrande «E’ comodo definirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto
di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. Faccio ancora mia un
altro aforisma di Bertolt Brecht “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali.
«Del delitto di Angela Petrachi – racconta
Giangrande - ne dava conto il 9 novembre 2002 lo stesso Corriere della Sera a
firma di Roberto Buonavoglia. “I genitori pensavano che fosse fuggita, forse con
un uomo. L' hanno cercata per 5 giorni prima di dare l' allarme. Ieri mattina,
invece, Angela Petrachi, 31 anni, separata e madre di due bambini, è stata
trovata morta da un cercatore di funghi in un boschetto di querce alla periferia
di Melendugno, 15 chilometri da Lecce. Aveva la gonna arrotolata sui fianchi.
Nessuna traccia degli indumenti intimi. Gli abiti, invece, erano strappati ma
erano gli stessi che la vittima indossava il giorno della scomparsa, il 26
ottobre, quando lasciò i figli di 7 e 11 anni nella casa materna dicendo: «Torno
subito». Sul cadavere il medico legale che oggi compirà l'autopsia, Alberto
Tortorella, ha riscontrato tante sevizie da far dire agli investigatori che «il
killer si è accanito sul corpo della povera donna». Angela Petrachi sarebbe
stata attirata in una trappola dall'assassino, che quasi certamente conosceva.
Forse l'uomo ha tentato di violentarla e lei ha resistito. L'ha colpita al volto
con un bastone o una pietra, ha messo il corpo faccia in giù e l'ha trascinato
per alcuni metri fino a nasconderlo dietro un cespuglio. Poi, prima di fuggire,
l'assassino ha infierito sul cadavere. Uno sfregio, secondo i militari, che
farebbe pensare a un delitto a sfondo sessuale forse riconducibile al giro di
frequentazioni della donna. Proprio su conoscenti e amici di Angela Petrachi
indagano ora i carabinieri che stanno controllando i tabulati delle schede
telefoniche della donna e stanno scavando nella sua vita privata. La vittima,
che svolgeva lavori saltuari, era separata da due anni dal marito, un militare
al quale la famiglia non aveva perdonato di aver sposato Angela. Dopo la rottura
del matrimonio la donna aveva frequentato un altro uomo che, alla fine della
relazione, l'aveva denunciata sostenendo che la 31enne teneva comportamenti
diseducativi con i figli. Per questo i due bambini erano stati affidati per 5
mesi a un istituto di Oria (Brindisi), fino al ritiro della denuncia. E proprio
per impedire che alla donna venissero sottratti di nuovo i bimbi i suoi genitori
hanno aspettato 5 giorni prima di denunciarne la scomparsa. Una perdita di tempo
forse fatale: un testimone ha detto ai carabinieri di aver visto la donna 24 ore
dopo la scomparsa.”. Angela Petrachi viveva a
Melendugno, con i figli di 5 e 7 anni. Alle 14.30 di sabato 26 ottobre 2002,
dopo aver pranzato con i figli in casa dei propri genitori, si allontanò dicendo
che sarebbe andata per un’ora a casa sua e poi sarebbe tornata in tempo per
accompagnare il figlio maggiore al catechismo. Ma questa evoluzione dei fatti
non si verificò mai. Giovedì 31 i genitori di Angela vennero avvisati che l’auto
della figlia si trovava nello spiazzo adiacente il campo sportivo, con la ruota
posteriore destra a terra per un chiodo conficcato nel copertone. All’interno i
documenti dell’auto e il giubbino. Secondo alcune testimonianze sarebbe stata
parcheggiata lì fin dal pomeriggio di sabato. I documenti di Angela vennero
ritrovati un paio di giorni. Non si seppe più nulla fino alle 8,30 circa di
venerdì 8 novembre, quando il corpo di Angela venne trovato da un cercatore di
funghi. Era in un boschetto, nelle vicinanze della strada su cui erano stati
rinvenuti i documenti e la borsa. Indossava ancora i vestiti che aveva quando
era uscita dalla casa dei genitori. Le indagini dei carabinieri si concentrarono
da subito sull’ex fidanzato della donna al quale Angela, quel sabato 26 ottobre,
aveva inviato ben 14 messaggi, tra le 17 e le 23. Nonostante tutto questo,
invece è stato condannato Giovanni Camassa. Secondo la ricostruzione degli
inquirenti, i due si erano dati appuntamento per l’acquisto di un cane ma
l’incontro ben presto degenerò. Come accertato dal medico legale, Angela fu
vittima di uno stupro, poi soffocata con le sue stesse mutandine e infine
accoltellata. Di quel delitto fu accusato e condannato in via definitiva
il 26 febbraio 2014 Giovanni Camassa. La corte di Cassazione ha confermato la
condanna alla pena dell'ergastolo per Giovanni Camassa, l'agricoltore 45enne
ritenuto responsabile dell'omicidio di Angela Petrachi, la 31enne uccisa
brutalmente nell'ottobre del 2002 nelle campagne di Melendugno (Lecce). I
giudici di primo grado avevano assolto l'imputato per non aver commesso il
fatto; in appello, invece, l'imputato fu condannato al carcere a vita. Angela
Petrachi, madre di due figli, uscita dalla casa dei genitori nel primo
pomeriggio del 26 ottobre 2002, scomparve nel nulla. Il suo corpo venne
ritrovato solo la mattina dell'8 novembre da un cercatore di funghi. L'autopsia
rivelò che la donna era stata violentata, strangolata con i suoi slip e
seviziata con la lama di un coltello. Secondo l'accusa, l'imputato e la vittima
si sarebbero incontrati nel pomeriggio del 26 ottobre per discutere
dell'acquisto di un cane. Durante l'incontro, però, la situazione sarebbe
degenerata e l'uomo, colto da un raptus forse perchè invaghito della donna,
avrebbe aggredito Angela Petrachi uccidendola. Carcere
a vita. E’ il verdetto emesso dai giudici della Suprema Corte dopo circa quattro
ore di camera di consiglio. Ci sono voluti la sbobinatura di 400 file, la
ripulitura di centinaia e centinaia di intercettazioni, un lavoro meticoloso da
parte dell’ingegnere informatico Luigina Quarta e una nuova istruttoria
dibattimentale per riscrivere una nuova inaspettata verità nel processo istruito
per fare luce sull’omicidio di Angela Petrachi, avvenuto il 26 ottobre del 2002.
I giudici di secondo grado, Presidente Roberto Tanisi, a latere Rodolfo Boselli,
condannarono all’ergastolo il presunto assassino, Giovanni Camassa, 44enne di
Melendugno, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto dopo aver
trascorso due anni e mezzo di carcere. Camassa si è sempre giustificato
affermando che quel giorno si trovava in compagnia della propria compagna, ma
gli accertamenti tecnici avrebbero ribaltato l’impianto difensivo costruito
dall’avvocato difensore Francesca Conte che aveva evidenziato come non vi
sarebbe mai stato un movente e fatto notare l’esistenza di rapporti burrascosi
tra la donna e il suo ex marito, tanto che la Petrachi presentò anche una
querela. I figli di Angela erano assistiti dall’avvocato Tiziana Petrachi.
Dopo la pronuncia della colpevolezza ribadita, in via definitiva, dalla
Cassazione i carabinieri della Stazione di Martano hanno arrestato Giovanni
Camassa, 47enne, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione
emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Lecce, in seguito alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione per l’omicidio
di Angela Petrachi. Camassa, dopo le formalità di rito è stato tradotto alla
Casa Circondariale di Lecce dove dovrà scontare la pena. Il ricorso alla Suprema
Corte era stato presentato dall’avvocato difensore Francesca Conte, che ha
sempre insistito sull’inesistenza di un movente che potesse spiegare il brutale
assassinio. L’autopsia permise di stabilire che la giovane era stata violentata,
strangolata e seviziata. A distanza di poco tempo i sospetti degli inquirenti si
concentrarono su Giovanni Camassa, con il quale la Petrachi aveva un
appuntamento il giorno della sua scomparsa per concordare l’acquisto di un cane.
Al termine del processo di primo grado l’uomo fu assolto, mentre in Appello
arrivò la condanna all’ergastolo da parte dei giudici a cui poco convincente
risultò anche l’alibi fornito dal presunto assassino, che ha sempre sostenuto di
avere trascorso il pomeriggio del 26 ottobre con la donna che in seguito diventò
sua moglie. L’accusa ha analizzato e confutato l'alibi
dell'imputato, dimostrando, attraverso riscontri di natura tecnica che, secondo
il pubblico ministero hanno evidenziato come le “risultanze delle consulenze di
parte siano prive di significato”, che l'imputato e la moglie non erano insieme
in quel tragico pomeriggio macchiato di sangue. Camassa, infatti, ha sempre
affermato che quel triste giorno di ottobre era proprio in compagnia di quella
che sarebbe poi divenuta sua moglie, Moira Flamini. Un passaggio fondamentale
questo. La difesa di Camassa, rappresentata dall’avvocato Francesca Conte, aveva
presentato ricorso in Cassazione. La penalista leccese ha sempre evidenziato
come non vi fosse un movente dell’omicidio. Non sarebbe mai stato concordato,
infatti, alcun incontro per l’acquisto di un cane, come sostenuto dall’accusa.
Nella denuncia di scomparsa non vi è alcun riferimento, né nella successiva
integrazione. La vicenda relativa al cane emergerebbe sol alcuni mesi dopo. Quel
pomeriggio Angela Petrachi avrebbe dovuto incontrare, con ogni probabilità, due
amiche. Una testimone, ritenuta inspiegabilmente inattendibile ha spiegato la
difesa, vede alle 14.50 la donna salire su una Lancia Thema blu. L’avvocato
Conte ha poi evidenziato come i rapporti tra la 31enne e l’ex marito fossero a
dir poco burrascosi, tanto che la stessa aveva in passato presentato una querela
nei suoi confronti. Appare singolare, secondo la nota penalista leccese, come
l’alibi dell’uomo sia stato verificato telefonicamente, contattando una donna
che, secondo la sua versione, era con lui quel pomeriggio. Tesi e ipotesi che
non hanno trovato riscontro nei giudici, che hanno deciso di scrivere le parole
“fine pena mai” sul fascicolo di Giovanni Camassa. A sollevare l’interesse sul
caso ci ha pensato il nipote di Camassa che ha chiesto il mio aiuto, certamente
non per risolvere il caso, né per porvi giustizia, incarico delegato alle toghe,
magistrati ed avvocati, ma per sollevare un velo pietoso sulla spinosa vicenda.
Testimonianza che è già stata riportata dal tg di Telenorba il 12 marzo
2014 e da un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno
del 13 marzo 2014. Egli mi scrive: “Sono Francesco Di Cianni, Vi scrivo
da Martignano, piccolo Comune della Provincia di Lecce, per illustrarVi una
situazione gravissima e che vede protagonista un uomo, mio zio, detenuto
ingiustamente per quasi 4 anni, e cosa ancor più grave, condannato all’ergastolo
in via definitiva, al termine di un Processo quanto mai strano e anomalo, che
non ha tenuto in considerazione aspetti fondamentali e prove che,
"senza ogni ragionevole
dubbio", se fossero state
considerate, avrebbero dimostrato l'assoluta innocenza ed estraneità ai fatti di
quella che invece appare essere solo un caprio espiatorio a protezione di chissà
chi o quale persona, invece evidentemente più influente di un normalissimo
cittadino onesto, che ad oggi è invece libero ingiustamente! I fatti,
brevemente, e che avremo modo sicuramente di affrontare e spiegarVi più nel
dettaglio attraverso tutte le carte processuali, riguardano l'omicidio di Angela
Petrachi, avvenuto nel 2002 in un Comune della medesima provincia di Lecce,
Melendugno, e per il quale è stato condannato per l'appunto mio zio, Giovanni
Camassa, senza nessuna prova e anzi con molti punti interrogativi e sospetti. A
parziale dimostrazione di ciò, era stato anche assolto con formula piena per non
aver commesso il fatto in primo grado in Corte di Assise dal Giudice Giacomo
Conte. Lo stesso Giudice infatti, al tempo dei fatti, dispose anche la
scarcerazione immediata dell'imputato. L'amara sorpresa giunse però in Corte
d'Appello, dove, come per magia, venne ribaltata la sentenza di primo grado (che
venne commutata in ergastolo, il massimo della pena prevista dal Codice Penale
Italiano, e che non viene comminata nemmeno ai Mafiosi, ma che evidentemente nel
caso di mio zio doveva cancellare in fretta il reato dalle spalle del vero
esecutore, molto più influente di un povero e comunissimo contadino leccese), e
la definitiva doccia fredda in Cassazione, il 26/02/2014, con la riconferma
dell'ergastolo in capo al mio congiunto. La cosa eclatante non sta nella
condanna in sé (non sarebbe il primo caso di mala giustizia italiana, e forse
neanche l'ultimo nostro malgrado), ma nel fatto che nei gradi successivi al
primo non sono state prese in considerazione prove eclatanti (una su tutte la
perizia del R.I.S. che scagionava l'imputato, e lo stesso Capitano del R.I.S.
che scriveva testualmente nella relazione "…..escludiamo
Giovanni Camassa dall'ipotesi che avesse potuto commettere il fatto."), o
testimonianze di persone che confermavano l'alibi di mio zio. Al tempo stesso,
non sono stati presi in considerazione fatti importanti e sicuramente decisivi
al fine dell'esito processuale (se appunto considerate), quali le denunce per
percosse alla povera vittima antecedenti il suo omicidio, o posizioni di persone
quanto meno sospette che dalle 17.00 alle 23.00 ricevevano messaggi da parte
della Petrachi anche dopo la presunta morte (che secondo l’accusa è avvenuta
intorno alle 13.00) e la presenza del loro DNA sul corpo della vittima e le
quali ad oggi sono libere e le cui posizioni non sono mai state affrontate
processualmente!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da ultimo abbiamo la testimonianza di nuove
persone che finalmente sembra abbiano trovato la forza di testimoniare a favore
di mio zio, dopo anni di terrore e paura per la loro incolumità.”. Ben venuto
nel club, direi a Francesco ed a tutti i disillusi da questa giustizia. Peccato
che a contarli tutti vien l’orticaria. Ben 5 milioni di errori giudiziari ed
ingiuste detenzioni negli ultimi 50 anni. Se sembran pochi per alimentare un
dubbio su come funziona la giustizia in Italia, vuol dire che vale il detto già
richiamato: “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la
chiama bugia, è un delinquente”.»
PRESUNTO COLPEVOLE. VITTORIO EMANUELE DI
SAVOIA.
Vittorio Emanuele di Savoia assolto: non
riciclò denaro sporco con i videopoker, scrive Oggi il
23 settembre 2010. Vittorio Emanuele di Savoia era stato in carcere per una
settimana nel 2006. Accusato di riciclare soldi sporchi con i videopoker. Oltre
che di altri gravissimi capi d’imputazione. Oggi l’assoluzione piena da parte
del gup di Roma «perché il fatto non sussiste». Vittorio Emanuele di Savoia è
stato assolto «perché il fatto non sussiste». E con lui anche gli altri cinque
imputati nel processo per la vicenda dei nulla osta legati ai videopoker, caso
scoperto nel 2006 dalla magistratura di Potenza. Allora il principe finì in
carcere per una settimana su iniziativa del pm Henry John Woodcock. La sentenza
di proscioglimento è stata pronunciata dal gup di Roma Marina Finiti. Oltre a
Vittorio Emanuele, il procedimento riguardava l’imprenditore messinese Rocco
Migliardi (definito nel capo di imputazione «soggetto legato alla criminalità
organizzata» nonchè gestore di aziende di distribuzione di videogiochi), Nunzio
Laganà, suo stretto collaboratore, e poi Ugo Bonazza, Gian Nicolino Narducci e
Achille De Luca, ritenuti gli organizzatori di quella che fu subito definita la
«holding del malaffare». Secondo l’ipotesi accusatoria, l’associazione per
delinquere era dedita anche a operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da
attività illecita tramite l’instaurazione di relazione con Casinò autorizzati, a
cominciare da quello di Campione d’Italia. Per questa vicenda Vittorio Emanuele,
che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestati, fu arrestato il 16
giugno del 2006 e rimase in carcere per una settimana. «L’assoluzione di oggi»,
commenta uno degli avvocati difensori, «consente di ribadire con maggiore forza
che gli arresti eseguiti quattro anni fa si fondavano su accuse inconsistenti».
PRESUNTO COLPEVOLE. CLAUDIO BURLANDO.
Il ministro dei Trasporti Claudio
Burlando sarà risarcito con 60 milioni dal suo collega di governo Carlo Azeglio
Ciampi, ministro del Tesoro, per l’ingiusta detenzione subita nel maggio del ’93
dall’ex sindaco pidiessino per l’affaire del Sottopasso di Caricamento,
scrive La Stampa il 12 dicembre 1997. Lo hanno stabilito i giudici della seconda
sezione penale della corte d’appello con un’ordinanza che è stata depositata
ieri mattina e in cui è stato deciso anche un rimborso di un milione di lire a
favore di Burlando per le spese legali. L’uomo politico pidiessino era stato
arrestato il 19 maggio del ’93 con l’accusa di truffa aggravata e di abuso
d’ufficio. Rimase in carcere per sei giorni e, poi, ottenne gli arresti
domiciliari che finirono il 31 maggio. Dopo circa quattro anni ed esattamente il
27 gennaio scorso il giudice dell’udienza preliminare lo assolse con formula
piena da tutti e due i reati. Quella sentenza è poi passata “in giudicato” e
cioè resa definitiva e irrevocabile il 12 aprile di quest’anno. Dopodiché
Burlando ha affidato all’avvocato Giuliano Gallanti attuale presidente
dell’Autorità portuale genovese, il compito di richiedere il risarcimento del
danno allo Stato e specificamente al ministero del Tesoro. Oltre a Gallanti era
associato, nei primi tempi dell’inchiesta, un altro avvocato chiamato poi a
importanti cariche istituzionali: Giovanni Maria Flick che quando è divenuto
appunto ministro di Grazia e Giustizia ha abbandonato, com’è ovvio, la difesa. I
giudici in sostanza dicono che la quantificazione dell’indennizzo per l’ingiusta
detenzione deve tenere conto del fatto che Burlando quando fu arrestato era
sindaco di Genova e dovette dimettersi. Non gli hanno, però, riconosciuto i 100
milioni previsti come massimo perché la “perdita d’immagine è stata prontamente
recuperata” dall’ex sindaco diventato ministro, come ha osservato l’avvocato
dello Stato Giuseppe Novaresi.
PRESUNTO COLPEVOLE. GIGI SABANI.
Arrestato, umiliato e messo al bando:
l'infarto fu casuale? Scrive Franco Insardà il 10 ago
2016 su “Il Dubbio”. Le accuse per Gigi Sabani furono archiviate, ma lo scandalo
distrusse la sua carriera. Tra la sua ex e il pm Chionna, che lo indagava,
scoppiò il classico colpo di fulmine e lui commentò: "Beffa nella beffa. Sono
proprio una bella coppia e Anita ha saputo scegliere bene: è passata
dall'accusato all'accusatore". «Che mi hanno combinato! Così mi diceva Gigi da
quella finestra, in quella casa dove era ai domiciliari, quando mi vedeva
passare in strada. Io cercavo di rincuorarlo dicendogli di stare tranquillo, che
presto sarebbe finito tutto. Tredici giorni in casa che, per uno come lui
abituato a stare sempre in mezzo alla gente, sono stati una vera
sofferenza». Edy, gestore dal 1990 con la moglie Francesca di un bar in largo
Tassoni, ricorda bene quei giorni che hanno segnato per sempre la vita del suo
amico Gigi Sabani, che viveva nell'appartamento a pochi passi dalla sua attività
in via dei Banchi Nuovi. Alla cassa del bar fa bella mostra di sé una foto con
Gigi sorridente come al solito, che lo abbraccia, più piccoli altri due scatti:
uno sempre con Sabani e un altro che ritrae un arzillo vecchietto. «È Aristide,
aveva un'osteria qui a fianco. Quando chiudeva veniva qui e cantava stornelli e
canzoni romanesche e Gigi si divertiva tanto», ricorda Edy. Quando furono
revocati gli arresti domiciliari per il quartiere fu una festa. «Tutti si
riunirono qui in piazza Tassoni, ognuno portava una bottiglia per brindare, per
Gigi fu un'iniezione di vita. Io cercavo di stemperare l'entusiasmo, anche nei
giorni successivi, ma lui mi diceva: lasciali fare». Aveva bisogno dell'affetto
del suo pubblico per riprendersi da quella brutta avventura. La sua era una
carriera che fino a quel momento non aveva conosciuto stop: tanti spettacoli,
programmi televisivi anche da conduttore, premi. Una vita sulla cresta dell'onda
che viene bruscamente interrotta con un danno di immagine incalcolabile. In
poche ore Sabani si ritrovò nella polvere, travolto da un'accusa falsa e
infamante. La prima Vallettopoli - la seconda è legata al pm di Napoli,
all'epoca a Potenza, Henry John Woodcock - era partita da Biella con l'inchiesta
sulla scuola per modelle "Celebrità", che avrebbe ospitato incontri privati fra
le ragazze e uomini di spettacolo con l'obiettivo di ottenere contratti al
cinema o in tv. L'accusa per Gigi Sabani fu di truffa a fini sessuali e
induzione alla prostituzione e per questo il 18 giugno del 1996 fu arrestato. A
metterlo nei guai furono le dichiarazioni dell'allora minorenne Katia Duso,
aspirante showgirl, che raccontò al pm Alessandro Chionna di approcci sessuali
con Sabani, a Roma, nell'estate 1995, in cambio della promessa di un aiuto per
lavorare nello spettacolo. Edy ricorda bene quel giorno: «Gigi stava sempre qui
da noi. Mi disse di far mangiare una ragazza che avrebbe dovuto accompagnare a
fare un provino. Era andata a prenderla alla stazione Beppe Pagano (ex factotum
e autista di Sabani per anni, diventato uno degli accusatori) la portò al bar,
poi arrivò Gigi e insieme andarono all'Hilton per i provini. In serata mi
telefonò e mi disse che stava facendo fare un giro in macchina alla ragazza,
prima di accompagnarla a prendere il treno. Tutto qui». In quella vicenda
insieme a Sabani furono coinvolti anche Valerio Merola e Raffaella Zardo. Il
primo diventato per tutti il "Merolone", perché la difesa dell'avvocato si basò
anche sulle presunte "grandi dimensioni" del pene del suo assistito che non
avrebbero potuto rendere possibile la violenza di cui era accusato (induzione
alla prostituzione, atti di libidine violenta e violenza carnale) fu rinchiuso
per dieci giorni nel carcere a Regina Coeli. La Zardo fu indagata e messa agli
arresti domiciliari durante le indagini, con l'accusa di aver indotto tre
ragazze alla prostituzione. L'indagine del pm Chionna si allargò anche a Gianni
Boncompagni, al quale venne notificato un avviso di garanzia con la
contestazione da parte del pm biellese dell'accusa di induzione alla
prostituzione. Per tutta l'estate i pm Chionna e Serianni interrogarono decine
di ragazze che in quegli anni avevano avuto un ruolo nella trasmissione Non è la
Rai, poi chiesero l'archiviazione per l'inventore di Alto gradimento e di tante
altre trasmissioni di successo. Gigi Sabani, difeso dall'avvocato Vincenzo
Siniscalchi, venne scarcerato il 1 luglio e presentò una denuncia per abuso
d'ufficio nei confronti di Chionna. L'inchiesta fu trasferita a Roma per
"incompetenza territoriale" del foro di Biella e il 13 febbraio 1997 arrivò la
richiesta di archiviazione del pm Pasquale Lapadura, accolta dal gip il 18
febbraio 1997. Per l'ingiusta detenzione Sabani ottenne il risarcimento di 24
milioni di lire. La quarta sezione della Corte di appello di Roma sentenziò:
«Posto che la detenzione si riferisce al giugno sembra che il calo degli
introiti netti del '97 (154 milioni di lire rispetto ai 400 dell'anno
precedente) non sia ad essa correlata direttamente e che dipenda da altre
ragioni: esistenza del procedimento penale a carico, che non è produttiva di
diritti alla riparazione; e diffusione, tramite i mezzi di comunicazione, delle
notizie circa la posizione di Sabani con riferimento a suoi interrogatori». «Il
discredito sociale riparabile - hanno rilevato i giudici - è solo quello
dipendente dalla detenzione e non dalla imputazione», e «la detenzione si svolse
tutta agli arresti domiciliari, regime meno afflittivo di quello della custodia
cautelare in carcere». Ma Sabani più volte commentò amaramente: «I giudici sono
gli unici che non pagano mai anche se sbagliano». Vittorio Sgarbi, un
personaggio che non le manda a dire, sulla figura di Sabani tombeur de femmes
espresse all'epoca un'opinione molto precisa: «È un'accusa ridicola. Si tratta
del tipico non trombatore. Sabani che molesta? Andiamo. Lo incontravo sempre al
ristorante Matriciano, verso l'una di notte, circondato da un codazzo di semi
gorilla e altri personaggi... ». Un ruolo confermato anche dall'amico del cuore
di Gigi: «Dopo la separazione dalla moglie comprò l'appartamento di via dei
Banchi Nuovi da Amy Stewart e, se non era in giro per fare spettacoli, stava
sempre qui al bar. Eravamo la sua famiglia. Quando aveva qualche lieve malanno
mia moglie gli preparava una semplice minestrina, ma per lui era una cosa
eccezionale. Spesso veniva suo figlio Simone che è diventato amico di mio
figlio: un rapporto che continua anche oggi». Quello di Gigi e le donne è un
capitolo particolare perché dalle cronache e dai racconti emerge il ritratto di
un uomo semplice, al quale piaceva stare in mezzo alla gente, farsi fotografare
con i suoi fan, ma che è stato nella sua vita spesso solo. Dopo la separazione
dalla moglie, Rita Imperi, dalla quale ha avuto il figlio Simone, Gigi ha avuto
altre donne che, ognuna a suo modo, hanno segnato la sua vita. Anita
Ceccariglia, sua fidanzata per quattro anni, ex di Non è la Rai, fu convocata
alla procura di Biella come testimone dal pm Chionna, all'epoca 29enne.
Quell'incontro fu galeotto. Tra la ragazza e il pm, appassionato anche di motori
tanto da disputare gare del Campionato italiano velocità turismo, scoccò la
scintilla. Il dottor Chionna lasciò l'inchiesta, ma Gigi Sabani chiosò: «Beffa
nella beffa. Sono proprio una bella coppia e Anita ha saputo scegliere bene: è
passata dall'accusato all'accusatore». E Valerio Merola aggiunse amaramente: «Se
i primi incontri fra i due si fossero svolti mentre l'inchiesta era ancora nelle
mani di Chionna, ci sarebbe da meditare». Alla fine della vicenda biellese Gigi
si fidanzò con Fabiana Savi e decise di andare via dall'appartamento di via dei
Banchi Nuovi. «Per me e per tutti noi che gli siamo stati vicini in questi anni
- racconta oggi Edy - è stato quasi un tradimento. Gigi mi diede tutte le targhe
e i Telegatto che aveva vinto nella sua carriera: "Tienili tu mi disse, so che
ti fa piacere". E io li conservo come fossero reliquie del mio amico. Queste
sono le chiavi dell'appartamento di via dei Banchi Nuovi e questi i doppioni di
una delle sue macchine, una Mercedes decappottabile. Dopo il trasferimento è
venuto sempre qui al bar, ma spesso era triste, soprattutto per quel marchio che
si portava addosso, nonostante fosse tutto finito». Dopo sei anni anche quella
storia giunse all'epilogo. Poi ci fu l'ultimo amore della sua vita, scoppiato un
anno prima della morte. È Gabriella Ponzo, un'attrice che dopo un inizio nel
cinema (Il corpo dell'anima e Quartetto di Salvatore Piscicelli, un piccolo
ruolo in Gangs of New York di Martin Scorsese, protagonista con Tinto Brass
in Fallo), ha continuato la sua carriera anche in teatro. Qualche giorno dopo la
morte di Gigi, Gabriella Ponzo ha scoperto di aspettare un bambino: il 19 maggio
2008 nacque Gabriele Sabani. Gigi Sabani non amava ricordare quella vicenda che
gli aveva sconvolto la vita e per la quale tanti che riteneva amici lo avevano
tradito o gli avevano girato le spalle. Nel libro di Antonello Sarno Al cuor non
si comanda - Vallettopoli 1 si sfogò: «Come morire a occhi aperti. Vedi quello
che ti succede e non puoi farci niente. Anzi, una cosa la puoi fare: conti i
buoni, pochissimi. La famiglia, poi Lino Banfi, Gianni Morandi, Arbore,
Celentano, Cutugno e Maurizio, sì Costanzo, più degli altri. Poi i cattivi, cioè
quasi tutti. Perché l'ambiente è una merda». Poi una sera, dopo dieci anni da
quella brutta storia, Gigi è casa della sorella Isabella, nel quartiere
Prenestino dove è cresciuto. Ha bisogno di stare un po' in famiglia, ha
ritrovato l'amore di una donna, non ha mai perso l'affetto del suo pubblico, ma
stenta a rientrare nel giro grosso della tv. Addirittura alcune trasmissioni
ideate e nate per lui vengono affidate ad altri che neanche lo invitano. Quella
sera, il 4 settembre 2007, verso le 20 non si sente bene, chiamano il medico di
famiglia che lo visita ed esclude complicazioni. Ma dopo qualche ora di dura
lotta, purtroppo, il suo cuore non ce la fa. Ai suoi funerali ci sono tante
persone semplici che lo hanno conosciuto e gli amici e i colleghi più cari.
Merola, l'amico coinvolto insieme a lui nell'inchiesta ha parole durissime:
«Questa morte ha una firma. Le ingiustizie alla fine danno questi risultati».
Maurizio Costanzo ribadisce: «Il mio ricordo va a quando, con il Maurizio
Costanzo Show, cercai di ridargli forza perché fu travolto da uno scandalo
finto, che non lo riguardava». Un altro che lo conosceva bene, Pippo Baudo, di
Sabani disse: «Ha avuto un grande, meritato successo. Era un buono e ha sofferto
tantissimo quando è stato accusato ingiustamente. Quella cosa lo ha ferito, non
se lo era mai dimenticato». Un giudizio simile lo diede anche Giancarlo Magalli:
«La vicenda lo aveva danneggiato umanamente e artisticamente. Aveva un forte
senso dell'amicizia, vide molti sparire e ci rimase male, io gli restai vicino,
ma chi fa questo lavoro vive anche dell'amore e della fiducia del pubblico.
Chissà se quello che è successo non sia la conseguenza di tante angosce che si è
tenuto dentro».
Gigi Sabani. Dal successo alla crisi
d’identità. Quel bisogno continuo di sdoppiarsi,
scrive Aldo Grasso, Corriere della Sera, 6 settembre 2007. Accusato con Valerio
Merola di provini a luci rosse, ma la storia finì in niente: prosciolti senza
nemmeno arrivare al processo. Negli arrembanti anni 80 è stato uno dei
protagonisti indiscussi della tv italiana: in Rai con «Domenica in» e
«Fantastico», a Mediaset con «Premiatissima» e «Ok, il prezzo e giusto» e poi
ancora in Rai con «Chi tiriamo in ballo?». Faceva l’imitatore, il suo umorismo
era facile e popolare, una risata la strappava sempre. Gigi Sabani è stato uno
di quei conduttori davanti a cui si aprivano tutte le porte, cui non mancavano
le occasioni per inseguire un successo che pareva senza fine. Poi un bel giorno
qualcosa si è rotto. Nell’estate del 1996 finisce in manette in compagnia di
Valerio Marola. Ad accusarli è il sostituto procuratore di Biella Alessandro
Chionna che, su dichiarazione di Raffaella Zardo, inaugura la prima grande
inchiesta di Vallettopoli: si parla di provini a luci rosse, di favori sessuali.
Un certa Katia sostiene di essersi intrattenuta sul sofà di Sabani in cambio di
una foto con dedica («a spaghettino») e della vaga promessa di una comparsata.
Stesse accuse a Merola, diventato subito «Merolone» perché l’interessato non
esita a sbandierare le misure del suo corpo contundente. La storia finisce in
niente, i due vengono prosciolti senza nemmeno arrivare al processo. Per giunta
il pm Chionna si fidanza e poi si sposa con una certa Anita Ceccariglia, finita
nell’inchiesta per aver frequentato i due imputati. Ancora recentemente, di
fronte allo scandalo della seconda Vallettopoli, Sabani non riusciva a darsi
pace: «Quando io e altri fummo sbattuti violentemente in prima pagina, senza
certezze sulle eventuali responsabilità, nessuno, a parte pochi, si impegnò per
difendere la nostra dignità. «Tagliato fuori dalla tv, sbalzato dal trono,
Sabani subì anche la beffa del risarcimento. Tredici giorni di ingiusta
detenzione patiti dal presentatore dal 18 giugno all’1 luglio del 1996 gli
valsero 24 milioni di lire (più un milione e rotti per le spese processuali). In
tribunale avevano fatto i conti della serva: gli arresti domiciliari sono meno
«afflittivi» della gattabuia, il contratto con «Sotto a chi tocca» di Canale 5
non era ancora firmato, nel 1997 Sabani ci aveva rimesso «solo» 250 milioni
rispetto all’anno precedente e così via.
Probabilmente, 24 milioni Sabani li guadagnava in
una o due serate e la Corte d’appello di Roma non aveva tenuto conto che per un
presentatore l’immagine è tutto e l’immagine di Sabani aveva subito un brutto
colpo. Dal quale, con ogni probabilità, non si è mai più ripreso. Sabani rientra
in tv nell’estate del 1998 con un modesto programma di spezzoni televisivi su
Rete4, «Io, Napoli e tu» con Katia Noventa, allora fidanzata di Paolo
Berlusconi. Sabani si ritrova così a fare gavetta. Tuttavia, e non solo per
colpa di Vallettopoli, il conduttore stava vivendo da alcuni anni una crisi di
identità tipica degli imitatori; non tutti hanno una personalità così forte da
riuscire a superare la loro natura eteronima. Quando Sabani capiva che il
pubblico si stava annoiando provava irrefrenabile il bisogno di calarsi nelle
vesti di un personaggio più famoso, giusto per cavare un applauso. Ma intanto
non era più lui, era continuamente costretto a sdoppiarsi. Sabani era un
imitatore. Nato a Roma il 5 ottobre 1952, nel suo quartiere Luigi era già famoso
all’età di cinque anni per la sua abilità nell’imitare il rumore inconfondibile
della circolare rossa Prenestina, il tram che faceva il giro della capitale. Si
fa conoscer dal pubblico a «La corrida», il programma radiofonico dei dilettanti
allo sbaraglio presentato da Corrado, imitando Morandi, Reitano, Baglioni e
altri. Notato da Gianni Ravera al Festival di Castrocaro, debutta in tv nel 1979
su Raiuno in occasione della manifestazione «La gondola d’oro» di Venezia.
Ingaggiato da Pippo Baudo per l’edizione 1979 di «Domenica in», riscuote un
grande successo di pubblico, confermato dalle edizioni 1981 e ’82 di
«Fantastico» e dal varietà di Canale 5 «Premiatissima» (1983). Nel 1983 gli è
affidata la conduzione su Italia 1 di «Ok, il prezzo è giusto». Altri suoi
successi: «Stasera mi butto» (1990), «Domenica in», «Il grande gioco dell’oca»
(1995), «Re per una notte» (1996), «7 x uno» (1999), «La sai l’ultima?», «I
fatti vostri» (2002). A volte dava l’idea di non trovarsi più in questa tv, a
volte era la stessa tv a non avere più occhi di riguardo per uno che sapeva,
eccome, piacere al pubblico generalista.
Merola: c’è una firma su questa morte.
Da quel momento Gigi fu discriminato, scrive P. Br. su "Il Corriere della Sera"
il 6 settembre 2007. «Noi viviamo in un Paese dove un magistrato, di cui non
voglio pronunciare mai più il nome, prima ti manda in carcere e poi, scoperto da
un paparazzo di Novella Duemila, si fa sorprendere in dolce compagnia dell’ex
fidanzata dell’uomo che ha appena fatto incarcerare grazie a un’inchiesta
inventata e destinata a finire poi nel nulla più assoluto». È arrabbiato Valerio
Merola (nella foto, degli anni ’90, con Raffaella Zardo). Gigi Sabani e Valerio
Merola. Ad accomunarli quella drammatica inchiesta del pm Alessandro Chionna su
una scuola per modelle di Biella. Uno «scandalo» che li aveva portati in carcere
nel ’96 per truffa a fini sessuali e induzione alla prostituzione di alcuni
giovani modelle in cambio di partecipazione a programmi tv. Poi, un anno dopo,
l’archiviazione e il risarcimento economico per quei tredici giorni di ingiusta
detenzione. Ieri Merola ha macinato chilometri in auto per precipitarsi dal nord
a Roma e rendere omaggio all’amico, in quella casa al Prenestino in cui i due
hanno rimuginato più volte sui loro passati guai. «Che vergogna — dice Merola —.
Un inutile scandalo, archiviato in ogni sua forma. Non c’è mai stato il
processo, siamo stati risarciti per questa ingiustizia. Ma vorrei che qualcuno
si facesse un esame di coscienza, perché questa morte per me ha una firma, non
credo che sia un evento naturale. Vorrei che stanotte qualcuno non trovasse
sonno. C’è un uomo che ha sbagliato clamorosamente e che non ha mai pagato per i
suoi errori, e che poi ha addirittura coronato il suo sogno d’amore con l’ex
fidanzata di uno dei suoi inquisiti… ». È un fiume in piena Valerio Merola. Più
volte usa un termine per ricordare la situazione di Gigi Sabani in questi ultimi
dieci anni: isolamento. «Abbiamo continuato a patire la discriminazione — dice
—. Anche dopo il risarcimento e l’archiviazione. In Rai e anche in Mediaset
quando qualcuno si azzardava a proporre il nostro nome c’era subito chi
obiettava: “Loro… meglio di no”. Gigi pativa molto per questi ostracismi e
diceva che erano in troppi a scansarlo. Avvertiva questo senso di disagio che
pochi amici riuscivano a superare». L’ultima sua sofferenza è fresca, risale a
questa estate. Merola ne ha discusso con Sabani, a caldo. «Su Raiuno avevano
deciso di replicare “Stasera mi butto”, uno spettacolo di imitatori che era
stato anni addietro un successo di Gigi. Quando lui l’ha saputo era tutto
contento. Finalmente, pensava. Poi la doccia fredda. Hanno deciso di programmare
lo spettacolo sulla prima rete senza degnarsi di invitarlo. “Ma perché mai il
direttore di Raiuno non mi ha invitato?” si chiedeva Gigi. “Che gli ho fatto a
Fabrizio Del Noce?”. E aggiungeva: “Ci sarei andato anche gratis. E poi parlano
del deficit della Rai. Quello era il mio programma. Gliel’avrei rifatto
gratis…”. Parliamoci chiaro: pochissimi gli sono stati vicini in questi ultimi
anni. E anche tra quei pochi, come Maurizio Costanzo, Gigi diceva che c’erano
troppi umori altalenanti. Un invito, poi più niente per parecchio tempo.
Un’altra polemica, recente, l’aveva avuta con Fiorello. Gigi ne aveva
ridimensionato le capacità, in un’intervista. Capirai. Fiorello gli aveva
risposto piuttosto male… ». «Questa è una società dove se vieni macchiato —
conclude Merola — la macchia non viene più tolta. E si paga con la vita. E poi
se ti risarciscono, non è che ti aiutano a riprendere. No, ti isolano
ulteriormente. E se non basta ti rubano anche gli amori…».
13 giorni di carcere, 24 milioni di
risarcimento, scrive Il Messaggero il 5 settembre
2007. Nel 1996 con grande clamore Gigi Sabani fu coinvolto, insieme a Valerio
Merola e ad altre persone nell’inchiesta del pm Alessandro Chionna su una scuola
per modelle, la Celebrità di Biella che nascondeva un intreccio di incontri
privati tra le giovani aspiranti e alcuni uomini di spettacolo, con l’obiettivo
di ottenere contratti in tivù o al cinema. Truffa a fini sessuali e induzione
alla prostituzione di alcune giovani modelle in cambio di partecipazione a
programmi televisivi: con queste motivazioni fu arrestato all’alba del 18 giugno
1996 il presentatore Gigi Sabani. A metterlo nei guai, le dichiarazioni
dell’allora minorenne Katia Duso, aspirante show-girl, che raccontò al pubblico
ministero di essere stata accompagnata nell’estate del ’95 da Ramella Paia a
Roma dove avrebbe avuto approcci sessuali con il presentatore, che le avrebbe
promesso in cambio di aiutarla nel mondo dello spettacolo. Sabani fu scarcerato
il 1 luglio ’96 e presentò denuncia per abuso d’ufficio nei confronti di Chionna
(che poi sposò a Roma il 10 maggio ’97 la sua ex-teste nell’inchiesta Anita
Ceccariglia, per quattro anni compagna di Gigi Sabani). Il 13 febbraio 1997 la
richiesta di archiviazione nei suoi confronti, «la prima notizia bella dopo
tanta sofferenza inutile», commentò Sabani. Il gip di Roma, su richiesta del pm
Pasquale Lapadura, il 18 febbraio 1997 archiviò il procedimento e Sabani fu
risarcito (con 24 milioni di lire) per 13 giorni di ingiusta detenzione.
PRESUNTA COLPEVOLE. LAURA ANTONELLI.
Processo troppo lungo, Laura Antonelli
risarcita, scrive "La Repubblica" il 20 maggio 2006.
Nove anni di procedimento e poi l’assoluzione, nove anni che hanno minato la sua
salute psichica e per i quali ora il ministero della Giustizia dovrà pagare.
L’attrice Laura Antonelli ha vinto la sua causa contro la lentezza della
giustizia e ora sarà risarcita con 108 mila euro, oltre agli interessi, per i
danni di salute e di immagine patiti a causa della “irragionevole durata del
procedimento” a suo carico. Nell’estate del 1991 nella villa dell’attrice,
diventata uno dei sex symbol italiani negli anni ’70 per il film Malizia di
Samperi, furono trovati 24 grammi di cocaina. Le fasi processuali sulla vicenda
durarono nove anni, ma alla fine la Antonelli fu assolta. In questo periodo il
crollo psichico dell’attrice fu repentino: da allora infatti vive in solitudine,
il corpo irriconoscibile anche a causa di interventi estetici sbagliati. Ora la
corte di appello civile di Perugia, presieduta da Sergio Matteini Chiari, ha
deciso per il risarcimento. La pronuncia del collegio è arrivata dopo che la
Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso degli avvocati della Antonelli,
Lorenzo Contrada e Dario Martella, aveva giudicato non adeguata la somma di
diecimila euro precedentemente assegnata alla Antonelli. “Sono contenta, non me
l’aspettavo”, ha commentato l’attrice parlando con i suoi legali. Questi ultimi
hanno a loro volta espresso soddisfazione per un provvedimento “che riconosce
uno dei risarcimenti più alti mai stabiliti per cause di questo genere” e che
costituisce un importante precedente alla luce della cronica lunghezza dei
procedimenti giudiziari italiani. Il dicastero della Giustizia, in base a quanto
disposto dai giudici umbri, dovrà pagare anche le spese processuali sostenute
dall’attrice e i costi di una consulenza tecnica svolta dal neurologo e
psichiatra Francesco Bruno. Quest’ultimo fu interpellato nel 2003 per stabilire
se lo stato dell’attrice, all’epoca alle prese con ideazioni deliranti a
contenuto mistico e allucinazioni uditive, fosse dovuto all’assunzione di
cocaina nel periodo culminato con il suo arresto o se fosse configurabile un
nesso di causalità con la durata del processo penale. Lo psichiatra dichiarò che
la lunghezza della vicenda giudiziaria aveva “senz’altro influito in modo
determinante sulla destabilizzazione psichica dell’Antonelli”. “Il nesso di
causalità tra i due eventi – concluse il perito – appare dunque ben confermato
sia per i criteri temporali, sia per quelli modali, sia per quelli di efficienza
lesiva”.
PRESUNTO COLPEVOLE. ROBERTO RUGGIERO.
Roberto Ruggiero. Risarcito l’avvocato
per 27 giorni di carcere. E’ l’avvocato opinionista tv di cronaca nera.
Scrive l'"Ansa" il 22 febbraio 1992)
Deve tenere conto anche delle sofferenze morali e
psicologiche e delle “conseguenze personali e familiari” il giudice chiamato a
stabilire la somma di risarcimento per ingiusta detenzione. Di conseguenza una
custodia cautelare, pur se limitata nel tempo, può essere riparata con il
massimo previsto, cioè cento milioni di lire. Lo stabilisce una sentenza della
prima sezione penale della Corte di cassazione, presieduta da Corrado Carnevale,
con la quale viene respinto il ricorso del ministero del Tesoro. La vicenda ebbe
inizio nel 1983, quando Roberto Ruggiero fu arrestato con l’accusa di traffico
internazionale di armi. L’uomo subì la custodia cautelare in carcere dal 16
giugno al 13 luglio 1983, per un totale di 27 giorni. In seguito il giudice
istruttore di Venezia lo prosciolse e riconobbe il diritto di Ruggiero al
risarcimento, che quantificò nella misura massima di cento milioni. Il ministero
si è rivolto in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che “ai fini della
determinazione del quantum non si dovrebbe tener conto delle sofferenze morali e
psicologiche”. Ma i giudici della Suprema corte sono stati di diverso avviso e
hanno anche escluso che per stabilire la somma di di diverso avviso e hanno
anche escluso che per stabilire la somma di riparazione si debba far riferimento
ad un “valore al giorno” da far coincidere con una o due volte l’importo della
pensione sociale. La Cassazione afferma che la Corte d’appello ha correttamente
indicato le modalità di svolgimento della custodia cautelare (caratterizzata da
una iniziale fase di isolamento), le conseguenze fisico-psichiche derivate dalla
sottrazione della libertà, l’incensuratezza e l’elevata posizione sociale di
Ruggiero.
PRESUNTO COLPEVOLE. CARLO PALERMO.
Il Csm condanna Palermo,
scrive Franco Coppola su "La Repubblica" il 27 giugno 1985. La perdita di sei
mesi di anzianità per Carlo Palermo, il giudice della maxi inchiesta sul
traffico di armi e droga, il giudice che ha chiesto e ottenuto di essere
trasferito a Trapani, nella sede cioè più calda d’ Italia. Una sanzione
disciplinare, quella decisa a mezzanotte dopo una camera di consiglio
insolitamente lunga (sette ore) dall’apposita sezione del Consiglio superiore
della magistratura, ritenuta troppo severa per chi vede in Carlo Palermo una
sorta di Robin Hood senza macchia e senza paura, troppo blanda per quanti lo
dipingono come un giustiziere-panzer, privo di scrupoli e di regole. Una
sanzione, a ben guardare, che potrebbe anche essere considerata equilibrata, se
su tutta la vicenda non pesasse l’ombra di una discutibile iniziativa presa da
Bettino Craxi non come privato cittadino ma nella veste di presidente del
Consiglio, alla quale ha fatto seguito una inusitata solerzia da parte del
procuratore generale Giuseppe Tamburrino, titolare dell’azione disciplinare. Per
tutta la giornata di ieri c’è stata battaglia a palazzo dei Marescialli intorno
alla posizione di Carlo Palermo, un magistrato tra i più coraggiosi, scampato il
2 aprile scorso a un attentato mafioso nella sua nuova sede di Trapani, da lui
stesso richiesta per continuare, in una zona quanto mai calda e al posto di
Antonio Costa, giudice finito in galera per collusioni con la mafia, quella
battaglia intrapresa anni prima a Trento contro la mafia della droga e delle
armi. Battaglia che ha avuto come protagonisti prima Guido Guasco e Giovanni
Tranfo, sostituti procuratori generali della Cassazione che ieri fungevano
rispettivamente da accusatore e da difensore di Palermo, poi i nove componenti
la sezione disciplinare del Csm, tutt’altro che d’accordo sulla eventuale
sanzione da infliggere all’incolpato. Guasco ha parlato in mattinata per due ore
sostenendo la “responsabilità” di Palermo per cinque dei sei capi d’incolpazione
e sollecitando la sanzione della perdita di sei mesi d’anzianità. Secondo il Pg,
infatti, il magistrato andava prosciolto dalla seconda “accusa”, quella di aver
bloccato un telegramma con cui l’avvocato Roberto Ruggiero raccomandava al suo
cliente Vincenzo Giovannelli, imputato nel processo per il traffico di armi e
droga, di presentare ricorso per Cassazione contro il provvedimento del
tribunale della libertà di Trento. Il Csm, invece, lo ha “condannato” per cinque
capi di accusa prosciogliendolo dalla “incolpazione” di aver interrogato degli
imputati in assenza dei loro difensori. Più o meno tutte di questo calibro –
Craxi a parte – sono le incolpazioni contestate a Palermo, fatti cioè che,
secondo il Pg, integrerebbero l’accusa di “essere venuto meno ai propri doveri
funzionali, così compromettendo il prestigio dell’ordine giudiziario”: accuse
all’avvocato Ruggiero di avvalersi di “metodi disonesti” e di “modalità
vergognose”, interrogazioni di imputati senza la presenza dei difensori;
l’arresto di un testimone per reticenza a cui è seguito il proscioglimento da
parte della corte d’appello; proseguimento delle indagini sul conto di imputati
dichiarati dal Pm estranei al traffico di armi e droga. Poi c’era l’ “affare
Craxi”, anzi l’”affare Craxi-Pillitteri”. Siamo nel 1983. Carlo Palermo,
affondando il bisturi nel magma ribollente del mercato dell’eroina, arriva alla
pista bulgara, al traffico internazionale delle armi, al “SuperEsse”, alla P2.
Con gli avvocati di alcuni imputati i rapporti si fanno tesi; due di essi,
Roberto Ruggiero e Bonifacio Giudiceandrea, finiscono in carcere per
favoreggiamento. Palermo non c’entra. All’origine dell’accusa sono delle
trascrizioni errate di intercettazioni telefoniche. Quando i due legali vengono
scarcerati arriva puntuale la denuncia contro il magistrato. Si apre
un’inchiesta, affidata alla magistratura veneziana che, nel febbraio scorso,
rinvia a giudizio Palermo per interesse privato in atti d’ufficio. E’ questa
anche la settima incolpazione di stampo disciplinare sulla quale, però, il Csm
non si è pronunciato in attesa della definizione del procedimento penale. Alla
fine di quell’anno, Palermo ordina la perquisizione di varie società
finanziarie, alcune delle quali risultano legate al Psi o fanno capo al
finanziere socialista Ferdinando Mach di Palmstein. Alcuni testimoni hanno fatto
il nome di Craxi e del cognato Paolo Pillitteri. Nei decreti di perquisizione,
allora, Palermo raccomanda a chi li eseguirà di fare attenzione se, nei
documenti delle società in questione, compaiono quei nomi eccellenti. E’ in quel
momento che Palermo si gioca l’inchiesta. Il 15 dicembre ’83, Craxi scrive al Pg
Tamburrino per lamentare che il magistrato ha citato il suo nome in un mandato
di perquisizione senza avvertirlo; nell’esposto, il capo del governo parla di
“gravissime violazioni di legge”, di comportamento “di eccezionale gravità…
inaudito”. E’ la fine dell’inchiesta sul traffico di armi e droga. Prende vigore
l’indagine penale a Venezia per l’arresto degli avvocati, Tamburrino investe
subito il Csm della procedura disciplinare, la Cassazione dirotta a Venezia
tutte le inchieste di Palermo. Il giudice fa appena in tempo a firmare
un’ordinanza di rinvio a giudizio, a spedire al Parlamento tutti gli atti
relativi a Craxi e Pillitteri (e l’Inquirente archivia il “caso”, proseguendo
però nell’indagine sulle società finanziarie del Psi) e a chiedere di essere
trasferito ad altra sede. Infine, il procedimento disciplinare, fissato per il
12 aprile e rinviato d’autorità, senza neppure interpellare l’interessato, dopo
l’attentato del 2 di quel mese.
PRESUNTO COLPEVOLE. SANDRO FRISULLO.
Sandro Frisullo, assolto dopo 4 mesi in
carcere come tangentista, scrive Fiorenza Sarzanini su
"Il Corriere della Sera" l'11 febbraio 2014. I giudici della Corte d’appello di
Bari hanno scagionato definitivamente il politico del Partito democratico Sandro
Frisullo. Dopo essere stato assolto dall’accusa di corruzione, l’ex
vicepresidente della giunta regionale della Puglia viene infatti dichiarato
innocente anche rispetto alle accuse di associazione per delinquere e abuso
d’ufficio. Secondo le indagini della Procura barese, il politico aveva favorito
l’imprenditore Gianpaolo Tarantini in cambio di utilità e di incontri con alcune
delle escort che frequentavano anche le serate di Silvio Berlusconi.
Contestazioni gravi che nel marzo 2010 – quasi un anno dopo le rivelazioni di
Patrizia D’Addario sulle feste dell’allora Presidente del consiglio – ne
determinarono l’arresto e lo convinsero a dimettersi dopo che una delle ragazze,
Terry De Niccolò, aveva raccontato a verbale e pubblicamente gli incontri.
L’esito del processo non basta comunque a placare la rabbia e l’amarezza di
Frisullo. «Sono stato assolto da tutti i reati per i quali ho subito il carcere
e ben quattro mesi di custodia cautelare. Avevo dichiarato fin da subito la mia
disponibilità ad essere sentito dalla Procura, e quando ciò è avvenuto (e cioè
quattro mesi più tardi, ndr ) ho riferito dei miei comportamenti dicendo sempre
la verità ed escludendo in modo categorico qualsiasi dazione di denaro da parte
di Tarantini. Ma ‘meritavo’ il carcere e questo a pochi giorni dalla data delle
elezioni regionali del 2010. Quella che ho vissuto è stata la più terribile
pagina della mia vita. Un vero e proprio calvario. La violenza di un così
brutale provvedimento contro la mia persona ha aperto una ferita difficilmente
rimarginabile. Il carcere ti spezza la vita. E soltanto l’affetto dei miei
famigliari, il sostegno e la stima di tante persone, la costante azione a favore
del bene comune e della legalità mi hanno consentito di affrontare una prova
così devastante». Frisullo si rammarica per la sua storia personale e politica
cancellata da questa vicenda e aggiunge: «Ho avuto subito l’angosciante
percezione di essere finito dentro un meccanismo che mi stritolava e che non mi
avrebbe lasciato scampo. Un infernale e potente circuito mediatico-giudiziario
mi aveva già condannato come un pericoloso tangentista e corrotto, ispiratore di
un sodalizio criminale ben collaudato. Si cancellava così la mia storia, quella
vera, quando da giovane sindaco avevo denunciato e testimoniato contro una
pericolosa cosca contribuendo a smantellarla».
PRESUNTO COLPEVOLE. CLELIO DARIDA.
Clelio Darida: “Io, ex ministro e sindaco
di Roma, 50 giorni in carcere innocente”, scrive la
Repubblica, 28 luglio 1994, 15 aprile 1997, 11 maggio 2017. Clelio Darida è
stato uno dei protagonisti della Prima Repubblica. Figura di spicco della
corrente della Democrazia Cristiana che faceva capo ad Amintore Fanfani, ha
ricoperto tre volte la carica di ministro (delle Poste, della Funzione pubblica
e della Giustizia). Ed è stato anche sindaco di Roma dal 1969 al 1976. Nel corso
della sua vita di politico fu travolto dall’esperienza di un’ingiusta
detenzione: oltre 4 mesi di custodia cautelare da innocente, tra carcere e
arresti domiciliari. Il 7 giugno 1993, in piena Tangentopoli, Darida finisce
nell’inchiesta sull’Intermetro: accusato dal Pool di Mani Pulite di aver
incassato una tangente di 1 miliardo e 750 milioni di lire, da girare alla Dc
per i lavori della metropolitana romana, finisce in carcere. In questo modo
diventa l’unico ministro della Giustizia a conoscere l’onta di entrare in cella
a San Vittore, a Milano, con l’accusa di corruzione aggravata. Vi rimarrà fino
alla fine di luglio, 50 giorni in tutto, prima di vedersi concedere gli arresti
domiciliari (che dureranno fino al 9 settembre del 1993). Clelio Darida verrà
assolto alla fine di luglio 1994 dalla Gip di Roma Adele Rando, dopo che
l’inchiesta era passata per competenza alla magistratura capitolina. Il pm,
Francesco Misiani, non impugnerà l’ordinanza di assoluzione. “Ho subito una
violenza infame ed infamante”, aveva protestato Darida tramite il suo avvocato,
Ettore Boschi, a poche ore dall’ordinanza che lo aveva mandato assolto. “Sono
rimasto 50 giorni in custodia cautelare in carcere senza che alcun atto
istruttore fosse compiuto”, aveva denunciato in Tv su Canale 5. “Quei quasi due
mesi di ingiusta detenzione sono stati come uno stupro, indimenticabile e
irreparabile”, ripeteva spesso. L’esperienza in carcere fu traumatica. La prima
notte Darida l’aveva passata in cella di sicurezza. In seguito, in cella aveva
incrociato due detenuti politici degli Anni di Piombo: lo minacciarono di morte,
visto che a cavallo degli anni Ottanta era stato proprio lui, da ministro della
Giustizia, a varare quell’articolo 90 che aveva cancellato i diritti della
riforma penitenziaria. Era quindi stato trasferito in un altro reparto, con i
detenuti comuni. “Mai un magistrato è andato a trovarlo né mai abbiamo ricevuto
notizia di qualche atto istruttorio” ricordava l’avvocato Boschi. “Solo il 24
giugno arrivò da Roma Francesco Misiani, il pm che nella capitale aveva
cominciato a lavorare all’inchiesta Intermetro. Fu corretto e gentile”. Anche
Misiani ricorda quell’incontro: “Darida mi disse molto gentilmente che non se la
sentiva di rispondere alle domande. Restammo a chiacchierare una mezz’ora. Era
molto provato. Mi disse che i primi giorni erano stati i più duri”. Per
questioni di sicurezza l’ex potente Dc aveva dovuto rimanere da solo durante
l’ora d’aria né aveva potuto frequentare – lui, cattolico fervente – la messa.
Finché un giorno in cortile, si era fatto forza e si era presentato ai detenuti
comuni: “Sono Darida, chiamatemi Clelio”. Da quel momento in avanti, tutto era
filato senza problemi. Anzi, amava ripetere che in cella si erano creati legami
di solidarietà molto forti e che la pasta più buona della sua vita gliel’avevano
cucinata i suoi compagni di cella. Dopo quell’esperienza, promise a se stesso di
battersi per difendere i diritti “di tanti poveri cristi che finiscono in
carcere innocenti e di cui nessuno parla”. Per quei giorni in custodia cautelare
da innocente (50 in carcere e 73 agli arresti domiciliari), Clelio Darida
ottenne la riparazione per ingiusta detenzione dalla IV sezione penale della
Corte d’Appello di Roma nell’aprile del 1997: 100 milioni di lire. I giudici
riconobbero che quella terribile esperienza provocò a Darida un danno morale e
materiale, oltre a gravi prostrazioni psicologiche. A 90 anni compiuti da pochi
giorni, Clelio Darida è morto l’11 maggio 2017.
PRESUNTO COLPEVOLE. FERDINANDO PINTO.
Teatro Petruzzelli, il manager vuole i
danni, scrive "La Gazzetta del Mezzogiorno" il 18
Settembre 2007. Dopo essere stato sottoposto per circa 16 anni alle indagini e a
vari gradi di processo (uno di primo grado, due di secondo e due pronunce della
Cassazione), e soprattutto dopo essere stato assolto in via definitiva
dall’accusa di aver ordinato il rogo del teatro Petruzzelli di Bari, l’ex
gestore Ferdinando Pinto ha chiesto la liquidazione dei danni subiti per la “non
ragionevole durata del processo” cui è stato sottoposto. Una durata
“ragionevole” del processo in Italia è fissata in sei anni. Il ricorso – nel
quale non si quantifica l’ammontare dei danni “patrimoniali e non” subiti
dall’impresario – è stato depositato dal legale di Pinto, avv. Michele Laforgia,
alla Corte d’appello di Lecce, competente per territorio a trattare i
procedimenti che riguardano la magistratura barese. Nel procedimento si
lamentano non solo i danni subiti da Pinto per le lungaggini del procedimento
penale, ma anche quelli legati all’accusa di associazione mafiosa che la Procura
antimafia di Bari, nonostante il diverso orientamento cautelare della Cassazione
emerso dopo l’arresto di Pinto, ha continuato a contestare all’ex gestore,
costringendo – secondo la difesa – a subire nel corso degli anni ingenti danni
patrimoniali, personali e professionali. Danni che l’impresario ritiene di aver
subito anche per l’ingiusta detenzione a cui è stato sottoposto per essere stato
arrestato il 7 luglio del ’93 e scarcerato per mancanza dei “gravi indizi di
colpevolezza” dal tribunale del riesame di Bari il 23 luglio successivo. Anche
per questa vicenda Pinto sta per chiedere un risarcimento dei danni. Il processo
per il rogo doloso del Petruzzelli (i cui interni furono distrutti all’alba del
27 ottobre del ’91) è terminato il 15 gennaio 2007 (iniziò il 14 febbraio ’96)
con la sentenza della Cassazione che ha spazzato via definitivamente la
ricostruzione fatta dalla Procura di Bari: questa accusava Pinto di aver
ordinato al clan mafioso dei Capriati (con il quale sarebbe stato indebitato per
600 milioni di lire presi ad usura, circostanza ritenuta non provata dalla
Suprema Corte) di incendiare la sua “creatura” per poi lucrare sulla
ricostruzione del teatro. Per questi motivi l’ex gestore (il 6 aprile 2001)
venne condannato nel primo processo d’appello a 5 anni e 8 mesi di reclusione
(due anni in meno della condanna inflitta in primo grado l’8 aprile ’98) per
concorso in incendio doloso. Il processo approdò in Cassazione che (il 28 maggio
2002) annullò la sentenza con rinvio e mandò gli atti alla Corte d’appello di
Bari che, al termine del processo d’appello bis (14 luglio 2005), mandò assolti
tutti gli imputati tranne il presunto incendiario Giuseppe Mesto. Questi,
assieme a Francesco Lepore, condannato con sentenza definitiva in un processo
stralcio, è stato ritenuto colpevole di aver appiccato materialmente il rogo. Fu
infatti proprio per l’intercettazione ambientale di un colloquio tra Mesto e
Lepore che gli inquirenti diedero una svolta alle indagini sull’incendio del
teatro. Una microspia captò la conversazione nella quale Mesto diceva a Lepore:
“Se tu il Petruzzelli non lo facevi, vedi era così?”, e poi continuava: “Madò,
non sia mai ci sta qualche microspia, adesso ci devono arrestare”.
PRESUNTO COLPEVOLE. MARIO SPEZI.
Mario Spezi. Giornalista ingiustamente in
carcere, scrive l'"Ansa" il 20 novembre 2007. “Quanto
vale la libertà personale di un giornalista? E quanto il diritto a svolgere
quotidianamente il suo lavoro? Secondo l’Avvocatura di Stato, duecento euro al
giorno”. Lo sottolinea il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti
Lorenzo Del Boca, commentando quanto avvenuto nel caso di Mario Spezi. “Non
sembra proprio che lo Stato tenga in grande considerazione il nostro mestiere”,
dice Del Boca. “Quando un magistrato cita un giornalista per diffamazione a
mezzo stampa – aggiunge – i tribunali decretano risarcimenti per decine di
migliaia di euro e, per di più, rendono la decisione immediatamente esecutiva.
Se si tratta del contrario cioè di un giudice che sbaglia – e vistosamente, per
considerazione della Suprema Corte – perché devono valere criteri così
palesemente difformi e umilianti?” Questi i fatti ricordati da Del Boca. “Il 7
aprile 2006 il cronista della Nazione Mario Spezi, da anni impegnato a seguire
per il suo giornale le terribili vicende del cosiddetto ‘mostro di Firenze’,
viene arrestato con l’accusa di depistaggio delle indagini sull’omicidio di
Francesco Narducci, un medico perugino coinvolto nell’inchiesta relativa ai
presunti mandanti dei delitti del mostro. Spezi trascorre 23 giorni in carcere:
una detenzione definita dalla Corte di Cassazione, nella sentenza di
scarcerazione, ‘illegale ed ingiustificata’. Talmente ingiusta da provocare
anche l’intervento del Committee to Protect Journalists, di New York, che scrive
all’allora premier Berlusconi chiedendo ‘la liberazione di un giornalista
incarcerato per aver fatto il suo mestiere meglio di altri, un giornalista
coraggioso che non si è lasciato intimidire da accuse e denunce”. Uscito dal
carcere, Mario Spezi così commenta la sua prigionia: “Sono stato vittima
dell’inquisizione, nessuno mi restituirà questi 23 giorni trascorsi in galera”.
E avvia la procedura per il risarcimento per ingiusta detenzione. “Nei giorni
scorsi, il 14 novembre, la prima udienza. Ed anche la prima sorpresa.
L’Avvocatura di Stato – spiega ancora una nota dell’Ordine – si costituisce
contro Mario Spezi ed offre un risarcimento di danni di 4.500 euro. Pari,
appunto, a circa 200 euro al giorno. Una decisione davvero singolare, anche
perché é raro che l’Avvocato dello Stato si costituisca contro un privato
cittadino, in questo caso giornalista. L’ultima parola spetta ovviamente al
magistrato che si è riservato di decidere”.
Mario Spezi ha avuto ancora una volta
ragione contro la procura di Perugia, scrive Franca
Selvatici su "La Repubblica" il 27 ottobre 2006. Il giornalista e scrittore
Mario Spezi ha avuto ancora una volta ragione contro la procura di Perugia. Ieri
la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico
ministero Giuliano Mignini contro la decisione del tribunale del riesame che il
28 aprile scorso aveva rimesso in libertà il giornalista. Spezi era stato
arrestato il 7 aprile per calunnia e depistaggio delle indagini sulla morte del
medico perugino Francesco Narducci, che la procura di Perugia ritiene collegata
con i delitti del mostro di Firenze e per la quale ha messo sotto inchiesta
diverse persone fra cui lo stesso Spezi. Il giornalista era rimasto in carcere
23 giorni, poi il tribunale del riesame aveva annullato in radice la misura
cautelare, ritenendo insussistenti gli elementi alla base delle accuse di
calunnia e depistaggio. Secondo la procura di Perugia, Spezi sarebbe uno dei
mandanti dei delitti del mostro e dell’omicidio di Francesco Narducci, e per
tale motivo avrebbe ingaggiato una lotta senza quartiere contro le indagini del
pm Mignini e del poliziotto-scrittore Michele Giuttari, fino al punto da
seminare falsi indizi a favore della pista sarda. Ma il tribunale del riesame
rilevò che Spezi credeva fermamente nella sua fonte, che non gli erano stati
trovati oggetti collegabili al mostro, né erano stati acquisiti indizi tali da
far supporre che volesse disseminare tracce di reato a carico di un operaio
sardo da lui ritenuto responsabile dei delitti. In sostanza i giudici del
riesame riconobbero che Spezi cercava prove a favore della sua tesi, e non
cercava di costruirne di false. Contro la scarcerazione di Spezi, il pm Mignini
si era appellato alla Cassazione. Ma ieri la Suprema Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso perché motivato in fatto e non in diritto, come hanno
sostenuto gli avvocati di Spezi, Sandro Traversi e Nino Filastò, e anche il
procuratore generale. Le conseguenze sono di due tipi. Da un lato il pm Mignini
può mandare avanti l’indagine su Spezi. Dall’altro, però, l’ordinanza del
riesame diventa definitiva, il che significa che i 23 giorni di detenzione
subìti da Spezi sono illegittimi. E a questo punto il giornalista-scrittore ha
la ferma intenzione di chiedere il risarcimento per l’ingiusta detenzione.
PRESUNTO COLPEVOLE. GIOVANNI TERZI.
Giovanni Terzi. Tangenti all’urbanistica,
dopo otto anni finisce incubo per assessore Terzi,
scrive "Il Corriere della sera" il 3 febbraio 2006. Ci sono voluti otto anni, ma
per Giovanni Terzi l’angoscia è finita. La Cassazione ha respinto il ricorso
presentato dalla Procura di Milano contro la sentenza di assoluzione del
consigliere comunale azzurro. Terzi era stato arrestato insieme ad altre sei
persone per una vicenda di presunte tangenti pagate in relazione a un intervento
edilizio a Bresso. “Nel 1998 – racconta Terzi – la Cassazione aveva già
stabilito che non dovevano esserci arresti in quanto non c’era né corruzione né
falso. Aspettare otto anni per vedere conclusa una simile esperienza credo sia
troppo”. Detto questo, il consigliere comunale dice di “avere avuto la fortuna
di incontrare giudici coraggiosi che hanno saputo ascoltare la mia tesi
difensiva senza pregiudizi”. Il rammarico resta: “In questi anni mio padre per
il dolore si è ammalato ed è morto. Purtroppo, non è una mia interpretazione”.
Terzi si dice anche “sconcertato” per la candidatura dell’ex procuratore Gerardo
D’Ambrosio: “Mi pare una scelta inopportuna, e anche autolesionista: adesso
proprio nessuno potrà più nutrire dubbi sulla politicizzazione di una certa
parte della magistratura”. Per l’avvocato di Terzi, Jacopo Pensa, “ogni volta
che la vicenda è stata esaminata con animo sgombro da pregiudizi, le sentenze
sono state favorevoli. Come in questo caso”.
Arrestato 3 mesi nel 1998. Condannato in
Tribunale a 2 anni e mezzo, scrive Luigi Ferrarella su
"Il Corriere della Sera" l'1 giugno 2005). Ma ora assolto in Appello, nel merito
dall’ accusa più grave e per prescrizione dal resto. Finisce così il processo a
Giovanni Terzi, il consigliere comunale milanese di Forza Italia che da
assessore all’ Urbanistica di Bresso era accusato di essersi fatto corrompere
nel 1997 dagli imprenditori Angelo Igino e Valter Bottani per il progetto di
riqualificazione del centro urbano di Bresso. Ieri la seconda Corte d’ Appello
(due ex pm, Marcelli e Spina, presieduti da Marta Malacarne), ha rivoluzionato
il primo verdetto. La corruzione, che l’accusa individuava in un’asserita
«fittizia» consulenza tra i Bottani e l’architetto Michele Ugliola per far
arrivare 100 milioni a Terzi, al pari del falso ideologico è liquidata da una
secca assoluzione sia di Terzi (difeso da Daniela Mazzocchi) sia dei Bottani
«perché il fatto non sussiste» (il paradosso è che Ugliola patteggiò).
Assoluzione confermata per Roberto Almagioni (difeso da Francesco Isolabella). E
la vettura Chrysler «prestata» dai Bottani a Terzi? Qui i difensori dei Bottani
(2 anni in primo grado), Lorenzo Crippa, Alessandro Pistochini ed Ennio Amodio,
hanno dimostrato che corretta fu la procedura urbanistica e dovuto l’atto d’
ufficio compiuto da Terzi. L’ auto è così diventata una corruzione impropria
susseguente, cioè una sorta di «regalìa» al pubblico ufficiale ma a cose già
fatte e regolari, per la quale la legge punisce non i privati (Bottani assolti)
ma solo il pubblico ufficiale Terzi, soccorso però dalla prescrizione dopo 7,5
anni: «Credevo nella giustizia – commenta – ma, fosse arrivata prima, avrebbe
evitato una morte eccellente: mio padre si è ammalato per questa storia». Pure
arrestati nel ‘98, sono assolti anche il segretario comunale di Bresso, Ezio
Lopes, e il costruttore Gabriele Sabatini: «non sussiste» l’ipotizzato prezzo di
favore su una casa.
PRESUNTO COLPEVOLE. ANTONIO GAVA.
L’ultima beffa a Gava: risarcito per
l’arresto appena dopo la morte, scrive Stefano Zurlo
su Il Giornale 12 agosto 2008. Dicono che il tempo sia galantuomo. Con lui no, è
arrivato troppo tardi. Antonio Gava, morto l’8 agosto, era fuori gioco dal marzo
’93 quando contro di lui fu scoccato un avviso di garanzia per camorra. «Un paio
di giorni prima della fine – racconta il figlio Angelo – gli ho dato la notizia
che i giudici avevano stabilito un risarcimento di circa 200mila euro per
l’ingiusta detenzione subita. Ma ormai stava male, malissimo, non so cosa abbia
percepito». Duecentomila euro per i sei mesi trascorsi agli arresti domiciliari,
fra il settembre 94 e il marzo ’95, schiacciato dall’accusa di aver tramato in
modo obliquo con il clan degli Alfieri. La corte d’assise dopo un processo
trascinatosi per anni e anni l’aveva assolto; la corte d’assise d’appello a
dicembre 2006 aveva confermato il verdetto e la Procura generale di Napoli non
se l’era sentita nemmeno di tentare la strada della Cassazione. Morte per
impaludamento di un’ipotesi accusatoria nata fra squilli di tromba. «Credo –
prosegue il figlio – che quello sia stato il momento più alto per mio padre,
dopo la lunga stagione delle umiliazioni e delle accuse più inverosimili».
Tredici anni nelle aule di giustizia per ritrovare un posto nella società e un
copione simile a quello srotolato per altri big della Dc, a cominciare da Giulio
Andreotti: l’avviso di garanzia, modellato sulle tesi della Commissione
antimafia di Luciano Violante, una manciata di pentiti pronti a descrivere
collusioni e intrecci perversi, un processo evaporato lentamente. Ora, forse, la
storia della Dc la scriveranno gli storici. Delle grandi indagini condotte a
partire dal 92-93 dai pm più agguerriti d’Italia, resta ben poco. Così come non
rimane molto dei chilometrici capi d’accusa costruiti contro Andreotti. «Siamo
contenti – riprende Angelo Gava – unicamente del riconoscimento di un principio,
anche se a distanza di tanto tempo niente ci può ripagare dell’amarezza che
abbiamo dovuto sopportare. Pensi che i magistrati sono arrivati a chiedergli se
era vero che fosse ammalato di tumore e lui non sapeva di avere questa malattia.
Pensi che fu interrogato a forza dai magistrati, contro il parere dei medici,
mentre era ricoverato dopo un infarto in un centro di riabilitazione». Frammenti
di quell’Italia che ha combattuto con inusitata ferocia nella prima metà degli
anni Novanta la battaglia, pure sacrosanta, per la legalità. «La verità cammina
con passo normale, mentre le bugie volano», ha riassunto ai funerali Arnaldo
Forlani, un altro big travolto da Mani pulite e finito sul ring di un Di Pietro
con la bava alla bocca. Oggi, fra prescrizioni, assoluzioni e sentenze
all’italiana da cui ciascuno estrae la sua verità, quel periodo sembra davvero
finito. «Ma devo dire – spiega l’avocato Eugenio Cricrì – che le accuse erano
davvero inconsistenti, generiche, vaghe. Si faceva riferimento a rapporti con
persone che lui nemmeno conosceva. Gava è sparito dalla vita del Paese nel ’93 e
non è mai più tornato. Non c’è stato il tempo e poi ormai l’Italia era
cambiata». La giustizia ha restituito qualcosa. Prima centosessantamila euro per
la lunghezza del procedimento, andato avanti per tredici anni; poi altri
duecentomila euro per l’ingiusta detenzione. Ma la contabilità degli euro non
basta per capire cosa è successo in Italia quindici anni fa e per descrivere il
passaggio traumatico dalla Prima alla Seconda repubblica. La storia dei Gava –
non solo l’ex ministro degli Interni Antonio, ma anche il padre Silvio, fra i
fondatori del Partito popolare, morto quasi centenario nel ’99 – si chiude così.
Antonio Di Pietro prova a congelare la cronaca: «Non era ancora morto – ha
scritto sul suo blog – che in molti lo hanno già dichiarato santo, una vittima
della stagione del giustizialismo». Quasi a sottolineare che invece, come ha
scritto Marco Travaglio, il processo «era doveroso e le accuse concrete e
documentate». Cricrì nota però altri sentimenti, anche dalle parti
dell’opposizione: «C’è stata la corsa a riabilitarlo anche da parte degli
avversari, come se volessero farsi perdonare la durezza, spropositata, del ’93 e
del ’94. Le parole di molti esponenti della sinistra mi hanno colpito così come
la decisione del sindaco di Castellammare di Stabia, un esponente del Pd, di
inviare il gonfalone alle esequie per onorare il concittadino». Enzo Scotti,
pure riemerso da una lunga eclissi e da un nugolo di processi, oggi
sottosegretario nel governo Berlusconi, parla di Gava come di uno dei giganti
della storia democristiana del dopoguerra: «Ha subito insieme ad Andreotti
accuse devastanti e le ha sopportate con grande dignità. Mi ha toccato la sua
sconvolgente serenità quando l’ho sentito al telefono, il giorno prima della
morte. Lo chiamavano il viceré, ma la lotta alla mafia è cominciata quando lui
era al Viminale. Sarà la storia a portare via le ombre e i sospetti».
PRESUNTA COLPEVOLE. DANIELA POGGIALI.
Ravenna, morti sospette in ospedale:
assolta l'ex infermiera Daniela Poggiali. L'imputata
in primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio di una sua
paziente 78enne. Decisiva una nuova perizia. La donna esulta alla lettura della
sentenza. Uscita dal carcere ha detto: "Mi riprendo in mano la mia vita", scrive
il 7 luglio 2017 "la Repubblica". Dopo quasi tre anni di carcere, è libera. La
Corte di assise di appello di Bologna ha assolto, perché il fatto non sussiste,
Daniela Poggiali, 45 anni, ex infermiera alla sbarra per l'omicidio di una sua
paziente 78enne, Rosa Calderoni, all'ospedale di Lugo, nel ravennate. L'imputata
in primo grado fu condannata all'ergastolo a Ravenna perché riconosciuta
colpevole di avere iniettato una dose letale di potassio all'anziana. La donna
ha accolto la sentenza in suo favore esultando, le sorelle e l'ex compagno sono
scoppiati a piangere. I due figli della vittima si erano invece allontanati
dall'aula mezz'ora prima della pronuncia per la tensione emotiva
accumulata. Poco più tardi, all'uscita per l'ultima volta dal carcere bolognese
della Dozza, la donna ha commentato: "Mi hanno dipinto per quello che non sono,
e adesso mi riprendo in mano la mia vita". Il caso di Daniela Poggiali era
scoppiato il 9 ottobre 2014, quando i carabinieri sono entrati nella sua casa di
Giovecca di Lugo per portarla in carcere. Attorno alla donna, sospettata per il
decesso di Rosa Calderoni avvenuto l'8 aprile di quello stesso anno, in breve
tempo è cresciuta un'indagine giudiziaria che l'ha portata ad essere sospettata
di decine di morti nei suoi anni di lavoro.
CONDANNA IN PRIMO GRADO. L'ex infermiera è poi
stata condannata all'ergastolo in primo grado per la morte della paziente
78enne. Durante il processo, il magistrato aveva fatto riferimento anche a tutti
i furti (70-80 all'anno) verificatisi nel reparto della Poggiali, quello di
Medicina, quando lei era in servizio. E soprattutto alle numerose morti sospette
sempre in sua presenza (che comunque non rientravano in questo processo). Senza
contare, infine, le foto che la ritraggono mentre fa delle smorfie accanto a
un'altra paziente appena morta. Quando il presidente della corte d'assise,
Corrado Schiaretti, aveva letto il verdetto, la Poggiali aveva abbassato gli
occhi e scosso la testa, prima di essere riportata nel carcere di Forlì. La
procura aveva chiesto la massima pena più l'isolamento diurno per un anno e
mezzo, che è stato invece escluso, come l'aggravante dei motivi abbietti. Alla
base della condanna in primo grado invece c'erano sono la premeditazione e l'uso
del mezzo venefici. Una donna "fredda, intelligente e spietata. Nemmeno lei sa
quanti pazienti ha ucciso", aveva scritto il giudice di Ravenna. Successivamente
la Procura di Ravenna le aveva notificato l'avviso di conclusione indagini per
il decesso di Massimo Montanari, 95 anni, morto il 12 marzo 2014 nel reparto
dove lavorava la donna in circostanze sospette.
ASSOLUZIONE IN APPELLO. A inizio di quest'anno è
iniziato il processo di appello a Bologna, sospeso per una nuova
perizia, riportata da L'Espresso, richiesta dai giudici per far luce su cosa sia
veramente accaduto la mattina di quell'8 aprile di tre anni fa in ospedale.
Perizia che è stata decisiva. Ora la procura potrà fare ricorso in Cassazione.
Intanto Daniela Poggiali, in carcere da ottobre 2014, è libera e potrà tornare
subito a casa. "Questi ribaltamenti processuali ripetuti sono espressione del
fatto che in questa fase storica nella giurisprudenza italiana convivono
espressioni culturali diverse", il commento dell'avvocato Luca Valgimigli, uno
dei due difensori di Daniela Poggiali. Il legale cita, tra gli altri, i
controversi casi degli omicidi di Meredith Kercher, uccisa a Perugia l'1
novembre 2007, e di Chiara Poggi, assassinata a Garlasco (Pavia) il 13 agosto
2007. L'altro difensore, Stefano Dalla Valle, ha parlato di "sentenza importante
per il presupposto giuridico forte per il contesto scientifico nel quale è
maturata la decisione dei giudici".
"EVITATO ERRORE CLAMOROSO". "Oggi si sono poste le
condizioni per evitare un clamoroso errore giudiziario". L'avvocato Guido
Magnisi, difensore dell'ex primario di Medicina Interna dell'ospedale di Lugo,
Giuseppe Re, commenta così la sentenza di assoluzione per Daniela Poggiali. Il
medico, infatti, è in udienza preliminare a Ravenna, imputato "per dolosamente
non aver impedito un evento", cioè l'omicidio volontario addebitato a Poggiali,
"che si aveva l'obbligo giuridico di impedire", ricorda il difensore. In questi
casi, secondo una norma "di rarissima applicazione, non impedire un evento che
si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Per l'avvocato
Magnisi "già il dato era paradossale, perché non si vede come un soggetto possa
impedire un evento omicidiario operato da un altro soggetto senza movente
alcuno, non si vede come lo possa impedire, in base a quale obbligo giuridico, e
come lo possa prevedere. Ma - prosegue - alla luce della sentenza odierna,
l'insussistenza assoluta del fatto omicidio dimostra che la povera Calderoni è,
come dimostrato in maniera incontrovertibile dalla perizia, deceduta per morte
naturale. Sicché Re oggi sarebbe imputato di omicidio volontario per non aver
impedito la morte naturale di una paziente... Credo - conclude - che forse solo
a Dio demiurgo e all'Ente supremo si possa chiedere di impedire la morte
naturale di una persona".
"Non uccise la paziente" Assolta
l'infermiera (che urla di gioia in aula). Era accusata
della morte di un'anziana I giudici: «Il fatto non sussiste, subito libera»,
scrive Andrea Acquarone, Sabato 8/07/2017, su "Il Giornale". Era entrata quasi
di «diritto» nel novero dei mostri. Provocante, sfrontata, irriverente di certo
antipatica. Altrettanto censurabile. Non fosse altro per i selfie in cui si
ritraeva sghignazzante accanto a una sua anziana paziente appena morta. Un
macabro luccichio negli occhi, un sorriso beffardo anche quel 9 ottobre 2014,
giorno in cui l'arrestarono con accusa di essere un'assassina seriale. Secondo
la Procura aveva ucciso decine di degenti terminali. Rubando persino soldi e
preziosi a malati ormai inermi. Un malvagio «angelo» della morte, insomma. E una
ladra. Lei è Daniela Poggiali, oggi 46 anni, all'epoca infermiera dell'ospedale
«Umberto I» di Lugo, nel Ravennate. Nel marzo 2016 si vide appioppare
l'ergastolo. Ma in aula non si erano riuscite a dimostrare altre morti se non
quella di una settantottenne, Rosa Calderoni, secondo l'accusa, uccisa con
un'iniezione di cloruro di potassio. Una sostanza utilizzata nelle flebo, in
quantità ridottissime. Un poco di più e diventa letale. Poi nel giro di qualche
giorno, nemmeno un esame autoptico, ne rinviene traccia. Gli investigatori
ipotizzarono che la Poggiali, tra il 2012 e il '14, avesse fatto fuori in questo
modo «silenzioso» addirittura una novantina di malati. Sospetti, evidentemente,
senza prove. E ieri il colpo di scena: i giudici della corte d'appello di
Bologna, l'hanno assolta. Ribaltando la sentenza di primo grado «perché il fatto
non sussiste». Era presente in aula Daniela, meno altezzosa del solito. E alla
fine quasi in lacrime. Stavolta di felicità. «Sì, sì», ha urlato. Si era sempre
proclamata innocente, del resto. Solo un'ammissione aveva fatto, a proposito di
quelle foto oscene: «Lì ho sbagliato, lo ammetto- disse a giudizio-. Però devo
dire un paio di cose: l'iniziativa non è stata mia ma di una collega che le ha
scattate. E poi mai avrei immaginato che girassero... Era un cosa privata tra me
e lei. Comunque un errore». «Daniela è stata vittima di una serie di pregiudizi
che riguardavano alcuni tratti della sua personalità complessi e obiettivamente
controversi». Aspetti che però «non avrebbero dovuto legittimare questo contagio
collettivo che ha indotto a rinvenire in lei un soggetto potenzialmente
criminogeno», commenta adesso, quasi con tono di rimprovero, il suo avvocato
Lorenzo Valgimigli. I togati, prosciogliendola, hanno disposto anche l'immediata
liberazione della bionda infermiera. «Probabilmente - osserva ancora il legale -
questi ribaltamenti processuali sono espressione di un fenomeno culturale
all'interno della giurisprudenza italiana dove ci si confronta, appunto, su
opzioni culturali diverse che riguardano i diversi standard probatori che
occorre conseguire per poter condannare o prosciogliere». Un giorno di gioia per
imputata e difesa. Che non è detto, però, duri a lungo. La possibilità che la
Procura faccia ricorso contro la sentenza è più che probabile. Nel frattempo
Daniela tenterà una nuova vita. Come e dove è difficile da prevedere. Accanto,
ha un compagno, che davanti ai giudici l'ha sempre protetta: «È una donna che
ama il suo lavoro, sempre flessibile nell'accettare turni disagiati, come per
esempio quelli notturni, una che andò a lavorare anche quando fu colpita da una
brutta malattia. Quando sarà finita questa storia ci sposeremo», aveva ripetuto
alla Corte Luigi Conficconi. Parole proferite un anno fa, prima della condanna.
Ora si vedrà. Ben diverso l'umore della famiglia della «non più vittima», Rosa
Calderoni. «Il fatto di avere avuto due verdetti diametralmente opposti - spiega
l'avvocato di parte civile - lascia un profondo senso di amarezza, incertezza su
cosa sia successo. Un malessere molto difficile da metabolizzare».
Infermiera di Lugo, assolta in appello
dopo la perizia shock. In primo grado era stata
condannata all'ergastolo. Oggi, dopo i dubbi emersi dalla perizia disposta dai
giudici d’appello di Bologna sull'unica morte sospetta, è arrivata la sentenza,
scrive Alessandro Cicognani il 4 luglio 2017 con Aggiornamento del 7 luglio 2017
su "L'Espresso". La Corte di assise di appello di Bologna ha assolto perché il
fatto non sussiste Daniela Poggiali, 45 anni, ex infermiera alla sbarra per
l'omicidio di una sua paziente 78enne all'ospedale di Lugo, nel ravennate. Da
quasi tre anni l’ex infermiera di Lugo Daniela Poggiali guarda la vita scorrerle
davanti attraverso le sbarre di una prigione, contando i giorni di una pena
senza fine. Da venerdì scorso le cose attorno a un caso giudiziario che ha
sconvolto l’Italia sono però mutate drasticamente. La perizia disposta dai
giudici d’appello di Bologna sull'unica morte sospetta per cui la Poggiali è
stata finora condannata (in primo grado) all’ergastolo ha posto per la prima
volta un dubbio importantissimo: quella paziente potrebbe essere morta anche per
cause naturali. Il caso di Daniela Poggiali scoppia il 9 ottobre del 2014. Sono
le sette di sera e fuori il sole sta per tramontare, quando i carabinieri
entrano nella sua casa di Giovecca di Lugo, mettendole le manette ai polsi e
portandola in carcere. Attorno alla donna, sospettata per il decesso della
paziente Rosa Calderoni avvenuto l’8 aprile di quello stesso anno, in breve
tempo cresce un’indagine giudiziaria che la porta ad essere sospettata di decine
di morti nei suoi anni di lavoro. La vita di Daniela Poggiali si sgretola poco a
poco, anche per via di quelle note fotografie nelle quali l’infermiera era
ritratta in gesti irrisori al fiano di una donna deceduta. Prima perde il lavoro
e poi nel marzo dell’anno scorso, dopo mesi di processo, arriva per lei la
sentenza più dura: il carcere a vita per aver ucciso Rosa Calderoni con una dose
letale di potassio. Fine pena mai. Il giudice di Ravenna Corrado Schiaretti
nelle motivazioni arriverà a descriverla come una donna “fredda, intelligente e
spietata. Nemmeno lei sa quanti pazienti ha ucciso”. A inizio di quest’anno è
iniziato il processo di appello a Bologna, sospeso per via di una nuova perizia
richiesta direttamente dai giudici per far luce su cosa sia veramente accaduto
la mattina di quell’otto aprile di tre anni fa in ospedale. Oggi, a oltre un
anno da quella condanna e con un nuovo processo ancora tutto da giocare, i tre
periti nominati dai giudici hanno detto la loro, mettendo per la prima volta in
dubbio l’omicidio. In oltre settanta pagine gli esperti Gilda Caruso, docente di
patologia cardiovascolare dell’università di Bari, Mauro Rinaldi e Giancarlo Di
Vella, rispettivamente docenti di cardiochirurgia e di medicina legale
dell’università di Torino, danno conto dei due mesi di analisi svolte sul caso
Poggiali-Calderoni. Ma andiamo per gradi tra le pieghe di un documento che,
giovedì e venerdì, sarà sicuramente alla base di una lunga battaglia in aula tra
il procuratore generale Luciana Cicerchia e gli avvocati dell’ex infermiera
Lorenzo Valgimigli e Stefano Dalla Valle.
La causa del decesso della paziente. Rosa
Calderoni morì per cause naturali? Questa è la prima domanda su cui hanno dovuto
dare risposta i periti, secondo cui «in definitiva tutti i riscontri, clinici e
laboratoristici, non hanno consentito di identificare una singola causa
patologica naturale, a insorgenza acuta, idonea a cagionare, con certezza e alta
probabilità, la morte della paziente. Deve osservarsi – aggiungono – che Rosa
Calderoni fosse portatrice di un insieme di patologie croniche e che qualunque
fattore endogeno o esogeno avrebbe potuto determinarne lo scompenso». Una
risposta aperta a più soluzioni dunque, ma che per la prima volta apre le porte
anche a una probabile causa naturale per la morte di quella paziente di 78
anni.
Il potassio come strumento per uccidere. Vi è
stata una indebita somministrazione di potassio alla paziente? Una seconda
domanda, su cui gli esperti hanno risposto ponendo ancora una volta un dubbio.
Stando ai professori il quadro clinico della Calderoni era «solo in parte
compatibile con l’iperkaliemia (eccesso di potassio nel sangue ndr) a
concentrazioni letali». In primo grado, su questo punto, fu fondamentale la
testimonianza della figlia di Rosa Calderoni, che ricordò come la mattina di
quell’8 aprile del 2014 l’ultima infermiera a entrare nella stanza di sua madre
per somministrarle le cure fu proprio Daniela Poggiali. L’ex infermiera stette
all’interno della stanza per 5-10 minuti, ma proprio su questo punto emergono
nuovi elementi sottolineati dai periti. La paziente quella mattina aveva infatti
due accessi venosi, uno al piede e l’altro alla giugulare. Secondo Carusi,
Rinaldi e Di Vella «la somministrazione rapida e letale di potassio sarebbe
stata possibile solo dalla giugulare», ma questa «avrebbe dovuto causare
l’arresto cardio-respiratorio nelle immediatezze dell’infusione». La Calderoni
morì invece 60 minuti dopo. La somministrazione nel piede, ritenuta però
impraticabile, al contrario avrebbe causato forti dolori, mai accusati dalla
paziente.
Il dibattito sul metodo Tagliaro. Il potassio è
sempre stato, fin dal primo giorno, l’elemento cardine del processo a Daniela
Poggiali. Secondo gli inquirenti fu proprio usando l’effetto potenzialmente
killer della sostanza che l’infermiera tolse la vita a quella paziente di 78
anni. La conferma, allora, arrivò dall’analisi dell’umor vitreo della donna, nel
quale il consulente dell’accusa professor Franco Tagliaro trovò valori
«sballati» di potassio a 56 ore dal decesso. Anche i periti dei giudici hanno
potuto analizzare il reperto, giungendo però a conclusioni che, ancora una
volta, pongono diversi dubbi su tutto il caso. Dopo aver ricordato che sulla
concentrazione di potassio influiscono decine di fattori, tra cui età, stato di
salute (il diabete mellito, come tra l’altro aveva Rosa Calderoni, può alterare
i valori di base), temperatura del corpo e che in letteratura non c’è consenso
unanime su quale sia l’equazione più affidabile per il calcolo della presenza di
potassio nell’organismo umano, anche per via dell’alto margine di errore, i
professori hanno preso atto che «il potassio rinvenuto risulta superiore al
valore atteso, ma limitatamente al campione di riferimento e alla metodologia di
indagine usata». Ossia il noto metodo Tagliaro più volte contestato dalla
difesa.
Il depistaggio sul prelievo di sangue. Un altro
punto fondamentale dell’inchiesta, riguardava la nota emogasanalisi delle 9 del
mattino di quel tragico 8 aprile eseguita su Rosa Calderoni. Secondo l’accusa
quell’esame, che mostrava valori della paziente nella norma, non era veritiero
in quanto la Poggiali avrebbe sostituito le sacche di sangue per evitare di
essere scoperta. Secondo i periti quel sangue è invece «compatibile con il
quadro clinico della paziente». Tradotto: nessun depistaggio.
Le cartelle cliniche. L’ultimo interrogativo posto
dai giudici d’appello riguardava invece la presenza in reparto di una paziente
sottoposta a cure a base di potassio. Dall’esame delle cartelle cliniche, stando
ai tre esperti, in quei giorni una donna era «sottoposta a terapia endovenosa
con potassio in pronto soccorso» per una grave ipokaliemia. Sei quesiti precisi
e dettagliati, a cui sono seguiti risposte che, aprendo di fatto le porte a una
possibile morte naturale di Rosa Calderoni, hanno portato un dubbio pesantissimo
all’interno del processo. E venerdì, giorno decretato per la sentenza di
appello, Daniela Poggiali avrà la risposta che attende: conferma della
colpevolezza oppure no?
PRESUNTO COLPEVOLE. PIER PAOLO BREGA MASSONE.
Biografia di Pier Paolo Brega Massone.
• Stradella (Pavia) 18 luglio 1964. Medico. Capo
dell’équipe chirurgo-toracica della clinica Santa Rita di Milano, la “clinica
degli orrori”. Arrestato il 9 giugno 2008 con l’accusa di omicidio aggravato
dalla crudeltà. L’ordinanza del giudice Micaela Curami «lo dipinge più che come
un dottore come un procacciatore d’affari. Un business man col camice bianco
alla caccia di soldi per il proprio reparto, pronto ad usare il bisturi anche
quando non ce n’era bisogno, pur di incrementare i rimborsi da chiedere al
sistema sanitario nazionale» (Walter Galbiati ed Emilio Randacio). Scarcerato
nel novembre del 2009, tornò in cella nell’aprile 2010, quando la Cassazione
rigettò il ricorso del difensore. Condannato a 15 anni e mezzo di carcere dai
giudici della Corte d’appello di Milano nel marzo 2012. Nel giugno 2013 la
Cassazione annullò la sentenza di secondo grado chiedendo a una nuova sezione
della Corte d’appello di Milano di ricalcolare la pena inflitta all’ex chirurgo
in quanto alcuni reati contestati erano caduti in prescrizione. Il 6 novembre
2013, nell’appello bis, arrivò la conferma della condanna già inflitta in
secondo grado a 15 anni e mezzo di carcere per lesioni ai danni di un’ottantina
di pazienti, falso e truffa al servizio sanitario nazionale. «Per l’accusa, l’ex
primario avrebbe eseguito interventi inutili e “ritoccato” le cartelle cliniche
dei malati allo scopo di gonfiare i rimborsi per le prestazioni da parte della
Regione. Ma, in seguito alla decisione della Suprema Corte, e prima dell’appello
bis, la procura generale di Milano, ritenendo la sentenza definitiva per la
parte in cui non era stata annullata, ha emesso un ordine di carcerazione».
Proprio quest’ordine di carcerazione fu contestato dalla difesa in quanto il
verdetto non era ancora passato in giudicato. I legali chiesero la revoca del
provvedimento restrittivo tramite un «incidente di esecuzione» dichiarato però
infondato dalla sezione feriale della Corte d’appello milanese. Quest’ultima
decisione fu di nuovo impugnata davanti alla Cassazione che diede ragione ai
legali di Brega Massone, bocciando sia l’ordinanza della sezione feriale sia
l’ordine di carcerazione (Corriere della Sera 15/1/2014). Così il 14 gennaio
2014 è uscito dal carcere, in attesa che la Cassazione pronunci l’ultima parola
dopo il ricorso dei suoi legali all’appello bis.
• È imputato anche in un secondo processo in cui
deve rispondere di quattro omicidi e altri casi di lesione.
• «È figlio d’arte. La passione per il bisturi
l’ha ereditata dal padre adottivo, uno stimato chirurgo dell’Oltrepò Pavese,
molto noto a Stradella e a Broni dove aveva pazienti che gli erano affezionati.
Morto il padre, Pier Paolo Brega Massone è diventato il loro punto di
riferimento. Se serviva un ricovero, di qualsiasi tipo, il chirurgo era sempre
pronto a trovare un letto a Milano. Alla Santa Rita, naturalmente. E sono
proprio loro, i pazienti dell’Oltrepò pavese, a difenderlo a spada tratta. “Ci
deve essere un errore – dicono in molti – per noi è un bravo medico, la verità
verrà a galla”. Pier Paolo Brega Massone, laureato a Pavia, dove ha fatto la
specialità in Chirurgia al Policlinico San Matteo, si è costruito una carriera
tutta basata su una robusta mole di lavoro. All’Istituto dei tumori di Milano,
dove ha lavorato tra il 2000 e il 2003, con contratti da borsista e da
collaboratore, e dunque da precario, i colleghi del reparto di chirurgia
toracica, parlano di lui come il medico armato di “turbo-bisturi”» (Laura
Asnaghi). GIORGIO DELL’ARTI su "Il Corriere della Sera", scheda aggiornata al 22
gennaio 2014
Clinica Santa Rita, 15 anni per Brega
Massone nel processo bis. Ergastolo annullato: “Omicidi preterintenzionali”.
Il chirurgo della cosiddetta "clinica degli orrori"
era stato condannato al carcere a vita nel primo processo poi annullato dalla
Cassazione. La Procura generale aveva chiesto comunque il "fine pena mai" ma la
richiesta non è stata accolta dalla Corte d'appello di Milano. La moglie del
medico scoppia in lacrime: "Ora vediamo la luce, mio marito non è un mostro",
scrive "Il Fatto Quotidiano" il 19 ottobre 2018. E’ stato condannato a 15
anni di carcere Pier Paolo Brega Massone, l’ex chirurgo toracico della Clinica
Santa Rita, nel processo bis davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano,
con al centro la morte di 4 pazienti, avvenuta in quella che i giornali
chiamarono la “clinica degli orrori”. L’ex braccio destro di Brega
Massone, Fabio Presicci, imputato per due dei decessi, è stato condannato a 7
anni e 8 mesi. I giudici hanno riformulato l’accusa per i due
in omicidio preterintenzionale, riducendo dunque la pena. A Brega Massone erano
già stati inflitti in via definitiva 15 anni e mezzo di carcere per truffa. “Ora
vediamo la luce” ha detto la moglie del chirurgo, Barbara Magnani che è
scoppiata a piangere dopo la lettura del dispositivo. La Magnani ha aggiunto di
non avere creduto che il marito fosse “un mostro” e di non avere mai perso la
“speranza nella giustizia” anche se “la paura era fortissima”. “Credo che negli
altri Stati europei non esistano pene così severe per i medici – ha aggiunto -,
sarebbe il caso che qualcuno ci riflettesse”. Rendendo dichiarazioni spontanee
la scorsa udienza, Brega Massone aveva detto: “Mi dispiace per tutto quello che
è avvenuto e chiedo scusa a tutte le persone che hanno molto sofferto, non era
mia volontà. Ora posso solo chiedere di rivedere la luce, poter essere utile e
stare con la mia famiglia”. Oltre ad avere riformulato l’accusa da omicidio
volontario a omicidio preterintenzionale, i giudici hanno escluso l’aggravante
del “fine di lucro” e hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Il sostituto
pg Massimo Gaballo aveva chiesto la conferma dell’ergastolo per Brega Massone e
21 anni di carcere per Presicci per omicidio volontario. Riteneva che le morti
contestate erano frutto di “un modus operandi seriale” dell’ex chirurgo e che i
“decessi erano altamente probabili” in quanto conseguenza di operazioni “ad alto
rischio morte” dei pazienti. A perdere la vita per via delle operazioni condotte
da Brega furono Giuseppina Vailati, 82 anni, Maria Luisa Scocchetti, 65
anni, Gustavo Dalto, 89 anni, e Antonio Schiavo, 85 anni. Tutti anziani portati,
secondo l’accusa, in sala operatoria senza alcuna giustificazione clinica per
interventi “inutili” effettuati al solo fine di “monetizzare” i rimborsi
del sistema sanitario nazionale per la clinica convenzionata. Una prima sentenza
era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Nel processo
principale, infatti, fino all’appello del dicembre 2015, Brega Massone era stato
condannato all’ergastolo per l’accusa di omicidio volontario plurimo (e per
questo Presicci aveva avuto una pena di 24 anni e 4 mesi). Per i supremi giudici
però non erano stati “omicidi dolosi” o comunque che non era motivata in modo
sufficiente la volontarietà.
Brega Massone non è più il mostro,
annullato l’ergastolo. Brega Massone è stato
condannato a 15 anni, mentre Fabio Presicci si è visto ridurre la pena da 24
anni e 4 mesi a 7 anni e 8 mesi, scrive Simona Musco il 20 Ottobre 2018 su "Il
Dubbio". Pierpaolo Brega Massone e Fabio Presicci non entravano in sala
operatoria accettando l’eventualità di uccidere i propri pazienti. Lo hanno
stabilito ieri i giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano,
riqualificando il reato a carico dell’ex chirurgo toracico della Clinica Santa
Rita e del suo vice da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. I due
erano accusati di omicidio volontario in relazione alla morte, rispettivamente,
di quattro e due pazienti in sala operatoria. Brega Massone è stato condannato a
15 anni, mentre Presicci si è visto ridurre la pena da 24 anni e 4 mesi a 7 anni
e 8 mesi. A giugno dello scorso anno la Cassazione aveva messo tutto in dubbio,
annullando con rinvio la condanna all’ergastolo pronunciata nel primo processo
d’appello il 21 dicembre 2015: per i giudici non si può parlare di dolo per le
vittime, uccise, secondo i pm, da “interventi inutili”, effettuati solo per
“monetizzare” i rimborsi del sistema sanitario nazionale. Un concetto che il
procuratore generale Massimo Gaballo ha ribadito anche nella requisitoria
dell’appello bis, chiedendo la conferma dell’ergastolo per Brega Massone e la
riduzione da 25 a 21 anni per Presicci, al quale aveva riconosciuto le
attenuanti generiche. Secondo Gaballo, c’era una “assoluta carenza di finalità
terapeutica degli interventi” finiti al centro dell’inchiesta e gli imputati
erano “perfettamente consapevoli di non poter dominare il rischio post
operatorio. La morte era una conseguenza prevedibile”. Un’immagine terribile,
che è valsa negli anni a Brega Massone la qualifica di “chirurgo killer”. Un
ruolo, secondo il suo avvocato, Nicola Madia, che i media «hanno costruito
accuratamente», come «un abito su misura, l’abito di un mostro e per questo ha
subito un trattamento così severo». L’ex chirurgo toracico, che al momento della
lettura della sentenza non era in aula, sarebbe invece soltanto un «fanatico
della chirurgia» che avrebbe pagato la sua “ambizione”. Brega Massone sta
scontando un’altra condanna definitiva a 15 anni e mezzo per truffa e lesioni
nei confronti di un’altra ottantina di pazienti. Accusa, quest’ultima, dalla
quale continua a professarsi innocente. La sentenza di ieri ha escluso anche
l’aggravante del nesso teleologico, ovvero «la finalità di lucro» degli
interventi eseguiti dai medici imputati, condannati a risarcire le parti civili.
«Sono felicissimo», ha confidato al telefono alle persone a lui vicine l’ex
chirurgo. «È una sentenza che mi emoziona, ora vediamo la luce», ha aggiunto la
moglie Barbara Magnani, che ha assistito a tutte le udienze. «Non l’ho mai
abbandonato – ha aggiunto, è difficile per me parlare oggi. Non ho mai creduto
che fosse un mostro e non ho mai perso la speranza nella giustizia, anche se la
paura era fortissima». Assente alla lettura del dispositivo anche Presicci, che
è stato radiato dall’albo dei medici e ha già pagato il suo conto con la
giustizia. L’ex medico era già stato condannato definitivamente a 8 anni e sei
mesi di carcere per un’ottantina di lesioni dolose, pena che ha finito di
scontare a settembre. «Mi di- spiace aver fatto soffrire involontariamente delle
persone commettendo errori – ha commentato all’Agi -. Non ho mai detto di avere
sempre fatto tutto bene, ma non ho mai voluto fare del male ai miei pazienti per
carpire la loro fiducia e fargli spendere soldi». Dopo due sentenze che
ritenevano dimostrato il dolo, la svolta è arrivata con la decisione dei giudici
della Cassazione, secondo cui non c’era nessuna prova che Brega Massone abbia
accettato l’eventualità della morte di quei pazienti. L’ex chirurgo era dunque
stato condannato al carcere a vita nonostante non fosse stata dimostrata la sua
volontà di correre il rischio di uccidere i propri pazienti pur di eseguire
quegli interventi inutili e dannosi, solo per ottenere i rimborsi garantiti dal
sistema sanitario. Una sentenza con la quale la Cassazione aveva chiesto ad una
nuova sezione della Corte d’Assise d’appello di Milano di valutare “la
qualificazione giuridica dei reati, in termini di omicidio volontario, anziché
di omicidio preterintenzionale”, escludendo a priori l’ipotesi dell’omicidio
colposo. Parole, quelle degli ermellini, che obbligavano i giudici di merito a
dimostrare «” a sussistenza dell’ulteriore elemento psicologico rappresentato
dal dolo omicidiario” in relazione ai quattro decessi avvenuti dopo interventi
privi “di giustificazione e legittimazione medico– chirurgica”. I giudici del
primo appello si erano quindi limitati a elencare una serie di possibili
indicatori del dolo eventuale, eludendo “il nucleo fondamentale del ragionamento
probatorio– argomentativo”, ovvero la prova della volontà degli imputati di
agire comunque di fronte alla probabilità che i pazienti perdessero la vita a
causa di quegli interventi. Tanto da parlare di “inadeguatezza del percorso
motivazionale” dei giudici d’appello in relazione a questo punto, dovuta al
fatto di aver attribuito “una dirimente capacità dimostrativa” agli elementi
indiziari correttamente utilizzati per dimostrare la natura dolosa delle lesioni
provocate nel corso dell’attività medico– chirurgica, ma che non possono invece
“valere di per sé a integrare la prova (anche) della sussistenza dell’elemento
psicologico”. Assente, secondo i giudici dell’appello bis.
Santa Rita, Brega Massone. L’orrore che
non c’era. Scrive Emanuele Boffi il 18 luglio 2017 su
Tempi. Controinchiesta su un caso che fu dipinto con tinte horror dalla nostra
stampa e tv. Alcuni ragionevoli dubbi su carte, perizie e soldi che ci portarono
a dipingere il chirurgo Brega Massone come un sadico killer in camice bianco.
«Clinica degli orrori. Bisturi assassini. I pirati della sanità. Una strage.
Decine di morti. Pazienti torturati. Macelleria. Vivisezione. Horror movie. Sala
operatoria a cottimo. Mutilava le donne. Tagliare via seni con noncuranza, come
si tira un pezzo di polmone a un gatto». E ancora: «Dottor Morte. Mai più
chirurghi come lui. Il primario degli orrori. L’odore dell’odio». Queste sono
solo alcune delle espressioni virgolettate o dei titoli apparsi sui giornali per
raccontare la vicenda della clinica Santa Rita di Milano e del suo primario di
chirurgia toracica Pier Paolo Brega Massone, primo medico in Italia, e
probabilmente al mondo, ad essere condannato all’ergastolo nell’esercizio delle
sue funzioni. Eppure il 22 giugno la Corte di Cassazione ha annullato la
sentenza sancendo che il chirurgo dovrà essere giudicato da un nuovo collegio di
Corte d’Assise d’Appello a Milano, non più con l’accusa di omicidio volontario.
Una decisione strabiliante, sia perché la Suprema Corte ha ribaltato la condanna
all’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà per la morte di
quattro pazienti dell’aprile 2014 e la sua conferma in appello nel dicembre
2015, sia perché, per la prima volta, la figura di Brega Massone non è stata
associata a quella del sadico killer. “Il Dottor Morte della clinica degli
orrori”, insomma, non lo era. In attesa di conoscere le motivazioni, qualche
considerazione può essere avanzata, non fosse altro per la mastodontica
sproporzione con cui il pronunciamento della Cassazione è stato accolto sui
nostri giornali – rapidamente relegato nelle notizie di cronaca – a fronte
invece della lunga e martellante campagna mediatica con cui il caso fu trattato
anni fa, quando faceva da titolo d’apertura a quotidiani, settimanali e tg
serali. Fino ad oggi, infatti, a proposito della “clinica degli orrori” ci è
stata raccontata una storia senza sfumature, graniticamente monolitica nella sua
narrazione, senza alcuna sbavatura non diremo innocentista, ma nemmeno
garantista. Se si escludono alcuni articoli apparsi su La provincia pavese e un
editoriale pubblicato il 24 giugno 2008 sul Corriere della Sera a firma di
Pierluigi Battista (“L’istinto di colpevolezza”) non esiste all’interno del
panorama mediatico italiano alcuna voce che abbia osato discostarsi dal
grandguignolesco canovaccio dell’horror movie. O meglio, una voce c’è e c’è
stata, e qui le si vuole rendere tributo se non altro come esempio di
giornalismo d’inchiesta fattuale e non teorematico, basato su prove e carte e
non su opinioni, preoccupato di documentare ogni propria affermazione prima di
sottoporla al pubblico giudizio. Certo, con una chiave interpretativa precisa
che può essere sempre discussa, ma che certamente ha il merito di motivare ogni
propria asserzione senza ricorrere all’ipse dixit o all’emotività. Si tratta
di E se il mostro fosse innocente? di Giovanna Baer e Giovanna Cracco (edizioni
Paginauno), controinchiesta pubblicata nel febbraio 2012 che – come è intuibile
dal titolo – cercava di smontare le accuse rivolte a Brega e alla sue équipe.
Dopo la pubblicazione del volume, Giovanna Cracco ha proseguito nella sua
indagine pubblicando sul sito della rivista Paginauno quelle che lei definisce
le sue “controcronache”, dettagliati resoconti delle udienze svolte in
tribunale. Cracco, come forse solo gli avvocati e i magistrati del procedimento,
può vantare di aver letto tutte le carte dell’accusa e della difesa, le 1.862
pagine di intercettazioni, tutti gli articoli dedicati alla vicenda. «Un lavoro
enorme – spiega a Tempi – che ha richiesto tempo e studio. Un lavoro fortemente
osteggiato, tanto che qui a Milano siamo riusciti ad organizzare una sola
presentazione e solo grazie all’interessamento di Marco Cappato dei Radicali, e
fuori città solo grazie all’appoggio dell’Ordine dei medici di Pavia, da sempre
assai critico sulle sentenze del tribunale. Non abbiamo mai ricevuto richieste
di smentite né querele, tutto ciò che scriviamo è motivato con documenti che
sono riportati nel volume o online. È tutto alla luce del sole. Non ci sono gole
profonde, non ci sono fonti riservate, è tutto e solo negli atti pubblici. Se
non vi fidate di noi, leggeteli e fatevi un’opinione». Il punto attorno cui
ruota tutto il ragionamento di Baer e Cracco è che vi sia un ragionevole dubbio
a proposito della colpevolezza del chirurgo e degli altri condannati. Per questo
è necessario raccontare la vicenda pur per sommi capi, ma a partire da un
aspetto su cui la stampa non si è mai per nulla concentrata, eppure
fondamentale: un’indagine della commissione Asl su tredici episodi di
tubercolosi segnalati in 18 mesi, a partire dal gennaio 2006, alla clinica Santa
Rita. A partire da questa indagine e da una segnalazione anonima giunta in
procura su un’ipotetica truffa alla Santa Rita ai danni del Sistema sanitario
nazionale a proposito dei rimborsi regionali, furono predisposti il sequestro
delle cartelle cliniche (inizialmente, non quelle dell’unità toracica dove
operava Brega) e le intercettazioni. In base a questo materiale è stato dato il
via al processo che poi si è ramificato in due filoni. Nel primo, si è arrivati
a sentenza definitiva e Brega è stato condannato a 15 anni e mezzo di carcere
per truffa, falso e per una ottantina di casi di lesioni dolose. Il secondo,
quello che ha portato all’ergastolo con l’accusa di omicidio volontario
aggravato dalla crudeltà per la morte di quattro pazienti e di lesioni dolose
per una quarantina di persone, è quello su cui la Cassazione s’è pronunciata di
recente.
Eterna carcerazione preventiva. Nel mezzo della
vicenda, Brega è stato licenziato dalla Santa Rita e il suo ricorso al Tar per
dimostrare la propria estraneità al “contagio da Tbc” non è mai stato discusso
nell’udienza fissata per il 19 giugno 2008. Dieci giorni prima, il 9 giugno
2008, fu arrestato con altre quattordici persone: dodici finirono ai
domiciliari, Brega e il suo primo aiuto, Fabio Presicci, al carcere di San
Vittore. Il Riesame fece cadere l’accusa di omicidio – che poi è tornata in
piedi – ma confermò le ipotesi di lesioni dolose e Brega rimase in custodia
cautelare – a parte una parentesi di sei mesi – per cinque anni, un’eternità.
Comunque la si pensi, risulta difficile non condividere l’osservazione di Cracco
e Baer nel denunciare il ricorso alla carcerazione preventiva come fortemente
limitante la libertà dell’imputato che, dalla piccola cella di San Vittore,
faticava enormemente a organizzare la propria difesa. Oltretutto, le tre
condizioni che per legge ne avrebbero motivato la custodia non parevano
sottostare. Quando essa fu predisposta, Brega non poteva inquinare le prove
perché già ampiamente acquisite; non poteva reiterare il reato perché, non
possedendo una sala operatoria, non poteva effettuare operazioni; aveva
dimostrato di non volere fuggire, non avendo mai approfittato, nemmeno nei mesi
di libertà, di una tale possibilità.
A Brega non furono mai concessi gli arresti
domiciliari. Pier Paolo Brega Massone si è sempre dichiarato innocente. Lo ha
fatto dal primo giorno in cui gli sono state mosse le accuse, lo ha ripetuto il
giorno in cui è stato condannato all’ergastolo, lo dice oggi: «Non ero un serial
killer. La mia priorità è sempre stata quella di dare ai pazienti la sicurezza.
Ho sempre agito in scienza e coscienza». A scanso di equivoci, è bene
sottolineare che il lavoro di Baer e Cracco arriva a imputare al medico una
truffa – ma non delle proporzioni per le quali è stato condannato –, ma a
criticare fortemente l’impianto accusatorio relativo all’accusa di lesioni
dolose e di omicidio volontario. In particolare, secondo le due autrici, è
provato che vi sia stato un raggiro in merito ai passaggi di reparto tra acuti e
riabilitazione (una truffa amministrativa, che non riguardava la cura dei
pazienti) e in merito alla codifica di alcune cartelle relative ai casi di
senologia, ma anche in questo caso, si tratta di falso in cartella e non
dell’intervento effettuato sulle pazienti.
Il linguaggio sconveniente. Quando la vicenda lo
travolge, Brega è uno stimato chirurgo originario del Pavese che ha al suo
attivo circa 1.400 interventi come primo operatore, ossia responsabile in sala
operatoria, e 371 pubblicazioni scientifiche di cui 169 con primo nome.
L’attenzione della procura si concentra su di lui a partire dalle
intercettazioni, in cui, secondo l’accusa, si rintraccia il movente: il denaro.
Oggi il sistema è cambiato, ma al tempo molte retribuzioni dei medici erano
legate in percentuale (tra il 9 e l’11 per cento) al rimborsi dei drg (il
sistema di calcolo della spesa attribuito a ogni diverso tipo di operazione)
percepito dalla clinica. Poiché nessuno è mai riuscito a dimostrare che Brega
fosse un sadico, l’aspetto economico è importante perché spiega, secondo le
sentenze, il motivo per cui Brega era spinto a intervenire il più possibile,
aumentando i propri guadagni. In effetti, i medici della Santa Rita, compreso
Brega, al telefono discutevano animatamente di soldi in relazione agli
interventi, ma, contestano Baer e Cracco, parlarne non significava ammettere che
si operava “solo e soltanto” con questo fine, negando quello medico. Il
linguaggio utilizzato – e che ovviamente in quei mesi finì su tutti i giornali
sapientemente enfatizzato – poteva essere considerato riprovevole moralmente,
persino scandaloso, ma non costituiva reato. Poteva indurci a pensare che Brega
fosse uno sbruffone pieno di sé, ma questo, se non suffragato da prove, non
faceva di lui un criminale seriale.
Mille euro in più al mese. Si tratta poi di
dettagliare a quanto effettivamente ammontasse la truffa. In quel periodo sui
quotidiani si potevano leggere cifre da capogiro («2,5 milioni») che, però, per
quanto riguarda Brega e la sua équipe, erano molto più contenute. A quel tempo,
alla Santa Rita così come in molti altri enti lombardi il rapporto tra chirurgo
e clinica era strutturato in due parti: sui ricoveri, come detto, al medico
spettava il 9 per cento dell’importo dei drg rimborsati dalla Regione; per le
degenze in riabilitazione il medico percepiva 10,33 euro per ogni giorno di
ricovero del paziente. Fatto salvo quanto già scritto, e cioè che una truffa ci
fu nei passaggi da un reparto all’altro, occorre anche andare a fare i conti in
tasca a Brega. Secondo quanto calcolato da Baer e Cracco, sulla base di una
consulenza tecnica depositata al primo processo, l’équipe dei tre medici – era
infatti Brega, con il 9 per cento percepito, a pagare i due aiuti – avrebbe
intascato 25.000 euro al lordo delle imposte nel 2005, 39.000 euro nel 2006,
25.000 euro nel 2007. Nella sostanza, le loro cifre non si discostano da quelle
che lo stesso Brega ha rivelato ad Annalisa Chirico che lo intervistò per
Panorama il 17 luglio 2014 mentre si trovava in carcere, e che si riferivano ai
casi contestati in entrambi i processi: «Il pm – disse il dottore – sostiene
che, “checché ne dica il mio commercialista”, io avrei incassato 300 mila euro
sulla base del fatto che la clinica aveva avuto 3 milioni. Il 9 per cento è pari
a 270 mila lordi, da dividere fra i tre componenti dell’équipe. Al netto delle
tasse, l’importo percepito da noi tre era di 151 mila euro. Poniamo pure che io
in qualità di primario ne prendessi il 65 per cento: la mia retribuzione sarebbe
stata di 98 mila euro. Quindi, secondo l’accusa, per guadagnare 1.000 euro in
più al mese io avrei deliberatamente rischiato quanto mi è successo. Non è un
caso che nelle fasi finali del processo lo stesso pm abbia precisato di non aver
quantificato il lucro sostenendo che io avrei effettuato gli interventi più “per
megalomania” che per trarne profitto». Il tasto su cui Baer e Cracco battono
maggiormente riguarda le perizie dei consulenti dell’accusa e della difesa così
come furono presentate nel corso del primo processo. La materia è complessa:
stiamo parlando di chirurgia toracica, un campo della medicina ad alta
specializzazione ed, inevitabilmente, le parole degli esperti sono fondamentali
per formare nei giudici una corretta interpretazione dei fatti. Baer e Cracco
insistono sul fatto che il profilo professionale del «grande accusatore» di
Brega fosse inadeguato. Si trattava di un dottore con un passato in chirurgia
generale, che da dieci anni non entrava in sala operatoria e che, al momento
della perizia, svolgeva l’attività di medico di base. Nel suo curriculum non
figuravano competenze nel campo della chirurgia toracica né in quello della
medicina legale. Fu l’unico dei periti dell’accusa a visionare tutte le 575
cartelle sequestrate e a segnalare ai pm i casi clinici da contestare. Gli altri
periti dell’accusa – tutti medici dal curriculum adeguato al compito – basarono
i propri pareri a partire dalla sua scrematura delle cartelle cliniche. Il
punto, fanno notare Baer e Cracco, è che nessuno di loro visionò le lastre (tac,
rx, etc) e la documentazione medica completa, ma solo i referti del radiologo.
Inoltre, le valutazioni dei periti dell’accusa furono generalmente molto
stringate e poco, a parte un caso, attente a motivare le proprie affermazioni
basandosi sulla letteratura scientifica. Nel caso del primo e più importante
perito, poi, per i casi relativi alle patologie toraciche non vi sono
indicazioni in letteratura, protocolli ospedalieri o linee guida atte a motivare
le proprie opinioni.
Chi ha ragione? Al contrario, i periti della
difesa, oltre a poter vantare curriculum adeguati e di fama internazionale,
forti del fatto di aver visionato tutto il materiale, immagini comprese,
giunsero a conclusioni diametralmente opposte. Tuttavia non fu loro sempre
consentito proiettare le lastre in udienza, fatto che avrebbe aiutato a
comprendere meglio le decisioni prese da Brega e dalla sua équipe in determinate
situazioni – anche perché, davanti ad alcune immagini, si è riscontrato in aula
l’inesattezza di quanto scritto nel referto. Le consulenze degli specialisti
della difesa, inoltre, risultarono molto lunghe e articolate (una supera le 500
pagine), riportando in calce riferimenti a una letteratura scientifica ricca e
dettagliata a sostegno delle proprie valutazioni. L’osservatore distaccato
potrebbe, a questo punto, conservare ancora qualche perplessità. Chi aveva
ragione? Fu anche per questo che gli avvocati di Brega chiesero più volte che
fosse disposta una perizia super partes. Il tribunale rifiutò sempre, arrivando
a definire, nella sentenza di primo grado, il lavoro dei consulenti della difesa
come «infarcito di imprecisioni, omissioni e contraddizioni». Fu in base alla
prima sentenza di condanna che una delle vittime, la signora D.P.,
cinquant’anni, sovrappeso, forte fumatrice, intentò una causa in sede civile
contro Brega. Il giudice del nuovo procedimento decise di nominare periti super
partes che analizzarono tutta la documentazione medica, le lastre, lo stato di
salute della signora dopo l’intervento di Brega. Le conclusioni cui giunsero
tali specialisti, in aperto contrasto con quelle del primo processo in cui la
donna era risultata vittima, furono che le terapie che le erano state prestate
erano «perfettamente appropriate» e che l’intervento cui era stata sottoposta
era stato «eseguito a regola d’arte». Oltre al caso D.P., nella vicenda Brega
Massone-Santa Rita esiste un altro caso in cui altri specialisti super partes
sono stati chiamati ad esprimersi e, anche in questo secondo, le conclusioni
sono favorevoli al chirurgo. La domanda di Baer e Cracco è inevitabile: quanti
altri casi D.P. esistono? Perché il tribunale non ha voluto disporre una perizia
super partes? E perché, anche di fronte a tali pareri, ha comunque condannato
Brega? Il dubbio che altri expertise avrebbero dimostrato il buon operato di
Brega è lecito e ragionevole.
Legge bavaglio. In tutta questa vicenda un ruolo
essenziale lo hanno giocato stampa e tv. L’11 giugno 2008, due giorni dopo i
primi arresti, la Santa Rita era già diventata sui quotidiani la «clinica degli
orrori» e Brega «il mostro». È la solita storia: sono note solo le ipotesi
investigative, ma raramente parole come «presunto» o «sospettato» appaiono
accanto ai nomi degli accusati. I termini complessi della chirurgia toracica
furono espunti dalle cronache e dai servizi dei tg, dando rilievo solo alle
posizioni della procura. Tra l’altro, in quel periodo, in Italia si stava
discutendo il ddl Alfano che avrebbe voluto limitare l’abuso e la diffusione
delle intercettazioni.
Il caso Santa Rita divenne uno dei cavalli di
battaglia dei detrattori della “legge bavaglio”. L’11 giugno 2008 una puntata di
Matrix condotta da Enrico Mentana e intitolata “La clinica degli orrori” mandò
in onda l’audio di alcune intercettazioni dando adito all’ospite Marco Travaglio
di affermare che, senza quelle, «non si sarebbe potuto scoprire che questi
[medici] non solo facevano i falsi delle cartelle cliniche ma ammazzavano la
gente». Oggi, dopo la sentenza della Cassazione, un finale molto diverso di
questa vicenda potrebbe essere scritto (il condizionale è d’obbligo), ma nessun
quotidiano o tv sembra più interessato a occuparsi del “mostro” della “clinica
degli orrori”. La storia non fa vendere più. E questa è una mesta certezza oltre
ogni ragionevole dubbio.
Quindi il dottore Brega Massone non era
un mostro…, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 24 giugno
2017 su "Il Dubbio". C’è una donna, sfinita ma tenace, che aspetta una
telefonata. Alla fine l’avvocato Titta Madia chiama e comunica: «Niente
ergastolo, niente omicidio volontario, tuo marito non passerà in carcere il
resto dei giorni, una nuova Corte d’appello dovrà rideterminare la pena». Lei,
Barbara, scoppia a piangere, perché si affaccia ancora una volta sulla vertigine
in cui è sospesa da 9 lunghi anni: mio marito non è un mostro eppure nessuno ci
crede. Lui, Pier Paolo Brega Massone, il dottor Frankestein della cosiddetta
clinica degli orrori, è a sua volta sospeso tra due ipotesi, nascoste nelle
motivazioni che la Suprema corte depositerà: omicidio colposo o omicidio
preterintenzionale. Barbara Magnani è la moglie del mostro. Sarà anche una donna
gentile ma quando nelle cronache viene riportata una sua dichiarazione, la si
precede sempre con espressioni del tipo “… ebbe il coraggio di dire… ”. Perché
la coniuge di un chirurgo toracico che – dicevano fino all’altro ieri le
sentenze – opera solo per incassare i rimborsi del sistema sanitario, non merita
neppure di piangere l’assenza del marito. Adesso un velo di fiducia nella
giustizia si è acceso negli occhi di questa signora. Secondo i familiari delle
quattro vittime, Brega Massone «deve pagare tutto». Ma per la sua famiglia, il
medico oggi 51enne ha sempre fatto il suo dovere. Ha praticato spesso una
tecnica di chirurgia toracica che ha in realtà una funzione diagnostica. Quattro
dei pazienti sottoposti a quel tipo di intervento sono deceduti: Giuseppina
Vailati, 82 anni, Maria Luisa Scocchetti, 65 anni, Gustavo Dalto, 89 anni e
Antonio Schiavo, 85 anni. Secondo la difesa, non furono i ferri del chirurgo ha
causare le morti, ma un quadro già in gran parte compromesso, rispetto a cui
Brega Massone provò, con gli interventi, a verificare se esisteva una estrema
possibilità di recupero. Secondo l’accusa, si trattò di «cose inspiegabili, con
«asportazioni di pezzi più o meno grossi di polmone». Stabilire la verità era
doveroso. Ma se a dodici anni dai fatti contestati, dopo due distinti
procedimenti penali, una condanna della Corte dei conti e due cause di
risarcimento civile, se in capo a questo lungo iter, la Cassazione stabilisce
che hanno sbagliato sia in primo che in secondo grado, potrà essere legittimo
dubitare che la verità stia davvero in quell’appellativo, “mostro”? E questa la
vertigine da incubo. Il labirinto in cui sono intrappolati i familiari del
medico. Loro, e i loro avvocati, hanno sempre protestato per il fatto che in
entrambi i processi penali i collegi giudicanti si siano rifiutati di
commissionare perizie d’ufficio. Sono stati ascoltati solo i pareri dei
consulenti di parte, accusa e difesa. Mai un tecnico che dovesse rispondere solo
al giudice terzo. Un’anomalia. Che potrebbe essere tra le architravi della
pronuncia arrivata due giorni fa dalla Suprema corte.
La clinica Santa Rita è un fiore all’occhiello
della sanità lombarda. Brega Massone vi lavora come primario del reparto di
chirurgia toracica. Il sistema delle strutture private accreditate presso la
Regione funziona perfettamente. Ma è anche oggetto di insinuazioni. A metà degli
anni 2000, all’epoca dei fatti contestati a Brega Massone, l’amministrazione è
presieduta da Roberto Formigoni e il sistema sanitario è considerato sotto il
pieno e capillare controllo della componente politica a cui fa capo il
governatore, Comunione e liberazione. In un clima segnato da veleni
impercettibili, si verificano le drammatiche vicende che costeranno le condanne
a Brega Massone. I quattro decessi e gli oltre 100 casi complessivi di
operazioni non necessarie, in parte delle quali sarebbe stato rilevato il reato
di lesioni, anche gravi. Il 9 giugno 2008 il chirurgo viene arrestato insieme ad
altre 13 persone, tra amministratori e medici della Santa Rita. Lui e Fabio
Presicci, il suo “braccio destro” (condannato a 25 anni in Appello e anche lui
destinatario della sentenza di annullamento della Cassazione), sono gli unici a
finire in carcere, gli altri vanno ai domiciliari. I particolari sono
immediatamente riportati dai media: mammelle asportate a donne anche giovani
nonostante bastasse togliere i noduli, e soprattutto quei numerosi interventi al
torace, fatali in cinque casi. Le indagini vanno avanti per 3 anni. Ne verranno
fuori due distinti procedimenti a carico del chirurgo originario di Pavia: uno
va più spedito, riguarda 83 operazioni «non necessarie», vede il chirurgo
imputato per lesioni anche gravi e truffa e arriverà a sentenza definitiva il 26
febbraio 2015. Nell’altro si procede con più lentezza: dopo l’arresto il
Tribunale del Riesame fa cadere l’ipotesi di omicidio volontario e i pm Grazia
Pradella e Tiziana Siciliano cercano nuove prove, sia per la responsabilità di
quelle 4 morti che per altri 45 casi di lesioni. Otterranno il rinvio a
giudizio, con l’accusa caduta due giorni fa in Cassazione, nel giugno 2012.
In entrambi i processi si assiste a un’ostinata
impuntatura dei collegi giudicanti: no a perizie d’ufficio, basta il
contraddittorio tra quelle di parte, che vede fatalmente soccombere i consulenti
della difesa. Uno di questi è Massimo Martelli, valentissimo e famoso chirurgo
toracico del Forlanini di Roma. Attesta in aula il che il collega si rifà a
tecniche diagnostiche d’avanguardia, sperimentate da diversi medici tedeschi. Il
riferimento alla Germania, come si vedrà, sarà però fatale. Intanto non basterà
a convincere i giudici della correttezza di Brega Massone. In uno dei
dibattimenti il presidente del collegio dice con chiarezza che, delle
argomentazioni scientifiche proposte, «non si riesce a capire granché». E allora
per quale motivo, nonostante la complessità della materia, i magistrati decidono
di non farsi assistere da consulenti d’ufficio? È l’effetto del clamore
mediatico, che nel frattempo è diventato inevitabilmente assordante. Brega è per
tutti il mostro, la Santa Rita, clinica degli orrori, deve cambiare nome in
“Istituto clinico Città studi”, come si chiama ancora oggi. I giudici non se la
sentono di ostinarsi a verificare in modo eccessivamente puntiglioso una verità
già affermata sui giornali. Al punto che in una delle udienze del processo per
omicidio, la presidente apostrofa così l’avvocato del chirurgo: «Stiamo facendo
un lavoro inutile e mi domando come mai i difensori continuino a sollevare delle
eccezioni quando basta andare con un iPad normale e queste telefonate le
ascoltiamo. Le hanno riportate tutti i media, ci stiamo prendendo in giro,
vogliamo smetterla? La Corte è veramente più che nervosa! Sono tutte opposizioni
inutili, non portano da nessuna parte. La Stampa, il Corriere… la Repubblica ha
riportato in grassetto le telefonate, in rete c’è l’audio e tutti noi usiamo
questi sistemi. Quindi è una presa in giro quella che sta succedendo in
quest’aula». Da verbale d’udienza, alla pagina 51. Come dire appunto che la
verità era scritta sui giornali e riprodurre le prove in dibattimento era
superfluo. Il 15 gennaio 2014, dopo 6 anni, Brega Massone mette piede fuori del
penitenziario di Opera: è scarcerato per decorrenza termini, in virtù del
protrarsi del giudizio sulle 83 operazioni, dopo che la Cassazione ha chiesto di
ricalcolare la pena inflitta in Appello, visto che nel frattempo il reato di
truffa è andato in prescrizione. Saranno gli ultimi tre mesi, almeno fino ad
oggi, trascorsi a piede libero dal chirurgo: il 9 aprile dello stesso anno Pier
Paolo Brega Massone è condannato all’ergastolo nel processo di primo grado per i
4 omicidi ed è arrestato in aula. «C’è pericolo di fuga», secondo il dispositivo
della Corte. Si scoprirà poco dopo, nelle motivazioni, che i contatti con i
luminari tedeschi erano stati decisivi: alcuni di loro erano stati presentati
dalla difesa come periti di parte, e i giudici danno per scontato che potrebbero
assicurare ospitalità in Germania al collega italiano fuggiasco. D’altra parte,
gli avvocati di Brega Massone hanno inutilmente insistito affinché il collegio
nominasse periti d’ufficio.
È la probabile sliding door di tutta la storia. Lo
dimostra un fatto riferito con modesta risonanza da gran parte dei media. Oltre
ai due procedimenti principali, vengono attivate anche due cause civili per
risarcimento danni, da altrettante pazienti che preferiscono non attendere
l’esito dei giudizi penali. In questi casi i magistrati si affidano a perizie
d’ufficio, a consulenti tecnici da loro stessi nominati, E accertano la
correttezza del chirurgo. L’avessero fatto anche i colleghi delle sezioni
penali, cosa sarebbe successo? Come sarebbe andata? Chi può escludere con
certezza che il chirurgo di Pavia fosse sì uno sbruffone, capace di esprimersi
con parole spicce sui pazienti, sulle operazioni e sui relativi rimborsi da
mettere a bilancio, ma non per questo si trattasse di un disonesto pronto a
usare tecniche d’intervento «inutili»? Non si è avuto il coraggio di sciogliere
l’incognita. Che Brega massone fosse un assassino era verità così indubitabile
che la psichiatra Chantal Podio, a fine 2014, riferì sconcertata di un suo
colloquio in carcere col chirurgo, a suo dire «incapace di ammettere le proprie
responsabilità, dunque impermeabile, un muro di gomma». La verità era così
indiscutibile che lo scienziata della psiche neppure provava a chiedersi se
dietro quella professione d’innocenza ci fosse almeno una parziale verità. I
giornali, prima delle sentenze, l’avevano già scritta. E ora, a 9 anni
dall’arresto, la Cassazione ci dice che quella verità, almeno in parte, era solo
un dogma.
Madia: «La Cassazione deve aver trovato
illogico definire Brega Massone un assassino», scrive
Valentina Stella il 24 giugno 2017, su "Il Dubbio". Intervista all’avvocato
Titta Madia che insieme al collega Luigi Fornari difende il dottor Pier Paolo
Brega Massone, in carcere da quasi 9 anni. «Irragionevole credere che Brega
Massone fosse un assassino»: è chiaro l’avvocato Titta Madia che insieme al
legale Luigi Fornari difende Pier Paolo Brega Massone, il chirurgo ex primario
della Santa Rita di Milano.
Avvocato Madia si aspettava questa decisione
dei Supremi Giudici? Era ottimista?
«Quando si va
in Cassazione è difficile essere ottimisti. Si ha una speranza, perché bisogna
tener conto che in Cassazione l’indice di accoglimento dei ricorsi è del 3 per
cento».
Quali sono stati i motivi principali – in
sintesi – posti alla base del vostro ricorso?
«Sono stati
due: Brega Massone era stato condannato per questi interventi chirurgici
ritenuti abusivi senza che sia stata fatta mai una perizia».
Una super perizia da voi chiesta più volte.
«Sì, ma ci è
stata sempre negata. Il secondo motivo è che ritenere che Brega Massone entrasse
in sala operatoria sapendo che era un assassino, e pronto ad uccidere delle
persone, era un fatto privo di qualsiasi ragionevolezza».
Adesso in Corte d’Appello si stabilirà se
trattasi di omicidio colposo o preterintenzionale?
«I giudici
dovranno attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione. Quindi avranno la
possibilità di fare una valutazione piuttosto limitata in base ai principi
espressi dalla Suprema corte».
Pur in assenza delle motivazioni, secondo lei
si può fin da ora intuire qual è stato l’iter logico- giuridico che i giudici di
Cassazione hanno seguito per giungere a questa decisione?
«È presto,
bisogna attendere le motivazioni che saranno molto importanti».
Quali sono state le anomalie più grandi che
hanno contraddistinto i vari gradi di giudizio?
«Una campagna
mediatica che forse non ha precedenti in Italia, che ha creato un mostro in
questa figura di chirurgo che probabilmente era soltanto un chirurgo azzardato,
un chirurgo che probabilmente rischiava più degli altri. E intorno a questa
figura si è creato il mostro soprattutto attraverso la televisione che ogni anno
mandava in onda il processo a Brega Massone, dipingendolo sempre come un mostro».
Si riferisce anche al docufilm L’infiltrato –
Operazione clinica degli orrori, andato in onda su Rai 3 nel 2014?
«Si, insieme a
tutta la campagna di stampa. Ma Brega Massone non è un mostro, ripeto.
Purtroppo, è noto come i mass media si appiattiscano sulla tesi dell’accusa e
fanno da megafono alle Procure. Alla tesi dell’accusa e alla tesi dei consulenti
dell’accusa che sono i consulenti di una parte e che non sono mai stati
verificati con una perizia super partes».
Invece in sede civile la stessa perizia aveva
dato ragione a Brega Massone, anche questa è una anomalia.
«Si è purtroppo
verificata una serie di gravi anomalie in questo processo, come ho detto prima,
a causa di una grossa pressione mediatica e forse anche a causa della
magistratura milanese che aveva un desiderio di punire in modo esemplare questo
personaggio e questa struttura sanitaria».
Si parla molto di super perizie, penso ad
esempio al processo a Massimo Bossetti, riguardo al quale a breve si saprà se
verrà concessa. Come mai si è reticenti nel concedere una perizia super partes?
«Perché a volte
subentra la paura che l’esito della super perizia possa smentire l’accusa, e la
tesi che piace alla gente, al senso comune e ai mass media».
In questo contesto si rende necessaria una
separazione delle carriere tra giudici e pm, su cui l’Unione della Camere Penali
sta raccogliendo le firme?
«Questa riforma
è indispensabile perché l’Italia è l’unico Paese in Europa nel quale il pubblico
ministero veste la stessa maglia del giudice».
Come ha accolto il suo cliente questa
decisione?
«Il mio cliente
è in carcere da ben 8 anni e mezzo, quindi posso raccontare la reazione della
moglie che ha avuto un pianto liberatorio».
Forse in Italia c’è un abuso della carcerazione
preventiva.
«Ci sono molte
cose da riformare ma il nostro è un Paese a parole garantista ma sostanzialmente
giustizialista».
PRESUNTI COLPEVOLI. GIOVANNI SCATTONE E
SALVATORE FERRARO.
GIOVANNI SCATTONE. FINE PENA: MAI.
Caso Marta Russo, Scattone: «Parlo
tre lingue, ma adesso potrei fare l’imbianchino». L’uomo condannato per omicidio
colposo per la studentessa: non voglio polemiche, rinuncio. Ma ci sono altri
prof condannati, scrive
Fabrizio Caccia su “Il
Corriere della Sera”. Accanto a lui c’è la moglie Cinzia, che
tutta la notte, anche con le lacrime agli occhi, ha tentato di dissuaderlo
(«Scusa Giò, domani che ci mangiamo, l’aria?»). Inutilmente, però. Giovanni
Scattone ha deciso: con l’insegnamento, con la scuola, lui ha chiuso.
Per sempre? «Sì, per sempre. Non tornerò indietro. È una parentesi della
mia vita che si chiude. Troppe polemiche. Insegno nei licei da dieci anni e ad
ogni inizio è la stessa storia. Basta, sono stufo. Certo, mi dispiace. E ora
sono anche un po’ preoccupato. È un salto nel vuoto. Rinuncio a un lavoro
sicuro. Novecento euro al mese che ci avrebbero fatto comodo. Per fortuna, sono
un tipo coraggioso».
La mamma di Marta Russo dice che «è stata fatta giustizia» e che lei è
«soddisfatta, soprattutto per i ragazzi». «Va
bene così. La rispetto, non dico altro. Contenta lei, contenti tutti». Ha
già pensato a cosa farà domani? «Sinceramente
non so. Scherzando, potrei dire che ho appena finito di tinteggiare le pareti
del corridoio di casa, non son venute male, forse ho scoperto un mondo...
Vedremo: conosco tre lingue, francese, inglese e spagnolo, potrei fare delle
traduzioni, correggere delle bozze, inventarmi ghostwriter, lavorare come
storico in qualche istituto di ricerca privato... Ma ho quasi 50 anni e non sarà
facile. Magari andrò via dall’Italia, cercherò qualcosa in Europa». Le
reazioni politiche, dopo la sua rinuncia, sono tantissime. Che cosa
risponderebbe se qualche partito dovesse offrirle una candidatura? «No
grazie. Vorrei restare fuori da certi giochi. Non m’interessa. A me piacerebbe
avere una vita normale». Secondo
la Cassazione lei è l’assassino di Marta Russo. Il passato non si cancella. «Io
non ho ucciso Marta Russo e mi porterò sempre nel cuore la speranza che, prima
della fine della mia vita, possa venir fuori la verità. In altri casi di cronaca
è successo: la verità si è saputa anche dopo 30 anni». Più
dura adesso o più dura quando la rinchiusero a Regina Coeli? «Fu
più dura all’epoca, senza dubbio. Ci passai più di un anno, ma resistetti. Avrei
potuto fare come Gardini o Cagliari. Togliermi la vita. Riuscii a non farlo. Ora
è diverso. Qualcosa per andare avanti la troverò». Roberto
Giachetti (Pd), vicepresidente della Camera, ha scritto questo tweet: «Rispetto
dolore della mamma di Marta Russo. Ma se neanche espiazione della pena riabilita
una persona, finisce stato di diritto». «Io
sono stufo di tutte le polemiche, perciò non dico nulla. Faccio presente, però,
che nel mondo della scuola non sarei stato io l’unico professore con una
condanna alle spalle. Eppure nessuno ci bada. Forse pago l’estrema “mediaticità”
del caso. Comunque ormai ho deciso. Mi dispiace però, anche per un altro
motivo...». Quale? «In
questo Paese, degli ex terroristi sono finiti addirittura in Parlamento. Altri,
dopo aver espiato la loro pena, oggi tengono conferenze, scrivono libri. Eppure
in tanti dicono adesso che io non posso fare l’educatore, che sono pericoloso
per i miei studenti. Pazienza, la mia coscienza mi dice invece che potrei
insegnare. Purtroppo, non c’è più la giusta serenità». I
suoi studenti che dicono? «Mi
consola molto la mail che mi ha appena mandato una mia ex allieva: mi ha scritto
che grazie a me ha deciso di continuare dopo il diploma e che studierà Storia
all’università. Mi basta questo. Ora spegnete le luci, per favore».
Scattone, il tribunale ha detto: 5 anni e 4 mesi.
Il popolo ha detto: fine pena mai, scrive
Angela Azzaro su "Il Garantista l'11 settembre 2015. Da ieri possiamo
dormire sonni meno tranquilli. In
Italia la condanna non viene decisa da un tribunale, con tre gradi di giudizio,
la valutazione delle prove, un’accusa e una difesa. Viene decisa dal popolo che
dello Stato di diritto se ne frega. E così che Giovanni
Scattone, dopo le polemiche per l’assegnazione di una cattedra, ha deciso di
lasciare. Ha rinunciato al posto e – parole del suo avvocato -si trova
ora in mezzo a una strada: “Se la coscienza – ha scritto all’Ansa – mi dice di
poter insegnare, la mancanza di serenità mi induce a rinunciare all’incarico”.
Scattone è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per l’omicidio
colposo (aggravato) di Marta Russo, uccisa da un colpo di pistola nei giardini
della Sapienza. Era il 1997. Con lui è stato
condannato per favoreggiamento Salvatore Ferraro. Scattone si è sempre
dichiarato innocente. Ma ha comunque pagato i suoi conti con la giustizia e ha
poi cercato di rifarsi una vita. Come è normale. Come è giusto che sia. Come,
soprattutto, recita la Costituzione all’articolo 27, quando indica nella pena
non uno strumento di vendetta ma di rieducazione.
Scattone c’ha creduto, ha vinto il concorso per avere una cattedra e grazie alle
nuove assunzioni ha ottenuto il posto. Ma non aveva fatto i conti con qualcosa
che la Costituzione non dice, che la civiltà dovrebbe ostacolare. Non ha fatto i
conti con la vendetta, l’idea che se hai sbagliato non potrai mai e poi
mai ritornare nel consesso umano e civile.
Scattone nella lettera in cui rinuncia alla cattedra ha scritto parole
durissime. Ha detto che gli si vuole impedire una vita da cittadino normale e
che quello che è accaduto non è degno di un Paese civile. La sua decisione di
lasciare è di fatto una sconfitta per tutti noi, la sconfitta di chi davvero
pensa che la società, la civiltà che abbiamo costruito, siano abbastanza forti
da permettere a una persona, che ha sbagliato, di pagare il suo debito e di
riprendere a vivere. Qui sta l’ipocrisia. Perché in realtà questa idea non vale
più. Si applicano le norme, ma poi vince ormai la cultura della vendetta,
dell’occhio per occhio, dente per dente. Se
una persona ha sbagliato, è bollata a vita, è condannata a vita. Il
processo che ha condannato Scattone e Ferraro è stato uno dei primi basati
principalmente su indizi e non su prove. E’
stato cioè uno dei primi grandi processi mediatici, dove ha contato più
la pressione popolare che lo Stato di diritto. Da qui quella sentenza a metà,
quei 5 anni e 4 mesi per omicidio colposo come se i giudici avessero, nel
dubbio, deciso di infliggere il minimo indispensabile. Nel dubbio, si sa, si
dovrebbe assolvere. Ma erano troppe le pressioni, troppa l’attenzione di
giornali e tv per non dare loro in pasto un colpevole.
Comunque sia andata, la Cassazione nel 1997 ha deciso per una condanna
definitiva a 5 anni e 4 mesi. La condanna è stata scontata. Il popolo
urlante, però, dice che non basta. L’obiezione più diffusa è che così si manca
di rispetto ai genitori di Marta Russo. Loro hanno perso una figlia, mentre
Scattone può insegnare. Confutare questo discorso è centrale. Dirimente. Perché
se ci affidiamo a questo ragionamento davvero possiamo chiudere i tribunali,
stracciare il codice penale, dare fuoco alla Costituzione. La terzietà del
giudice rispetto al dolore dei parenti della vittima o della vittima stessa è
fondamentale per non ricadere nella vendetta, in una società che non ha fiducia
nel cambiamento delle persone.
Non dando una seconda possibilità a Scattone è come se dicessimo che
l’essere umano non cambia, che la rieducazione è una utopia, che l’unico modo
che abbiamo per garantire il rispetto della vita è quello di vendicarci contro
chi sbaglia. Non dando
una seconda possibilità a Scattone, non stiamo dando una possibilità a
noi, alla società di cui facciamo parte per uscire dal clima di odio e di livore
che si stanno affermando. Ecco perché sarebbe bello che Scattone, come auspicato
anche dal suo avvocato, Giancarlo Viglione, cambiasse idea e non si facesse
intimorire da chi oggi lo perseguita.
In Italia il
garantismo è sempre più a rischio,
scrive
Christian Raimo,
giornalista e scrittore su
“L’Internazionale”.
Giovanni Scattone era stato condannato per l’omicidio di Marta Russo, ormai
quasi una ventina d’anni fa, in un processo iperamplificato dai mezzi
d’informazione e farraginoso. Ha scontato cinque anni per omicidio
preterintenzionale, è uscito di galera, e si è fatto anche un decennio di
precariato nella scuola, poi quest’anno aveva avuto una cattedra di ruolo in un
liceo romano. Oggi la sua rinuncia al posto di lavoro dopo la campagna
accusatoria montata dal Corriere della Sera e ripresa da vari giornali – secondo
la quale era una vergogna avergli assegnato una cattedra statale – conclude nel
modo peggiore una delle settimane più brutte della storia recente italiana per
quello che riguarda i temi della giustizia; certificando, se mai ce ne fosse
bisogno, il dilagare di quello che un bel libro recente di Stefano Anastasia,
Manuel Anselmi e Daniela Falcinelli ha definito
Populismo penale – un
giustizialismo tanto vigoroso da essere una mentalità politica. La settimana era
cominciata con la pubblicazione delle cinquantadue pagine della corte di
cassazione che chiarivano le ragioni dell’annullamento della sentenza
sull’omicidio di Meredith Kercher: c’era scritto che il processo aveva avuto “un
iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante
anche di clamorose defaillance o
‘amnesie’ investigative e di colpevoli omissioni di attività di indagine”. Tra
le motivazioni di questo fallimento eclatante (che ha compreso dibattimenti
estenuanti, anni di carcere per gli imputati tra cui molta custodia cautelare)
sempre la corte ha scritto: L’inusitato clamore
mediatico del delitto Kercher e i riflessi internazionali della stessa vicenda,
non hanno certamente giovato alla ricerca della verità provocando un’improvvisa
accelerazione delle indagini nella spasmodica ricerca di colpevoli da consegnare
all’opinione pubblica internazionale. E poi ha
rilevato un altro elemento interessante, quando dice che se le indagini
non avessero risentito di tali colpevoli omissioni, si sarebbe con ogni
probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di
certezza, quantomeno di affidabilità, nella prospettiva vuoi della colpevolezza
vuoi dell’estraneità di Knox e Sollecito.
La sentenza sul processo di Perugia e il linciaggio mediatico di Scattone
mostrano che se c’è una cultura diffusa, vincente, condivisa è quella di un
giustizialismo vendicativo, bilioso, regressivo con tratti fascistoidi che ha
largo spazio anche nei media che si proclamano progressisti, laici, fanatici
della costituzione. Quell’impronta garantista che i padri costituenti avrebbero
voluto far diventare parte della cultura sociale del paese di Cesare Beccaria
oggi è un alone fantasmatico, evanescente. Più che di giustizia e di avversari
politici l’opinione pubblica ha bisogno di colpevoli morali che svolgano in modo
efficace la funzione di capri espiatori. Topi elettrizzati. Era già successo
qualche mese fa, per esempio, con la nomina di Adriano Sofri nella consulta
sulle carceri voluta dal ministro Orlando: massacrato
dai giornali, anche quella volta Sofri aveva alla fine rinunciato. Se prendiamo
il caso simile di Giovanni Scattone, ci rendiamo conto che per moltissime
persone il diritto penale non è sufficiente ma occorre una specie di surplus di
giudizio, che Anastasia e gli altri definiscono diritto penale emozionale, in
cui i diritti della vittima sono potenzialmente infiniti (l’abuso del paradigma
vittimario di cui hanno scritto molti: per una buona sintesi, Daniele Giglioli, Critica
della vittima). In uno stato di diritto scambiato per un tribunale
teologico giacobino, non ci sarà mai risarcimento, e quindi si può continuare a
esercitare la richiesta di vendetta anche oltre la sentenza definitiva, e il
normale oblio; mentre i diritti del condannato – per esempio il suo diritto al
reinserimento, al riscatto, o i semplici diritti civili – sono annullati. Quando
per vent’anni si è paventato il rischio di una diseducazione giuridica di massa
dovuta alla spettacolarizzazione dei processi, quando si faceva notare la nociva
inutilità di contrastare il berlusconismo giocando tutto sul piano giudiziario,
forse si doveva già immaginare che il risultato sarebbe stato quello di veder
allargarsi il contagio del populismo penale anche a reati non commessi da
politici. Oggi sembra che un processo non abbia valore se non comprende anche la
riprovazione morale, la gogna, lo spettacolo (che obbrobrio sono i recital con
la lettura delle intercettazioni fatta da attori!). E sembra che non ci sia
conflitto politico, contrasto sociale che non sia d’altra parte fondato sullo
stigma morale. La comunità civile desiderata dai giustizialisti è uno stato
d’allerta etico dove si è sempre pronti a reagire come topi elettrizzati allo
scandalo di qualcuno da poter condannare all’istante, per sentirsi consolati di
appartenere al novero dei giusti. Giovanni Scattone è stato condannato e ha
scontato la pena (compresa un’interdizione provvisoria dai pubblici uffici),
Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati assolti. Qualunque cosa si possa
pensare delle loro idee, delle vicende giudiziarie e politiche che li hanno
coinvolti, a loro va la solidarietà di chi crede in uno stato di diritto e in
una cultura garantista.
Il caso Scattone è la fine dello stato di
diritto. Sono passati vent’anni dal fatto, una
sentenza definitiva per omicidio colposo (lo stesso reato ascritto a Grillo, per
intenderci) è stata eseguita nella sua interezza. Ma questo non basta per il
circo mediatico-giudiziario italiano, scrive
Claudio
Cerasa su “Il Foglio”.
Al direttore - La
rinuncia di Scattone all’incarico legittimamente ottenuto conferma che nel circo
mediatico-giudiziario italiano esistono una pena ufficiale e una ufficiosa.
Stavolta non c’entrano i giudici, c’entriamo noi. Penne e lingue che solleticano
gli istinti delle fiere. Unica eccezione rimarchevole il ministro Stefania
Giannini che a Panorama dichiara: “Manderei mia figlia a scuola da Scattone”.
Sono passati vent’anni dal fatto, una sentenza definitiva per omicidio colposo
(lo stesso reato ascritto a Grillo, per intenderci) è stata eseguita nella sua
interezza. A norma di legge non prevedeva l’interdizione. Eppure al condannato
si nega il diritto di riannodare i fili della propria, sfilacciata, esistenza.
Marta Russo non risorge. Giovanni Scattone muore di nuovo.
Annalisa Chirico. Ha
ragione Roberto Giachetti: se neanche l’espiazione della pena riabilita una
persona qui non siamo di fronte solo a un linciaggio, siamo di fronte alla fine
dello stato di diritto.
Scattone e i "cattivi maestri", scrive
Massimo
Bordin su “Il Foglio”. Ho sempre pensato che l’espressione, largamente
abusata, “cattivi maestri” contenga una contraddizione insanabile. Al maestro
non dovrebbe essere richiesto di essere buono o cattivo. Un maestro sa delle
cose e le insegna. Se non le sa o non è capace di insegnarle, semplicemente non
è un maestro. L’insegnamento trasmette sapere e gli insegnanti per questo sono
pagati, devono spiegare a mio figlio che, per esempio, chi ruba o uccide è
sottoposto a processi e sanzioni, mentre tocca a me spiegargli perché non si
deve rubare o uccidere. Questa è la prima cosa che ho pensato leggendo le
dichiarazioni sulla vicenda di Scattone. La seconda riguarda il preambolo a ogni
sentenza di tribunale: “In nome del popolo italiano”, non “In nome delle
vittime” ai cui familiari non appartiene la sorte del condannato, almeno secondo
i nostri codici. Tanto più a condanna scontata.
Caso Scattone: in uno stato moderno
funziona così, scrive
Francesco Felis
su “Il Corriere della Sera”. Caso Scattone. Merita il trattamento che ha
avuto? Ma uno Stato deve far riferimento al fatto che meriti o meno qualcosa, o
che si sia pentito o no di qualcosa dopo che ha espiato la pena? Premettiamo che
Scattone è stato condannato per omicidio colposo, cioè per aver agito con
leggerezza, o senza rispettare norme di condotta regolamentari, ma senza volontà
specifica di uccidere. Ma se anche fosse lui l’omicida, nonostante quello che
lui afferma, nonostante che il processo abbia evidenziato metodi, da parte del
PM, di acquisizione delle cosiddette prove metodi un po’ dubbi, se nonostante
tutto questo fosse il vero autore del fatto, ha espiato la pena. Con
l’espiazione della stessa chiude ogni pendenza verso la società. Perciò è
inutile interrogare la persona offesa, come se dovesse dare un perdono o
ricevere qualcosa. E’ duro, sembra crudele dirlo, ma verso la società i conti
sono chiusi, e perciò perchè non può esercitare certe attività con rilievo verso
la società e lo Stato, come se avesse sempre bisogno di un assenso dei parenti
della vittima? Attribuire, di fatto, diritti di veto o di altro genere, non è
legittimo e non è da Stato di diritto. La pena, inoltre, è, deve essere
riabilitativa. Per cui, se anche fosse stato colpevole, per lo Stato lo è, lui
dice di no, la famiglia della vittima di sì, ma tutti questi sono rapporti
privati tra loro, per lo Stato e la società si è riabilitato. La pena ha avuto
una funzione rieducativa e lui si è rieducato. Perciò è contraddittorio
presumere una rieducazione e al contempo pretendere che per svolgere un lavoro
debba avere un consenso, peggio perdono, dai parenti della vittima. Sarà brutale
dirlo, ma non funziona così uno Stato moderno. Funzionava così nei Promessi
Sposi (episodio di Fra Cristoforo che chiede perdono) o nel Medio Evo.
Scattone no, i terroristi sì. La strana
morale dei forcaioli.
L’omicida di Marta Russo ha rinunciato alla cattedra. Dalla quale non sono mai
scesi Curcio, Negri e gli altri, scrive Antonio Rapisarda su “Il Tempo”
In Italia non tutti i «cattivi maestri» hanno la
stessa sorte. Giovanni Scattone, ad esempio, non insegnerà più. Dopo le
polemiche scatenate per l’assegnazione della cattedra di liceo (dove avrebbe
dovuto tenere lezioni di Psicologia), l’ex assistente di Filosofia del Diritto
condannato per l’omicidio di Marta Russo - e sempre proclamatosi innocente -
alla fine ha scelto di rinunciare a insegnare per mancanza di serenità e per
chiudere una polemica, come ha spiegato ieri il nostro direttore Gian Marco
Chiocci, animata da una «gogna popolare che ha sancito la fine dello stato di
diritto». Vale per tutti i «condannati» lo stesso ragionamento? Tutti hanno
subito la stessa «gogna» di Scattone? Non proprio. In Italia, si sa, una
cattedra - reale o virtuale - non si nega a nessuno: ci sono finiti ex
terroristi, ex fiancheggiatori, condannati di tutti i tipi. Molti di questi la
sinistra italiana - così veloce nell’invocare censure e limitazioni per
CasaPound in queste ore - si è ben guardata dall’isolarli o dall’osteggiare
quando sono, letteralmente, saliti in cattedra o alla ripreso la ribalta con
tesi non proprio in linea con la socialdemocrazia. Quella che vi proponiamo
allora non è ovviamente una lista di proscrizione - lungi appunto dallo spirito
del Tempo - ma un promemoria del doppiopesismo della sinistra all’italiana sì.
«In Italia insegnano altri condannati - ha spiegato non a caso lo stesso
Giovanni Scattone - e sono stati riabilitati tanti ex detenuti che hanno avuto
condanne perfino più pesanti della mia. Penso ad ex brigatisti a cui è stata
data la ribalta dell'università, a intellettuali stimati e ben retribuiti, ai
cosiddetti "cattivi maestri" eletti». In cattedra, più volte, è finito appunto
Renato Curcio, il fondatore delle famigerate Brigate Rosse. Lui ha messo in
chiaro: «Io parlo solo del mio lavoro di ricercatore, il resto non mi interessa.
Non salgo in cattedra e non sono un cattivo maestro». Se non sale
metaforicamente in cattedra, resta il fatto che l’ideologo delle Brigate Rosse è
stato invitato qualche anno fa, tra le altre, all’Università di Lecce in merito
al suo libro «Il carcere speciale» e all’Università del Salento. E alle vibrate
proteste del centrodestra - nel silenzio delle forze di centrosinistra - il
professore e autore dell’invito replicava ai tempi: «Criticare l'invito di
Renato Curcio a Lecce è un atto di intolleranza». E confermava: «Alza la voce
solo certa politica». Decano della «cattedra» è anche Toni Negri, tra gli
animatori di Potere Operaio, filosofo ed ex parlamentare eletto nelle liste
radicali. Bene, il teorico dell’autonomia, che può «vantare» una condanna a
dodici anni nel processo «7 aprile», è stato un habitué dei seminari della
gauche negli atenei parigini e continua a essere un guru della sinistra
no-global italiana. Più volte ospite della trasmissione L’Infedele di Gad Lerner
in prima serata come «docente di Harvard», c'era chi ricordava al presentatore
icona della sinistra televisiva che forse era necessario completare la
descrizione dell’ospite con l’articolo di Potere operaio dove si invitano i
proletari a colpire «il corpo fisico del potere» (Lerner ha replicato che «Negri
ha da tempo saldato per intero i suoi conti, scontando fino all'ultimo la sua
condanna detentiva»). Per alcuni dei protagonisti della stagione della
contestazione, poi, se non ci sono stati ricollocazioni accademiche o
mediatiche, il rientro nella scena non ha scatenato scandalo tra i benpensanti.
Che dire, ad esempio, di Oreste Scalzone? Il capo di Autonomia Operaia è stato
più volte invitato a tenere incontri dagli studenti universitari dei collettivi
(incontri finiti spesso in «scontri») e anche di assemblee, come quelle tenute
nel 2007 a La Sapienza dove fu invitato per ricordare la cacciata del leader
della Cgil Lama. Anche un omicida pluricondannato come Cesare Battisti continua
ad avere - tra Brasile e Francia - adulatori e sostenitori tutti di impronta
rigorosamente progressista. Altri «ex» invece hanno avuto un vero e proprio
posto di lavoro, altro che strali dalla sinistra di governo. È il caso di Franco
Piperno, il fondatore di Potere Operaio nominato - dopo la condanna per banda
armata e associazione sovversiva - nel 1998 assessore ai Vigili urbani a Cosenza
dall’allora sindaco socialista Giacomo Mancini. Ma la ciliegina sulla torta è
ciò che è successo nella giunta di Giuliano Pisapia (il censore della
manifestazione di CasaPound) con Maurizio Azzolini «promosso» capo di gabinetto
del vicesindaco di Milano Guida. Azzolini è rimasto nell’immaginario per alcune
foto che lo ritraggono con la P-38 in mano il 14 maggio 1977 a Milano, giorno in
cui morì l’agente Antonio Custra. Bene, per Pisapia Azzolini ha espiato la pena
(non è suo il colpo che ha ucciso l’agente) e pertanto oggi può ricoprire
«incarichi di responsabilità». In questo caso «l’opportunità politica» tanto
sbandierata dal sindaco di Milano per giustificare il divieto imposto alla festa
di CasaPound - associazione legalmente riconosciuta - non vi era. Altro peso,
altra misura.
Marta Russo, 20 anni fa il
«delitto della Sapienza»: la dinamica, i testimoni, la condanna di Scattone e
Ferraro.
Scrive Angela Geraci il 2 maggio 2017 su “Il Corriere della Sera”. Marta Russo è
una studentessa romana di Giurisprudenza ed ex campionessa juniores di scherma.
Ha 22 anni quando la mattina del 9 maggio del 1997, alle 11,42, viene colpita da
un proiettile alla nuca mentre cammina con un’amica in un vialetto all’interno
dell’Università La Sapienza, a Roma. Il colpo entra da sotto l’orecchio sinistro
e le condizioni della ragazza appaiono subito molto gravi. I testimoni
raccontano che nessuno si è avvicinato a Marta prima dello sparo: il colpo è
partito da lontano. Molti studenti - come riporta uno dei primi lanci
dell’agenzia Ansa di quel giorno - «dicono di aver sentito una sorta di “tonfo
sordo” che farebbe pensare che sia stato utilizzato un silenziatore». L’amica di
Marta Russo, Iolanda Ricci, dirà di aver pensato inizialmente a un malore. Buio
fitto sul movente. È l’inizio di una vicenda giudiziaria lunga e molto
complicata, un rompicapo per investigatori e magistrati che appassiona giornali
e opinione pubblica.
La scena del crimine, il
cortile dell’Università. Negli investigatori si fa subito strada il
convincimento che il proiettile che ha colpito Marta sia partito dai bagni a
piano terra della facoltà di Statistica. Le indagini si concentrano anche sulla
ditta che si occupa delle pulizie nell’ateneo.
Marta Russo viene dichiarata
morta dopo cinque giorni di agonia: alle 22 del 13 maggio 1997. I genitori
Donato e Aureliana donano gli organi della ragazza, così come lei voleva. Il
proiettile che ha ucciso Marta, frantumandosi in undici schegge, è un calibro 22
del peso di 2,6 grammi.
Ai funerali di Marta Russo, il
16 maggio 1997, partecipano migliaia di persone (tra cui anche Romano Prodi,
Walter Veltroni, Luciano Violante, il ministro Luigi Berlinguer).
Il lavoro degli investigatori
(un pool di 80 persone) continua e c’è un significativo passo avanti: il 19
maggio vengono trovate tracce compatibili con polvere da sparo sul davanzale
della finestra dell’aula 6 dell’Istituto di Filosofia del Diritto della facoltà
di Scienze Politiche. Tutte le persone che lavorano nell’Istituto - docenti,
assistenti e personale amministrativo - vengono interrogate. In foto un momento
della ricostruzione degli inquirenti, nel 1998.
Il 12 giugno 1997 c’è il primo
arresto: si tratta del professore Bruno Romano, direttore dell’Istituto di
Filosofia del diritto. Il docente finisce ai domiciliari con l’accusa di
favoreggiamento perché secondo l’accusa avrebbe chiesto a chi era presente negli
uffici quel 9 maggio di tenere la bocca chiusa. Una settimana dopo tornerà
libero e due anni dopo, il 1° giugno 1999, sarà assolto in primo grado.
A portare all’arresto del
professor Romano è stata la testimonianza di una sua assistente, Maria Chiara
Lipari. La ragazza fa anche i nomi di chi era presente quel giorno nell’Istituto
di Filosofia del diritto (e dice anche di ricordare che c’era «un’atmosfera
strana»): Gabriella Alletto, 45enne, segretaria; il ricercatore Salvatore
Ferraro, 30 anni; l’assistente Giovanni Scattone, 29; l’usciere Francesco
Liparota, 35 anni. In foto Maria Chiara Lipari nel 2000.
Il 14 giugno 1997, a tarda
sera, vengono arrestati Giovanni Scattone (in foto lo scatto segnaletico della
polizia), Salvatore Ferraro e Francesco Liparota: l’accusa è concorso in
omicidio volontario.
Francesco Liparota. L’usciere
dice di essere stato nell’aula 6 la mattina del delitto e di aver visto Scattone
sparare e mettere la pistola nella cartelletta di Ferraro. Poi ritratta tutto
spiegando di aver avuto paura e di essersi sentito sotto pressione. Sarà
rinviato a giudizio e l’accusa chiederà per lui una condanna a 5 anni e 9 mesi
ma verrà assolto in primo grado. Condannato a 4 anni per favoreggiamento nel
primo processo di appello nel 2001; condannato a 2 anni (sempre per
favoreggiamento) nell’appello bis del 2002 e infine assolto definitivamente nel
2003.
Scattone e Ferraro si dicono
fin da subito totalmente innocenti ed estranei alla vicenda. Il processo inizia
il 20 aprile del 1998 nell’aula bunker del Foro italico di Roma. Va in scena il
balletto delle dichiarazioni dell’importante - e controversa - super testimone:
la segretaria Gabriella Alletto (in foto ai tempi del processo di primo grado).
Secondo gli inquirenti c’era anche lei nell’aula 6 quel 9 maggio insieme a
Liparota, Scattone e Ferraro. La 45enne a lungo nega di essere stata lì, poi
dichiara invece di aver visto i due assistenti: «Scattone era nell’aula 6 e
aveva una pistola in mano» mentre Ferraro «era scostato dalla finestra, non
poteva vedere quello che succedeva di sotto». Dirà di aver cambiato versione
perché sottoposta a pressioni da parte di inquirenti e magistrati. Grandi
polemiche scoppiano quando viene reso pubblico il video di un vecchio
interrogatorio in cui la Alletto giurava di non aver visto nulla. Alla fine sarà
rinviata a giudizio per favoreggiamento e condannata in primo grado a un mese di
reclusione.
La sentenza di primo grado
arriva il 1° giugno del 1999, dopo 70 udienze: Giovanni Scattone viene
condannato a 7 anni di reclusione per omicidio colposo mentre a Salvatore
Ferraro sono inflitti 4 anni per favoreggiamento personale. I due - per cui
l’accusa aveva chiesto 18 anni per omicidio volontario ipotizzando «uno
scellerato gioco criminale» alla base del delitto - vengono scarcerati per
decorrenza dei termini di custodia cautelare. Assolti Liparota e il professor
Romano. In foto Scattone e Ferraro, che fin da subito si sono detti innocenti e
continueranno a farlo sempre, il giorno della sentenza.
Al primo processo d’appello
che inizia il 3 maggio del 2000, il procuratore generale Luciano Infelisi chiede
22 anni per Scattone, 16 per Ferraro e 4 per Liparota. La sentenza di appello
arriva il 7 febbraio e aumenta le pene per gli assistenti: 8 anni a Scattone, 6
a Ferraro. Liparota, assolto in primo grado, viene condannato a 4 anni per
favoreggiamento. Ma la Cassazione, il 6 dicembre 2001, decide che il processo è
tutto da rifare perché alcune prove sono «illogiche e contraddittorie» e le
testimonianze della Alletto e di Lipari sono considerate inattendibili.
Il secondo processo di appello
inizia il 15 ottobre 2002. La sentenza arriva il 30 novembre 2002: Giovanni
Scattone viene condannato a 6 anni, Salvatore Ferraro a 4 anni e Francesco
Liparota a 2 anni.
L’ultimo atto giudiziario del
«delitto della Sapienza» arriva il 15 dicembre 2013: la Cassazione condanna
definitivamente Scattone a 5 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo;
Ferraro a 4 anni e 2 mesi per favoreggiamento; e assolve Liparota. La sera
stessa Giovanni Scattone viene portato in cella mentre con il carcere preventivo
Ferraro ha già scontato la sua pena. La Cassazione decide di cancellare per lui
l’interdizione all’insegnamento dato che è ritenuto colpevole di omicidio non
volontario. Esce da Rebibbia il 2 aprile 2004 quando viene affidato in prova ai
servizi sociali: in tutto ha trascorso in carcere 2 anni e 4 mesi. L’arma del
delitto non è mai stata trovata. Scattone continua a dichiararsi innocente e nel
2007, a dieci anni dalla morte di Marta Russo, scrive un lungo articolo
su L’Europeo: «Il delitto dell’università rappresenta uno dei più clamorosi
errori giudiziari degli ultimi anni - scrive adombrando l’ipotesi di una pista
terroristica e ricordando che il 9 maggio è l’anniversario dell’uccisione di
Aldo Moro - In realtà nessuna delle domande più ovvie («Chi è stato? Da dove?
Perché?») ha ricevuto a tutt’oggi una risposta minimamente plausibile». Nel 2001
ha sposato Cinzia Giorgio, ragazza che si era innamorata di lui durante il
processo e gli aveva scritto lettere quando lui era in galera. Nel 2015 si è
tornato a parlare di lui quando ha ottenuto una cattedra alle superiori.
Nel 2011 il tribunale di Roma
ha condannato Ferraro e Scattone a risarcire i familiari di Marta con circa un
milione di euro. Ferraro è stato anche condannato a versare alla Sapienza 28mila
euro come risarcimento per i danni d’immagine.
La famiglia I Russo. Il padre
Donato, Tiziana, sorella di Marta, e la moglie Aureliana. Tiziana dichiarerà
anni dopo: «Marta è morta. È stata uccisa da una pallottola. C’è la sua tomba,
ci sono i suoi ricordi, c’è la sua figura in tante iniziative pubbliche. Ma ad
ucciderla è stato Giovanni Scattone con la complicità di Salvatore Ferraro.
Questa è la verità. Storica e processuale. Una verità grande come la memoria di
una studentessa, assassinata per gioco all’università».
Il Prof. Giovanni Scattone rinuncia alla
cattedra e diventa Giovanni L’Assassino. Fuori dal
Coro, scrive Fabio Cammalleri il 10 Settembre 2015 su "La Voce di New York". La
vicenda di Giovanni Scattone, condannato per l’omicidio di Marta Russo, la
studentessa di 19 anni uccisa alla Sapienza il 9 Maggio 1997, e dissuaso da una
“moral suasion collettiva” a rinunciare al ruolo di insegnante, pur avendo
espiato la pena, pur riabilitato, ci dice, una volta di più, che in Italia la
barbarie giuridica è preminente: oggi, dopo il processo, ieri, nel processo.
Giovanni Scattone, Professore di ruolo (la nomenclatura aggiornata forse è
diversa, ma ci siamo capiti), ha rinunciato alla cattedra dell’istituto
professionale in cui avrebbe dovuto insegnare. Condannato per omicidio colposo
nei confronti di Marta Russo, da qualche giorno era stato investito da ogni
sorta di critica indiretta. Critiche allusive: certo, ha scontato la pena, però
si può far insegnare psicologia a un assassino? Critiche velate: certo, era
stato riabilitato, però ‘almeno’ l’interdizione dai pubblici uffici? Critiche
ricattatorie: certo, era tra i legittimi destinatari della Legge di assegnazione
definitiva delle cattedre, però chi è incensurato e rimane fuori? Per quanto
indirette, evidentemente hanno fatta breccia nella coscienza assente di Giovanni
Scattone “l’Assassino”; il quale ha così motivato la rinuncia: “se la coscienza
mi dice, come mi ha sempre detto, di poter insegnare, la mancanza di serenità mi
induce a rinunciare all’incarico per rispetto degli alunni che mi sono stati
affidati”. Non male, per una coscienza inesistente. Sì, perchè, Giovanni
Scattone ha capito di essere non più un uomo, più o meno cosciente, ma
semplicemente, irreversibilmente, un assassino: e con la certezza che solo il
nostro magnifico Processo Penale e il nostro esemplare Ordine Giudiziario
possono assicurare. Giovanni L’Assassino, pronto per la leggenda nera, come Ivàn
Il Terribile, Jack Lo Squartatore e via così. Giustizia è fatta. Quasi, in
verità: perchè, a voler essere precisi, misura per misura: sicchè un bel
suicidio sarebbe l’ideale. Ma, dobbiamo pur sempre fingere di essere una
comunità civile (una specie di Duca Vincenzo Collettivo), che deve saper
distinguere Amos da un cannibale, come auspicherebbe Leo Strauss; perciò, titoli
di coda ed happy end: è solo una scelta di “buon senso”, di “opportunità”, non
imposta (mai sia) e tuttavia benvenuta. Ipocriti: fino alle midolla e oltre. Ma
la vicenda ultima di Giovanni Scattone ci permette di tornare brevemente alla
penultima, cioè al suo processo, alla sua condanna. Anzi, ai cinque processi.
Perchè tanto limpide erano le prove, tanto certi erano i fatti, che alla
condanna si è arrivati per consunzione. Ma non tornerò alla sentenza di condanna
per la quale un Procuratore Generale di Cassazione, chiedendone l’annullamento,
volle dire: “Ci sono pagine che in uno Stato di diritto non vorrei mai
leggere”; precisando che bisognava “gettare alle ortiche le dichiarazioni della
Alletto e di Maria Chiara Lipari”, cioè dei testimoni (diciamo) posti al centro
dell’accusa; nè vorrò tornare al videotape in cui proprio la testimone Alletto
crollava in lacrime, scongiurando di non essere costretta a mentire contro gli
indagati; o al “la prenderemo per omicida”, graziosamente sillabatole da un
pubblico ministero, per sospingerla vieppiù verso la verità (e poi titolo di un
libro); nè alle quindici traiettorie ipotizzate, fra piano terreno e primo
piano, da cui poi si trascelse la famosa Aula n. 6 dell’Istituto di Filosofia
del Diritto, sul cui davanzale, però, si rinvennero solo reperti pulviscolari, a
“forte possibilità” di provenire da inquinamento atmosferico e non da polvere da
sparo; nè sulla postura della vittima che, se fosse stata colpita dall’Aula 6,
avrebbe dovuto tenere il capo chinato verso terra e verso sinistra, come
cercando qualcosa (postura mai allusa da qualcuno), e non ritto e in avanti,
come quando si cammina: ma così l’unica traiettoria possibile sarebbe dovuta
provenire dal primo piano (bagno dei disabili di Statistica), dove mai Scattone
potè dirsi fosse stato; e non voglio riandare nemmeno alla genesi delle
testimonianze -Maria Chiara Lipari che, dicendo di essere entrata nell’Aula 6 ma
di non aver visto Scattone, si sente rispondere dai pubblici ministeri che
allora l’indiziata è lei; così indica altre persone, fra le quali la suddetta
Alletto, che nega, e allora è lei l’indiziata, costretta alla performace del
videotape; no, non tornerò a cose così. E manco a dirlo, tutti, CSM, ANM,
stipendi e pensioni, sono rimasti dov’erano. Non occorre tornarci: perchè sono
materiali sicuri e inossidabili, che verranno utili al tempo in cui in Italia si
costruirà una giusta Colonna Infame. Invece vorrei solo soffermarmi su una
curiosità. Fu così equo e “diritto” quel processo, che qualcuno volle persino
supporre una sorta di condanna “strategica”. Il Prof. Alberto Beretta Anguissola
sostenne che la prima condanna (quella che pose le basi, per così dire) avrebbe
inteso salvare i pubblici ministeri dai pasticci: giacchè, essendo
contemporaneamente impegnati nelle indagini per l’omicidio del Prof. D’Antona,
una clamorosa assoluzione li avrebbe indeboliti. L’estensore della sentenza di
condanna, il Dott. De Cataldo, noto scrittore di provvedimenti giudiziari e di
romanzi, lo citò per danni: ma non si è mai saputo da dove mai il Prof. Beretta
Anguissola avesse cavato simile ipotesi, perchè alla citazione l’attore
rinunciò. Il Dott. De Cataldo in uno dei suoi libri (In Giustizia, questo, una
sorta di memoire) lepidamente liquidò l’ipotesi sul registro dell’assurdo:
proponeva una teorica conversazione telefonica fra un ministro X o un Senatore
Y, che più o meno dettavano l’immonda strategia. Assurdo, ovviamente. Sebbene,
solo immaginare che l’innocenza di un imputato possa divenire oggetto di
raccomandazione, come un voto di matematica o un appuntamento per la TAC, fa
correre al passaporto. Che il Prof. Anguissola, studioso di Marcel Proust, non
pensasse al telefono? Ma a les intermittences du coeur, al palpitante moto verso
la giustizia? Alla sfuggente, misteriosa ma necessaria vastità dell’onere
interpretativo, per cui, con una pistola a canna lunga ma anche corta,
silenziata ma anche no, arrugginita ma da troppo per essere quella, e che
nessuno ha mai trovato, un giorno, Giovanni Scattone, per gioco, per
sperimentare il delitto perfetto (e, a questo punto, proprio del
buon Raskol’nikov dovremmo scordarci?), o per nessun motivo, divenne Giovanni
l’Assassino? E Marta Russo? E che c’entra, Marta Russo?
Il caso Marta Russo, la
finestra dell’orrore e una sentenza irrisolta.
Pressioni e falle dell’inchiesta Così si è arrivati alla condanna per omicidio
colposo, scrive Goffredo Buccini l'11 settembre 2015 su "Il Corriere della
Sera". La finestra di Marta, ormai, quasi si confonde tra le altre, anonime, del
primo piano, sul retro di Giurisprudenza. La vecchia serranda di legno marrone
abbassata a metà, le doghe ingrigite della tenda, il condizionatore spostato
sotto il davanzale rispetto alle foto di diciott’anni fa. Da quella finestra,
alle 11 e 42 del 9 maggio 1997, partì il proiettile calibro 22 che stroncò la
vita di Marta Russo, a quindici metri di distanza, lì in mezzo al vialetto, dove
è stata piantata una magnolia dai genitori. E a quella finestra è rimasta
incatenata la vita del colpevole, Giovanni Scattone, ben oltre la condanna
definitiva a 5 anni e 4 mesi. Nell’aula 6 del dipartimento di Filosofia del
diritto, da dove Scattone, secondo la sentenza, ha sparato, ora ci tengono i
seminari. Chiedo: non fa impressione? «Ma lei quanti crede che lo sappiano?», mi
risponde sorridendo Andrea, classe 1988, quarta elementare diciott’anni fa,
sbucando dalla porta del collettivo studentesco: «Lo sappiamo io e pochi
altri». Delitto e processo sono rimasti imprigionati come Scattone, appesi a
quella finestra dell’orrore, dentro una bolla di non detto che a quel tempo la
gente ha tuttavia percepito, è diventata narrazione popolare ed è stata la
dannazione successiva dell’ex assistente della Sapienza, la sua pena accessoria
e impronunciabile che ancora oggi lo costringe a rinunciare a una cattedra.
Andrea ha appena due anni meno di Scattone allora, ma pare un ragazzo, come
molti di una generazione consegnata dalla precarietà a un’infinita adolescenza.
Fisico da rugby, barbetta, garantismo tenace: «L’hanno condannato per omicidio
colposo, no?, mica è un pedofilo. Mica gli hanno dato interdizioni. Io dico,
basta, rispettiamo le sentenze: perché non dovrebbe insegnare?». Ma il punto sta
proprio là, per molti: nel percorso della sentenza e nel non detto. Per capirlo
occorre un esempio astratto: se il professor X, né ubriaco né drogato, ammazza
un passante con la macchina in un malaugurato incidente stradale e viene
condannato per omicidio colposo, a quanti salterebbe in mente di impedirgli poi
di tornare in cattedra? E allora dov’è la differenza con la condanna per
omicidio colposo inflitta a Scattone? Proviamo a dirlo senza girarci attorno,
scusandoci in premessa perché le sentenze, come ci ricorda Andrea, si
rispettano. A quel colpo partito per sbaglio, maneggiando incautamente una
pistola poi mai più ritrovata, senza immaginare che fosse carica, col braccio
teso fuori dal davanzale della maledetta finestra, beh, non ci hanno mai creduto
in tanti. Men che meno la pubblica accusa che, al tempo, ha insistito a chiedere
18 anni per omicidio volontario, costruendo un’ipotesi di scuola. Si chiama dolo
eventuale: Scattone e il suo amico inseparabile, Salvatore Ferraro, secondo
alcuni vera mente della coppia, sedotti da Nietzsche e dal superomismo decidono
per gioco, sfregio o chissà quale bizza della mente l’azzardo di quello sparo
tra la folla di studenti che passa sotto la finestra, ben consapevoli di poter
colpire qualcuno e accettando l’evento (da qui il dolo).
E’ una tesi sostenibile? Forse
sì, forse no, ma è l’unica, in totale assenza di qualunque altro
movente. Mancano troppe cose nella pessima inchiesta che, sotto l’enorme
pressione dell’opinione pubblica, la Procura di Roma mette in piedi allora. I
testi sono tutti alquanto ballerini e vengono sollecitati a parlare con metodi
non sempre amichevoli (famoso resta il video-choc di un interrogatorio
dell’accusatrice chiave, Gabriella Alletto). Le perizie sono così contrastanti
da lasciare aperta l’ipotesi alternativa di un colpo partito da un’altra
finestra, in un bagno dell’istituto di Statistica, un piano sotto
Giurisprudenza, e sotto Scattone e Ferraro (contro il quale, giova ricordarlo,
resterà in piedi solo il favoreggiamento). Ciò nonostante, certo, si potrebbero
condannare Scattone e Ferraro per l’omicidio odioso di una ragazzina che tutti
vediamo figlia nostra. Oppure assolverli, perché mancano prove sicure. I
giudici, che sono pur sempre umani, non se la sentono di prendere nessuna delle
due strade più estreme e imboccano il vicolo stretto della condanna «dimezzata»,
con la tesi assai faticosa di uno sparo per errore. In fondo, una soluzione
all’italiana che porta con sé italianissimi paradossi. Comprensibilmente la
famiglia di Marta, sentendosi risarcita solo in piccola parte, continua a stare
addosso al colpevole, anno dopo anno, chiedendone almeno contrizione e
pentimento: ma Scattone continua a proclamarsi innocente, dunque, non può
chiedere perdono. Come capita sovente in Italia, dove non arriva la giustizia
arrivano l’ostracismo e la disumanizzazione del reo. La logica di molti genitori
in queste ore («non voglio che un assassino faccia lezione a mio figlio»)
scavalca del tutto la sentenza e torna a pescare in quell’abisso di non detto
dove guardiamo smarriti. L’idea stessa della riabilitazione implica un’etichetta
che Scattone rifiuta. E’ un perfetto rompicapo etico e giudiziario. Nel quale,
tuttavia, non bisogna dimenticare le vere vittime, i familiari di Marta, unici
detentori di un diritto, per così dire, all’eterno rancore. Noi possiamo solo
sperare che trovino pace. E, per quanti ci riescono, provare a restituire
un’ipotesi di umanità anche a chi (forse) l’umanità se l’è negata un giorno
giocando a fare Dio affacciato alla finestra.
Si riapre il caso Marta
Russo. Contraddizioni, testi e buchi nell’indagine: nel libro di Vittorio
Pezzuto il confronto tra le ipotesi investigative. Analizzate le dichiarazioni
che hanno portato alla condanna di Scattone e Ferraro,
scrive Dimitri Buffa su “Il Tempo" l'1 Maggio 2017. Un omicidio senza movente e
senza l'arma del delitto. Ma con due persone condannate in via definitiva. A
dieci anni dall'omicidio di Marta Russo (9 maggio 1997) arriva un libro, molto
accurato e preciso, che potrebbe contribuire a far riaprire il caso. Lo ha
scritto Vittorio Pezzuto, che se l’è dovuto pubblicare da solo, tanta la
pavidità delle case editrici in Italia nell'affrontare casi scomodi. In esso si
ripercorrono quelle drammatiche settimane successive all'inspiegabile omicidio
all'interno dell'Università La Sapienza a Roma per il quale furono condannati
gli ex assistenti della cattedra di filosofia del diritto Giovanni Scattone e
Salvatore Ferraro. Nel libro, specie nella parte iniziale, ci si sofferma a
lungo sulle possibili piste alternative abbandonate inspiegabilmente dagli
investigatori. A partire da quella degli addetti di una ditta di pulizie che
avevano l'incredibile hobby del tiro a segno e che possedevano pistole
modificate o modificabili anche all'interno dei locali a loro disposizione
dentro l'Università̀. Per tacere di quella, inquietante, di un altro personaggio
strano, che deteneva un arsenale a casa e che frequentava anche lui la Sapienza,
dilettandosi al tiro a segno con armi ottenute con falsi certificati di lavoro.
Cosa per la quale poi patteggiò la condanna a un anno di reclusione sia pure
uscendo dall'inchiesta. I due malcapitati, di cui Pezzuto in un capitolo ad hoc,
il quinto, rievoca anche la criminalizzazione mediatica («Costruire due
mostri»), vennero dopo un tortuoso iter processuale condannati a cinque anni e
quattro mesi (Scattone) e a 4 anni e due mesi (Ferraro). Il tutto dopo che il 6
dicembre 2001, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, su richiesta
conforme del Procuratore Generale Vincenzo Geraci (il quale definì «basi di
sabbia» le testimonianze di Gabriella Alletto e di Maria Chiara Lipari,
aggiungendo che erano da «gettare alle ortiche») aveva annullato le condanne di
primo e secondo grado. La Cassazione stigmatizzò i metodi degli inquirenti.
Marta Russo: delitto a La
Sapienza 20 anni dopo. Genesi di un libro rifiutato.
La controinchiesta scottante sul delitto a La Sapienza sarà in vendita su
Amazon. La firma Vittorio Pezzuto, scrive Patrizio J. Macci il 10 aprile 2017 su
"Affari Italiani". Venti rifiuti sommari, decine di mail che hanno solcato il
web con motivazioni di una banalità sconcertante, risposte scompiscianti, rinvii
e palleggiamenti. “MARTA RUSSO - Di sicuro c’è solo che è morta”, la corposa e
documentissima contro-inchiesta scritta dal giornalista Vittorio Pezzuto in
occasione del ventennale del celebre omicidio a "La Sapienza" (9 maggio 1997),
sembrava destinata a non trovare alcuno spazio in libreria. Sarà invece proposta
dal più grande editore internazionale dal 19 aprile: parliamo di Jeff Bezos,
patron di Amazon. Basterà collegarsi allo store del sito e con un semplice clic
acquistarne una copia, in versione sia cartacea sia e-book.
Un libro che per tutti non
s'aveva da pubblicare. Intanto vi proponiamo un piccolo campionario delle
motivazioni con le quali è stato di volta in volta rifiutato: uno
"sciocchezzaio" che ci aiuta a comprendere lo stato attuale dell'editoria
italiana e soprattutto le ragioni della sua profonda crisi.
FRASI FATTE, FRASI DETTE
"Guardi, a noi questa storia
interessa moltissimo e il suo lavoro di ricerca storica è stato veramente
enorme”.
"Bene, mi fa piacere
sentirlo."
"Però vede, lo stile del libro
è troppo enfatico, ricorre a volte a frasi fatte e appare talmente schierato a
favore dagli accusati che il lettore è spinto a parteggiare per il lavoro dei
magistrati."
"Addirittura."
"Intendiamoci, consideriamo
questa vicenda giudiziaria una vera schifezza però così non va. Che ne dice di
mandarci fra qualche mese un proposal...".
"...un che? Intende una
proposta?"
"Sì, insomma... La proposta di
un capitolo asciugato con stile più asettico, più idoneo allo stile della nostra
casa editrice. Se riscrive il libro in questo modo può darsi che poi il nostro
consiglio di amministrazione si decida nel tempo alla sua pubblicazione."
"Grazie, ci penso su e le farò
sapere."
CI VORREBBE UNA
SPONSORIZZAZIONE
"Buonasera, mi chiamo Vittorio
Pezzuto e..."
"Sì certo, la conosco. Dica."
"Volevo proporle la
pubblicazione di un libro-inchiesta sul caso Marta Russo. A maggio cade il
ventennale dell'omicidio e poiché siete una casa editrice specializzata in saggi
di cultura liberale..."
"... Mhh. Un libro del genere
però non si ripaga solo col mercato. Occorrerebbe un sostegno, uno sponsor
all'edizione..."
"Addirittura?"
"Eh sì. Il problema è che su
questi temi c'è una forte concorrenza del web..."
"Del web?! Veramente la Rete è
spesso sinonimo di insulti, approssimazione, fonti incerte..."
"Guardi, se proprio insiste
può mandarmi una scheda dell'opera e nel caso le faccio sapere."
"Faccio prima a mandarle, per
sua cultura personale, l'intero volume. Sono circa 500 pagine..."
"... Ah, una cosa corposa."
"Beh, sì. È un libro, mica un
tweet."
L’EDITORE DI QUALITÀ
"Guardi Pezzuto, diamo per
scontato che il suo libro sul caso Marta Russo sia un capolavoro. Per quale
motivo però dovremmo pubblicarlo?"
"Forse proprio perché, come
dice lei, si tratta di un capolavoro."
"Ehh, fosse così semplice..."
L’EDITORE “MILANESE”
"Buongiorno, mi chiamo
Vittorio Pezzuto e ho avuto il suo numero da (...). La chiamo perché, dopo aver
scritto qualche anno fa la biografia di Enzo Tortora, ho appena ultimato
un'accurata contro-inchiesta sul caso Marta Russo in occasione del prossimo
ventennale di questo omicidio che tanto ha diviso l'opinione pubblica. Mi
rivolgo alla sua casa editrice perché mi dicono essere seria ma soprattutto
perché da molti anni pubblica libri coraggiosi di denuncia...".
"Guardi, a parte queste note
di colore che non interessano nessuno..."
"Sì?"
"...Io la inviterei a recarsi
ogni tanto in libreria per vedere cosa viene pubblicato. Scoprirà che la storia
che propone è molto vecchia”.
"Veramente in libreria mi
capita di andarci, e vi scopro sempre nuovi libri sulla prima e sulla seconda
guerra mondiale, per non parlare di nuovi tomi sulle Brigate Rosse, sulla morte
di Pasolini, sul caso Moro...".
"Io la inviterei a non
accostare il caso Moro a un banale episodio di cronaca nera che non ha avuto
alcun risvolto politico e giudiziario!".
“Ma veramente...".
Riprendono le recensioni di
Giuditta’s files. Quest’oggi ci occupiamo di “Marta Russo – Di sicuro c’è solo
che è morta”, di Vittorio Pezzuto (2017, Amazon), scrive Daniele Capezzone
Martedì 2 maggio 2017 su "Affari italiani”. Doppia doverosa premessa. La prima:
Vittorio Pezzuto è un caro amico, ne ho a lungo condiviso l’impegno civile e
politico, ne ho apprezzato l’opera giornalistica, e soprattutto ho ammirato quel
vero capolavoro (non a caso, pluri-saccheggiato da presunti grandi raccontatori
e narratori televisivi) che è stato il libro Applausi e sputi, la più
documentata e straziante analisi della vicenda giudiziaria, politica e umana di
Enzo Tortora. La seconda: sono da sempre convinto dell’innocenza di Giovanni
Scattone e Salvatore Ferraro, riconosciuti invece colpevoli dalla giustizia
italiana, a seguito del caso di Marta Russo, la studentessa uccisa il 9 maggio
del 1997 nei vialetti dell’Università La Sapienza di Roma. Ma mettete da parte
questi miei pre-giudizi, e (davvero: è un invito e insieme un “volantinaggio”)
leggete l’ultima fatica di Pezzuto, frutto di cinque anni di lavoro. Si tratta
di una monumentale controinchiesta, che in un paese normale avrebbe già gettato
le basi per la riapertura anche giudiziaria del caso. Pezzuto ha scelto come
titolo il famoso incipit dell’articolo che il grande Tommaso Besozzi scrisse
su L’Europeo sulla morte del bandito Giuliano (“Di sicuro c’è solo che è
morto”): ecco, per la povera Marta Russo, vale qualcosa di molto simile. E’ un
viaggio terrificante (ma insieme illuminante) non solo nella giustizia italiana,
ma anche in una politica chiacchierona (già allora, ansiosa di dichiarazioni
fini a se stesse, di presenzialismo inconsistente, di banalità, e ovviamente di
giustizialismo anche da parte di chi – in altri contesti – predicava
garantismo), di un giornalismo manettaro e superficiale (rileggere la brutalità
e la faciloneria di certi giudizi illumina le caratteristiche di alcune “grandi
firme”: per il presente e per il futuro, non solo per il passato), e anche di
un’editoria priva di coraggio che ha a lungo rifiutato la pubblicazione del
libro, e con patetiche scuse ha declinato la proposta di Pezzuto (pur reduce da
un indiscusso successo editoriale!), fino alla scelta liberatoria di pubblicare
il volume su Amazon.
Il libro si raccomanda da sé,
e merita successo per varie ragioni:
-un certosino lavoro di
classificazione e riordino di un materiale enorme e magmatico;
-la cura chirurgica nel
recuperare i peggiori misfatti di "giornalisti" e "opinionisti", rendendone bene
il misto di sensazionalismo, improvvisazione, sciacallaggio: Pezzuto li
definisce bene "turisti del mistero";
-la denuncia forte di una
"giustizia" descritta da un’agghiacciante considerazione di Ferraro, all’epoca
avviato alla carriera universitaria ("ho insegnato qualcosa che non esiste");
-la scelta di citazioni
davvero appropriate di Longanesi per punteggiare il tema di ciascun capitolo;
-il modo in cui Pezzuto spiega
il meccanismo di "costruzione dei mostri”, con la dignità, il decoro personale,
il riserbo e il self-restraint dei due accusati che si tramutano in altrettanti
capi d'accusa aggiuntivi ai loro danni.
Non dimentichiamo che si
tratta forse del primo caso recente di processo mediatico. O comunque, se non
del primo caso, del caso che ha indubbiamente aperto una nuova fase: con intere
trasmissioni televisive e mesi di “inchieste” giornalistiche ossessivamente
dedicate alla questione, tutte o quasi in ottica colpevolista a prescindere, e
un dispiegamento di mezzi mediatici senza precedenti.
Aggiungo tre elementi
assolutamente non scontati, vista la gran mole del lavoro:
-una scrittura sempre
curatissima, con un registro che resta limpido e pulito lungo tutto il saggio;
-una ammirevole "empatia" nei
confronti di tutte le figure deboli e colpite (a partire dalla vittima,
ovviamente), delle quali l’autore rende molto bene il punto di vista;
-il fatto che, pur dinanzi a
una cavalcata così lunga e carica di dettagli, Pezzuto riesca a mantenere
l'attenzione del lettore vivissima fino alla fine.
Nonostante tanti boicottaggi,
questo libro merita di essere letto, compreso e meditato a lungo. Anzi, quei
boicottaggi offrono una ragione di più per apprezzarlo. Alla fine della lettura,
resta solo un …problema: sentirsi sicuri e a proprio agio in questa Italia.
Daniele Capezzone
Marta Russo: in un libro
una nuova ipotesi sulla morte. A 20 anni dall'uccisione della studentessa
romana, un saggio di Vittorio Pezzuto lancia un'inquietante ipotesi: l'omicidio
potrebbe essere stato causato da uno scambio di persona,
scrive Maurizio Tortorella il 3 maggio 2017 su Panorama. La mattina del 9 maggio
1997, a Roma, poco prima di mezzogiorno una pallottola colpisce alla testa la
studentessa Marta Russo, appena 22 anni, mentre sta passeggiando in un viale
dell’Università “La Sapienza”. La sua morte, avvenuta quattro giorni dopo, desta
grande clamore in tutta Italia. Chi ha ucciso la ragazza, e perché? Gli
inquirenti si convincono presto che a sparare sia stato Giovanni Scattone, un
dottorando in giurisprudenza, con la complicità del collega Salvatore Ferraro.
Il loro movente? Nessuno. Paradossalmente, però, è proprio l’assenza di un
movente a inchiodarli. Ad accusarli sono testimonianze controverse e una
particella di bario e antimonio trovata sulla finestra dell’aula 6 dell’Istituto
di filosofia del diritto. Esattamente a 20 anni di distanza, il caso Marta Russo
resta però una storia quasi incredibile, oscura e sfuggente ma anche rivelatrice
di un certo tipo di magistratura e di un certo tipo di giornalismo. Se ne occupa
ora Vittorio Pezzuto, giornalista e autore di altri libri di denuncia, in un
ponderoso saggio analitico. Il libro ha un titolo che riecheggia l’attacco di un
famoso articolo di Tommaso Besozzi, mitico inviato di nera, spedito dal
settimanale Europeo sulle tracce dei veri assassini del bandito Salvatore
Giuliano: Marta Russo: di sicuro c’è solo che è morta (664 pagine, disponibile
su Amazon dal 19 aprile, in versione sia cartacea, a 16 euro, sia e-book a 7.99
euro). Scritto con lo stile di un legal thriller e basato su una mole imponente
di documenti, il saggio ripropone per la prima volta le fasi dell’inchiesta e i
diversi colpi di scena nei diversi gradi del processo che nel 2003 portarono
alla condanna dei due giovani, che sempre si sono proclamati innocenti. Ma
soprattutto, sia pure vent’anni dopo l’omicidio della povera Marta Russo, arriva
a una conclusione sconvolgente su un caso che per larga parte dell’opinione
pubblica resta ancora inspiegabile. Studiando gli otto faldoni contenenti i
documenti dell’inchiesta e del processo (interrogatori, perizie balistiche,
intercettazioni ambientali e telefoniche, trascrizioni delle udienze in Corte
d’assise), tutti i lanci dell'agenzia Ansa sul caso dal 1997 al 2015 nonché
circa 8 mila articoli ed editoriali apparsi sui maggiori quotidiani e periodici,
Pezzuto (che in passato ha scritto per Sperling&Kupfer di Applausi e sputi, una
biografia “definitiva” e controcorrente di Enzo Tortora), è convinto che la
verità processuale sia del tutto lontana dalla verità fattuale. Pezzuto, però,
non si limita a mettere uno accanto all'altro i mille dubbi sul verdetto che nel
2003 ha visto Scattone e Ferraro condannati a pene peraltro miti e di per sé
apparentemente irragionevoli per un omicidio, sia pure colposo: 5 anni e 4 mesi
di reclusione per Scattone (cui è stata addirittura accordata la riabilitazione
penale e accordato il diritto a insegnare); 4 anni e 2 mesi per Ferraro. La sua
è di fatto un'inchiesta parallela e diversa rispetto a quella compiuta in primo
grado dall'allora procuratore aggiunto di Roma, Italo Ormanni, e dal
sostituto Carlo Lasperanza. Pezzuto infatti pare convinto di avere trovato, se
non le potenziali prove di uno scambio di persona, quanto meno una serie di
indizi concentrici: a morire, 20 anni fa, a Roma, avrebbe forse dovuto
essere una ragazza messinese di 26 anni, iscritta al terzo anno fuori corso di
Giurisprudenza alla Sapienza. "Sarebbe sarebbe stata lei e non Marta Russo il
vero bersaglio di quel maledetto colpo di pistola", scrive Pezzuto nel libro.
Del resto, le due ragazze potevano essere confuse: stessa lunghezza e colore dei
capelli, stessa carnagione chiara, stesso sguardo, altezza e corporatura molto
simili. E il movente? Qualcosa di assai più credibile di uno sparo a caso: la
mafia. Scrive Pezzuto: "I sicari sarebbero giunti dal Sud per attuare una
vendetta trasversale contro suo padre, un imprenditore che aveva denunciato per
estorsione e usura i criminali mafiosi che gli avevano tolto fino all’ultima
lira e che si erano impossessati dei suoi due supermercati". Il fatto più
inquietante è che la ragazza segnala quasi subito i suoi sospetti all'autorità
giudiziaria, e viene sentita il 1° luglio 1997. I due pubblici ministeri romani
che seguono il caso, però, non si convincono della tesi. Così la ragazza e suo
padre si rivolgono anche al sostituto Carmelo Petralia, alla Procura di
Messina. "I boss ci hanno rintracciato anche a Roma" gli dicono. "Per l’agguato
potrebbero aver scelto l’Università dove quasi ogni giorno io percorrevo lo
stesso tragitto fatto da Marta". Il verbale però viene inoltrato alla Procura di
Roma perché competente sul caso e viene archiviato. Non basta. Perché c'è
addirittura una seconda pista alternativa: in questo caso si tratta di una
giovane di Frosinone, studentessa alla Sapienza di Roma e a sua volta assai
simile a Marta Russo, il cui padre aveva presentato denunce ed esposti contro
una serie di personaggi in qualche modo "pericolosi" della città, tanto da avere
ricevuto numerose minacce. "La nostra è una pena che non finirà mai" ha
dichiarato con amarezza Donato Russo il 29 gennaio 2007, alla cerimonia di
inaugurazione della nuova tomba monumentale che da allora raccoglie i resti
della figlia, al cimitero del Verano. Sulla lapide, scrive Pezzuto, c'è la foto
di Marta, quella che abbiamo imparato a conoscere: "Un volto dai tratti
regolari, coi capelli biondi lisci scriminati al centro, la promessa di un
sorriso disegnata da labbra rosse e sottili. E occhi chiari, profondi e quieti,
che continuano a interrogarci sulle ragioni misteriose del suo assassinio.
Ancora oggi non riusciamo a risponderle. Sappiamo soltanto che purtroppo, in
tutta questa storia, di sicuro c’è solo che è morta".
Marta Russo, quel
pasticciaccio brutto diventato tabù,
scrive il 6 Maggio 2017 "Il Dubbio". “Di sicuro c’è solo che è morta”. Il titolo
è già un pugno in faccia. Ma è anche il primo brivido dello strepitoso legal
thriller scritto da Vittorio Pezzuto sul delitto di vent’anni fa. Nessun editore
ha voluto pubblicarlo: “Abbiamo paura”, dicevano. Ci ha pensato direttamente
l’autore, grazie ad Amazon. Ve ne offriamo due estratti. La mattina del 9 maggio
1997 una pallottola colpisce alla testa la studentessa Marta Russo mentre sta
passeggiando in un viale dell’Università “La Sapienza”. La sua morte, avvenuta
quattro giorni dopo, desta un enorme clamore in tutta Italia. Chi l’ha uccisa, e
perché? Ben presto gli inquirenti si convinceranno che a sparare sia stato il
dottorando Giovanni Scattone, con la complicità del collega Salvatore Ferraro.
Il loro movente? L’assenza di un movente. Ad accusarli vi sono testimonianze
controverse e una particella di bario e antimonio trovata sulla finestra
dell’aula 6 dell’Istituto di Filosofia di diritto. Una storia incredibile,
oscura e sfuggente ma anche rivelatrice di un certo tipo di Italia, di un certo
tipo di magistratura, di un certo tipo di Università, di un certo tipo di
giornalismo. Scritto con lo stile avvincente di un legal thriller e avvalendosi
di una documentazione imponente, questo nuovo saggio di Vittorio Pezzuto Marta
Russo. Di sicuro c’è solo che è morta (già autore della biografia di Enzo
Tortora Applausi e sputi, Sperling& Kupfer) ripropone per la prima volta le fasi
dell’inchiesta e i diversi colpi di scena nei diversi gradi del processo che
portarono alla condanna dei due giovani. Ma soprattutto, vent’anni dopo
quell’omicidio, arriva a una conclusione sconvolgente su un caso che per larga
parte dell’opinione pubblica resta ancora inspiegabile. Dopo che per un anno e
mezzo tutti i maggiori editori italiani hanno rifiutato di pubblicarlo («Questa
storia non interessa più nessuno», «Non avrebbe un mercato», «Il libro ci piace
molto ma abbiamo paura di essere citati dai magistrati» ), Pezzuto ha deciso
così di autopubblicarlo e di metterlo in vendita direttamente su Amazon ( 664
pagine, versione cartacea 16 euro, e- book 7.99 euro). Pubblichiamo due
estratti. Dal capitolo 4 (“Da La Sapienza a Regina Coeli”) e dal capitolo 14
(“Microscopio e cronometri”).
Dal Capitolo 4 – DA “LA
SAPIENZA A REGINA COELI”. Due catture nella notte. Con incredibile rapidità, il
gip Muntoni decide di firmare le ordinanze di custodia cautelare contro Scattone
e Ferraro mentre l’interrogatorio di Gabriella Alletto è ancora in corso. Una
soluzione che costringerà quest’ultima a mantenere le sue accuse, se non altro
per evitare un’incriminazione per calunnia. Le sue tardive rivelazioni hanno
infatti il pregio di inserire sulla scena del delitto quel quarto uomo di cui i
magistrati sono da tempo sicuri ma che nemmeno la volenterosa Lipari aveva
confermato esistesse. A uccidere Marta Russo sarebbe quindi stato Giovanni
Scattone, mentre una frase dell’impiegata («Se non ricordo male, subito dopo lo
sparo si chinò a terra all’interno della finestra dopo aver rilasciato la
tenda») li convince che abbia avuto anche la freddezza di raccogliere il
bossolo. L’amico e collega Ferraro si è limitato a fargli da complice, portando
via la pistola nella sua borsa. Per gli inquirenti si tratta davvero di un colpo
di fortuna. Ferraro è infatti mancino e quindi non avrebbe potuto rivolgere
l’arma in direzione di Marta perché impedito nel movimento della mano dal
cassone del condizionatore d’aria alla sinistra della finestra. E non avendo mai
sparato in vita sua, l’imputazione a suo carico avrebbe potuto essere solo di
omicidio colposo. Con Scattone invece le cose cambiano: a differenza dell’amico
ha fatto il servizio militare come carabiniere ausiliario e pertanto ha già
usato armi. L’accusa quindi può restare quella di omicidio volontario. Le
volanti della polizia partono subito alla ricerca dei due giovani collaboratori
del professor Carcaterra. Scattone viene rintracciato intorno alle 23 mentre sta
cenando con alcuni amici in un ristorante all’aperto nei pressi del Foro
Italico. Un ispettore e altri due agenti in borghese gli chiedono di seguirlo in
Questura. Il giovane è disorientato. Intuisce subito che si tratta dell’indagine
sull’omicidio di Marta Russo ma a dire il vero non è molto aggiornato sui suoi
sviluppi: mancano un paio di giorni all’esame finale nazionale per il dottorato
di ricerca e in quel periodo trascorre gran parte della settimana a Napoli, dove
segue un corso di perfezionamento in Filosofia del diritto con frequenza
obbligatoria. Gli agenti della Squadra mobile lo trattengono negli uffici di via
San Vitale fino alle prime luci dell’alba. Foto segnaletiche, impronte digitali
e un interrogatorio serrato senza l’assistenza di un avvocato. Dopo avergli dato
da leggere l’ordinanza di custodia cautelare, il capo della Squadra mobile
D’Angelo e il suo vice Intini alternano minacce e blandizie. Vogliono che
ammetta subito che il colpo gli è partito per caso («Altrimenti ti farai almeno
24 anni!») e riveli il luogo esatto da cui ha fatto fuoco. Gli agenti sono
stanchi e innervositi. «Che fine ha fatto la pistola?» gli urlano addosso.
«Quale pistola?» risponde sempre più sconcertato Scattone. È allora che
s’incazzano, che iniziano a strattonarlo violentemente, facendo però attenzione
a non provocargli tracce o ferite riscontrabili. Scattone nega con fermezza ogni
addebito. I funzionari a quel punto si allontanano, lasciandolo in compagnia di
un agente che gli spiega: «Sono in riunione per decidere il da farsi». Sono le
cinque del mattino quando una volante lo trasferisce nel carcere di Regina
Coeli. Rinchiuso in una cella di isolamento vicino all’infermeria, gli resta
solo l’eco delle ultime parole degli agenti: «Se confessi resti dentro al
massimo due giorni, giusto il tempo di sostenere l’interrogatorio di garanzia
del gip. Pensaci bene…». Anche Salvatore Ferraro viene arrestato quando ancora
si sta asciugando l’inchiostro della firma della Alletto in calce alla sua
ultima deposizione. Quattro agenti alti, corpulenti e nervosi entrano a casa sua
mentre in boxer e t- shirt sta suonando con la sua chitarra acustica un vecchio
blues di Robert Johnson. Si tratta di Me and the Devil Blues, parla del diavolo
che all’improvviso bussa alla porta. Un brano decisamente azzeccato. «Ci segua».
«Per caso mi state arrestando?». «Assolutamente no». Un’ora dopo l’assistente
universitario si trova in una stanza della Digos, con le manette ai polsi e
ancora convinto che si tratti di una messinscena per verificare l’attendibilità
delle sue deposizioni precedenti. Tant’è vero che una mezza dozzina di
investigatori, tra funzionari e semplici agenti, si avvicendano davanti alla sua
poltrona chiedendogli se abbia detto davvero tutto quello che sa. Col
trascorrere del tempo il loro atteggiamento cambia e l’atmosfera, all’inizio
piuttosto rilassata, s’indurisce in sguardi e movenze imbottiti di tensione e
stanchezza. Quando Ferraro conferma per l’ennesima volta di non sapere nulla del
delitto, Belfiore sbuffa spazientito e sbatte il pugno sul tavolo: «Parla o
finisci in galera!» A quel punto Intini gli consegna l’ordinanza di custodia
cautelare. Ferraro la legge velocemente e strabuzza gli occhi. «Dai, parla!
Dicci che è stato Scattone e stasera te ne vai a casa!» insistono quelli. «Non
posso dirlo, non sono stato testimone di nulla!». «E allora sei solo un gran
pezzo di merda!». «Ve lo ripeto, io con l’assassino di questa ragazza non
c’entro nulla!». Ferraro sorride con amarezza. Cerca di astrarsi dalla
situazione. Per mantenere il controllo dei nervi fissa una fotografia di Rossano
Calabro, appiccicata alla parete più lontana, che lo riporta ai luoghi della sua
infanzia. Intanto gli agenti lo braccano con sorrisi maliziosi e voci di volta
in volta suadenti, minacciose, beffarde. «Dicci che a Scattone è partito un
colpo per sbaglio, e te ne vai a casa a dormire in santa pace!». Lui però
rifiuta l’accomodamento, la disonesta logica del “mors tua vita mea” gli ha
sempre fatto ribrezzo. Non ha quasi più parole, e non vuole certo sprecarle
accusando Scattone solo per far finire al più presto quest’incubo. Scuote la
testa, chiude gli occhi, dondola nel buio. Il suo respiro si sta accartocciando,
sopraffatto dalla sensazione quasi materiale di una forza avvolgente che lo sta
schiacciando. «Bene, ebbravo lo stronzo!…», «Finirai a marcire in galera!»,
«Questa è la fine della sua brillante carriera, dottor Ferraro!» gli urlano a
pochi centimetri. Lui allora riapre gli occhi: «Con una coscienza pulita sarà
facile ricominciarne un’altra».
23 SECONDI E UN MANICHINO CHE
MANCA. Quando il dibattimento è ormai alle battute finali, ecco rifarsi strada
un’ipotesi clamorosa: l’ora ufficiale del delitto non sarebbe quella giusta. Un
tabulato Telecom, ottenuto a suo tempo dalle difese e poi richiesto dalla Corte
alla Procura, certifica infatti che la telefonata che quella mattina Iolanda
Ricci ha fatto al fidanzato da una cabina telefonica dell’Università è terminata
alle 11,39 e 1 secondo (anche se lei, nei verbali e al processo, l’aveva sempre
collocata intorno alle 11,30). Come si ricorderà, in udienza ha raccontato che
immediatamente dopo aver abbassato la cornetta è stata raggiunta da Marta,
insieme alla quale si è incamminata in direzione dell’uscita su viale Regina
Elena, sotto il tunnel della Facoltà di Giurisprudenza, per andare a seguire una
lezione di Storia economica in via del Castro Laurenziano. Da quella cabina, per
raggiungere a piedi il punto del vialetto in cui l’amica è stata colpita, si
impiegano al massimo sessanta secondi. Marta quindi non sarebbe stata uccisa
alle 11,42 ma – secondo più, secondo meno – due minuti prima. Un dettaglio che
cambierebbe tutto. Se il colpo è stato esploso alle 11,40 come ha fatto allora
Maria Chiara Lipari a sentire (lo ha confermato in udienza) un «tonfo sordo»
alle 11,44 mentre era in procinto di entrare nell’aula 6? E perché la Alletto ha
ripetuto più volte che la dottoranda fece il suo ingresso «nell’immediatezza
dello sparo, forse dopo una trentina di secondi, massimo un minuto»? Qualcosa
evidentemente non quadra. «Qui non siamo più nel campo delle opinioni» osserva
la difesa di Ferraro. «Si tratta di numeri, di cose esatte. E una discrepanza
del genere, a nostro giudizio, rende del tutto inattendibile non solo il
racconto della Lipari ma tutto il resto della ricostruzione». (…) Alla Procura
di Roma va però almeno riconosciuta una ferrea coerenza: alla Lipari hanno
sempre voluto credere, adoperandosi fattivamente per favorire l’incessante work
in progress della sua memoria. Un calvario doloroso della mente («dall’ano
proprio del cervello», come aveva riconosciuto lei stessa) che merita la pena –
sì, la pena – di essere ricordato per sommi capi. Interrogata il 21 maggio 1997
nel Commissariato dell’Università, dapprima sostiene che durante il primo
tentativo di telefonata al padre, mentre girava le spalle alla stanza, le è
parso che non vi fosse nessuno. L’interrogatorio viene improvvisamente sospeso
per «accertamenti tecnici» e ripreso in tarda serata. Solo allora dice «di non
essere sicura» della presenza di qualche altro suo collega nell’aula, quindi
aggiunge che «mi sembra di ricordare che qualcuno sia uscito frettolosamente.».
A dirla tutta, adesso che ci riflette meglio, «mentre stavo con la cornetta in
mano, questo signore ha aperto dall’interno la porta e, passandomi accanto,
nell’uscire mi ha salutato bofonchiando qualcosa». Racconta poi di non aver
avuto «la sensazione del vuoto» nella stanza anche se non sa precisare quante e
quali persone vi fossero («comunque non donne»). Fa un primo nome: «Forse era
presente il mio collega Andrea Simari», che risulterà invece assente. Non ha
comunque sentito «alcun rumore che possa somigliare ad uno sparo.» A notte
fonda, dopo altre cinque ore di interrogatorio in Questura, dichiara «di non
aver visto nessuno vicino alla finestra» ma «due o forse tre persone, due
certamente di sesso maschile e una probabilmente di sesso femminile» spostate
verso il centro della stanza e «che parlottavano tra loro». Entrando nella
stanza ha avuto comunque la «sensazione netta» di una «forte tensione
nell’aria». Butta giù altri nomi: quelli di Francesco Liparota, di Gabriella
Alletto («Quello che ricordo è un interrogativo che mi è passato nel cervello
come un lampo in quel momento e cioè: “Che ci fa Gabriella qua? ”») e infine
dell’assistente Massimo Mancini ( del quale ha udito il «suono della voce, ma
questo a livello subliminale senza averne quindi altra possibilità di
precisione» ). Sfortuna vuole che però anche quest’ultimo risulterà assente,
circostanza che la costringe a precisare in seguito che il suo nome gli è stato
suggerito da un funzionario di polizia mentre lei «non ci pensava affatto».
Nella notte tra il 26 e il 27 maggio dichiara invece di aver visto tre
individui, due al centro della stanza e uno vicino alla finestra che poi l’ha
salutata uscendo. Gli investigatori le fanno allora il nome di Ferraro ma lei si
rifiuta di confermarlo dal momento che quella persona non l’ha vista in faccia.
Intercettata poco dopo al telefono col padre, sostiene però di avere finalmente
ottenuto il suo «ricordo visivo»: non ne è ancora certa ma quell’uomo ha proprio
«la sensazione di averlo visto in facci». E poi aggiunge: «Ma se fosse quel
calabrese, quel calabrese ci ha… Veramente ci può avere proprio degli amici con
le armi, in casa in Calabria proprio sotto al cuscino… ». Il 19 giugno, quando
ormai Scattone e Ferraro sono stati arrestati grazie alle parole della Alletto
(la cui testimonianza combacia finalmente con i suoi “ricordi”), precisa di aver
avuto «la sensazione netta» che nella stanza vi fossero più persone, forse
quattro. La sera dell’8 agosto, tre mesi dopo il delitto, si reca infine negli
uffici della Polaria dell’aeroporto di Fiumicino. Sta partendo per le vacanze e
vuole a mettere a verbale altri particolari «di cui, adesso, ho un ricordo
preciso»: prima di entrare nell’aula 6 ha sentito «un rumore sordo, un tonfo» e
adesso rammenta «con precisione» la figura di Ferraro nella Sala assistenti («In
particolare ho focalizzato l’espressione del suo volto» ). Non appena l’ha vista
questi si è voltato di scatto verso la finestra, l’ha salutata impallidito ed è
uscito dalla stanza insieme a un’altra persona. Chi? «L’impressione è che si
tratti di Scattone». Lo stesso che, vedi tu a volte il caso, era stato arrestato
nella notte del 14 giugno come omicida e le cui foto riempivano da un pezzo
tutti i giornali. La Procura è soddisfatta. Per sparare da quella finestra in
direzione della vittima bisognava usare la destra. Non poteva essere stato
Ferraro perché non sa sparare ed è pure mancino. Lui invece è destro e ha fatto
il servizio militare nell’Arma dei carabinieri. Tutto combacia, quindi. Ben
fatto, Maria Chiara! Il suo accidentato percorso di ricostruzione mnemonica può
dirsi ora finalmente concluso. Per apprezzarne al meglio le dinamiche ne verrà
mostrata al processo una tappa significativa. Si tratta di un video di 17 minuti
registrato la sera del 26 maggio 1997 in occasione di un sopralluogo che la
Lipari e gli inquirenti hanno effettuato presso la Sala assistenti. L’audio è
pessimo. Dalle immagini si evince comunque lo sforzo evidente della ragazza, che
con espressione corrucciata parla più volte di «lampi», riferendosi a quei brani
di memoria che tenta di richiamare nella sua mente con l’aiuto del procuratore
aggiunto Italo Ormanni. Questi sollecita la sua preziosa testimone, invitandola
più volte a «cercare di focalizzare» i suoi ricordi. La ragazza allora mima i
movimenti che avrebbe compiuto quella mattina, chiude gli occhi e porta le mani
alle tempie, si tormenta i capelli, balbetta, pronuncia frasi sconnesse mentre
sul suo volto si alternano preoccupazione e concentrazione: «Un maschio forse
là…», dice indicando il lato destro dell’aula. «Non so, forse si sono mossi,
forse…» spiega al capo della Squadra mobile Nicolò D’Angelo e al commissario
Francesca Monaldi che intanto fanno posizionare dei manichini in base alle sue
indicazioni. Alla fine la telecamera ne inquadra due al centro della stanza
(rappresentano Liparota e la Alletto) e un terzo poco lontano dalla finestra: è
Salvatore Ferraro, di cui però non ha ancora fatto il nome. In questo presepio
manca ancora la sagoma del personaggio più importante, l’omicida Scattone. Ma
come abbiamo visto, è solo questione di tempo.
PRESUNTO COLPEVOLE. RAFFAELE SOLLECITO.
Raffaele Sollecito: «Ho denunciato i miei
giudici». Intervista di Valentina Stella il 16 Aprile
2017 su “Il Dubbio”. Raffaele Sollecito non molla e chiede allo Stato tre cose:
capire perché la sua vita è stata stravolta dalla macchina giudiziaria, essere
risarcito per aver trascorso da innocente 4 anni in carcere, e condannare
civilmente i magistrati che lo hanno punito ingiustamente. La storia di questo
ragazzo, dalla voce e dell’atteggiamento mite, e che può essere riassunta da
questa frase che apre il suo sito The long path through injustice (il lungo
percorso attraverso l’ingiustizia), è quella di un giovane uomo che ancora non
si è risvegliato completamente dall’incubo che lo ha segnato quando aveva solo
23 anni, che aveva da poco perso la madre e che stava per laurearsi. Il suo
futuro è incerto, tra il nuovo lavoro a Parma e l’esito delle sue iniziative
giudiziarie contro lo Stato. Tuttavia sull’omicidio della studentessa inglese
Meredith Kercher, uccisa nel 2007 a Perugia, esistono due certezze: la prima è
che per quel brutale assassinio c’è un solo colpevole, l’ivoriano Rudi Guede,
condannato in via definitiva con il rito abbreviato a 16 anni di reclusione. La
seconda è che per il delitto sono stati assolti per non aver commesso il fatto,
dopo ben 5 gradi di giudizio, Raffaele Sollecito e Amanda Knox. A mettere un
punto alla vicenda giudiziaria dei due ex fidanzati, che al momento dei fatti si
conoscevano da appena una settimana, ci ha pensato la Cassazione il 27 marzo
2015 con una sentenza di cui è bene sottolineare un estratto riguardo le
indagini: un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la
risultante di clamorose defaillances o amnesie investigative e di colpevoli
omissioni di attività di indagine. Ora però si apre un altro capitolo: Raffaele
Sollecito chiede, appunto, i danni allo Stato. Il primo tentativo per il
risarcimento per ingiustizia detenzione è stato respinto, ma gli avvocati Giulia
Bongiorno e Luca Maori hanno annunciato il ricorso in Cassazione. Intanto si è
aperto da poco l’altro filone: l’ingegnere informatico, assistito dagli avvocati
Antonio e Valerio Ciccariello, ha deciso di fare causa ad alcuni magistrati,
chiedendo tre milioni di euro in virtù della legge sulla responsabilità civile
dei togati che prevede cause “per dolo o colpa grave”.
Perché hai deciso di fare causa ai giudici?
Quali sono, a vostro parere, le colpe gravi?
«Si tratta di
tutte le mancanze interpretative che ci sono state in questi anni. Ad esempio è
cambiato il movente da un giudizio all’altro, la prova sul Dna è stata travisata
più volte, il materiale probatorio è stato interpretato in maniera differente da
un giudice all’altro, addirittura diversi magistrati hanno diciamo – disatteso
le regole pur di dimostrare l’indimostrabile. Oltretutto questi errori vengono
in una certa maniera stigmatizzati e riassunti dalla Corte di Cassazione che mi
ha assolto».
La persona che forse più di tutte ha segnato il
tuo destino è stato il pm Giuliano Mignini.
«Lui ha
condotto le indagini e mi ha accusato, ma alcuni giudici mi hanno dichiarato
ingiustamente colpevole e hanno messo l’ultima parola. È vero comunque che
Mignini è stato sanzionato dal Csm per avermi vietato di conferire con il mio
avvocato in fase preliminare, e questa la considero una grave lesione dei miei
diritti di difesa».
La Corte d’appello di Firenze ha respinto
invece l’istanza per il risarcimento per ingiusta detenzione a causa della tua
condotta dolosa o gravemente colposa. Percepisci un pregiudizio da parte della
magistratura nei tuoi confronti o sei fiducioso sull’esito del risarcimento e
della causa ai magistrati?
«La
magistratura è fatta di tante teste diverse. Di fatto la sentenza della Corte di
appello di Firenze non ha fatto altro che condannarmi un’altra volta, perché
hanno completamente distorto e disatteso tutte le risultanze probatorie che sono
intervenute durante questi anni, non prendendo minimamente in considerazione
tutto quello che è emerso durante le udienze. Hanno reinterpretato tutto il
caso, piazzandomi addirittura sulla scena del crimine. Tra virgolette è come se
mi avessero detto “Sollecito ti è andata bene tutto sommato, però ora stai
zitto”. Si sono comportati in maniera indecente».
Contro di te c’è una sorta di accanimento?
«Forse risulto
loro antipatico, forse non piaccio perché sottolineo i loro errori; d’altronde
hanno totalmente stravolto e distrutto la mia esistenza, per questo non capisco
perché dovrei essere magnanimo nei loro confronti o rimanere zitto nell’angolo e
dire “no, per favore non fatemi più del male”. Hanno la colpa di aver
perseguitato per anni degli innocenti. Perciò, quantomeno, credo che possa
chiedere delle spiegazioni allo Stato di tutta questa vicenda. E vorrei una
risposta chiara».
Ora come va la tua vita a Parma?
«Mi sono
trasferito da un mese per una nuova opportunità lavorativa. Sono stato accolto
decisamente bene: molte persone mi hanno dato il benvenuto e mi hanno trattato
con rispetto. La cosa più importante è il lavoro e spero di riuscire a far
fronte ai grossi debiti nei quali mi ha lasciato questa giustizia».
Sollecito: «Ridatemi la mia vita».
L'ingegnere informatico, assolto per l'omicidio di Meredith
Kercher, ha fatto causa a nove giudici per aver travisato fatti, circostanze e
prove sul caso Kercher. Ci ha spiegato come sta ricominciando a vivere, con un
nuovo lavoro, a Parma. Intervista di Monica Coviello del 12 aprile 2017 su
"Vanityfair.it". «Nessuno mi restituirà il tempo che ho perso. Non c’è cifra che
possa risarcire dieci anni di vita rubati». Ma Raffaele Sollecito, 33 anni,
assolto per l’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa di 22 anni uccisa la
sera del primo novembre del 2007 a Perugia, dove era in Erasmus, un risarcimento
l’ha chiesto. Circa tre milioni di euro. Ha citato in giudizio, in base alla
nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati, nove tra pubblici
ministeri, procuratori generali, giudici delle indagini preliminari e giudici di
corte d’assise e corte d’assise d’appello, per aver travisato fatti, circostanze
e prove sul caso Kercher.
«Il calcolo della somma è stato fatto a tavolino
dai miei avvocati – ci spiega Sollecito – considerando gli anni passati in
carcere, l’iter giudiziario, l’entità dei travisamenti. Quei soldi li userei per
me, per riprendermi la mia vita, e per fare opere di bene, ma anche
per ripianare i debiti di cui ho dovuto coprirmi durante quegli anni di inferno.
Poi, vorrei che venisse chiarita la posizione dei giudici. Ma ne parleremo,
eventualmente, tra qualche anno».
Dopo tutti quegli anni passati tra carcere e
processi, ha ancora intenzione di tornare in tribunale?
«Ci sono ancora, in tribunale, e non per mia
volontà. Sono stato querelato dal sostituto procuratore della Repubblica di
Perugia Giuliano Mignini per vilipendio e calunnia, per le affermazioni
contenute nel mio libro “Honor bound”, pubblicato negli Stati Uniti. Sono altri
che vogliono tenermi sotto processo».
Lei ha trascorso quattro anni in carcere.
«Sono stati tragici e tristi. Ho trascorso sei
mesi in isolamento e 3 e mezzo in massima sicurezza a Terni, mentre vedevo
affondare la mia vita».
Che cosa le hanno insegnato questi anni?
«A essere meno pauroso. Poi, la detenzione mi ha
fatto conoscere un mondo che ignoravo: ho capito che la carcerazione, nelle
modalità italiane, non ha senso. Si passano 22 ore, almeno, in una cella di 2
metri per 3, e le altre due in una più grande, che si chiama “passeggio”. Gli
effetti si possono immaginare. Chi è colpevole dovrebbe avere la chance di
potersi riabilitare, e chi è in attesa di giudizio non dovrebbe finire dietro le
sbarre».
Può esserci il pericolo che fugga.
«Ma no: bisognerebbe cambiare identità, e per
farlo sono necessari investimenti esosi che forse solo i mafiosi potrebbero
permettersi. Chi è in attesa di giudizio, al massimo, potrebbe essere affidato a
una comunità: il carcere è una pena estremamente pesante. E la gente non tiene
conto che a tutti potrebbe capitare, prima o poi, di finire in giudizio per
qualcosa che non hanno fatto».
Ha stretto amicizie in carcere?
«Sì, certo. Ero un po’ la mascotte, lì dentro. In
mezzo a tante persone con una vita disastrata, ero l’unico studente, per di più
di ingegneria, e di famiglia buona. Ero un pesce fuori dall’acqua, e facevo un
po’ tenerezza a tutti».
Quanto è presente il ricordo del carcere nella
sua vita quotidiana?
«Più che altro, sono costretto tutti i giorni a
fare i conti con questa vicenda, che continua ad avere spazio. Sono ancora
costretto a giustificarmi, a spenderci energie. I gossip e i dubbi sulla mia
persona mi danno tanto dolore».
La gente continua a guardarla con sospetto?
«Purtroppo capita: per strada una ragazza, quando
mi ha visto, ha cominciato a piangere spaventata. Ma se lo fanno, è solo perché
tutta la vicenda è stata raccontata in un modo fuorviante sui giornali e in
tribunale. La gente comune si è informata seguendo i media, non leggendo le
carte del processo. Non sono io che faccio paura: è l’immagine che hanno dato di
me che fa schifo. Pensi anche a tutte le accuse mosse verso mio padre».
Quali?
«Hanno detto che era un mafioso. Invece è un
medico, che non ha avuto nemmeno la possibilità di pagare tutte le spese di
questo processo: abbiamo dovuto vendere le proprietà di mia mamma, siamo
sommersi dai debiti. Le chiacchiere sono state alimentate dai tribunali e dai
giornalisti, ed è da loro che pretendo spiegazioni. Io non ne posso più di
darne».
Ora vive a Parma.
«Sono qui da meno di un mese e mezzo, grazie agli
amici che mi hanno dato questa opportunità. Lavoro come ingegnere informatico
per un’azienda, Memories IT Company, e ho creato insieme ai colleghi un portale
di servizi. Vivo in una stanza in cui mi ospita un amico. Ma mi trovo bene: la
gente mi ha accolto con affetto. Se il lavoro andrà bene, rimarrò qua: mi
piacerebbe».
Ripensa spesso al periodo della morte di
Meredith?
«Sono totalmente estraneo ai fatti e mi sono
scocciato di ripensarci. Ma vengo invitato a diversi convegni sul caso, quindi
devo tornarci spesso. Quando ci rifletto, mi viene da piangere pensando ad anni
che non potrò più vivere, che erano bellissimi e che non torneranno».
Sente ancora Amanda?
«Pochissimo: ognuno ha la sua vita, siamo presi da
altri pensieri. Ma Amanda l’ho conosciuta cinque giorni prima di quella vicenda:
per me Perugia è altro».
Ha mai fatto visita a Rudy Guede?
«Non ci sarebbe motivo di andare a trovarlo: non
lo conosco. La sua posizione è chiara: il suo Dna è stato ritrovato sulla scena
del crimine e lui ha tentato di alimentare ombre e dubbi su di Amanda e me,
anche se sa che siamo innocenti».
È stata fatta giustizia per Meredith?
«A mio parere sì: secondo me non è stato un
omicidio compiuto da più persone».
Ha contatti con la sua famiglia?
«Mi hanno ignorato durante questi anni: non li ho
mai sentiti. Ho tentato qualche volta di avere un dialogo con loro, ma ho
trovato solo dei muri».
Giustizia carogna. Errori
giudiziari e controversi indennizzi per l'ingiusta detenzione.
Raffaele Sollecito e Giuseppe
Gulotta. Quando la giustizia è strabica, permalosa e vendicativa.
Di Antonio Giangrande
Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Antonio Giangrande ha scritto i libri
che parlano della malagiustizia e della ingiustizia, in generale, e del delitto
di Perugia, in particolare.
Giustizia carogna, scrive
Fabrizio Boschi il 31 gennaio 2017 su "Il Giornale”. Nel febbraio 2012 ci provò
un deputato di Forza Italia, Daniele Galli: presentò una proposta di legge per
obbligare lo Stato a rifondere le spese legali del cittadino che viene imputato
in un processo penale e ne esce assolto con formula piena. Non venne mai nemmeno
discussa. Eppure affrontava una delle peggiori ingiustizie italiane.
Raffaele Sollecito, in seguito
alla sua definitiva assoluzione, ha deciso di chiedere solo l’indennizzo per
ingiusta detenzione, scartando l’idea di chiedere anche il risarcimento danni
per responsabilità civile dei magistrati, consigliato dalla magnanimità ed
accondiscendenza dei suoi legali verso i magistrati di Perugia.
"Nelle prossime settimane
valuteremo eventuali istanze relative all'ingiusta detenzione". Lo ha detto uno
dei legali di Raffaele Sollecito all’Agi il 30 marzo 2015, Giulia Bongiorno,
spiegando che eventuali azioni di "risarcimento e responsabilità civile non
saranno alimentati da sentimenti di vendetta che non sono presenti nell'animo di
Sollecito". Quanto alla responsabilità civile dei magistrati inquirenti, "quello
della responsabilità civile dei magistrati è un istituto serio che non va
esercitato con spirito di vendetta – ha aggiunto il legale - e allo stato non ci
sono iniziative di questo genere".
Ciononostante la bontà d’animo
di Raffaele Sollecito viene presa a pesci in faccia.
Raffaele Sollecito non deve
essere risarcito per i quasi quattro anni di ingiusta detenzione subiti dopo
essere stato coinvolto nell’indagine l’omicidio di Meredith Kercher, delitto per
il quale è stato definitivamente assolto insieme ad Amanda Knox. A stabilirlo è
stata la Corte d’appello di Firenze l’11 febbraio 2017 che ha respinto la
richiesta di indennizzo ritenendo che il giovane abbia «concorso a causarla»
rendendo «in particolare nelle fasi iniziali delle indagini, dichiarazioni
contraddittorie o addirittura francamente menzognere». Il giovane arrestato
assieme ad Amanda Knox e poi assolto per l’omicidio a Perugia di Meredith
Kercher, aveva chiesto 516mila euro di indennizzo per i 4 anni dietro le sbarre.
Alla richiesta di risarcimento
si erano opposti la procura generale di Firenze e il ministero delle Finanze.
Nella richiesta di risarcimento i legali di Sollecito avevano richiamato la
motivazione della sentenza della Cassazione nelle pagine in cui venivano
criticate le indagini secondo la Suprema Corte mal condotte dagli inquirenti e
dalla procura di Perugia. In primo grado, nel 2009, Raffaele Sollecito e
l’americana Amanda Knox erano stati condannati dalla Corte d’Assise di Perugia a
25 anni e 26 anni di carcere per omicidio. Nel 2011 vennero poi assolti e
scarcerati dalla Corte d’Assise d’appello dal reato di omicidio (alla Knox fu
confermata la condanna a tre anni per calunnia). Nel 2013 la Corte di Cassazione
annullò poi l’assoluzione e rinviò gli atti alla Corte d’Assise d’Appello di
Firenze che condannò (2014) Sollecito a 25 anni e Knox a 28 anni e 6 mesi.
Infine, il 27 marzo 2015, il verdetto assolutorio della Cassazione.
Prima dei commenti ci sono i
numeri. Sconcertanti, scrive Alessandro Fulloni il 31 12 2016 su "Il Corriere
della Sera”. Il dato complessivo lascia senza parole. Il risarcimento
complessivo versato alle vittime della «mala-giustizia» ammonta a 630 milioni di
euro. Indennizzi previsti dall’istituto della riparazione per ingiusta
detenzione, introdotto con il codice di procedura penale del 1988, ma i primi
pagamenti – spiegano dal Ministero – sono avvenuti solo nel 1991 e
contabilizzati l’anno successivo: in 24 anni, dunque, circa 24 mila persone sono
state vittima di errore giudiziario o di ingiusta detenzione. L’errore
giudiziario vero e proprio è il caso in cui un presunto colpevole, magari
condannato in giudicato, viene finalmente scagionato dalle accuse perché viene
identificato il vero autore del reato. Situazioni che sono circa il 10 per cento
del totale. Il resto è alla voce di chi in carcere non dovrebbe starci: custodie
cautelari oltre i termini, per accuse che magari decadono davanti al Gip o al
Riesame. In questo caso sono previsti indennizzi, richiesti «automaticamente» -
usiamo questo termine perché la prassi è divenuta inevitabile - dagli avvocati
che si accorgono dell’ingiusta detenzione. Il Guardasigilli ha fissato una
tabella, per questi risarcimenti: 270 euro per ogni giorno ingiustamente
trascorso in gattabuia e 135 ai domiciliari. Indennizzi comunque in calo: se nel
2015 lo Stato ha versato 37 milioni di euro, nel 2011 sono stati 47. Mentre nel
2004 furono 56. Ridimensionamento - in linea con una sorta di «spendig review» -
che viene dall’orientamento della Cassazione che applica in maniera restrittiva
un codicillo per cui se l’imputato ha in qualche modo concorso all’esito della
sentenza a lui sfavorevole - poniamo facendo scena muta all’interrogatorio - non
viene rimborsato. In termini assoluti e relativi, gli errori giudiziari si
concentrano soprattutto a Napoli: 144 casi nel 2015 con 3,7 milioni di euro di
indennizzi. A Roma 106 casi (2 milioni). Bari: 105 casi (3,4 milioni). Palermo:
80 casi (2,4 milioni). La situazione pare migliorare al Nord: per Torino e
Milano rispettivamente 26 e 52 casi per 500 mila e 995 mila euro di indennizzi.
Alla detenzione si accompagna il processo, che può durare anni. Quando l’errore
subito viene accertato, la vita ormai è cambiata per sempre. C’è chi riesce a
rialzarsi, magari realizzando un obiettivo rimasto per tanto tempo inespresso. E
chi resta imbrigliato nell’abbandono dei familiari, nella perdita del lavoro,
nella necessità di tirare a campare con la pensione.
Carceri "Negli ultimi 50 anni
incarcerati 4 milioni di innocenti". Decine di innocenti rinchiusi per anni.
Errori giudiziari che segnano le vite di migliaia di persone e costano caro allo
Stato. Eccone un breve resoconto pubblicato da Ristretti Orizzonti, che ha reso
nota una ricerca dell'Eurispes e dell'Unione delle Camere penali, scrive Romina
Rosolia il 29 settembre 2015 su "La Repubblica". False rivelazioni, indagini
sbagliate, scambi di persona. E' così che decine di innocenti, dopo essere stati
condannati al carcere, diventano vittime di ingiusta detenzione. Errori
giudiziari che non solo segnano pesantemente e profondamente le loro vite,
trascorse - ingiustamente - dietro le sbarre, ma che costano caro allo Stato.
Eccone un breve resoconto pubblicato da Ristretti Orizzonti, che ha reso nota
una ricerca dell'Eurispes e dell'Unione delle Camere penali italiane. Quanto
spende l'Italia per gli errori dei giudici? La legge prevede che vengano
risarciti anche tutti quei cittadini che sono stati ingiustamente detenuti,
anche solo nella fase di custodia cautelare, e poi assolti magari con formula
piena. Solo nel 2014 sono state accolte 995 domande di risarcimento per 35,2
milioni di euro, con un incremento del 41,3% dei pagamenti rispetto al 2013. Dal
1991 al 2012, lo Stato ha dovuto spendere 580 milioni di euro per 23.226
cittadini ingiustamente detenuti negli ultimi 15 anni. In pole position nel
2014, tra le città con un maggior numero di risarcimenti, c'è Catanzaro (146
casi), seguita da Napoli (143 casi). Errori in buona fede che però non
diminuiscono. Eurispes e Unione delle Camere penali italiane, analizzando
sentenze e scarcerazioni degli ultimi 50 anni, hanno rilevato che sarebbero 4
milioni gli italiani dichiarati colpevoli, arrestati e rilasciati dopo tempi più
o meno lunghi, perché innocenti. Errori non in malafede nella stragrande
maggioranza dei casi, che però non accennano a diminuire, anzi sono in costante
aumento. Sui casi di mala giustizia c'è un osservatorio on line, che dà conto
degli errori giudiziari. Mentre sulla pagina del Ministero dell'Economia e delle
Finanze si trovano tutte le procedure per la chiesta di indennizzo da ingiusta
detenzione. Gli errori più eclatanti. Il caso Tortora è l'emblema degli errori
giudiziari italiani. Fino ai condannati per la strage di via D'Amelio: sette
uomini ritenuti tra gli autori dell'attentato che costò la vita al giudice Paolo
Borsellino e alle cinque persone della scorta il 19 luglio 1992. Queste stesse
persone sono state liberate dopo periodi di carcerazione durati tra i 15 e i 18
anni, trascorsi in regime di 41 bis. Il 13 febbraio scorso, la Corte d'appello
di Reggio Calabria ha riconosciuto un altro grave sbaglio: è innocente anche
Giuseppe Gulotta, che ha trascorso 21 anni, 2 mesi e 15 giorni in carcere per
l'omicidio di due carabinieri nella caserma di Alcamo Marina (Trapani), nel
1976. Trent'anni dopo, un ex brigadiere che aveva assistito alle torture cui
Gulotta era stato sottoposto per indurlo a confessare, ha raccontato com'era
andata davvero. Altri casi paradossali. Nel 2005, Maria Columbu, 40 anni, sarda,
invalida, madre di quattro bambini, venne condannata con l'accusa di eversione
per dei messaggi goliardici diffusi in rete, nei quali insegnava anche a
costruire "un'atomica fatta in casa". Nel 2010 fu assolta con formula piena. Per
l'ultimo giudice, quelle istruzioni terroristiche erano "risibili" e "ridicole".
Tra gli ultimi casi, la carcerazione e la successiva liberazione, nel caso Yara
Gambirasio, del cittadino marocchino Mohamed Fikri, accusato e subito scagionato
per l'omicidio della ragazza. Sono fin troppo frequenti i casi in cui si accusa
un innocente? Perché la verità viene fuori così tardi? Perché non viene creduto
chi è innocente? A volte si ritiene valida - con ostinazione - un'unica pista,
oppure la verità viene messa troppe volte in dubbio. Forse, ampliare lo spettro
d'indagine potrebbe rilevare e far emergere molto altro.
Ma veniamo al caso
"Sollecito".
I rischi della difesa, scrive
Ugo Ruffolo il 12 febbraio 2017 su"Quotidiano.net". La decisione sembra
salomonica: Sollecito, assolto per il rotto della cuffia, viene liberato ma non
risarcito per la ingiusta pregressa detenzione. Quattro anni, per i quali chiede
500.000 euro. Sollecito dovrebbe ringraziare il cielo di essere libero e non
forzare la mano, per non fare impazzire i colpevolisti. Ma Salomone non abita
nei codici. I quali sarebbero un sistema binario. O tutto, o niente. Se sei
assolto, non importa come, la ingiusta detenzione ti deve essere risarcita. C’è
però l’articolo 314 del c.p.c., il quale prevede una sorta di concorso di colpa
del danneggiato, che neutralizzerebbe la sua pretesa al risarcimento. Come dire:
se sei assolto, ma per difenderti hai mentito o ti sei contraddetto, allora sei
tu ad aver depistato polizia e giudici, o ad aver complicato il loro lavoro. Se
ti hanno prima condannato e poi assolto, e dunque se hai fatto quattro anni di
carcere ingiustamente, la colpa è anche tua; e questo ti impedirebbe di chiedere
il risarcimento (come dire: un po’ te la sei voluta). Sembrerebbe giusto, almeno
in linea di principio. Ma sorge il problema che, assolto in penale l’imputato,
in sede civile viene processata la sua linea difensiva, ai fini di accordargli o
meno risarcimento da ingiusta detenzione. In altri termini ciascuno è libero di
difendersi come crede, anche depistando o mentendo (potrebbe essere talora
funzionale alla difesa nel caso concreto). Ma chi sceglie questa linea si espone
al rischio di vedersi poi rifiutato il risarcimento. È quanto obbietta a
Sollecito l’ordinanza della Corte d’Appello, ricostruendo quella storia
processuale come costellata di depistaggi, imprecisioni, contraddizioni e
menzogne. Che talora Sollecito aveva ammesso, giustificandosi con l’essere
stato, al tempo, “confuso”. I suoi avvocati annunciano ricorso in Cassazione,
per contestare come erronea quella ricostruzione processuale. Dovrebbero avere,
credo, scarsa possibilità di vittoria. Salomone, così, rientrerebbe dalla
finestra ed i colpevolisti eviterebbero di impazzire. Ma quel che turba, è un
processo che si riavvolta su se stesso, cannibalizzandosi: processo del processo
del processo (e anche, processo nel processo nel processo). Come riflesso fra
due specchi all’infinito.
Sollecito, no ai risarcimenti.
Non è abbastanza innocente. La Corte d'appello di Firenze nega 500mila euro per
4 anni di cella: «Troppi silenzi e menzogne», scrive Annalisa Chirico, Domenica
12/02/2017, su "Il Giornale". Per la giustizia italiana puoi essere innocente e,
a un tempo, colpevole. La Corte d'appello di Firenze ha rigettato la richiesta
di risarcimento per ingiusta detenzione avanzata da Raffaele Sollecito. Il
dispositivo, pubblicato dal sito web finoaprovacontraria.it, s'inserisce nel
solco della cosiddetta giurisprudenza sul concorso di colpa. In sostanza, il
cittadino che, ancorché assolto, abbia contribuito con dolo o colpa grave a
indurre in errore inquirenti e magistrati, vede ridimensionato il proprio
diritto a ottenere un risarcimento per la detenzione ingiustamente inflitta. Nel
caso di Sollecito, quattro anni di carcere e un'assoluzione definitiva, questo
diritto si annulla, si polverizza, nessun risarcimento, non un euro, niente. Per
i giudici della terza sezione penale, «le dichiarazioni contraddittorie o false
e i successivi mancati chiarimenti» da parte del giovane laureatosi ingegnere
dietro le sbarre avrebbero contribuito all'applicazione e al mantenimento della
misura cautelare. Ma quali sarebbero le dichiarazioni «menzognere»? «Io non mi
sono mai sottratto agli interrogatori - commenta al Giornale il protagonista,
suo malgrado, dell'ennesimo colpo di scena in un'odissea giudiziaria durata
quasi dieci anni Ho letto la decisione, sono sbigottito. Avverto l'eco della
sentenza di condanna, forse sono affezionati agli errori giudiziari». Sollecito
è scosso, non se l'aspettava. «Credevo di aver vissuto le pagine più nere della
giustizia italiana. Devo prendere atto che la mia durissima detenzione sarebbe
giustificata». Nelle ore successive al ritrovamento del cadavere di Meredith
Kercher, la studentessa inglese barbaramente uccisa nell'appartamento di via
della Pergola nel 2007, Sollecito risponde alle domande di chi indaga, cerca di
ricostruire nel dettaglio gli spostamenti suoi e di Amanda, la ragazza americana
che frequenta da una settimana, prova a fissare gli orari di ingresso e uscita
dal suo appartamento perugino, se Amanda si sia mai assentata nel corso della
notte, se il padre gli abbia telefonato dalla Puglia verso l'ora di cena o prima
di andare a dormire, Raffaele non si sottrae ma fatica a ricordare con
esattezza, si contraddice, giustifica l'imprecisione ammettendo di aver fumato
qualche canna come fanno gli universitari di mezzo mondo, nel corso
dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al gip dichiara: «Ho detto delle cazzate
perché io ero agitato, ero spaventato e avevo paura. Posso dire che io non
ricordo esattamente quando Amanda è uscita, se è uscita non ricordo». Ma c'è di
più. Nell'ordinanza di 12 pagine, si legge che il silenzio mantenuto
dall'indagato dopo l'interrogatorio di garanzia Sollecito fu tenuto per sei mesi
in isolamento avrebbe contribuito a indurre in errore i giudici. In altre
parole, l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, frutto di una
valutazione della difesa in via prudenziale, diventa indizio di un'innocenza a
metà: Sollecito è ancora sotto processo. Per spazzare via ogni dubbio, si
afferma che la stessa sentenza di assoluzione emessa dalla Cassazione avrebbe
rinvenuto «un elemento di forte sospetto a carico del Sollecito» a causa delle
dichiarazioni contraddittorie. Non vi è traccia invece delle censure espresse
dai supremi giudici sull'operato dei pm: «clamorose défaillance o amnesie
investigative e colpevoli omissioni di attività di indagine», scrivono gli
ermellini. Per l'omicidio della Kercher un cittadino ivoriano sconta una
condanna definitiva a sedici anni di carcere. Ormai la cultura del sospetto ha
inghiottito quella del diritto, è la stessa che fa dire candidamente al
presidente dell'Anm Davigo che pure gli innocenti sono colpevoli.
Innocenti di serie B, scrive
Claudio Romiti il 14 febbraio 2017 su “L’Opinione. Destando un certo scalpore,
soprattutto tra quei cittadini avvertiti che credono in una visione garantista
della giustizia, la Corte d’Appello di Firenze ha negato qualunque risarcimento
a Raffaele Sollecito per l’ingiusta detenzione. Quattro interminabili anni
passati dietro le sbarre che, per una persona vittima di una ricostruzione dei
fatti a dir poco surreale, devono essere sembrati un inferno. Così come un
inferno, che in alcuni aspetti continua a sussistere per il giovane ingegnere
informatico pugliese, è stato il lunghissimo iter processuale, fortemente
inquinato da un forte pregiudizio mediatico che ancora oggi fa sentire i suoi
effetti presso una parte dell’opinione pubblica disposta a bersi qualunque
pozione colpevolista. In estrema sintesi i giudici di Firenze hanno stabilito,
bontà loro, che il comportamento iniziale del Sollecito, considerato
eccessivamente ambiguo e, in alcuni casi, menzognero, avrebbe indotto gli
inquirenti perugini in errore, convincendo questi ultimi - aggiungo io - a
mettere in piedi un castello di accuse fondato sul nulla, visto che nella stanza
del delitto non furono ritrovate tracce dei due fidanzatini dell’epoca,
contrariamente alle decine e decine di evidenze schiaccianti a carico di Rudy
Guede. Quest’ultimo, considerato ancora oggi da molti analfabeti funzionali di
questo disgraziato Paese solo un capro espiatorio dell’atroce delitto di
Perugia, vittima dei soliti poteri forti capitanati dalla Cia, fino a
coinvolgere la longa manus di Donald Trump, il quale in passato si era
interessato del caso.
Sta di fatto che Raffaele
Sollecito, pur essendo scampato ad uno dei più clamorosi errori giudiziari della
storia italiana, viene considerato oggi, negandogli alcun risarcimento, un
innocente dimezzato. Un mezzo colpevole che avrebbe cagionato le sue disgrazie
per non aver fornito in modo chiaro le ragioni della sua innocenza. Tant’è che
persino il silenzio mantenuto dall’imputato dopo l’interrogatorio di garanzia,
come sottolinea Annalisa Chirico sul “Il Giornale”, avrebbe indotto i giudici
nell’errore. “In altre parole - commenta la stessa Chirico - l’esercizio di un
diritto costituzionalmente garantito, frutto di una valutazione della difesa in
via prudenziale, diventa indizio di una innocenza a metà”. E se la decisione di
avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti viene
valutata in questo modo, ciò significa che nelle nostre aule giudiziarie ancora
aleggia quell’idea molto medievale dell’inversione della prova. In un evoluto
sistema giudiziario, al contrario, spetta sempre all’accusa dimostrare al di là
di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza di qualunque imputato. E se questo
non accade, proprio perché siamo tutti innocenti fino a prova contraria, le
conseguenze fisiche, morali e finanziarie di una accusa caduta nel nulla non
possono ricadere sulla testa di chi l’ha pesantemente subìta. Da questo punto di
vista, dopo l’annuncio del ricorso in Cassazione presentato dall’avvocato di
Sollecito, Giulia Bongiorno, dobbiamo sempre sperare, al pari del mugnaio di
Potsdam, che ci sia sempre un giudice a Berlino.
Ma quale è il comportamento
contestato a Raffaele Sollecito?
Si legge il 11 Febbraio 2017
su “Il Tempo”. "Credevo di aver vissuto le pagine più nere della Giustizia
Italiana, ma nonostante la Cassazione mi ha dichiarato innocente, devo prendere
atto che la mia durissima detenzione sarebbe giustificata. Ripeto, la Cassazione
aveva sottolineato l'esistenza di gravissime omissioni in questo processo e di
defaillance investigative". Così Sollecito - assolto dall'accusa di aver
partecipato all'omicidio di Meredith Kercher - commenta sul suo profilo
Facebook. "Riprendono in toto la sentenza di condanna di Firenze, piena di
errori fattuali ingiustificabili - scrive ancora Sollecito - Adesso questi
giudici non tengono minimamente conto di sentenze in cui è acclarato il clima di
violenza durante gli interrogatori. Non mi sono mai sottratto ad un
interrogatorio e dire che non mi hanno ascoltato è soltanto una scusa, visto che
ho fatto mille dichiarazioni spontanee". Per l'avvocato di Sollecito, Giulia
Bongiorno, la decisione della Corte d'appello di Firenze «si caratterizza per
una serie consistente di errori. Basterebbe pensare che esclude il diritto al
risarcimento sulla base delle dichiarazioni che avrebbe reso Sollecito e
dimentica che esistono delle sentenze in cui è stato attestato che addirittura,
nell'ambito della questura, furono fatte pressioni e violenze alla Knox e
Sollecito proprio nel momento in cui rendevano queste dichiarazioni». «Non c'è
un solo cenno sulla situazione in questura - aggiunge il legale - Inoltre,
l'ordinanza dimentica che le dichiarazioni non possono in nessun modo aver
inciso sull'ingiusta detenzione perché non sono state citate come decisive nei
provvedimenti restrittivi in cui si faceva invece riferimento ad altri elementi.
Infine, in sede di dibattimentale, Sollecito non ha reso alcun esame quindi non
si vede come le sue dichiarazioni possano aver causato il diniego di libertà in
quella fase. È una sentenza - conclude il legale - che verrà immediatamente
impugnata in Cassazione».
Insomma, la Corte di Appello
di Firenze, volutamente e corporativamente non ha tenuto conto del clima di
violenza e coercizione psicologica che sollecito ha subito nelle fasi in cui gli
si contesta un atteggiamento omissivo e non collaborativo.
In ogni modo. Se a Firenze a
Sollecito si contesta un comportamento in cui abbia «concorso a causarla»
(l'illegittima detenzione), rendendo «in particolare nelle fasi iniziali delle
indagini, dichiarazioni contraddittorie o addirittura francamente menzognere»,
come se non fosse nel suo sacrosanto diritto di difesa farlo, ancor più
motivato, plausibile e condivisibile sarebbe stato il diniego alla richiesta
dell'indennizzo di fronte ad una vera e propria confessione.
Invece si dimostra che in
Italia chi esercita impropriamente un potere, pur essendo solo un Ordine
Giudiziario, ha sempre l'ultima parola per rivalersi da fallimenti pregressi.
Giuseppe Gulotta, risarcito
con 6,5 milioni di euro dopo 22 anni in carcere da innocente. Il muratore di
Certaldo (Firenze) è stato condannato nel 1976 per duplice omicidio e assolto
nel 2012. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha riconosciuto l'indennizzo.
L'avvocato aveva chiesto 56 milioni di euro, scrive "Il Fatto Quotidiano" il 14
aprile 2016. Sei milioni e mezzo di euro di risarcimento per aver trascorso 22
anni in carcere da innocente. La corte d’appello di Reggio Calabria ha stabilito
l’indennizzo per Giuseppe Gulotta, il muratore di Certaldo (Firenze) accusato di
aver ucciso due carabinieri e poi assolto nel 2012. La richiesta di Gulotta,
attraverso il legale Pardo Cellini, ammontava a 56 milioni di euro. “Stiamo
valutando un ricorso in Cassazione”, ha spiegato l’avvocato. “Se da un lato
siamo soddisfatti perché con la decisione dei giudici di Reggio Calabria finisce
questo lungo percorso, dall’altro non ci soddisfa che sia stato riconosciuto
un indennizzo e non un risarcimento”. “Per trentasei anni sono stato
un assassino”, aveva raccontato in un libro del 2013 lo stesso Gulotta, “dopo
che mi hanno costretto a firmare una confessione con le botte, puntandomi una
pistola in faccia, torturandomi per una notte intera. Mi sono autoaccusato: era
l’unico modo per farli smettere”. Nel 1976, a 18 anni, Gulotta fu condannato per
il duplice omicidio di Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, avvenuto nella
caserma Alkmar di Alcamo Marina, in provincia di Trapani.
In carcere in Toscana da
innocente, crea una fondazione per le vittime degli errori giudiziari. Giuseppe
Gulotta fu condannato per l'omicidio di due carabinieri. Dopo 40 anni ha
ricevuto i 6,5 milioni di indennizzo dallo Stato, scrive Franca Selvatici il 17
gennaio 2017 su "La Repubblica". È arrivato finalmente l'indennizzo dello Stato
per Giuseppe Gulotta e per la sua vita devastata da un tragico errore
giudiziario. In tutto 6 milioni e mezzo di euro, che dopo anni di carcere, di
disperazione e di difficoltà economiche permetteranno all'ex
ergastolano, accusato ingiustamente dell'atroce esecuzione di due giovani
carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, trucidati il 26 gennaio 1976
nella piccola caserma di Alcamo Marina, di assicurare un po' di agiatezza alla
moglie Michela e ai figli e di aiutare chi, come lui, è finito in carcere
innocente. Giuseppe Gulotta, nato il 7 agosto 1957, aveva poco più di 18 anni
quando finì nel "tritacarne di Stato". Chiamato in causa con altri da un giovane
che, dopo essere stato trovato in possesso di armi, fu torturato, costretto a
ingoiare acqua, sale e olio di ricino e a subire scosse elettriche ai testicoli,
anche lui fu incatenato, circondato da "un branco di lupi", picchiato,
insultato, umiliato e torturato, finché - come ha raccontato nel libro Alkamar
scritto con Nicola Biondo e pubblicato da Chiarelette - "sporco di sangue,
lacrime, bava e pipì" - non ha firmato una confessione che, seppure ritrattata
il giorno successivo, gli ha distrutto la vita. Il 13 febbraio 1976 fu arrestato
e dopo ben nove processi il 19 settembre 1990 fu condannato definitivamente
all'ergastolo. Scarcerato nel 1978 per decorrenza dei termini della custodia
cautelare, era stato allontanato dalla Sicilia. I genitori lo mandarono in
Toscana, a Certaldo, e qui - fra un processo e l'altro - Giuseppe ha conosciuto
Michela, sua moglie, che gli ha dato la forza di resistere nei 15 anni trascorsi
in carcere. Nel 2005 ha ottenuto la semilibertà. Sarebbe comunque rimasto un
"mostro" assassino se nel 2007 un ex carabiniere non avesse deciso di raccontare
le torture a cui aveva assistito. Da allora Giuseppe - assistito dagli avvocati
Baldassarre Lauria e Pardo Cellini - ha intrapreso l'impervio percorso della
revisione del processo. Il 13 febbraio 2016 - esattamente 40 anni dopo il suo
arresto - è stato riconosciuto innocente e assolto con formula piena dalla corte
di appello di Reggio Calabria. Quattro anni più tardi, il 12 aprile 2016, dopo
altre estenuanti battaglie gli è stato definitivamente riconosciuto l'indennizzo
di 6 milioni e mezzo a titolo di riparazione dell'errore giudiziario. Anche gli
altri tre giovani condannati come lui sono usciti assolti dal processo di
revisione, incluso Giovanni Mandalà, morto in carcere disperato nel 1998. Per i
suoi familiari lo Stato si appresta a versare un indennizzo record, il più alto
mai riconosciuto in Italia: 6 milioni e 600 mila euro.
Dieci anni dopo Sollecito si racconta:
"Servirebbe un film anche su di me. Rivoglio la mia vita".
Di Giacomo Talignani l'8 aprile 2017 su Repubblica TV. Tra gli occhi delle
persone "che mi guardano come colpevole, come una se fossi una patata bollente"
Raffaele Sollecito, 10 anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia, prova
a ripartire da Parma dove lavora come ingegnere informatico in una azienda di
app. Assolto in Cassazione, dice di sentirsi "abbandonato dallo Stato" e ferito
per "il risarcimento economico negato". Come per Amanda (prodotto da Netflix)
anche lui vorrebbe che si facesse chiarezza sul suo ruolo, "magari con un film
per raccontare il mio processo. Voglio avere indietro la mia vita".
Assolto per il delitto di Perugia,
Sollecito fa causa ai giudici. Raffaele Sollecito e
Amanda Knox assolti per l'omicidio di Meredith Kercher. A Genova per competenza
territoriale. "Hanno sbagliato e mi hanno rovinato la vita, ora paghino", scrive
Marco Preve l'11 aprile 2017 su "La Repubblica". A dieci anni da uno dei casi
di cronaca nera più clamorosi e controversi, uno dei sospettati che dovette
trascorrere quattro anni in carcere prima di essere riconosciuto innocente
presenta il conto alla magistratura: tre milioni di euro per una serie di
“errori e travisamenti delle prove”. Va in scena a Genova l’ultimo capitolo del
delitto di Perugia. Meredith Kercher, Mez come era soprannominata dagli amici,
era la studentessa inglese di 22 anni che venne uccisa con una coltellata alla
gola la sera del primo novembre del 2007 mentre era nella casa di Perugia dove
trascorreva l’Erasmus. Tra una serie di ribaltoni giudiziari e una pressione
mediatica pesantissima, solo nel 2015 i due sospettati principali, Raffaele
Sollecito e la statunitense Amanda Knox, sono stati assolti definitivamente
dalla Cassazione. Sollecito aveva avviato una richiesta di risarcimento per
ingiusta detenzione che, però a febbraio gli è stata respinta. Nessuno sapeva
che avesse citato in giudizio, in base alla nuova legge sulla responsabilità
civile dei magistrati, nove tra pubblici, ministeri procuratori generali,
giudici delle indagini preliminari e giudici di corte d’assise e corte d’assise
d’appello chiedendo un risarcimento – si parla di una cifra attorno ai tre
milioni - per aver travisato fatti, circostanze e prove relative all’omicidio di
Meredith Kercher. La legge sulla responsabilità civile prevede cause “per dolo o
colpa grave”. Solo per il secondo caso è prevista la citazione anche dei giudici
popolari. Ma l’ultima parola spetta al giudice Pietro Spera al quale è stata
affidata la causa. Sarà lui, oggi, a decidere se coinvolgere nella citazione
anche i 12 giurati popolari della Corte di Assise di Perugia e di quella di
Assise di Appello di Firenze. La causa è radicata nel capoluogo ligure perché
gli ultimi giudici ad aver condannato Sollecito sono quelli della Corte di
Appello di Firenze, e per processi in cui siano coinvolti magistrati toscani il
tribunale competente è quello di Genova. Formalmente, in aula è stata citata la
Presidenza del Consiglio in rappresentanza dei giudici. A difenderla ci sarà
l’Avvocato dello Stato Giuseppe Novaresi. In caso di condanna lo Stato, dopo
aver pagato il risarcimento, si rivarrà a sua volta nei confronti dei singoli
pm, gip e giudici citati. Sollecito e Knox vennero condannati in primo grado e
assolti in appello a Perugia con una decisione annullata dalla Cassazione che
dispose un appello bis a Firenze dove i due vennero nuovamente dichiarati
colpevoli del delitto di via della Pergola. Prima di essere di nuovo e
definitivamente assolti dai Supremi giudici con delle motivazioni decisamente
pesanti: “colpevoli omissioni” nelle indagini, condotte con “deprecabile
pressapochismo”. Tra i principali bersagli” di Sollecito il pm di Perugia
Giuliano Mignini che aveva condotto le indagini. A febbraio di nuovo la Corte di
Appello di Firenze aveva respinto la richiesta di risarcimento da mezzo milione
di euro per ingiusta detenzione: “I giudici - aveva detto Sollecito - non hanno
tenuto conto della sentenza della Cassazione che mi ha definitivamente assolto
da tutte le accuse. Questa aveva infatti rilevato che ci sono state gravi
omissioni e defaillance degli investigatori e dunque cerano precise
responsabilità’ nella fase delle indagini. Per questo sono sorpreso da una
decisione che ancora una volta proviene da Firenze e che sembra non dare seguito
a una chiara sentenza della Cassazione”.
Raffaele Sollecito a Parma: "Voglio
essere riconosciuto innocente davanti all'Italia".
Intervista di Maria Chiara Perri del 10 aprile 2017 su "La Repubblica",
all'ingegnere 33enne a dieci anni dal delitto di Perugia. Sogna un documentario
che lo riabiliti agli occhi dell'opinione pubblica: "Ancora molti pregiudizi
verso di me, le istituzioni ammettano di aver sbagliato". Nel documentario di
Netflix "Amanda Knox" ogni intervento di Raffaele Sollecito, originario di
Giovinazzo, è preannunciato da vedute di maestosi faraglioni della costa barese.
E’ piuttosto straniante vedere il co-protagonista dell'eclatante caso
giudiziario internazionale a proprio agio davanti a un caffè in piazza Ghiaia a
Parma, mentre cita alcuni dei luoghi più frequentati dai giovani parmigiani -
bar Gianni, parco Ducale, via Farini - come fosse ormai “di casa”. A dieci anni
dal delitto di Meredith Kercher, che lo ha reso suo malgrado noto alle cronache
mondiali, Raffaele Sollecito riparte dalla città emiliana dove si è trasferito
stabilmente da ormai più di un mese. Lo ha portato a Parma una collaborazione
stretta con una società di sistemi informatici, Teknomaint Srl, per la
sponsorizzazione di un software da lui ideato per la prenotazione online di
ombrelloni e altri servizi turistici, suntickets.it. Per ora è ospitato a casa
di amici nei pressi di barriera Bixio, ma non esclude di trovare una
sistemazione fissa per il futuro e, chissà, di prendere la residenza. Oggi
divide la sua attività tra quella di ingegnere informatico e la partecipazione a
convegni e incontri per far conoscere la sua vicenda. La riabilitazione agli
occhi dell’opinione pubblica, mancata dopo l’assoluzione in via definitiva, è un
traguardo che il 33enne cerca con forza.
Raffaele, come è stato accolto a Parma?
“Mi trovo bene qui. Amo il paesaggio del
Lungoparma, lo stile liberty, i bellissimi parchi come il Ducale dove c’è la
sede del Ris. Le persone hanno un’aura un po’ francese e distaccata, abbastanza
diffidente, diciamo che tendono a stare sulle loro ma qualcuno mi ha detto
persino 'benvenuto'. A Perugia l’atteggiamento era diverso, molto più invadente.
Quando è uscita la notizia del mio trasferimento ci sono state un po’ di
polemiche sui social network, ma penso che la Rete tiri fuori il peggio della
gente quando si tratta di criticare. Canalizza un odio latente che oggi è molto
presente nella società italiana e che si scarica su capri espiatori, ad esempio
gli immigrati. Io però a Parma ho trovato collaborazioni, approcci cordiali, la
possibilità di promuovere il mio libro. Ho scoperto persino di avere alcuni
parenti che vivono a Traversetolo”.
Immagino che anche qui, come in tutta Italia,
la riconoscano.
“Agli sguardi sono abituato, cerco di passarci
sopra. A volte quando mi sento gli occhi addosso parlo con le persone, non sono
chiuso se qualcuno ha una curiosità nei miei confronti. Quello che pesa è il
pregiudizio: la gente si immagina di tutto e di più”.
Lei sa che l’opinione dell’uomo della strada
sul caso Kercher è ancora ‘Amanda e Sollecito sono fuori perché hanno i soldi
per i bravi avvocati, Guede è dentro per tutti”.
“L’uomo della strada non sa di che cosa parla. Non
sono i soldi ad aver portato una persona in carcere, è la scena del crimine. Le
tracce di Rudy Guede ci sono, quelle mie e di Amanda no. Vorrei che le persone
riflettessero: se questo fosse successo a loro, che cosa avrebbero fatto? E’
giusto che una persona innocente per difendersi debba avere i soldi? E se uno
non li ha, deve rimanere in carcere? La mia famiglia ha investito molto sulle
consulenze di parte in termini di tempo e denaro, io mi sono fatto quattro anni
di carcere tra isolamento e massima sicurezza, oggi devo ancora affrontare
debiti. L’uomo della strada parla dopo aver visto un’immagine di me e di Amanda
che ci abbracciamo, senza sapere che non ci siamo neanche avvicinati a quella
stanza, che ho dato io l’allarme ai carabinieri. Sono state diffuse molte
informazioni distorte e sono stato dipinto come un personaggio negativo per dare
spazio alle tesi della Procura”.
Prima ha citato la sede del Ris. Questo le
ricorda il processo?
“Molti pensano che le indagini nel 2007 siano
state condotte dal Ris, ma non è così. E’ stata la Polizia scientifica di Roma,
che all’epoca non aveva le certificazioni internazionali per fare le indagini
forensi. Il Ris nel processo di appello bis è giunto alle stesse conclusioni
della nostra consulenza di parte su procedure e protocolli riguardanti le tracce
di Dna sul coltello. Ho raccontato la verità in convegni, interviste, in tv”.
Nonostante l’assoluzione definitiva, non le è
stato riconosciuto un risarcimento per l’ingiusta detenzione.
“E’ come se lo Stato mi avesse preso in antipatia
perché ho attaccato i magistrati che hanno fatto grandi errori. La motivazione
con cui mi negano il risarcimento è, di fatto, che dovevo essere condannato e
che dovrei dire grazie perché sono stato assolto. Questo mi fa molto arrabbiare.
Qual è il loro gioco? Mi sento abbandonato a me stesso. E’ colpa mia se hanno
fatto errori? Io lo dico, pretendo di poterlo dire. Io voglio essere
riconosciuto innocente davanti all’Italia”.
C’è ancora pregiudizio nei suoi confronti. Come
lo vive sulla sua pelle?
“E’ come essere ai domiciliari, immerso in una
società ostile. Gli sconosciuti mi percepiscono come una patata bollente, un
ordigno pronto a esplodere perché sono sotto i riflettori. Se mando un
curriculum o telefono a un’azienda presentandomi come Raffaele Sollecito, è
matematico che non ci sarà una risposta positiva. L’unica soluzione è
presentarmi con la mia faccia e parlare direttamente con le persone, solo così
si apre una strada. L’ho scoperto dopo tante porte in faccia. Sono stato
coraggioso perché non so in quanti, dopo quattro anni di carcere e dieci sui
media, abbiano voglia di affrontare la vita. Quest'esperienza ha fatto sì che a
33 anni per molti aspetti non abbia timori, ma avrei preferito vivere
serenamente piuttosto che passare quello che ho vissuto”.
Lei ha vissuto l’esperienza del carcere quando
era molto giovane.
“In quel periodo ho avuto un grande supporto dalla
mia famiglia e dagli amici. Ho un carattere particolare, sono molto riflessivo e
non rancoroso, l’odio non è nel mio vocabolario. I primi tempi ero certo che si
sarebbero accorti di aver sbagliato e che sarebbero tornati sui propri passi.
Invece, per mantenere l’orgoglio o il prestigio delle proprie carriere hanno
tenuto in piedi un castello di carte. Oggi vedo le cose allo stesso modo in cui
le vedevo allora, mi chiedevo: è possibile che abbiano costruito tutto questo
sul nulla? Sì, lo hanno fatto. Quando l’ho capito ho messo da parte la mia vita
per fare emergere la verità. Questo non deve succedere più. Non hanno ripagato
la mia fiducia nelle istituzioni e hanno sbattuto innocenti in carcere con
indagini penose. Io non voglio gogne, non mi interessa accusare gli inquirenti
con nomi e cognomi, voglio solo che mi sia restituita la mia dignità e che si
dica che le istituzioni hanno sbagliato”.
In che modo potrebbe essere riabilitato agli
occhi dell’opinione pubblica?
“Magari con un documentario in cui rappresentanti
delle istituzioni, della magistratura, del Ris, insomma figure esperte e di
rilevanza sociale, spieghino che cos’è stato questo processo. Io ad oggi, dopo
una sentenza definitiva, non ho ancora capito se lo Stato mi ha assolto o no, ci
sono giudici che mi dicono cose opposte. Voglio risposte chiare, che mettano
fine a uno scempio”.
Col senno di poi, ci sono cose che non farebbe
o che farebbe in modo diverso?
“Quel giorno andrei a Gubbio, dove dovevo andare,
non rimarrei con Amanda. Le direi: mi dispiace ma è un problema tuo e delle tue
amiche. Io avevo 23 anni, conoscevo Amanda da cinque giorni, la settimana
successiva avrei dovuto discutere la tesi. Insomma, sono stato coinvolto in una
storia tristissima ma completamente al di fuori da ogni mio raggio d’azione. E
poi mi prenderei subito un avvocato, come mi venne consigliato in questura. Non
lo feci perché appunto ero molto giovane e preso da tutt’altro, pensavo ‘ma
perché mai dovrebbero toccarmi, non c’entro nulla’”.
Come vorrebbe che la vedessero?
“Come un ingegnere informatico che fa software. Mi
divido tra quest’attività e i convegni, c’è molto interesse nel settore forense
per la mia vicenda. Nel futuro mi piacerebbe proporre alle Procure l’idea di un
software per compilare i verbali in modo sicuro. Il sistema informatico si
aprirebbe prima degli interrogatori, riconoscerebbe voci e ruoli del presenti e
trascriverebbe automaticamente tutta la registrazione, per poi salvarla criptata
sui server del Ministero dell’Interno. Sarebbe una garanzia in più per tutti,
inquirenti e imputati, ed eviterebbe verbali approssimativi che vengono
dichiarati inutilizzabili in sede processuale. Come i miei”.
PRESUNTA COLPEVOLE. AMANDA KNOX.
Amanda Knox: “Io, colpita e molestata
dalla giustizia italiana”, scrive il 13 Agosto 2017
"Il Dubbio". La ragazza assolta per l’omicidio di Meredith Kercher torna a
parlare: “L’aiuto di Trump mi danneggiò”. “Ringrazio Trump per avermi sostenuto,
ma il suo aiuto avrebbe potuto danneggiarmi”. Amanda Knox, la ragazza di
Seattle assolta per l’omicidio di Meredith Kercher dopo una lunghissima
battaglia giudiziaria, torna a parlare della sua vicenda. Lo fa con una lunga
intervista a “Rolling Stones” e punta dritto contro Donald Trump che la difese,
certo, ma la sua non è “sembrata una difesa ma una sorta di bullismo, di
arroganza da parte degli americani nei confronti degli italiani. Come se gli
americani si sentissero in diritto di dire agli italiani cosa fare”. Dunque,
ammette Amanda: “Avrei preferito che Trump avesse agito con maggiore prudenza”.
Ma il giudizio di Amanda nei confronti dei magistrati italiani è durissimo: “Ho
denunciato il fatto di avermi negato il diritto di avere un avvocato, di avermi
colpita durante gli interrogatori”, racconta Amanda, che poi rincara la dose:
“Mi interrogarono per oltre 53 ore in cinque giorni. Il risultato fu che
l’interrogatorio finì nel modo sbagliato che tutti abbiamo visto. Non mi
lasciavano uscire senza che affermassi qualcosa che includesse il nome di
qualcuno. Questa cosa insana di estorcere false confessioni è molto comune. Non
c’è alcun bisogno di colpire le persone o di molestarle verbalmente e
psicologicamente. C’è un motivo se tutto ciò è definito illegale. Ero una
ragazza di 20 anni senza precedenti con la giustizia e con un livello di
italiano pari a quello di un bambino di 10 anni”. Poi le accuse a Guede, l’unico
riconosciuto colpevole dai giudici: “Non voglio incontrare mai più quella
persona, quello che ha fatto è stato terribile, ma so che chiamandolo cattivo
non capirò mai perché lo ha fatto. Ho compreso il pubblico ministero, Giuliano
Mignini: per quanto le sue idee fossero folli, almeno ho capito da dove
venissero fuori. Ho capito che aveva motivi nobili e che in fondo ha a cuore le
persone. Ho capito perché e come de-umanizza le persone e come lo ha fatto con
me. Ma non ho ancora capito Guede. Non ce l’ho con lui, ma mi spaventa.”
PRESUNTO COLPEVOLE. LUCIANO CONTE.
Luciano Conte, 54 giorni in carcere per
un latitante in casa ma a sua insaputa. C’era una
volta la casa a sua insaputa, e persino la tangente a sua insaputa. Ma il
latitante a sua insaputa è un brivido che, in casa propria, ha sperimentato solo
un barista: che ne avrebbe volentieri fatto a meno, visto che l’equivoco da
incubo gli è costato 54 giorni per sbaglio a San Vittore e altri 86 giorni per
errore agli arresti domiciliari. Custodia cautelare prima di essere scagionato
dall’accusa di aver nascosto a casa il latitante Gioacchino Matranga, fuggito il
26 ottobre 2009 dalla prospettiva di 30 anni per traffico di droga. La serrata
caccia datagli dal pm Paolo Storari aveva riacciuffato Matranga il 31 dicembre e
individuato anche la casa in cui era stato a Natale: casa del barista Luciano
Conte, dunque arrestato dal gip Giulia Turri insieme al cognato di cui il
latitante parlava intercettato con la moglie. Inutilmente il barista si sgolò
dalla cella: mai conosciuto Matranga, non sapevo stesse nel mio appartamento e
non me ne sono accorto, è mio ma ci vado poco perché vivo a casa della mia
compagna, ed ecco le foto che provano che dal 24 al 28 dicembre non ero a Milano
ma in vacanza con lei in Svizzera. Tutto inutile. Fin quando in Tribunale la
verità riflessa si impone alla giudice Marina Zelante che assolve Conte per non
aver commesso il fatto: è stato il cognato, a sua insaputa, a dare per 4.000
euro a un basista del latitante le chiavi di casa prese alla moglie (sorella del
barista) che ogni tanto andava a farvi le pulizie. E ora, «per la “beffa” di
essere assolto sulla base degli stessi elementi indicati sin dall’inizio», con
l’avvocato Francesca Galli il barista chiede allo Stato 70.000 euro di
risarcimento per ingiusta detenzione. (Fonte: Luigi Ferrrarella, Corriere della
sera, 3 aprile 2013)
PRESUNTO COLPEVOLE. MARIO CONTE.
Addio a Mario Conte, magistrato vittima
della malagiustizia. Gli errori
giudiziari sono
qualcosa che può capitare a tutti. Finire in carcere da innocenti, vivere un
periodo più o meno lungo di ingiusta
detenzione, è molto meno raro di quello che si
possa pensare. Un fenomeno che in Italia è decisamente sottovalutato perché –
numeri alla mano – costituisce in realtà una vera emergenza sociale: come altro
definireste i circa mille casi di riparazione per ingiusta detenzione che ogni
anno in media si verificano nel nostro Paese, da più di vent’anni a questa
parte? La storia del magistrato Mario
Conte, una precocissima esperienza a Palermo in
prima linea nell’antimafia seguita da una carriera come pm a Bergamo, sotto
questo aspetto è illuminante. Finì trascinato in un’accusa infamante, per un
giudice dalla condotta cristallina come lui, per opera di un pentito. Travolto
da capi di imputazione pesantissimi. Sottoposto a un’odissea giudiziaria a cui,
nel tempo, si aggiunse un macigno ancora più colossale: una malattia terribile
come il mieloma multiplo. Difficile dire se provocata, magari indirettamente,
dal calvario personale cui già era stato sottoposto dal momento
dell’incriminazione infondata. Ma destinata comunque a cambiargli la vita per
sempre. Mario Conte ha impiegato 18 anni per dimostrare la sua totale estraneità
a ogni accusa. Ha vinto contro la malagiustizia,
ma ha dovuto cedere a qualcosa contro cui, purtroppo, non poteva che soccombere.
Di lui ci resta un libro testamento dal titolo chiaro ed efficace come pochi
altri. Perfetto per ricordare a tutti che finire nelle maglie dell’errore
giudiziario può
accadere a chiunque: a prescindere dalla condizione sociale, dalla provenienza,
dalla collocazione geografica. E quando la giustizia sbaglia, sono dolori veri.
Raccontare la sua storia in giro per l’Italia sarebbe stato, per quanto
possibile, un piccolissimo risarcimento alle vicende nelle quali è stato suo
malgrado coinvolto. Ma Mario Conte non ce l’ha fatta: è spirato pochi giorni
prima che il suo libro «E se fossi tu l’imputato? Storia di un magistrato in
attesa di giustizia» (Guerini e Associati Editore) potesse essere presentato nel
paese che aveva dato le origini alla sua famiglia, Villanova del Battista, al
quale era molto legato. Quello che ha riguardato Conte può essere catalogato
come mero errore giudiziario, uno di quelli che in Italia, purtroppo, non sono
così rari? Napoletano di nascita, ma irpino di Villanova per origini familiari,
Conte era entrato in magistratura a soli 27 anni: da allora, a Bergamo per anni
da pubblico ministero presso la Procura della Repubblica. «E se fossi tu
l’imputato?» è il suo libro-testamento che invita a fuggire, a rigettare il
concetto di giustizia come mero e vuoto esercizio del potere. Un titolo che è
una domanda secca a chi legge, per far intendere che l’errore può colpire
chiunque: anche magistrati come lui. Perché gli ultimi 18 anni della vita di
Conte sono un vero e proprio calvario. Prima, nel 1997, viene accusato da un
pentito di essere a capo di una serie di presunte operazioni illecitamente
gestite dai militari del Ros di Bergamo e di Roma, che avrebbero costituito una
struttura deviata per strumentalizzare le norme sulla consegna controllata di
stupefacenti, al fine di conseguire brillanti operazioni. Nel 2003, Conte riceve
il primo avviso di garanzia. Le accuse, gravissime, gli piombano addosso come un
macigno: associazione a delinquere, traffico di stupefacenti, falso, peculato.
«Io sono un pm, non un narcos», reagisce d’istinto. Normale, per chi aveva
trascorso quattro anni, dal 1992 al 1996, da applicato presso la Direzione
Distrettuale Antimafia di Palermo. Là dove la mafia la si combatte giorno dopo
giorno, minuto dopo minuto. Al dramma giudiziario si aggiunge quello
strettamente personale, che alcuni neurochirurghi ritengono legato al primo a
filo doppio: nel 2006 gli viene diagnosticato un mieloma multiplo. Conte non si
arrende e alla battaglia per la sua innocenza affianca quella per la guarigione.
Battaglie che terminano nello stesso periodo, seppur con esiti drammaticamente
opposti: dopo aver rinunciato alla prescrizione, nel luglio 2014 viene assolto
con formula piena dalla Corte d’Appello di Milano. Il 2 ottobre scorso, invece,
deve arrendersi al male che in 9 anni lo ha divorato. Dopo i funerali, tenuti a
Bergamo, oggi, con una celebrazione alle 17 presso la Chiesa di Santa Maria
Assunta, lo ricorderà anche Villanova del Battista. Oltre all’insegnamento di
una vita integerrima, Mario Conte lascia un libro che è anche un testamento, una
visione del tanto discusso e discutibile sistema giuridico italiano maturata
attraverso la propria professione e la vicenda che lo ha coinvolto. Un sistema
che egli conosce benissimo ma del quale rimane vittima. Eppure, basterebbero
«piccoli accorgimenti: bisogna recuperare – scrive Conte – le distinzioni dei
ruoli e la cultura della prova, oggi spesso soppiantata da una visione della
giustizia non già come servizio nei confronti del cittadino, ma come esercizio
di un potere che funge da ammortizzatore sociale, scadendo così in un’attività
di supplenza di altri poteri dello Stato incapaci di esprimere il proprio
ruolo». (fonte: Domenico Bonaventura, Il
Mattino, 10 ottobre 2015)
Storia di
Mario Conte, magistrato rovinato dalla “giustizia”.
Un processo all’ingiusto processo,
scrive il 28
Maggio
Francesco Amicone su
“Tempi”. Messo
alla sbarra per vent’anni secondo le accuse (inattendibili) di un criminale
senza scrupoli, uscito assolto ma distrutto da due gradi di giudizio, l’ex pm ha
deciso di scrivere un libro per legittima difesa.
A partire da oggi, giovedì 28 maggio, sarà nelle librerie “E se fossi tu
l’imputato?” (Guerini e Associati, 143 pagine, 15,50 euro), il libro in cui l’ex
pm di Bergamo Mario Conte “processa” l’ingiusto processo subìto per vent’anni
dopo essere stato coinvolto nella rumorosa indagine sul generale del Ros
Giampaolo Ganzer. Pubblichiamo l’articolo tratto dal numero di Tempi in edicola
che racconta la sua storia. L’Italia non sarebbe abbonata alle
sentenze europee per violazione dei diritti umani e la giustizia avrebbe risolto
gran parte dei suoi problemi, se fosse svelta come lo era Biagio Rotondo a
uscire di prigione. Rotondo era un criminale soprannominato “il Rosso”. Entrava
in prigione con accuse che avrebbero sistemato chiunque per anni e riusciva
ottenere gli arresti domiciliari dopo qualche mese. Spaccio, rapine, furti. La
sua fedina penale era costellata di crimini, anche violenti, ma riusciva a
cavarsela con le parole. Mandava a chiamare il pm di turno e in cambio di
informazioni per lui si aprivano le porte del carcere. Per i suoi accusati,
invece, ad aprirsi era una lunga stagione di guai. Dalle parole di Rotondo nasce
l’inchiesta che dal 1997 ha coinvolto alcuni carabinieri della sezione
anticrimine di Bergamo, i vertici dei carabinieri e un magistrato, per
associazione a delinquere e traffico di stupefacenti. Rotondo non c’è più, si è
impiccato in carcere nel 2007, ma il processo per alcuni imputati, in
particolare l’ex comandante del Ros Giampaolo Ganzer, è ancora in corso. La
durata quasi ventennale del processo è solo un particolare dell’esperienza da
imputato vissuta da Mario Conte. Per trent’anni pm a Bergamo e oggi scrittore
per legittima difesa, dal 1997 al 2014 Conte ha calcato aule di tribunali e
studi di avvocati replicando alle accuse di Rotondo, della procura di Brescia e
di Milano, dalle quali è stato completamente scagionato lo scorso anno.
Dichiarato due volte innocente, ha preso la penna e ripercorso la sua vicenda
giudiziaria raccontando nel dettaglio gli errori, le discrasie del sistema e
alcune sviste dei pm che hanno condotto l’inchiesta.
E se fossi tu l’imputato? è
il titolo del libro di Conte, editato da Guerini. La vicenda ha inizio nel 1997.
A giugno di quell’anno, Rotondo viene arrestato per tentato omicidio, rapina,
illecita detenzione e porto di armi dalla questura di Brescia. Le porte del
carcere si sarebbero chiuse per almeno un decennio se non avesse aperto bocca.
Non bastava il mea culpa, c’era bisogno di una storia. Il Rosso l’aveva e la
offrì alla procura di Brescia. Il pm Fabio Salamone decise di ascoltarla.
Rotondo parlò della sua collaborazione con i carabinieri di Bergamo, due anni
come informatore fra il 1992 e il 1994, soffermandosi su alcune irregolarità
compiute dai militari e spiegando, dichiarazione dopo dichiarazione, in cosa
consistesse il suo lavoro. Il compito affidatogli da “il Biondo”, “il Ciccio” e
altri militari del Ros infiltrati nelle organizzazioni del narcotraffico,
sarebbe stato quello di trovare criminali e istigarli ad acquistare la droga da
loro importata tramite alcune fonti. In Italia, la legge sulle attività sotto
copertura vieta la provocazione, ma stando a Rotondo, era proprio quello che
facevano lui e gli altri militari coinvolti: avrebbero imbastito un traffico di
stupefacenti internazionale con la protezione di un magistrato di Bergamo, Mario
Conte, che firmava gli atti di indagine per ottenere successo, pubblicità e fare
carriera. Il “sistema” sarà poi definito
dai magistrati e dai giornalisti “metodo Ganzer”,
generale dei carabinieri allora in ascesa e oggi in pensione, con una sentenza
della Cassazione ancora pendente. Salamone, colpito dalle confessioni di
Rotondo, fece parlare il pregiudicato per altri due anni. L’inchiesta, per
quanto delicata, approdò davanti a un giudice soltanto nel 2003, a Milano. Nel
frattempo Rotondo non smise di delinquere e fu nuovamente arrestato nel 2007,
dopo aver violato più volte il programma di protezione testimoni che aveva
conquistato con le sue dichiarazioni sul Ros. Sulla base delle parole di Rotondo
è stato costruito un processo in cui Conte viene accusato di essere a capo del
“sistema” con cui gli agenti del Ros, sotto la sua regia, avrebbero violato la
legge sulle “consegne controllate” di droga, usando come burattini il Rosso e
narcotrafficanti del calibro di Otoya Tobon, soprannominato “El drago” (un
colombiano ai vertici del cartello di Calì e in seguito collaboratore della Dea
americana). Il problema, afferma l’ex pm di Bergamo, non è avere cercato
riscontro alle parole del pentito, ma il metodo seguito per verificarle. Le
dichiarazioni di Rotondo difficilmente potevano essere ritenute attendibili, nel
suo caso. Esaminato dalla difesa o dalla accusa, Rotondo più volte aveva
cambiato versione dei fatti. Ai giudici che hanno assolto Conte è parso evidente
dalle stesse dichiarazioni del pentito, il quale nel 1997 affermava «io non so
se il dottor Conte sapesse come le operazioni venivano gestite», per poi
cambiare parere dopo quattro anni di collaborazione: «Il dottor Conte certamente
sapeva che lo stupefacente era nelle mani del Ros e che io cercavo acquirenti».
Ma non si fermano qui le perplessità sulle dichiarazioni di Rotondo, perché il
consulente di Conte, analizzando i nastri delle registrazioni del 1997 e del
1998, vi riscontrò molte anomalie. Ad esempio numerose interruzioni – in alcuni
casi ogni sei minuti, in un caso addirittura ogni cinquanta secondi – e a volte
sovra-incisioni che avrebbero dovuto rendere quelle registrazioni
inutilizzabili. Il metodo operativo che avrebbe seguito Conte, usare le fonti
dei carabinieri come Rotondo o “El drago” per imbastire traffici di droga
direttamente dagli uffici della procura, sarebbe poi stato confermato da un
appunto (senza data e non protocollato) di un maresciallo dei carabinieri. Si
tratta di un resoconto di una riunione del 1991 fra il pm Conte e sottufficiali
del Ros e del Road. In quell’occasione, stando all’appunto inoltrato da
un maresciallo (del Road) ai superiori di stanza a Roma, Conte avrebbe
teorizzato come infrangere la legge per incastrare alcuni narcotrafficanti.
Nella riunione si era parlato di un’operazione sotto copertura nel quadro
dell’allora nuova legge sugli agenti “undercovered”. L’appunto del carabiniere
(deceduto prima di testimoniare), stando all’accusa confermava le parole di
Rotondo. Secondo i giudici, però, non poteva considerarsi fedele a quanto detto
da Conte. Ciò è avvalorato dal fatto che nessun altro ufficiale di polizia
giudiziaria aveva pensato di informare i superiori di quel “metodo” di condurre
le operazioni anti-droga. Ma ciò che ha stupito Conte è il fatto che sia stato
proprio lui a dovere chiamare a testimoniare i presenti alla riunione per
dimostrare che quell’appunto non poteva corrispondere a un suo discorso. Anche
in questo caso, secondo il magistrato di Bergamo, si è disatteso un principio
cardine del sistema processuale italiano. Il pm, infatti, non è un avvocato
dell’accusa che si limita a cercare conferme alla sua teoria. Deve applicare la
legge senza ignorare gli indizi a favore dell’imputato. Un modo di procedere
diverso porta alla «inversione dell’onere della prova», dove è un presunto
colpevole a dovere dimostrare la falsità o la verità di una teoria, quando
questo compito spetterebbe ai pm. Nel processo Conte ci sono stati 43 depositi
di atti relativi a indagini integrative in un arco temporale che va dal 2005 al
2012, con una media di un deposito di migliaia di pagine ogni due mesi. Il
fascicolo del solo dibattimento è composto da circa 95 mila file. Migliaia di
pagine, decine di faldoni da studiare, e tempi che si allungano portano inoltre
a errori e confusioni negli stessi addetti ai lavori. È quasi inevitabile.
Quando il procuratore generale fece appello contro la sentenza di primo grado
che aveva assolto Conte, avrebbe dovuto aver studiato tutti gli atti nei
quarantacinque giorni a disposizione per legge. Il che avrebbe implicato una
velocità di lettura media di circa 2 mila pagine al giorno e un impegno
giornaliero di circa 17 ore lavorative. 24 ore su 24, se si conta anche la
redazione dei motivi di appello, una volta letti gli atti. Umanamente
impossibile. Nella doppia veste di ex imputato e magistrato (favorevole alla
responsabilità civile), Conte si chiede come può funzionare una giustizia che
non risponde dei propri errori. Gli abbagli che sono spesso favoriti da una
proliferazione di atti, mettono in difficoltà sia l’accusa sia la difesa. Conte,
a riguardo, cita un esempio lampante. Nei suoi capi d’accusa era stata inserita
un’operazione della procura di Bologna, condotta da un altro magistrato.
L’errore all’apparenza banale fu fatto presente al pm che gestiva l’inchiesta
nella seconda fase (udienza preliminare) e sembrò essere accolto. Ma fu
dimenticato nella richiesta di rinvio a giudizio. Questo sbaglio, spiega l’ex pm
Conte, ha comportato una evitabile perdita di tempo. Si è dovuto chiamare il
magistrato di Bologna e farlo venire a testimoniare a Milano per provare che
quell’operazione non aveva nulla a che fare con l’imputato. Nelle requisitorie
dei pm si assiste, racconta Conte, a una replica delle inesattezze presenti
negli atti. Dalle date alle interpretazioni, ovunque può nascondersi una svista.
Emergono anche aspetti non chiari sul modo di seguire le regole da parte della
stessa autorità giudiziaria. Riguardo all’uso delle intercettazioni, ad esempio.
Conte spiega come nel suo processo dovessero essere acquisite alcune
conversazioni registrate dalla procura di Roma ma che ciò fu impossibile. Il pm,
nel dibattimento, informò le parti dell’impossibilità di acquisirle per «motivi
tecnici». Si trattava, disse l’accusa, di «conversazioni registrate dalla
Guardia di Finanza su delle cassette purtroppo oggi irrecuperabili». Conte volle
controllare e scoprì un’altra verità. I finanzieri avevano scritto al pm
milanese: «È d’obbligo precisare che l’operazione di registrazione venne
effettuata per soli scopi operativi. Non essendoci alcuna autorizzazione formale
dell’autorità giudiziaria». «Come già specificato, la registrazione non era
stata oggetto di alcuna autorizzazione del pm (di Roma, ndr), il quale,
verbalmente, al momento del coordinamento con gli operanti circa le attività da
esperire, aveva con gli stessi convenuto di effettuare tale registrazione».
Stando alle parole dei finanzieri, quindi, era stata eseguita un’intercettazione
abusiva. Ecco perché non potevano essere acquisite. Si conclude con una seconda
assoluzione in appello, senza strette di mano o risarcimenti, la vicenda di
Conte. La carriera dell’ex pm, oggi giudice civile, è ancora bloccata dal
Consiglio superiore della magistratura, che a un anno dall’assoluzione chiede a
Conte di rispondere della richiesta di rinvio a giudizio di dieci anni fa,
incurante dell’innocenza stabilita dai tribunali. E
se fossi tu l’imputato? è
un “processo” a un processo. Un libro che dimostra nel dettaglio come la
malagiustizia può nascere quando chi dovrebbe applicare le leggi si dimentica
dei princìpi che stanno alla base del giusto processo, dalla presunzione
d’innocenza all’onere della prova.
E se fossi tu
l’imputato? Il caso del magistrato Mario Conte,
scrive l'11
Giugno 2015 Luigi
Amicone su "Tempi". La
lettera del direttore di Tempi al Foglio a proposito del libro del «pm indagato,
triturato e assolto dopo vent’anni».
Sul Foglio
di oggi appare
una lettera del direttore di Tempi Luigi
Amicone e relativa risposta di Claudio Cerasa. Le riproponiamo di seguito.
Al direttore – C’è un volumetto appena uscito in libreria per i tipi della
Guerini&Associati (E
se fossi tu l’imputato?) che ben si potrebbe definire una
esemplificazione della testimonianza di Piero
Tony, con
esposizione fin troppo minuziosa, tecnica e dettagliata di come si costruisce un
“mostro” attraverso un lavorìo perfettamente rispettoso di tutte le regole del
circo mediatico-giudiziario ma anche totalmente avulso dai dati, prove,
riscontri fattuali. Il caso del magistrato (anch’egli appartenente a Md) Mario
Conte è
interessante. Dimostra che quando l’accusa si trasforma in epopea narrata dalla
grancassa mediatico-scandalistica, solo un pm può avere gli strumenti per
difendersi da altri pm. Oggi, dopo vent’anni di processi e il manifestarsi di un
cancro come quello che uccise Tortora, Mario Conte è un magistrato a cui è stato
restituito l’onore umano e professionale, completamente prosciolto dall’accusa
di essere stato il regista di una organizzazione criminale strutturata in
cellula deviata dei Ros che avrebbe trafficato e spacciato per “brillanti
operazioni di polizia” il puro e semplice traffico e spaccio di stupefacenti in
tutta Italia. Ma in tutta Italia però – ci conferma l’esperienza di questo
magistrato democratico – un pm che rispetti le leggi dello scandalismo mediatico
può violare le leggi, farla franca e uccidere per via giudiziaria anche un
collega, se necessario. Come? Cito ad esempio un episodio riferito nel libro.
«Dagli atti risulta che il Goa (Gruppo operativo antidroga della Guardia di
Finanza ndr) aveva inviato il 19 maggio 2004 al pm di Milano, in risposta alla
sua richiesta di acquisizione dei nastri delle registrazioni, una nota18 nella
quale c’era scritto qualcosa di ben diverso da quanto dichiarato dalla pubblica
accusa: “È d’obbligo precisare – si legge – che l’operazione di registrazione
venne effettuata per soli scopi operativi. Non essendoci alcuna autorizzazione
formale dell’A.G. … Come già specificato, la registrazione non era stata oggetto
di alcuna autorizzazione del pm [di Roma], il quale, verbalmente, al momento del
coordinamento con gli operanti circa le attività da esperire, aveva con gli
stessi convenuto di effettuare tale registrazione”. Non vi era alcun
provvedimento di autorizzazione per quelle intercettazioni. Era stata eseguita
un’intercettazione abusiva! Fa, poi, quasi sorridere, se come al solito non si
giocasse con il destino delle persone, il fatto che la Guardia di Finanza parli
di intercettazioni “per soli scopi operativi”, categoria che sicuramente mi
manca non trovando un riscontro normativo. Il pm di Milano, in conclusione,
apprende di un’intercettazione abusiva, ma non prende nessuna iniziativa a
riguardo».
Il problema
definitivo è che nessun cittadino italiano può mettersi al posto di Conte. Pm
indagato, triturato e assolto dopo vent’anni. Perché nessun cittadino italiano
può permettersi collegi di difesa come quelli di Andreotti o di Berlusconi.
Oppure, in alternativa, difendersi come si è difeso il pm Conte, sapendo
letteralmente dove “mettere le mani” (munito per altro di un programmino
informatico capace di vivisezionare e individuare gli elementi cruciali nella
montagna di atti processuali, nel caso: 100 mila file). Perciò, per rispondere
all’interrogativo del libro, se fossi stato tu l’imputato Mario, ma Laqualunque
e non un Conte pm, avresti potuto semplicemente rassegnarti. Cominciare a
scrivere le tue memorie dal carcere e imparare a morire di cancro.
Luigi Amicone.
Grazie della lettera. Sul tema garantismo e sulla lotta dura e pura e senza
paura alla repubblica delle manette le confesso però che la partita più
appassionante in questi giorni si gioca fuori da Roma. Si gioca a Venezia,
secondo me. Dove vincerà l’ex magistrato Felice Casson, tanti auguri sinceri, ma
se per una qualsiasi ragione dovesse vincere il suo rivale,
Luigi Brugnaro,
siamo pronti a farci un bel selfie con una buona bottiglia di champagne. Cin
cin.
PRESUNTO COLPEVOLE. BENIAMINO ZAPPIA.
Beniamino Zappia. Tre anni di ingiusta
detenzione per mafia. Ma era solo un’omonimia. Per
essere un esponente di spicco della mafia può attendersi, gli era anche andata
bene: 3 anni di carcere più 11 mesi agli arresti domiciliari. Il fatto è, però,
che Beniamino Zappia non era affatto quello che gli inquirenti pensavano che
fosse: non era un boss della mafia italo-canadese. I giudici se ne sono accorti
in ritardo, assolvendolo con formula piena. E il suo legale, l’avvocato Luis
Eduardo Vaghi, ha subito pensato di presentare un’istanza di riparazione
per ingiusta detenzione. Ma procediamo per gradi. Come e quando comincia questa
storia? Tutto inizia il 22 ottobre 2007, con il blitz della Dia di Roma
ribattezzato “Orso Bruno”. Beniamino Gioiello Zappia – questo il nome del
protagonista della vicenda – viene arrestato con un’accusa pesantissima:
associazione a delinquere di stampo mafioso. I magistrati della Capitale lo
indicano come l’uomo di collegamento, a Milano, tra le cosche agrigentine e
quelle italo-canadesi legate al clan dei fratelli Rizzuto di Montreal. Nel capo
di imputazione, lo descrivono come “personaggio storicamente legato
all’associazione mafiosa Rizzuto”, di cui “è da sempre suo referente in Italia e
in particolare a Milano ed in Svizzera”. Un uomo, insomma, “dedito alle più
disparate attività delinquenziali” di cui, sempre stando all’ipotesi
accusatoria, i Rizzuto si sarebbero serviti per infiltrarsi negli appalti
milionari per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Insieme a lui,
che ha ammesso davanti ai magistrati di conoscere alcuni membri della famiglia
Rizzuto solo “per nome”, finiscono dietro le sbarre altri 18 presunti esponenti
del clan italo-canadese dei Rizzuto. Diciamolo subito: Beniamino Zappia non è
uno stinco di santo, la sua fedina penale non è immacolata. Ma di qui ad
accusarlo di essere un boss ce ne corre. Il giorno del suo arresto viene portato
nel carcere milanese di San Vittore. Poi viene trasferito a Roma e quindi
spostato ancora, prima a Benevento e poi a Secondigliano. Poco più di un anno
dopo essere stato arrestato, Zappia vive il suo periodo più difficile. Da fine
novembre 2008, a 70 anni compiuti (Zappia è del 1938) scatta per lui la
sorveglianza speciale: è il cosiddetto regime di “carcere duro”, previsto dal 41
bis per i mafiosi. Un incubo che finisce il 25 maggio 2010, con la concessione
degli arresti domiciliari. La fine del calvario giudiziario arriva il 23
novembre 2012, a 5 anni, un mese e un giorno dall’operazione che lo aveva
portato in carcere. La sentenza di assoluzione è di totale proscioglimento:
“perché il fatto non sussiste”. Una volta tornato libero il suo assistito,
l’avvocato Vaghi decide di andare a fondo: è convinto che gli inquirenti romani
abbiano fatto un errore macroscopico: uno scambio di persona dovuto a
un’omonimia. Ha studiato con la massima cura tutte le carte processuali. Nel
capo di imputazione dell’operazione “Orso Bruno”, si legge che “Robert Papalia
(presunto boss delle cosche di Montereal) ha coadiuvato Giuseppe Zappia
nell’attività finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione del
ponte sullo stretto di Messina”. Si parla di Giuseppe, non Beniamino, Zappia. Ma
le anomalie non finiscono qui. Un’altra anomalia emerge dalle motivazioni della
sentenza dove è citata la testimonianza del vicequestore Alessandro Mosca,
ufficiale della Dia di Roma che ha coordinato l’inchiesta Orso Bruno. Nel corso
del dibattimento, il funzionario ha dichiarato che “l’indagine è nata nel 2003
presso la procura della Repubblica di Roma a seguito di una segnalazione
pervenuta alla Dia della Polizia Canadese, nella quale si segnalava la presenza
in Roma di un personaggio, Giuseppe Zappia, soprannominato in Canada il
‘Commendatore’, che veniva indicato come fortemente legato ad un’organizzazione
criminale che operava a Montreal, denominata famiglia Rizzuto”. Sempre in
quel’occasione, si legge nel provvedimento, “il vice questore Mosca ha chiarito
che Giuseppe Zappia è persona diversa dall’imputato medesimo, né suo parente”.
La stessa tesi viene sostenuta nel corso del processo da Lorie Mcdougall, un
ufficiale della polizia canadese. È lo stesso investigatore che ha seguito le
indagini sulla famiglia di Vito Rizzuto dal settembre 2002 e che ha affermato di
essere consapevole che l’imputato era persona diversa da tale Giuseppe Zappia,
soggetto questo coinvolto nei traffici e nei rapporti con il Rizzuto in
particolare nella procedura per l’appalto per la costruzione del ponte sullo
Stretto di Messina. Per l’avvocato Vaghi non ci sono dubbi: Beniamino Zappia è
stato vittima di “un caso di mera omonimia”. Quel che è peggio, secondo il
legale, è che la difesa ha tentato in ogni modo di portare alla luce l’equivoco,
ma tutti gli elementi raccolti “sono stati sistematicamente ignorati, sia in
sede di indagine che in sede di udienza preliminare”. Lo dimostra proprio
l’esame dell’ufficiale Mcdougall, citato come testimone dalla Procura, che
durante la fase dibattimentale “rammostrava al giudicante l’errore in cui era
corsa la pubblica accusa. E a questa stessa conclusione si poteva arrivare con
maggiore tempestività”. (fonte: Askanews, 7 marzo 2015).
PRESUNTO COLPEVOLE. MARCO SAVINI.
Marco Savini, otto anni per dimostrare di
essere innocente. “Assolto perché il fatto non
sussiste”: una formula di cui l’avvocato Marco Savini conosce perfettamente il
valore e non soltanto per via della sua professione. È grazie a questa frase,
pronunciata per tutti i capi di imputazione, infatti, che l’ex vicesindaco di
Montesilvano (in provincia di Pescara) è uscito a testa alta dall’inchiesta
Ciclone, che a luglio 2007 cambiò per sempre la sua vita costringendolo, all’età
di 32 anni, a 98 giorni di arresti domiciliari. Un’avventura giudiziaria lunga
otto anni che Savini ora ha deciso di portare fino in fondo attraverso una
richiesta di un risarcimento danni in grado, se non di cancellare la sofferenza
di essere stato accusato ingiustamente di una lunga serie di reati che vanno
dall’associazione a delinquere, al falso, dalla truffa alla corruzione, almeno
di poter dimostrare che la giustizia ha compiuto correttamente tutto il suo
percorso. “Ho sempre avuto fiducia nel sistema giudiziario”, rivela Savini, “e
pur ritenendomi una persona assolutamente estranea a tutti i capi di
imputazione, in maniera rispettosa e silente, mi sono fatto i miei processi e mi
sono difeso. Ma proprio perché credo molto nel sistema, adesso il sistema
prevede che chi come me ha subito ingiuste detenzioni o, come nel mio caso, un
danno alla propria immagine, possa ottenere un risarcimento. Non voglio gridare
al complotto e non lo faccio in un’ottica di rivincita, ma è solo un modo per
compensare le opportunità personali perse e che credo siano state perdute anche
dalla città. E non perché Marco Savini era il più bravo di tutti”, chiarisce
l’ex vicesindaco, “ma perché erano stati attivati dei processi amministrativi
che poi sono stati tranciati e messi nel tritacarne”. A detta di Savini,
l’inchiesta Ciclone ha creato dei grandi danni soprattutto alla città. “In
questi anni, non si è lavorato per l’affermazione di un nuovo progetto”,
prosegue, “ma soltanto per differenziarsi da un passato con il quale non si è
mai fatto il conto. L’inchiesta ha rappresentato un alibi per molti,
un’opportunità per altri, ma il dato oggettivo è che Montesilvano in 8 anni ha
perso tante occasioni e soprattutto la reputazione. Mi auguro che la politica
montesilvanese di centrosinistra recuperi il tempo perso”. Per Savini è
importante, però, non commettere gli stessi errori del passato. “L’errore finora
è stato consentire agli interessi privati di entrare nelle istituzioni”,
prosegue, «sia ben chiaro in maniera legittima attraverso le elezioni. Ma
dobbiamo fare in modo che i partiti fungano da filtro. I cittadini devono poter
scegliere tra persone lontane da interessi economici”. L’ex vicesindaco, già
assessore nella giunta Gallerati, torna a quel 2007 e alla domanda se «rifarebbe
quanto fatto finora» non ha dubbi: «È facile con il senno di poi dire non
rifarei il vicesindaco, ma forse non è neanche vero questo. Dopotutto, senza
questa esperienza non sarei quello che sono oggi ed è stata utile anche per la
mia professione di avvocato, perché ha confermato la mia fiducia nei confronti
della giustizia. Certo ho commesso degli errori, ma non mi sono mai nacchiato di
reati, e questo è un dato oggettivo”. Sull’importo della richiesta di
risarcimento danni, attualmente al vaglio dei suoi colleghi avvocati, spiega:
“La richiesta non è stata ancora quantificata, aspettiamo prima le motivazioni
della sentenza”. (fonte: Antonella Luccitti, il Centro, 2 gennaio 2015)
PRESUNTO COLPEVOLE. OSCAR MILANETTO.
Oscar Milanetto, niente scommesse: la sua
fu ingiusta detenzione. Coinvolto in una brutta storia
legata al calcioscommesse,
ne è uscito fuori completamente scagionato. Ma sull’ingiusta
detenzione subita,
ben 17 giorni in carcere da innocente con la pesante accusa di associazione per
delinquere finalizzata alla frode sportiva, Omar
Milanetto (ex
calciatore e oggi dirigente del Genoa) non vuole passarci sopra come se nulla
fosse accaduto. E, acclarata con sentenza definitiva la sua innocenza, ha dato
mandato ai suoi avvocati di richiedere ciò che la legge prevede espressamente
nei casi come il suo: una riparazione per l’ingiusta detenzione subita, quei
giorni in custodia cautelare che gli hanno distrutto la reputazione e portato
via la serenità. Ci sono voluti quattro anni e mezzo per escludere ogni
coinvolgimento di Milanetto in una presunta – ma mai accaduta – combine della
partita Genoa-Lazio del 2011. E oggi l’ex centrocampista vuole andare fino in
fondo. Dopo aver rifiutato assieme al suo Genoa patteggiamenti
in ambito sportivo e subito quattro anni e mezzo di persecuzione giudiziaria
culminata con 17 giorni di ingiusta detenzione, Omar Milanetto e
con lui (moralmente) tanti genoani che l’hanno sempre difeso, è passato al
contrattacco. Il dirigente RossoBlu ha atteso la fine della vicenda innanzi alla
Caf(di cui abbiamo dato conto) con la definitiva conclusione dell’affaire
Lazio-Genoa, per chiedere un cospicuo risarcimento danni allo Stato. In più
circostanze ci siamo occupati di vicende carcerarie, di innocenti in galera e di
‘piccoli’ Enzo Tortora o nomi noti prima adorati e poi gettati nella polvere con
tanto di tv, siti e giornali non bramanti di meglio, che ogni tanto fanno
capolino nelle cronache giudiziarie. Quella di Milanetto,
infatti, è ormai questione di civiltà e non più sportiva. Ma ricordiamo
brevemente i fatti: il 28 maggio 2012 Milanetto, all’epoca centrocampista del
Padova, fu tirato giù dal letto in piena notte, trascinato in carcere davanti ai
figli attoniti e caricato di accuse pesanti come l’associazione per delinquere
finalizzata alla frode sportiva. Tutto ciò per le dichiarazioni false di
improbabili collaboratori come Ilievsky o per le intercettazioni mal trascritte
o interpretate in modo errato. Su tutte, quella in cui il calciatore spiegava di
volersi recare ad Albaro per degli acquisti, trascritta come se Milanetto avesse
detto di voler andare ‘dal baro’ per truccare qualche partita. 17 giorni di
ingiusta carcerazione preventiva per accuse sgretolatesi fino all’assoluzione
finale, che porrebbero sul banco degli imputati in un paese progredito a livello
giuridico il Pm cremonese (e sampdoriano) Roberto Di Martino che si è
intestardito nel portare avanti iniziative (fra cui questa) fondate sul nulla e
quei giudici che di volta in volta permettono arresti in stile tangentopoli,
ovvero finalizzati a ottenere confessioni o nomi. La testardaggine con cui
Milanetto (e con lui il Genoa) ha fatto emergere dopo quattro anni e mezzo la
sua innocenza per la presunta ma inesistente combine con Lazio nel 2011,vedrà
ora un’ulteriore coda dopo l’annuncio dato a Primo Canale dall’avvocato dell’ex
calciatore, Maurizio Mascia. Come già preannunciato alcuni mesi fa, a luglio,
ora è giunta la conferma che l’azione legale contro lo Stato sarà intrapresa e
la cifra richiesta sarà di 516.546 euro, ovvero l’equivalente di un miliardo di
lire. Somma che forse non ripaga della gogna, della sofferenza, dell’umiliazione
e dell’ingiusta detenzione subite ma che può – se riconosciutagli – servire a
ribadire ancora una volta quanto costino sulla pelle dei cittadini e sulle
finanze pubbliche certi errori giudiziari pagati da tutti i cittadini, in
assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati in Italia. (fonte:
Fabrizio Ferrante, Blastingnews,
11 ottobre 2015)
PRESUNTO COLPEVOLE. DIALLO A..
Diallo, 2 mesi in carcere per un
“disguido d’ufficio”. La burocrazia è uno dei problemi
fondamentali della giustizia italiana.
E, nel caso che vi stiamo per raccontare, anche la causa prima di un’ingiusta
detenzione, se non di un vero e proprio errore
giudiziario. Proprio così: in Italia può accadere
che, per quello che in burocratese viene ridotto a un banale “disguido
d’ufficio”, un uomo sia costretto a passare in carcere senza
motivo più di due mesi. E’ l’ennesima storia di malagiustizia:
per colpa di un incredibile intreccio di coincidenze, unito a un pasticcio di
competenze tra commissariato e questura,
una comunicazione importantissima – perché certificherebbe che un condannato sta
effettivamente rispettando l’obbligo di firma che gli è stato comminato – si
perde nei meandri della burocrazia. Con il pessimo risultato di far risultare il
protagonista di questa vicenda (Diallo A., un ventottenne immigrato regolare,
originario della Guinea) responsabile di un reato che in realtà non ha mai
commesso: “renitente all’obbligo di firma”, per usare l’arido linguaggio della
polizia. Un errore, dunque. Non proprio un errore giudiziario nel significato
che il codice penale dà a questa locuzione, ma uno sbaglio che causa un danno
non da poco a chi invece, avendo già sbagliato di suo e volendo regolare i
propri conti con la giustizia, si ritrova invece a vestire un ruolo che non
vorrebbe: quello di chi ricasca nell’errore di commettere un reato.
Nell’articolo del quotidiano milanese “Il Giorno” che riportiamo, viene
ricostruita nei dettagli questa vicenda paradossale e per certi versi
sintomatica dello stato della giustizia italiana. Tutta colpa di una firma, e di
dove la metti. Se in questura o se in un commissariato di zona. E, nel secondo
caso, c’è il rischio che quella firma si perda, si vanifichi e vanifichi anche
il suo effetto. E il firmatario torni spedito a San Vittore. Per
due mesi e un tot, dove è tuttora: per un «disguido d’ufficio». Un errore. Non
suo. Il suo, quello di spacciare piccole dosi, lo ha pagato con un
patteggiamento a un anno di reclusione: per cui la pena di Diallo A. – 28enne
della Guinea, lingua francese e poco italiano – l’1 luglio è stata commutata dal
giudice Micaela Curami in obbligo di firma trisettimanale. Ma un «disguido
d’ufficio» – come viene definito dal dirigente della Divisione anticrimine della
questura, Maurizio Azzolina, in una nota di chiarimenti a Procura, direttissime,
e legale che Diallo è riuscito finalmente a nominare, Antonio Nebuloni – lo ha
rinfilato a San Vittore, dal 30 luglio fino a tuttora. E il tuttora comprende un
pasticcio di competenze su chi ha titolo, allo stato degli atti, sul detenuto,
per cui la sua posizione potrebbe rimbalzare tra giudice del procedimento (nel
frattempo divenuto definitivo), ufficio esecuzione della Procura e Tribunale di
sorveglianza. A tutti i quali saranno destinate carte per la scarcerazione del
ragazzo, che poi sarà in grado di valutare con il legale una causa per ingiusta
detenzione. La prima colpa di Diallo – regolare sul territorio italiano – è il
piccolo spaccio, la seconda è di non avere una dimora certa. Questo sarebbe,
stando alla ricostruzione imbarazzata fatta dalla questura, il motivo
dell’equivoco. Lui infatti, arrestato in flagranza il 24 maggio, condannato l’1
luglio a un anno e 1.200 euro di multa, ottiene la commutazione della pena in
obbligo di firma, lunedì mercoledì e venerdì presso uffici della polizia
giudiziaria. Dove regolarmente si presenta dall’1 al 6 luglio: nel commissariato
di Porta Genova ma a insaputa degli uffici centrali. Così su Diallo, già il 6
luglio piomba la segnalazione della divisione anticrimine come renitente
all’obbligo. Ragione per cui il tribunale il 10 luglio ripristina la custodia in
carcere, e il 30 luglio – nel corso di un controllo – Diallo torna a San
Vittore. Il giovane africano impiega oltre due mesi a capire e a trovare un
legale che lo capisca. Quando l’avvocato Nebuloni ricostruisce che Diallo si è
«presentato alla firma presso il commissariato Milano Porta Genova dall’1.7 al
30.7» e che «non ha mai saltato neppure un giorno del suo obbligo», la questura
avvia una verifica interna. Da cui: «Effettivamente il Diallo in data 1.7.2015
si presentava» al commissariato Porta Genova; mentre «non risulta che si sia mai
presentato negli uffici della questura dove era stato invitato…». La
trasgressione delle prescrizioni è segnalata «in quanto dalla interrogazione
allo Sdi non risultava essere stato sottoposto agli obblighi di nessun ufficio
di polizia…». E, non avendo il ragazzo eletto alcun domicilio certo, «l’ufficio»
era nell’«impossibilità di avere uno specifico commissariato come riferimento»,
così unico strumento utile all’accertamento restava la banca dati che lo aveva
invece obliato. Solo «dalla successiva consultazione degli atti dell’Archivio
generale è stata rinvenuta la nota del commissariato di Porta Genova, diretta
anche alla Divisione anticrimine per conoscenza». Ma «la citata nota per un mero
disguido d’ufficio sfuggiva all’attenzione degli operatori e quindi veniva
trattata alla stregua di tutta la corrispondenza che perviene per conoscenza
all’ufficio arrestati ai soli fini dell’archiviazione». E fu così che Diallo –
Guinea – fu archiviato a San Vittore. (fonte: Marinella Rossi, Il
Giorno, 9 ottobre 2015).
Altro che errori giudiziari. Giustizia in
Italia, dove tutto può accadere. Gli orrori e le
ingiustizie del nostro sistema, scrive Valter Vecellio su “L’Indro”. Molti lo
ricordano certamente
Un giorno in pretura:
il film di Steno con
un grande Alberto
Sordi, un altrettanto bravo Peppino
De Filippo; e Sophia
Loren, Silvana
Pampanini, Walter
Chiari, Leopoldo
Trieste; ambientato nella seconda sezione della pretura di Roma, davanti
al giudice Salomone Lo Russo,
si presentano gli imputati di diversi, piccoli reati. Un film che parla, in
chiave leggera, ma al tempo stesso serissima, della giustizia cosiddetta minore:
quella chiamata a confrontarsi quotidianamente con le vicende umane più comuni e
disparate. Qui mancano De Filippo, Sordi, Chiari; ma sono comunque episodi che
possono far parte di quella galleria, una sorta di Un giorno in pretura due; e
rivelano più di qualsiasi convegno o trattato giuridico, lo stato della
giustizia in Italia. Per esempio: un detenuto, riconosciuto
innocente, e nonostante
ciò in carcere. Non per un giorno, una settimana, che può capitare, anche
se non dovrebbe. In
carcere per ben 72 giorni: oltre due mesi. Non tanto per il classico
‘errore giudiziario’; perché non c’è giudice competente sul suo caso.
Incredibile? Bene, vediamola, la storia di Diallo
A., 28 anni, originario della Guinea, piccolo spacciatore. Per questo
viene condannato; patteggia, e si vede commutata in obbligo di firma. A questo
punto viene – si fa per dire – il bello. Diallo è in carcere; per svista
amministrativa, per burocrazia inerte, per quel che si vuole, resta in cella,
non viene liberato. Finalmente si accorgono che non dovrebbe starci; a questo
punto i portoni del carcere si aprono? Proprio no. Nessuno
firma l’ordine di scarcerazione, e Diallo continua
a stare in quella cella dove, per ‘disguido’ (giustificazione della
questura) è stato rinchiuso. L’avvocato difensore si rivolge al giudice, per
ottenere lo sblocco della situazione; il giudice, pur comprensivo, risponde con
un non luogo a provvedere: ha ammesso il patteggiamento, commutato la pena in
obbligo di firma tri-settimanale; lui a questo punto esce di scena. L’inghippo
sta nel fatto che a causa di quel disguido, gli atti sono stati trasmessi alla
Procura. Il Pubblico
Ministero competente, qui entra in campo Franz Kafka, dovrebbe
concedere la sospensione dell’esecuzione della pena; ma
il provvedimento si applica a chi è in libertà, proprio per evitargli la
galera. Ma in questo caso, Diallo in
galera già c’è… Potrebbe
intervenire il Giudice di sorveglianza; però
la cosa non è ancora nella fase delle sue competenze, la sentenza
definitiva non è a sua disposizione; solo dopo quella, il difensore può proporre
istanza di misure alternative. Ora tutta questa labirintica e tortuosa
situazione ci si augura di averla raccontata come si è verificata; non si
esclude di aver commesso qualche imprecisione; come si può immaginare, capire, e
spiegare, come sia potuto accadere quello che è accaduto, è complicato. Prima o
poi la vicenda si risolverà, se già in queste ore non si è risolta. Non è questo
il problema; il
problema è che è potuto accadere. Un caso interessante è quello del
Tribunale di Prato. Un caso che diventa un caso perché c’è un giudice gran
lavoratore, colpevole appunto di lavorare troppo. Di udienza in udienza, riesce
a smaltire una quantità di procedimenti: questo singolare magistrato, una donna,
spiega che “proprio non riesco a fare rinvii su certe questioni, mi sento come
un medico o un’infermiera che stanno soccorrendo un moribondo e non se ne vanno
se suona la campanella di fine lavoro”. Vallo a dire a cancellieri e al
personale del tribunale che lavora oltre l’orario previsto senza essere
retribuito… In Tribunale raccontano che la pianta organica è sotto-dimensionata,
che il personale è stato ridotto del 35 per cento. A Prato, raccontano,
convivono 127 etnie, la falsificazione dei marchi è ormai un qualcosa di cronico
e storico; e una quantità enorme di micro, ma anche macro reati. “Dovremmo
essere almeno un centinaio come a Lucca o Pisa invece siamo una quarantina”,
dice Sergio Arpaia, cancelliere e sindacalista dell’Unsa. Non ha torto,
beninteso. Lo riconosce anche il magistrato iper-attivo, il potenziamento del
personale è necessario. Al tempo stesso, ragiona, “qui decidiamo della vita
delle persone e non si può ascoltare la campanella di fine lavoro”… Della serie:
c’è sempre qualcuno che sta peggio di quanto si sta noi. La disegnatrice e
attivista iraniana Atena Farghadani, 29 anni, è detenuta nel famigerato carcere
di Evin a Teheran, condannata a 12 anni e nove mesi per oltraggio; ma anche per
attentato alla sicurezza nazionale e diffusione di propaganda a ostile alle
istituzioni; in realtà è colpevole di pensare come non pensano gli ayatollah, e
di aver disegnato alcune vignette che hanno preso di mira esponenti del regime,
perfino e la guida suprema, Alì Khamenei. Prelevata in casa nell’agosto 2014 dai
pasdaran della Guardia rivoluzionaria, Atena viene malmenata e trascinata in
carcere. Rilasciata a novembre, è di nuovo arrestata, dopo aver denunciato in un
video i maltrattamenti in cella. Nuovo rilascio, quindi l’ultima incarcerazione
a gennaio; altre denunce di percosse, uno sciopero della fame di protesta, il
peggioramento delle condizioni di salute. Un giorno incontra l’avvocato
difensore; alla fine del colloquio, si congeda con una stretta di mano.
L’avvocato, Mohammad Moghimi, per questa stretta di mano arrestato: il gesto
viene bollato come ‘al limite dell’adulterio’; lo liberano dopo tre giorni, paga
una cauzione di 60.000 dollari, resta comunque sotto accusa. Atena, è accusata
di condotta indecente e relazione sessuale inappropriata; deve perfino a subire
un test di verginità e gravidanza nel carcere in cui è rinchiusa.
PRESUNTO COLPEVOLE. MARCO SANTESE.
Marco Santese.Gli nascondono polvere
bianca nell’auto, parrucchiere passa 26 giorni in carcere.
Trascorse ventisei lunghi giorni fra carcere e arresti domiciliari con l’accusa
di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, erano invece poco più di 23 grammi
di zucchero. Dopo un lungo anno di indagini, gli investigatori hanno scovato i
presunti registi della messinscena ordita ai danni del parrucchiere brindisino
Marco Santese, 30 anni. Secondo l’accusa del pm Giuseppe De Nozza, che ha
chiesto per entrambi il rinvio a giudizio per calunnia aggravata in concorso, si
tratta della ex moglie Monica Biasi, 25 anni e Antonio Sanasi, 40 anni, il nuovo
compagno di lei. Il movente? Pare che Sanasi temesse un ritorno di fiamma fra i
due ex e che, con la complicità di un confidente storico dei carabinieri, avesse
soffiato la calunnia nelle orecchie dei militari. Il prologo di questa
incredibile vicenda risale a poco più di un anno fa. Il parrucchiere brindisino,
incensurato, viene arrestato dai carabinieri il 29 marzo scorso. Quella mattina
stessa una telefonata avverte i militari che sotto il copri cerchio della sua
auto l’artigiano nasconde lo stupefacente. Alle 7,30 scatta il blitz, in sei
piombano nella bottega del rione Santa Chiara, e la perquisizione conferma le
informazioni dello spione. Non è tutto. Ancora più incredibile è il fatto che,
da lì a poco, il narcotest sulla sostanza conferma che si tratta di cocaina.
L’uomo viene arrestato di fronte ai clienti increduli e al datore di lavoro,
allibito. Il legale difensore, Gianvito Lillo, non si arrende e ostinatamente
chiede una seconda perizia che viene infine disposta dal pubblico ministero. I
risultati confermarono l’innocenza proclamata per ventisei lunghi giorni dalla
vittima: è zucchero, comune disaccaride saccarosio in polvere. Il gip Alcide
Maritati dispose l’immediata scarcerazione dell’artigiano mentre l’avvocato
Lillo sporse per conto del proprio assistito denuncia contro ignoti. Gli
investigatori si misero immediatamente a caccia dei calunniatori. La coppia è
stata stanata dagli stessi militari della compagnia francavillese, indagini
coordinate dal maresciallo Antonino Farrugia, impianto accusatorio corroborato
da un massiccio carico di intercettazioni. E’ lo stesso Marco Santese, nel
corso dell’interrogatorio di garanzia, a suggerire la pista agli inquirenti, sa
bene che non sono molte le persone che possono nutrire motivi di rancore nei
suoi confronti. La traccia si rivela assai puntuale e i carabinieri, con una
motivazione in più del solito, arrivano presto e bene al punto, i registi della
storia sono la ex moglie e il nuovo compagno. Il movente? Un insano desiderio di
vendetta. A ordire il piano contro il parrucchiere, suggerendo il nascondiglio
dello stupefacente posticcio a un confidente dei carabinieri, fu Santese, il
nuovo compagno della ex moglie, con l’obiettivo di eliminare il rivale dalla
circolazione. Letteralmente. Le intercettazioni confermano le prime intuizioni
degli investigatori, tanto che la prima ipotesi di reato a carico dei due, ossia
falso per induzione, muta in calunnia aggravata in concorso per aver fatto
ingiustamente rischiare all’artigiano una pena da otto a venti anni di
carcere. Fissata per il 28 maggio l’udienza preliminare che deciderà per il
rinvio a giudizio o l’archiviazione del caso, mentre pende di fronte alla Corte
d’appello di Lecce la richiesta risarcitoria per ingiusta detenzione.
(Fonte: Sonia Gioia, Brindisi Report, 10 aprile 2011)
PRESUNTO COLPEVOLE. FRANCESCO FUSCO.
Francesco Fusco. “I pm mi hanno rovinato
la vita in cambio di 8 mila euro”. “Signor Presidente,
faccia qualcosa per gli italiani, eviti che finiscano nelle mani di persone che
possono rovinare la loro vita come hanno fatto con me, eviti che la magistratura
abbia a spargere tanta sofferenza”: con queste parole, il 13 luglio del 2008,
Francesco Fusco, ex dirigente dell’Agusta – arrestato due volte e processato tre
per reati mai commessi, prosciolto da ogni accusa, ma solo dopo dieci anni di
persecuzione giudiziaria – concludeva una lettera al Presidente Napolitano,
destinata a non ricevere risposte. L’aveva scritta con la sola mano destra, dal
letto dell’istituto Redaelli di Milano, dove l’aveva inchiodato un ictus
paralizzandogli il lato sinistro e lo tormentava un cancro alle ghiandole
salivari. Fusco è morto a Milano l’altro giorno, e questa mattina – venerdì 27
luglio – avrà le sue esequie. Vittima di una giustizia approssimativa e
occasionale, sbadata quanto spietata nei suoi carsici accanimenti. Una storia da
Giobbe, la sua, la storia di un giovane benestante, apolitico, che dopo una
bella carriera da giornalista, a 53 anni, nell’89, viene assunto all’Agusta
dall’allora presidente Roberto D’Alessandro, craxiano, come direttore delle
relazioni esterne. Nel settembre del ’92 i pm Antonio Vinci e Francesco Misiani
lo arrestano (il primo morirà d’infarto nel ’98 mentre era agli arresti
domiciliari per corruzione; e il secondo sarà incriminato nel ’96 per
favoreggiamento e assolto solo dopo essersi dimesso dalla magistratura: un
sinistro contrappasso). I pm pensano che Fusco sappia tutto delle tangenti
intermediate da D’Alessandro, che invece faceva da sé. Lo sbattono in prigione
senza neanche interrogarlo: vogliono nomi. Lui non ne sa, alla fine il gip lo
scarcera. Riprende a lavorare, nel privato, ma nel ’94 lo riarrestano negli Usa
per “corruzione di persone ancora da identificare”. Stessa trafila, altri tre
mesi bruciati tra carcere e domiciliari, un altro lavoro perduto, e poi una
trafila estenuante fino al 2001 – 2 milioni di euro per difendersi e mantenere e
curare se stesso e la famiglia – quando arriva l’assoluzione definitiva. Nel
frattempo un’altra incriminazione, a Milano, che in tre anni evapora, con lo
stesso pm Gherardo Colombo che ne propone il proscioglimento per l’evidente
estraneità ai fatti. Fusco chiede l’indennizzo per l’ingiusta detenzione: lo
stato valuta la sua via crucis 8 mila euro. Vale la pena ricordare tutto questo
nel giorno del suo ultimo viaggio. Perché i giornali di solito raccontano le
inchieste e le condanne: molto più raramente gli errori giudiziari e il calvario
di chi ne subisce le devastanti conseguenze. (fonte: Sergio Luciano, Italia
Oggi, 27 luglio 2012).
PRESUNTO COLPEVOLE. ANDREA MARCON.
Andrea Marcon, ingiusto il suo arresto.
La vita distrutta di un maresciallo dei carabinieri.
«L’arresto? Uno choc. Io arrestavo i delinquenti, non sarebbe dovuto succedere
il contrario». Il maresciallo maggiore Andrea Marcon viene catturato
nell’ottobre 2005 in caserma, mentre comanda ad interim la stazione dei
carabinieri di Montecchio Maggiore. «Fu terribile», ricorda. Dieci giorni di
detenzione e poi la sospensione dal servizio. «Quasi trent’anni di carriera
cancellati, perché la maggior parte di colleghi e superiori mi voltarono le
spalle, come fossi appestato, eppure ero sicuro di non avere violato la legge»,
aggiunge angosciato e sconsolato. Il tempo non ha lenito la ferita che dice
durerà per il resto della sua esistenza. Poi il rientro in servizio e il
trasferimento al battaglione di Bologna in attesa del processo. «Sono ripartito
da capo, poi la seconda tegola, perché col rinvio a giudizio ci fu la seconda
sospensione, mi sentivo finito perché con lo stipendio ridotto a 700 euro non
potevo più mantenere la famiglia», rammenta la pagina più umiliante della sua
vita. Quindi due processi conclusisi allo stesso modo: la pubblica accusa che
chiede la condanna, i giudici che lo assolvono con formula piena. Un arresto del
tutto ingiusto. La Corte d’Appello menziona poche volte il suo nome nelle 42
pagine della sentenza con la quale sono stati invece condannati a 5 anni di
reclusione gli ex colleghi Francesco Menolascina e Ignazio Mirigliani.
L’inchiesta è quella nota delle operazioni antidroga dei carabinieri di
Valdagno, tra il 2004 e 2005, giudicate in secondo grado illegali nell’utilizzo
degli agenti provocatori. Per Marcon una vicenda anche straziante, perché nelle
stesse ore in cui veniva assolto a Venezia definitivamente – la procura generale
non ha presentato ricorso in Cassazione – il padre moriva a Torri di Quartesolo.
Intanto, una decisione il maresciallo l’aveva presa. «Sono andato in pensione,
nonostante avessi 52 anni, e in teoria pensassi di avere davanti a me ancora una
decina d’anni di carriera. Ma con 700 euro al mese non si può vivere, avendo
famiglia». Già, la famiglia. Con l’arresto è andata a pezzi. Tanto che nei
momenti più bui, quando «la depressione ti assale e pensi perché un servizio
fatto come mille altre volte stavolta è giudicato illegale, per giunta
arrestando spacciatori», Marcon ha pensato «di farla finita». «Non mi vergogno a
dire di essere andato a comprare la gomma per attaccarla al gas di scarico della
macchina – insiste senza alcun velo d’infingimento – e se mi sono fermato
all’ultimo è stato per mio figlio. Perché se sei innocente, come poi i giudici
hanno per due volte stabilito, non te ne fai una ragione di essere invischiato
in una storia allucinante». Marcon racconta di quando per andare a compiere le
operazione antidroga usava la propria macchina, per non gravare sullo Stato.
«Avevo sempre lavorato così e io non c’entravo davvero nulla con gli eventuali
illeciti commessi – dice -, perché io comandavo il radiomobile, le indagini
erano imbastite dai colleghi del nucleo e io intervenivo nella fase conclusiva,
a supporto. Invece, sono stato preso in mezzo». Il maresciallo in pensione
sottolinea con amarezza che non tutti sono uguali. «Io senza essere mai
condannato – osserva – sono stato sospeso due volte dal servizio e in pratica
costretto ad andarmene dall’Arma nonostante il mio stato di servizio fosse
ineccepibile, mentre il generale dei carabinieri Ganzer, per indagini antidroga
di ben altra dimensione e gravità, è stato condannato a 14 anni di carcere e non
è mai stato sospeso. Io constato il trattamento diverso. Ci sono militari di
seria A e serie B». La «grande famiglia» dell’Arma quando Marcon venne arrestato
nei fatti «mi espulse». «Sono stato abbandonato da tutti – conclude – in
particolare dall’Arma, nonostante una vita spesa a correre dietro ai banditi. Ne
sono uscito a pezzi, perché a costo di sembrare retorico, io gli alamari li
avevo cuciti sulla pelle. Adesso chiederò i danni allo Stato per l’ingiusta
detenzione e per le spese che ho dovuto sostenere di avvocato, Lucio
Zarantonello, che ringrazio perché mi ha sostenuto come un fratello. Ma per il
resto…». (Fonte: Ivano Tolettini, Il Giornale di Vicenza, 5 febbraio 2012).
PRESUNTA COLPEVOLE. CHIARA BARATTERI.
Chiara Baratteri. Era al bar a lavorare,
altro che rubare: con quella banda di truffatori non c’entra.
E’ notte fonda a Niella Tanaro, in provincia di Cuneo. A casa Baratteri, Chiara,
la madre, dorme nella sua camera, nell’altra stanza c’è Jodie, il figlio
adolescente, che è andato a letto presto perché domani c’è la scuola. Il
silenzio ovattato viene interrotto dal campanello della porta: “Aprite,
Carabinieri!”. Chiara, senza rendersene conto, si ritrova con le manette ai
polsi, circondata da uomini dell’Arma, davanti al figlio che trema di paura. La
donna crede di sognare, di trovarsi in un orrendo incubo. E’ invece è tutto
vero. Chiara viene fatta salire sulla gazzella con il lampeggiante acceso e
condotta prima nella stazione dei Carabinieri di Mondovì, poi nel carcere di
Cuneo. Solo all’arrivo nel penitenziario piemontese viene messa al corrente
dell’accusa di far parte di una banda di nomadi Sinti responsabile di una
sessantina di truffe e raggiri ai danni di anziani della zona. E’ l’11 ottobre
del 2007. Cinque giorni e cinque notti in una cella prima di dimostrare che lei,
con quei due episodi, tentato furto e furto, commessi il 26 ottobre e il 24
novembre 2006, in due case di anziani di Carcare, non c’entrava nulla. Chiara,
come sempre, era al lavoro dietro il bancone del bar “Caffè Le Olle”, lungo la
statale 28 tra San Michele Mondovì e Vicoforte. “Sono stata arrestata sulla base
di un riconoscimento fotografico, ma nei giorni in cui avrei tentato la truffa e
il raggiro a Carcare, in provincia di Savona, ero a lavorare al bar, a Niella
Tanaro, come ho dimostrato dai registri del locale. E’ stata un’esperienza
allucinante che non auguro a nessuno”, ha spiegato la signora, 35 anni,
assistita dall’avvocato Mario Almondo di Torino, che ne ha ottenuto la
scarcerazione dopo l’interrogatorio di garanzia, “vista l’infondatezza delle
notizie di reato”, come affermato dal Gip di Savona Emilio Fois. “Durante
l’interrogatorio è emerso in maniera incontrovertibile che lei non aveva nulla a
che fare con quei fatti. E anche le fattezze fisiche della mia assistita sono
ben diverse da quelle riconosciute dall’anziana”, ha sottolineato il legale.
Dopo due anni la posizione di Chiara Baratteri è stata archiviata e la donna,
assistita dall’avvocato Gabriella Turco, del foro di Mondovì, ha chiesto un
indennizzo per l’ingiusta detenzione. “Per il coinvolgimento in questa vicenda,
la mia assistita ha subito danni all’integrità psico-fisica, patrimoniali, di
immagine e morali, non soltanto per la privazione della libertà, ma anche per il
discredito su di lei gettato dalle notizie di cronaca che la dipingevano come
una persona costantemente dedita a reati odiosi, tanto più odiosi quanto deboli
ed indifese sono le vittime”, ha precisato l’avvocato. Il 1 marzo 2012 la terza
sezione penale d’Appello di Genova, presidente Paolo Galizia, relatore Vincenzo
Papillo, consigliere Maurizio De Matteis, ha accolto la domanda di risarcimento
riconoscendo alla Baratteri la somma di 6.180 euro, oltre agli interessi e alle
spese legali.
PRESUNTO COLPEVOLE. FRANCO MOCERI.
Franco Moceri. Altro che trafficante di
droga, doveva solo costruire un muro. Era rimasto
coinvolto nell’operazione antidroga “El Dorado” nel 2008. Rimasto in carcere sei
mesi, era stato poi rilasciato e prosciolto da ogni accusa. Un imprenditore di
Mazara, Franco Moceri, rimasto coinvolto nell’operazione antidroga “El Dorado”
del 2008 ha ottenuto, da parte della Corte di appello di Palermo, un
risarcimento di 41 mila euro per l’ingiusta detenzione. Moceri, dopo avere
subito una lunga detenzione cautelare, nel corso della quale si era sempre
proclamato innocente, era stato condannato in primo grado a sei anni di
reclusione, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di
stupefacenti. E questo nonostante “anche gli altri imputati, durante gli
interrogatori, abbiano più volte ricordato che l’operaio era una persona
estranea ai fatti”, spiega il suo avvocato, Giuseppe Pinella. Ma in appello il
verdetto della corte d’assise si è capovolto: Franco Moceri fu assolto per non
aver commesso il fatto e riconosciuto come “un semplice operaio a cui era stato
dato l’incarico di costruire un muro proprio nel luogo in cui, mesi dopo,
sarebbero state sequestrate le piantagioni-bunker di cannabis”, dice ancora
l’avvocato Pinella. Che immediatamente aveva presentato una richiesta di
risarcimento danni collegata all’ingiusta detenzione (6 mesi in carcere) subita
dal suo assistito. Ora, a risarcimento ottenuto, l’avvocato Pinella attacca:
“Questo risarcimento è comunque inadeguato, pur essendo un ristoro per la
carcerazione subita ingiustamente, perché certamente non potrà elidere il
pregiudizio che si è formato a carico di Moceri, il quale da quella data non ha
quasi più lavorato a causa del grave pregiudizio che la notizia del suo arresto
e della lunga detenzione gli ha causato”. L’operazione “El Dorado” risale al
febbraio 2008, quando i carabinieri di Trapani insieme alla Direzione
distrettuale antimafia di Palermo, arrestarono dodici persone con l’accusa di
traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale,
operante tra Mazara, Campobello, Marsala e Petrosino, avrebbe goduto del
sostegno di indiziati mafiosi imparentanti con boss di Cosa Nostra. Gli
affiliati avevano inizialmente aperto dei canali di traffico di cocaina con la
Spagna e il Marocco e, in seguito, avevano avviato la produzione di due
piantagioni di cannabis, nelle campagne di Mazara del Vallo, per un totale di
oltre 2 mila piante destinate a produrre più di 120 milioni di dosi.
L’operazione portò alla condanna di 112 anni di carcere per nove persone.
(fonte: il Giornale di Sicilia, 26 gennaio 2013).
PRESUNTO COLPEVOLE. SALVATORE RAMELLA.
Salvatore Ramella. Una vita devastata. E
i giudici aumentano il risarcimento. Quanto valgono
nove giorni in carcere da innocente? Quale risarcimento per ingiusta
detenzione potrà mai soddisfare la vittima di un errore giudiziario grossolano,
che sconvolge una vita in tutti i suoi aspetti: lavorativi, personali, privati?
Stando ai parametri ufficiali previsti dalla legge, poco più di duemila euro
dovrebbero rappresentare il giusto indennizzo per un dramma così grande come
quello di finire in prigione senza colpa per più di una settimana. Ma talvolta
anche i giudici capiscono che è il caso di andare oltre le fredde tabelle che
impongono i parametri di calcolo della riparazione per ingiusta detenzione. E si
rendono conto che è il caso di aumentare l’importo, perché pur nella
consapevolezza che nessuna somma potrà mai risarcire una tragedia come questa,
c’è un limite a tutto. E’ quello che è accaduto a Salvatore Ramella, funzionario
di banca coinvolto in una storia di riciclaggio con cui non aveva nulla a che
fare. In questo articolo, la sua storia. Il puro calcolo matematico per i nove
giorni passati in carcere ingiustamente porterebbe a liquidare come indennizzo
per l’ingiusta detenzione 2.122 euro, più 38 centesimi. Ma i giudici della Corte
d’appello di Reggio Calabria chiamati a pronunciarsi sull’istanza di
risarcimento presentata dal funzionario di banca Salvatore Ramella, prima
indagato e poi pienamente scagionato nell’ambito dell’inchiesta “Gioco
d’azzardo”, nei giorni scorsi hanno deciso di innalzare l’entità del
risarcimento a 15 mila euro. Ramella, che in questa vicenda è stato assistito
dall’avvocato Bonaventura Candido, all’epoca quando scattò il blitz – siamo nel
maggio del 2005 –, era direttore di una filiale della banca Unicredit e per nove
giorni fu ristretto in carcere; successivamente lo stesso gip dispose la misura
meno afflittiva dell’obbligo di dimora, e pochi giorni dopo il Tribunale del
Riesame ne dispose la liberazione totale con annullamento dell’ordinanza di
custodia in quanto «non sorrette le accuse di riciclaggio dal requisito della
gravità indiziaria». E si arrivò fino all’ottobre del 2007 con l’archiviazione
dell’inchiesta disposta dal gip di Reggio Calabria. Eppure, dopo l’arresto, il
funzionario di banca, fino a quel momento con un posto di alta responsabilità
nell’ambito del suo istituto di credito, fu sospeso cautelativamente dal datore
di lavoro dal 12 maggio al 5 settembre del 2005, successivamente fu trasferito
in una sede bancaria a Roma presso il Servizio crediti della Direzione regionale
Centro Sud. I giudici d’appello nell’argomentare la decisione con cui hanno
stabilito di concedere un indennizzo molto più alto rispetto al “freddo” calcolo
matematico da effettuare in questi casi, scrivono che «…nella liquidazione
dell’indennizzo, il giudice deve procedere in via equitativa, essendogli
riconosciuta – entro i confini della ragionevolezza e coerenza –, ampia libertà
di apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, avendo riguardo non
solo alla durata della custodia cautelare ma anche e non marginalmente alle
concrete conseguenze sociali, personali e familiari scaturite dalla privazione
della libertà».
E i giudici della Corte d’appello hanno
riconosciuto che la vita di Ramella fu letteralmente “devastata” da questa
vicenda. (fonte: Enrico Di Giacomo, Stampalibera.it, 14 gennaio 2011).
PRESUNTO COLPEVOLE. SALVATORE GRASSO.
Salvatore Grasso. Undici anni in carcere
per omicidio. Ma quel giorno lui era a centinaia di chilometri.
Undici anni passati in carcere da innocente, fino all’arrivo di una lettera che
lo scagiona da un omicidio mai compiuto. Ora Salvatore Grasso, 53 anni, è
tornato a Giarre, il paese in provincia di Catania dove vive l’anziana madre. Ma
nel frattempo ha perduto tutto: due figli, il lavoro, tutti i suoi progetti, i
soldi che aveva messo da parte come agente immobiliare. “Ti chiedo scusa per non
aver parlato prima ma tu e Iuculano siete innocenti ed io ora sono pronto a
dirlo ai giudici”. Poche righe scritte di pugno da Agatino Di Bella, detenuto
nel carcere di Porto Azzurro e reo confesso dell’omicidio di Salvatore Calì,
siciliano emigrato in Germania, sono state decisive per la scarcerazione di
Salvatore Grasso. “Quella busta è arrivata come un fulmine a ciel sereno –
racconta l’uomo – ed è stata decisiva per la fine del mio incubo”. E’ un uomo
provato Salvatore Grasso, dai problemi di salute, dall’ingiusta detenzione e dal
travagliato iter giudiziario che va avanti dall’agosto dell’86, quando Salvatore
Calì, un siciliano emigrato come lui in Germania viene misteriosamente ucciso in
un boschetto alla porte di Haltberg. Dell’omicidio viene accusato, oltre a
Grasso, un altro suo amico, Francesco Iuculano Cunga, anche lui condannato per
omicidio dalla corte d’assise di Catania. Grasso, che si costituisce una prima
volta in Francia, inutilmente cerca di dimostrare la sua innocenza. Così
trascorre tre anni in carcere, fino al ’90 quando viene prosciolto in appello e
torna in libertà. Un anno dopo però la corte di Cassazione annulla con rinvio la
sentenza ed il nuovo verdetto, che lo condanna a 26 anni, gli fa crollare il
mondo addosso. Per 5 anni Salvatore Grasso vive da latitante. “Certo – dice –
avrei potuto restare dov’ero, probabilmente non avrei avuto problemi, ma non mi
davo per vinto e poi, come si fa a difendersi se si è lontani?”. Nel giro di
qualche mese Grasso perde i due figli, uno dei quali scompare in circostanze
tragiche. “Nessuno potrà mai cancellare il sospetto terribile che su quella
morte – ricorda con un filo di voce l’uomo – non pesi anche la mia tragedia
personale, una vicenda che i miei figli vivevano come una macchia terribile che
non si è fatto in tempo a cancellare…”. L’ emozione più grande, tanto intensa da
essersi tradotta in un malore, è arrivata l’altro ieri quando Salvatore Grasso è
stato convocato dal direttore del carcere di Brucoli. “Mi ha chiesto come mi
sentissi – racconta Grasso – e poi mi ha dato un foglio su cui c’era scritto
“Provvisoria sospensione dell’esecuzione della pena in attesa della revisione
del processo”. Ho avuto bisogno di sedermi, poi mi sono sentito male e sono
stato portato in infermeria”. E’ stata la corte d’assise d’appello di Messina,
che a fine mese pronuncerà la sentenza al processo di revisione chiesto da
Grasso, a disporre la sua scarcerazione. Oltre alla lettera inviata dal vero
assassino, agli atti del processo c’è ora anche la testimonianza di un uomo che
aveva telefonato a Grasso poco prima che venisse ucciso Salvatore Calì e che
afferma che Grasso si trovava a centinaia di chilometri di distanza dal luogo
dell’omicidio. (fonte: Michela Giuffrida, la Repubblica, 3 febbraio 2005).
PRESUNTI COLPEVOLI. VINCENZO E GIUSEPPE
IAQUINTA.
‘NDRANGHETA, VINCENZO IAQUINTA DOPO LA
CONDANNA. Video Le Iene: “Siamo stati marchiati per
delle voci”. ‘Ndrangheta, Vincenzo Iaquinta dopo la condanna parla a Le Iene,
video. La rabbia del calciatore: “Io e mio padre siamo innocenti, non mafiosi”,
scrive il 4.11.2018 Silvana Palazzo su "Il Sussidiario". «Non è uscito niente su
mio padre, stiamo parlando del nulla». Così Vincenzo Iaquinta parla a “Le Iene”
della condanna a 19 anni di suo padre Giuseppe. L’ex attaccante di Udinese e
Juventus ha ricostruito con Giulio Golia le tappe dell’inchiesta che ha portato
al processo e alla condanna. «Mi fa paura sentire questa parola, essere
accostati alla ‘ndrangheta è la cosa più brutta che poteva capitarmi. Avevo
fiducia nella giustizia, ma ora è arrivato il momento di far capire alla gente
che mio padre è innocente. Sono stanco di questa situazione». Iaquinta parla di
accanimento nei confronti della sua famiglia. «Essere calabrese non vuol dire
essere ‘ndranghetista. Ho paura solo a parlarne, sto tremando. Sono stato
marchiato». Iaquinta ha raccontato le lacrime dei figli per le condanne e il
dolore di sua madre, malata di tumore da quattro anni. «Io avevo preso il porto
d’armi, le armi sono rimaste sempre a casa mia. Mia sorella chiese di andare ad
abitare in quella casa, allora mio padre se l’è portate a casa sua per
sicurezza, e quella è stata un’ingenuità perché dovevo denunciare lo
spostamento. Sono stato condannato perché ho dato le armi ad un mafioso, che
sarebbe mio padre». Nelle carte del processo si parla però di frequentazioni del
padre con presunti capi della ‘Ndrangheta. «Mio padre ha detto che li conosceva,
ma non ha fatto niente con loro, e le carte lo dimostrano. Conoscere certe
persone non è reato, tutti si conoscono in paese. Ma questo non vuol dire che ha
fatto qualcosa di sbagliato». Ma a Iaquinta fa male anche sapere che qualcuno
insinua facilitazioni per i presunti legami con la ‘Ndrangheta: «Non mi hanno
mai chiesto niente a parte qualche maglietta o foto. Questa è mafia?». (agg. di
Silvana Palazzo)
Vincenzo Iaquinta parla a “Le Iene” dopo la
sua condanna a due anninel processo più grande mai celebrato al Nord sulla mafia
calabrese. L’ex attaccante di Udinese, Juventus e Nazionale proclama con rabbia
la sua innocenza ai microfoni di Giulio Golia, e fa lo stesso per il padre, che
è stato condannato invece a 19 anni. «Siamo innocenti», dichiara nell’intervista
rilasciata al programma di Italia 1. Si tratta della prima intervista rilasciata
dal calciatore dopo la sentenza. Parlando con la Iena, Iaquinta sostiene che lui
e suo padre sono stati condannati perché calabresi di Cutro, paese da cui viene
il boss principale al centro del processo Aemilia, Nicolino Grande Aracri. Tra
le accuse c’è quella che la ‘Ndrangheta avrebbe facilitato la sua carriera. «Ma
stiamo scherzando, tutte fesserie! È la cosa più schifosa che hanno detto i
pentiti: io ho fatto 90 gol in serie A e 40 presenze in Nazionale».
Vincenzo Iaquinta si è fatto un’idea sul processo
Aemilia, per il quale il 31 ottobre scorso c’è stata la prima sentenza, quella
in primo grado. «Può essere che questo processo, se assolvevano mio padre,
poteva cadere perché non c’era più un’immagine per i media». L’ex attaccante di
Udinese e Juventus sostiene che il processo ruoti solo attorno al suo nome, che
si regga in piedi per questo. «Lo stiamo tenendo su noi questo processo:
Iaquinta…, Iaquinta…, su tutti i giornali. Ci sono state 119 condanne, hanno
parlato solo di Iaquinta Giuseppe e Vincenzo Iaquinta», prosegue il calciatore.
La popolarità ha i suoi pro e contro, sottolinea Iaquinta. «I giornali mettono
solo: due anni a Iaquinta per ‘Ndrangheta, maledizione!». Per Iaquinta questa è
la cosa più brutta che possa capitare: «Un giorno mi sono fermato al McDonald’s.
Una signora che era alla cassa mi ha riconosciuto: “Ah, c’è Iaquinta”. E di là
quello che lavava i piatti ha detto: “Ah, quel mafioso!”. E io c’avevo i bambini
in macchina».
A “Le Iene Show” la prima intervista di
Vincenzo Iaquinta dopo la condanna a due anni nel processo “Aemilia”,
scrive Antonio Galluzzo su spettacolinews.it il 5 novembre 2018. Durante la
puntata di oggi, domenica 4 novembre, de “Le Iene Show” (in onda in prima serata
su Italia 1) verrà trasmessa la prima intervista a Vincenzo Iaquinta dopo la
condanna a due anni subita al termine del primo grado del processo “Aemilia”, il
più grande mai celebrato contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. L’ex
attaccante della Juventus e della Nazionale campione del Mondo 2006 è stato
condannato per “reati di armi”. Il calciatore avrebbe lasciato nella
disponibilità del padre Giuseppe (condannato a 19 anni nello stesso processo)
armi legittimamente detenute e munizioni. Giuseppe Iaquinta aveva però ricevuto
un provvedimento dal prefetto di Reggio Emilia, nel 2012, che gli vietava di
detenere armamenti e pallottole a causa delle segnalazioni relative alla
frequentazione con alcuni degli indagati. Di seguito la trascrizione di alcuni
passi dell’intervista realizzata da Giulio Golia. Insieme a Vincenzo Iaquinta, è
presente anche sua moglie Arianna.
Iena: Il campione del mondo che è legato alla
‘ndrangheta?
Iaquinta: Mi fa paura sentire questa parola qua.
Essere accostati a questa ‘ndrangheta è la cosa più brutta che mi poteva
capitare.
Iena: Tu non hai mai parlato.
Iaquinta: No, mai, perché io avevo fiducia in
questa giustizia. Ho aspettato però adesso basta, è arrivato il momento di far
capire alla gente che mio padre non c'entra niente in tutto questo. Veramente, è
innocente. Sono stanco, Giulio, sono veramente stanco di questa situazione. Sono
stanco. Ieri, dopo la condanna, sono arrivato a casa… i miei bambini che
piangevano… mia madre che è malata di tumore da 4 anni… ma un cuore ce l'ha
questa gente o no? Ce l'ha un cuore?
Mio padre è calabrese, anche io sono calabrese,
sono di Cutro. Essere di quel paese non vuol dire che tu sia ‘ndranghetista. È
questo che non capisco. Hanno fatto di tutta un'erba un fascio. Oggi tu dai la
carta d'identità a Reggio Emilia, "Sei di Cutro? Sei mafioso - qua dicono - sei
‘ndranghetista".
Iena: Che significa ‘ndrangheta per te?
Iaquinta: La ‘ndrangheta a me non interessa,
Giulio. È una cosa che nella mia famiglia deve stare lontana perché non fa parte
di noi. Ho paura a parlare solo di ‘ndrangheta, vedi che sto tremando. Scusa la
tensione ma sono così io, sono genuino come mi vedete. Non c’è cosa più brutta
di venire marchiato col nome della ‘ndrangheta, non c’è cosa più brutta. A mio
padre hanno tolto la White List (il certificato per lavorare con gli enti
pubblici, ndr) e non riusciva a capirne il motivo, il perché. È andato mio padre
alla DDA di Bologna a dire ‘Venite a controllare’ perché lui era pulito, non
aveva fatto niente. Io ho preso il porto d’armi con due armi dichiarate.
Iena: Andavi a sparare al poligono?
Iaquinta: Sono stato al poligono una volta, quando
le ho prese, poi non ci sono più andato. Ero sempre a Torino, così le armi sono
rimaste sempre a casa mia. Nel 2014 mia sorella mi chiese se poteva andare ad
abitare a casa mia, dove io detenevo regolarmente queste armi. Mio padre, a mia
insaputa, per sicurezza ha preso queste armi, le ha trasferite a casa sua, in
cassaforte. È stata un'ingenuità di mio padre. Quando vengono ad arrestare mio
padre, nel 2015, le armi non le avevano trovate. Dopo tre giorni ritornano
questi della DDA e gli ho detto io che c'erano le mie armi. Ho detto: "Guardate
che mio padre ha preso le armi, le ha prese per sicurezza", gli ho spiegato
tutta la storia.
Iena: E loro che ti hanno detto?
Iaquinta: "Stai tranquillo, vedrai che sarà una
cosa amministrativa". Dopo 15 giorni, invece, mi chiamano alla caserma di
Quattro Castella dove c'era una notifica che diceva che io queste armi le ho
date in mano alla ‘ndrangheta, che sarebbe mio padre… dandomi l'articolo 7
(l’aggravante mafiosa, ndr). Con la sentenza l'articolo 7 è caduto perché non
c'era l'aggravante mafiosa.
Iena: È possibile che tuo padre abbia preso alla
leggera determinate amicizie?
Iaquinta: Ma può anche essere, ma mio padre andava
a mangiare con quelli. C’è scritto anche agli atti che conosceva tutti, ma
conoscerle è reato? Se conoscerle è un reato alziamo le mani e si fa 19 anni di
carcere, ma non è così. Mio padre deve aver fatto qualcosa con questi qua per
essere condannato, ma mio padre non ha fatto niente perché le carte lo
dimostrano al processo. Cutro è un paese normale, dove tutti si conoscono. Mio
padre conosce tutti al paese, ma questo conoscere non vuol dire conoscere
persone che hanno fatto del male, non vuol dire che mio padre ha fatto del male
anche lui, perché mio padre in tutta questa storia non c'entra nulla,
assolutamente. È pulito mio padre, e si chiedeva “Perché mi devono fare qualcosa
se io sono pulito?”. Se la gente ha commesso dei reati perché non sta in
carcere? Perché io sono un uomo pulito e ho paura ad andare al bar e incontrare
una persona che è delinquente e se la conosco non la devo salutare? Quel
delinquente tienilo in carcere così mio padre può andare al bar tranquillo. Alla
cena di Pagliani c’erano avvocati e giornalisti. Mio padre si è fermato dieci
minuti e non sapeva neanche di cosa stavano parlando. Il signor Pagliani non lo
conosceva neanche, lo ha conosciuto poi in carcere.
Iena: Nel momento in cui uno che tu sai vicino a
una famiglia mafiosa ti chiama e ti invita a cena, uno perché ci va?
Iaquinta: Perché una volta gli dici di no, la
seconda gli dici di no, venti volte gli dici di no, poi ci devi andare. Quello
può dire "perché non viene da me? Che paura ha?". È un'offesa per loro e poi ci
vai. Mio cugino si è sposato la figlia di Grande Aracri (boss della ‘ndrangheta,
ndr), mio padre e mia madre sono stati invitati a questo matrimonio e ci sono
andati, basta. Per rispetto in Calabria si va ai funerali e si va ai matrimoni.
Iena: Le persone che conoscevano tuo padre tu le
conoscevi?
Iaquinta: Certo che le conoscevo, ma conoscere
queste persone non vuol dire che io sia ‘ndranghetista. Ma stiamo scherzando?
Abbiamo la casa in questo villaggio, di fianco a casa mia abita il fratello di
Nicolino Grande Aracri. Un giorno Nicola è entrato a casa mia, è venuto lì per
salutarci perché c'ero io… Queste persone erano orgogliose di me, di quello che
ho fatto a livello calcistico, io sono diventato campione del mondo. E abbiamo
fatto questa foto, e questa foto qua poi è andata su Facebook ed è agli atti
dicendo che quello era un summit di ‘ndrangheta. A mezzogiorno, con dei bambini,
c'erano i miei figli, c'erano i miei cognati. C'era un summit e tu vai a
pubblicarlo su Facebook?
Iena: Voi sapevate chi erano?
Moglie: Ma certo che lo sapevamo chi era.
Iaquinta: Come faccio a dirgli di uscire perché è
‘ndranghetista?
Moglie: Non è che quando arriva si presentano con
armi… Tu puoi evitare di farci un affare perché sai chi è, ma non puoi evitare
di salutare o dare la mano o fare la foto.
Iaquinta: Perché, per un po' di paura, non lo so.
Iena: Se si offende uno che sai che appartiene
alla ‘ndrangheta qualche scrupolo te lo fai.
Iaquinta: E certo, quello sì, sicuramente.
Moglie: Ma noi abbiamo quattro bambini…
Iaquinta: Tutti si farebbero qualche scrupolo.
Solo del nome ‘ndrangheta ho paura.
Iena: Hai facilitato delle volte delle persone?
Iaquinta: Mai, mai. A me queste persone non hanno
mai chiesto niente.
Iena: Qualche maglietta?
Iaquinta: Magliette, palloni, fotografie. Perché,
non posso fare fotografie o dare una maglietta? È un reato? È mafia? Ma in
quanti si fanno la foto con me che io non so neanche chi siano? Può essere il
più delinquente del mondo, perché io devo dire di no? Ma dai, ma stiamo
scherzando? Quando toccano la tua dignità è impossibile stare zitti o stare
fermi, è impossibile! Penso che se una persona si arrabbia è perché non ha fatto
niente. Si sono attaccati a robe allucinanti, ci sono i pentiti che hanno
parlato che mio padre faceva fatturazione falsa, e dove sono queste fatture
false?
Iena: Hanno detto che la ‘ndrangheta ti ha
facilitato nel mondo…
Iaquinta: Ma ha facilitato cosa? A me non ha
facilitato nulla… Perché non ho bisogno della ‘ndrangheta. Io ho guadagnato dei
soldi, secondo te ho bisogno dei soldi della ‘ndrangheta o mio padre aveva
bisogno dei soldi della ‘ndrangheta, ma stiamo scherzando?
Iena: Vengono messe in discussione tutta una serie
di cose: come ci sei arrivato a giocare in nazionale…
Iaquinta: Quella è la cosa più schifosa che hanno
detto i pentiti. Tutte fesserie, balle. Io ho fatto 90 gol in Serie A, sono
arrivato in Nazionale: 40 presenze in Nazionale, ho vinto un Mondiale. Perché
queste cattiverie su di noi? Sulla questione emersa durante il dibattimento
processuale riguardo agli ombrelloni nel villaggio a Cutro di Giuseppe Iaquinta,
l’ex attaccante della Nazionale risponde: Hanno rubato due ombrelloni che noi
avevamo pagato, un amico di infanzia di mio padre ha chiamato un personaggio di
questi dicendo che a Iaquinta avevano rubato questi due ombrelloni e non c'è più
rispetto. I PM l'hanno girata come se mio padre era una persona importante, no?
Ci sono stati ridati gli ombrelloni ma pagati, non è perché ce li ha portati la
‘ndrangheta, capito? Abbiamo la fattura e le abbiamo portate anche agli atti
queste cose qua. L'amministratore di questo villaggio è venuto a fare
dichiarazioni e non gli hanno neanche creduto.
Iena: E dalle indagini non è uscito un
collegamento per appalti…
Iaquinta: Assolutamente, mai. Mio padre gli ha
portato un faldone così di roba che ha chiesto al commercialista e ha detto
"Ecco qua, controllate".
Iena: Ha avuto qualcuno a lavorare di qualche
famiglia ‘ndranghetista?
Iaquinta: No, no mai.
Iena: Qualcosa ci deve essere…
Iaquinta: Se c’era stato veniva fuori. Ma non è
venuto fuori niente, Giulio. Su mio padre non c’è un’intercettazione telefonica,
sono sempre gli altri che parlano del nostro cognome. Non è che è uscito fuori
‘Tuo padre ha fatto questo’. No, stiamo parlando del nulla. Io ero convinto che
mio padre ne sarebbe uscito pulito, invece no. Solo per una cena, perché sei
andato al matrimonio o al funerale, parliamo di due ombrelloni! Può essere che
questo processo, se avessero assolto mio padre, sarebbe potuto cadere perché non
c’era più un’immagine per i media? Lo stiamo tenendo su noi sto processo
‘Iaquinta, Iaquinta’, tutti i giornali… Ci sono state non so quante condanne,
cento e passa condanne ieri…
Iena: 119!
Iaquinta: Ma hanno parlato di Giuseppe e Vincenzo
Iaquinta. Essere famosi ha i suoi pro e i suoi contro. I giornali mettono solo
due anni a Iaquinta per ‘ndrangheta. Maledizione, maledizione. È la cosa più
brutta che ti può capitare, un giorno mi sono fermato al Mc Donald e una
signorina, quella che era alla cassa, mi ha riconosciuto ‘Ah c’è Iaquinta’ e di
là quello che lavava i piatti ha detto "Ah quel mafioso". E io avevo i bambini
in macchina, capito? Perché mio padre è ancora in carcere? Dopo una condanna di
primo grado già in carcere? Sono andati a prenderlo ieri, ieri sera. Non lo so
perché questo accanimento contro di noi, non lo so. Non è emerso niente su mio
padre che poteva esserci una associazione, non è emerso niente. Partiamo dal
fondo della famiglia Iaquinta, chi è stata la famiglia Iaquinta e cosa si è
costruito mio padre a 16 anni che è venuto a lavorare in fabbrica a Milano con
suo fratello che dormiva in fabbrica. E si è costruito tutto da solo, tutto da
solo senza l’aiuto di nessuno. Come mi sono fatto io tutto da solo, ad arrivare
a certi livelli. E questi qua in un secondo vogliono rovinare la famiglia
Iaquinta, in un secondo dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto? È così che
funziona l’Italia, è così? Per tre giudici? Per due PM? O per un pentito che ha
detto solo cazzate nel processo? Un pentito che ha fatto le cose e va a buttare
merda addosso alla gente, è questa l’Italia? No Giulio, non è così. Basta! Mi
sono rotto le palle di stare zitto, c’è da parlare. Io lotterò fino alla morte
per l’innocenza per mio padre. Perché io lo conosco talmente bene, è una persona
che non si permetterebbe mai di far del male a me. Io sono nato a Crotone, e
siccome mia madre e mio padre abitavano in una casa piena di umidità, dove il
bagno era fuori e avevano paura che se mi portavano lì morivo con tutta quella
umidità. Mi hanno lasciato due mesi da mia nonna e da mio nonno. Loro sono
tornati qua perché mio padre lavorava e dopo mi sono venuti a prendere. La gente
deve capire da dove siamo partiti anche noi. Abbiamo altri due gradi giudizio e
la verità deve venire fuori, per forza. Ho fiducia nella giustizia, Giulio.
Iena: Tu hai fiducia?
Iaquinta: Al 100% sull’innocenza di mio padre.
PRESUNTA COLPEVOLE. BEATRICE CENCI.
Beatrice Cenci, il fantasma
dell’ingiustizia. Il suo processo fu una farsa, la sua
barbara esecuzione l’11 settembre 1599 venne seguita da migliaia di persone,
scrive Daniele Zaccaria il 13 Ottobre 2018 su "Il Dubbio". Il carro che porta i
Cenci al patibolo si fa largo tra grappoli di folla; e grida, singhiozzi,
ululati provengono dai marciapiedi, dalle carrozze, dai balconi dei palazzi, in
un misto di compassione e ferocia, di eccitazione e paura, nobiltà e popolino a
formare un unico, delirante branco. E mentre la processione attraversa Santa
Maria di Monserrato, i Banchi, Tordinona, e si avvicina al luogo dell’esecuzione
l’aria è satura di calore: quell’ 11 settembre 1599 a Roma fa un caldo torrido,
l’estate sembra non voler finire più. C’è un momento però in cui la schiera si
azzittisce, un istante sospeso, quasi a raccogliere pensieri e spiriti animali
prima del supplizio: la figura sdegnosa di Beatrice appare sul ciglio di San
Celso, neanche uno sguardo rivolto agli astanti, gli occhi dritti su ponte S.
Angelo dove di lì a poco verrà decollata, ceppo e mannaia, l’ombra del boia già
occhieggia sinistra sul palco. Sul carro, dietro di lei, la matrigna Lucrezia
Petroni tremante e inebetita, e il corpo già afflitto ma ancora in vita del
fratello Giacomo: durante il tragitto lo hanno mazzolato sul cranio, divelto con
tenaglie roventi, alla fine morirà per squartamento nel più brutale dei
martirii. Lucrezia non sopporta la scena e perde i sensi, Beatrice, che è già il
suo fantasma, rimane muta e altera. Al fratello Bernardo, che ha appena 15 anni,
viene risparmiato il patibolo ma non lo strazio di assistere alla morte dei suoi
cari, anche lui perde i sensi per l’orrore e rimane svenuto per mezz’ora. La
prima testa a cadere è quella di Lucrezia, tagliata di netto dallo spadone del
boia. Poi tocca a Beatrice, la star, ha 22 anni, ed è di una bellezza rara. Le
cronache raccontano di una preghiera sussurrata, di un bacio lieve al crocifisso
e, anche qui, di un istante di esitazione da parte del carnefice prima che le
vibrasse il colpo fatale: «Intimorito si trovò impacciato a vibrarle la mannaia.
Un grido universale lo imprecava, ma frattanto il capo della vergine fu mostrato
staccato dal busto, ed il corpo s’agitò con violenza. La testa di Beatrice fu
involta in un velo come quella della matrigna, e posta in lato del palco; il
corpo nel calarlo cadde in terra con gran colpo, perché si sciolse dalla corda».
In piazza quel giorno c’erano migliaia di persone, tra di loro anche un giovane
pittore lombardo, Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. In dodici persero la
vita, chi per insolazione, chi schiacciato nella calca, chi affogato nel Tevere.
Una cupa giornata di morte e di delirio, quell’ 11 settembre 1599. Erano stati
condannati alla pena capitale direttamente da Papa Clemente VIII per l’uccisione
del conte Francesco Cenci, padre di Beatrice, Giacomo e Bernardo e marito di
Lucrezia, sua seconda moglie. Un delitto premeditato per porre fine alle
violenze di quell’uomo malvagio di cui tutti dicevano un gran male. Francesco
Cenci, ultimo esponente di una nobile e influente casata che acquistò i titoli
del medioevo, era arrogante, brutale e perverso, coinvolto in risse e diversi
fatti di sangue, finito più volte a processo per violenze sessuali e pedofilia
(aveva violentato il figlio 12enne di un popolano) era sempre riuscito a
comprarsi un’assoluzione, sfruttando la sua posizione e le sue ricchezze. Ma era
con le donne della sua famiglia che riusciva a esprimere al meglio la sua
crudeltà. La figlia maggiore Antonina scrive addirittura a Clemente VIII per
sfuggire agli abusi paterni, il pontefice, che non aveva alcuna simpatia per
Francesco, accoglie la richiesta combinandole un matrimonio con un nobiluomo di
Gubbio. Costretto a pagare una ricca dote si sfoga su Beatrice che fa segregare
assieme a Lucrezia in un castello in provincia di Rieti che appartiene alla
famiglia Colonna, nel territorio del Regno di Napoli. È il 1595 e, fino alla
morte avvenuta nel 1598, il castello sarà teatro di sevizie e percosse, di
continue umiliazioni, accentuati dall’animo sempre più incarognito di Francesco,
malato di gotta e di rogna e assediato dai debiti e dai creditori. Con l’aiuto
dei domestici Olimpio Calvetti e Marzio da Fioran, Lucrezia, Beatrice e Giacomo
tentano di ucciderlo per ben tre volte, provando ad avve- lenarlo, tentando di
pagare dei briganti locali, stordendolo con l’oppio. Alla fine è Olimpio a
ucciderlo nel sonno, a colpi di martello e a chiodate. Ufficialmente Francesco
Cenci è morto per una brutta caduta da una balaustra, ma la messa in scena è
goffa, amatoriale. Fanno ritrovare il corpo in un orto ai piedi del castello.
Non ci vuole molto agli investigatori mandati sia dal viceré del Regno di Napoli
che dal Vaticano per capire che quello non era un incidente, ma un delitto.
Riesumano il cadavere, trovano i segni delle martellate sul cranio e alcuni
buchi nel collo, due chirurghi certificano l’omicidio. Il movente è limpido:
tutti sapevano delle brutalità del conte nei confronti dei familiari che avevano
più di una buona ragione per liberarsi di lui. I Cenci vengono portati a Roma,
in un primo momento ai domiciliari nel loro palazzo sotto la sorveglianza delle
guardie pontificie. Si dichiarano innocenti, sono una famiglia molto in vista,
dei “vip” e il loro processo, che oggi verrebbe definito uno show mediatico,
calamita l’attenzione morbosa dell’opinione pubblica ed è condotto dai più noti
giuristi dell’epoca. Il dibattimento vede affrontarsi infatti due autentici
principi del foro, Pompeo Molella per la pubblica accusa e Prospero Farinacci
per la difesa, il giudice è Ulisse Moscato che due secoli più tardi il francese
Stendhal (grande appassionato della tragedia dei Cenci) descrive nelle
sue Cronache Romane come «uomo dalla profonda sapienza e dalla superiore
sagacità dell’intelletto». Ma Clemente VIII, lo stesso che l’anno successivo
farà ardere vivo Giordano Bruno, non può accettare una sentenza che non si
concluda con la morte per gli accusati. L’avidità, la cupidigia untuosa di Papa
Aldobrandini, beneficiario naturale della confisca dei beni dei Cenci, rende il
processo una farsa, fosse stato per lui non ci sarebbe stato nessun processo, li
avrebbe fatti squartare tutti appena arrivati a Roma. Irritato dalla
ragionevolezza e dalla moderazione di Moscato e preoccupato che possa venire
colpito dalla grazia della giovane, lo fa sostituire dal giudice Cesare Luciani,
noto per la facilità con cui spedisce gli imputati dal boia fin dai cupi tempi
di Sisto V, soprannominato “il Papa della delazione e delle forche”. Ma
soprattutto c’è Beatrice, superba e altezzosa, che rifiuta di ammettere le
violenze e gli stupri del padre, un po’ per scongiurare il movente, un po’ per
orgoglio e vergogna. A nulla servono le suppliche del suo avvocato, che la
invita ad ammettere l’omicidio ma anche a elencare tutti gli abusi subiti da
quell’orrendo genitore, abusi che potranno servire da altrettante attenuanti e a
risparmiarle la vita. Niente da fare, lei rigetta con sdegno ogni accusa.
Molella porta in aula a testimoniare il domestico Marzio che alla vigilia aveva
confessato sotto tortura, ma alla vista di Beatrice, di cui era perdutamente
innamorato, scoppia a piangere e ritratta tutto. Viene ucciso qualche giorno
dopo a colpi di mazza dagli aguzzini del Papa. Olimpio, l’altro domestico che
aveva partecipato alla congiura era invece riuscito a darsi alla macchia prima
degli arresti, ma viene ritrovato da un simpatizzante dei Cenci che lo ammazza
per impedirgli di testimoniare. La sentenza di condanna a morte è scontata,
tanto che viene emessa in assenza di Farinacci, ancor prima che possa
pronunciare l’arringa difensiva. Soltanto al piccolo Bernardo è risparmiato il
supplizio, lo condannano ai “remi perpeutui” nelle galere delle Stato Pontificio
(comprerà la sua libertà qualche anno dopo pagando un’ingente somma).
Immediatamente i Cenci sono portati in prigione, Lucrezia e Beatrice rinchie
nella Corte Savella, Giacomo e Bernardo nel carcere di Tordinona, prima
dell’esecuzione ci sarà la tortura. Clemente VIII vuole infatti che i Cenci
confessino e vuole eliminarli prima che la pietà possa far breccia nei
sentimenti del popolo, incuriosito e appassionato da quella tragica vicenda.
Confesseranno tutti, l’ultima a piegarsi è proprio Beatrice, sottoposta al
trattamento della “corda” che consiste nel sollevare il corpo tramite una
carrucola mentre delle grosse funi ti spezzano giunture e articolazioni. Si
piega per il dolore fisico, insopportabile, ma anche perché capisce che tutto è
ormai perduto, che i suoi familiari hanno confessato, che niente e nessuno potrà
salvarla dallo spadone affilato del boia. Il suo processo e la sua esecuzione,
il barbaro squartamento del fratello Giacomo, simbolo di una giustizia
vendicativa e ancella del potere, ha colpito a fondo l’immaginario collettivo
del popolo e degli artisti e intellettuali. E nei secoli ha ricevuto il tributo
di scrittori come Stendhal, Shelley, Dumas, Artaud, Moravia, di pittori come
Caravaggio, Artemisia Gentileschi (anche lei in piazza il giorno della morte),
Guido Reni, di musicisti come Rota e Goldschmidt, di cineasti come Mario
Camerini e Lucio Fulci. La leggenda vuole che ogni 11 settembre, annunciato da
una gelida brezza, il fantasma di Beatrice Cenci appaia all’imbrunire sui
balconi di Castel S. Angelo. La testa appoggiata sulle mani bianche come la
luna, la camminata leggera e altezzosa, una luce malinconica nello sguardo, e un
sorriso beffardo da regalare ai romani, proprio come quando era in vita.
PRESUNTO COLPEVOLE. ARMANDO CHIARO.
La Cassazione: «È innocente» Ma ha fatto
7 anni di carcere. Armando Chiaro per il pm era «uomo
di camorra», scrive Simone De Meo, Lunedì 02/07/2018, su "Il Giornale". L'ex
coordinatore flegreo del Pdl Armando Chiaro ha già scontato una pena a sei anni
e mezzo di galera per un reato da cui è stato assolto due giorni fa. Carcere
preventivo, carcere ingiusto nel suo caso. Accusato di essere l'uomo di
collegamento tra la camorra di Marano - il potente clan Polverino, che ha
ramificazioni in mezz'Europa - e la macchina comunale. C'erano i pentiti,
c'erano le intercettazioni, c'era il teorema della Procura. Ma l'inchiesta è
crollata in Cassazione, e la condanna - inflitta in primo grado e confermata,
con un piccolo sconto di sei mesi sui sette anni iniziali, in Appello - è stata
cancellata. Era l'epoca della caccia alle streghe nel centrodestra campano, il
2011. Con una compagine di pm e investigatori convinti che il Pdl vincesse e
triturasse record elettorali nei feudi della sinistra per aver venduto l'anima
al diavolo con lupara e coppola. Ipotesi, suggestioni in alcuni casi che, però,
furono trasfuse in atti giudiziari. Come l'indagine che, il 3 maggio di
quell'anno, portò alla cattura di 38 presunti fiancheggiatori della cosca di
Peppe Polverino, soprannominato o barone per i modi aristocratici. Tra loro, tra
estorsori, trafficanti di droga e faccendieri in odore di zolfo, anche Armando
Chiaro, consigliere comunale uscente e coordinatore del Pdl per Marano e i
Comuni vicini. Indicato nelle conversazioni spiate dalle forze dell'ordine col
duplice soprannome di «onorevole» o «assessore Mesillo», dal nome di fantasia di
un politico corrotto del film Il Camorrista di Giuseppe Tornatore. Ci sono
voluti sette (anni che Chiaro ha trascorso tra carcere e domiciliari) per
scoprire che è innocente. Durante il processo, furono trascritte e depositate
addirittura le intercettazioni tra Chiaro e Luigi Cesaro, l'allora presidente
della Provincia di Napoli. Di che cosa parlavano, i due esponenti del Pdl? Di
politica, di accordi elettorali, di strategie e alleanze per vincere le elezioni
amministrative. Di tutto quello che, normalmente, è argomento del giorno per un
politico. Materiale «scottante», invece, per gli inquirenti che ritennero usarlo
come ulteriore indizio per dimostrare la colpevolezza di un sistema, a loro
dire, malato. Falso, tutto ribaltato dagli ermellini che, oltre ad assolvere
Chiaro, hanno disposto il dissequestro dei beni e la cancellazione della pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Pur detenuto, Chiaro risultò
eletto alle comunali. Ottenne 385 preferenze, i suoi sostenitori e gli amici di
sempre avevano tappezzato Marano di manifesti in sua difesa. Fu poi il prefetto
a intervenire e a disporre la sostituzione in consiglio comunale. Quella
dimostrazione di affetto, però, divenne prova del grado di condizionamento - che
certo esiste - della criminalità organizzata a Marano. All'epoca, si segnalò per
l'attivismo a favore di una politica tutta manette e gogna mediatica l'allora
senatrice del Partito democratico Teresa Armato. Firmò due interrogazioni
parlamentari e chiese l'intervento del ministro dell'Interno. Chissà che cosa
dirà, oggi.
PRESUNTA COLPEVOLE. EMILIA SALOMONE.
Assolta? Alla Corte dei conti non basta:
«Restituisca 12 milioni di euro». Il caso nella
procura di Torre annunziata: accusata di corruzione rinuncia alla prescrizione
per ottenere giustizia, viene dichiarata innocente ma è costretta lo stesso a
risarcire lo Stato, scrive Simona Musco l'1 luglio 2018 su "Il Dubbio". Quasi
vent’anni di calvario giudiziario e un’assoluzione perché il fatto non
costituisce reato. Ma poi la beffa: nonostante non abbia commesso alcun delitto,
Emilia Salomone, assistente giudiziario al Tribunale di Torre Annunziata per 40
anni, dovrà pagare circa 12 milioni di euro di danni erariali. Sette milioni di
euro in solido con il “cancelliere d’oro” Domenico Vernola e 5 milioni e 700mila
euro (in concorrenza) con l’allora procuratore Alfredo Ormanni. A stabilirlo è
stata la Corte dei conti in sede d’appello, che nonostante l’assoluzione nel
processo ordinario ha deciso che l’assistente giudiziario ha contribuito a far
intascare a Vernola circa 30 miliardi di lire, sgraffignati allo Stato grazie ad
una serie di falsi mandati di pagamento. «Per la Corte dei conti la mia non
sarebbe un’assoluzione piena – racconta la donna al Dubbio –. Questo nonostante
io sia un dipendente di sesto livello e non dovrei quindi nemmeno comparirci,
davanti alla magistratura contabile. Era il dirigente a doverne rispondere».
Quella storia, per la Procura campana, fu un vero e proprio terremoto. Tutto
ruotava attorno alla figura di Vernola, che per anni avrebbe falsificato i
mandati di pagamento, collezionandone dal 1995 al 2002 ben 176, con i quali si
era fatto rimborsare, assieme ad alcuni agenti della polizia giudiziaria finiti
con lui a processo, circa 16 milioni di euro, con il “visto” per liquidazione,
appunto, dall’ex procuratore Ormanni. La colpa di Salomone era stata quella di
aver registrato, con la propria firma, 103 ordinativi al cosiddetto modello 12.
Senza dolo, secondo il Tribunale di Roma che l’ha assolta in appello, dopo che
la donna aveva rinunciato alla prescrizione per dimostrare la propria innocenza.
Con «una ripetitività e continuità tale da renderla quantomeno pienamente
consapevole della assoluta anomalia di mandati intestati sempre a Vernola»,
invece, secondo la Corte dei conti, che nella sentenza 117 del 2017 parla di
«dolosa acquiscenza (…) al sistema fraudolento ordito da Vernola». Si trattava
di pagamenti effettuati in assenza di documentazione, per procedimenti penali
inesistenti, missioni mai effettuate, anche durante periodi di ferie e congedi.
Pagamenti ingiustificati e esorbitanti, anche da 7mila euro a missione. Anomalie
delle quali Salomone si accorse, segnalandole al proprio superiore, che però la
tranquillizzò. «Appena mi sono accorta che qualcosa non andava – spiega – per
prima cosa ho riferito tutto al mio dirigente, che mi ha rassicurata, dicendo
che erano spese coperte da segreto e, perciò, autointestate. Glielo dissi due
volte e a dire la verità ero preoccupata, ma più per un fatto amministrativo:
non ho mai pensato che Vernola stesse rubando». Nessun sospetto, infatti, aveva
sfiorato Salomone: del cancelliere si fidava. «Era un tipo sui generis e molto
disordinato nel suo lavoro, quindi attribuivo a questo le sue mancanze», spiega.
Ma a creare il sospetto della Procura prima e della Corte dei conti poi è stato
un prestito da parte di Vernola alla donna. «Io non gli ho mai chiesto quei
soldi – racconta –, gli avevo soltanto chiesto di presentarmi il direttore della
banca, perché sapevo che tra loro c’erano buoni rapporti». Quei soldi servivano
per l’acquisto di una proprietà, acquisto per il quale Salomone avrebbe voluto
accedere ad un prestito agevolato. Ma Vernola non ha mai presentato il direttore
alla donna, proponendo un’altra soluzione. «Mi disse che sua sorella, vedova di
un generale e senza figli, aveva molti soldi da parte e che lo avrebbe fatto con
piacere, anche perché così avrebbe pagato meno tasse – racconta –. Facemmo anche
una scrittura privata, dissero che non volevano niente in cambio. Mi dovevo solo
limitare a restituire 5 milioni l’anno». Salomone e suo marito ricevettero 50
milioni a testa, tutti versati tramite assegni, dei quali restituirono 25
milioni, sempre a mezzo assegni. «Dopo il suo arresto, non avendo contatti con
la sorella, mi sono fermata», aggiunge. Ma quel prestito, per la Corte dei
conti, sarebbe stata la prova della partecipazione della Salomone a quel piano
fraudolento messo in piedi da Vernola. «Io non ho mai falsificato nulla –
sottolinea –. Mi limitavo ad annotare i pagamenti, in un registro che poi veniva
controllato dalla Procura. Quella davanti alla Corte dei conti doveva essere una
causa civile, invece mi sono sentita di nuovo giudicata. Hanno deciso di
condannarmi, ma in realtà io non ho fatto niente. E vorrei si sapesse». I
mandati di pagamento che Vernola intestava a se stesso, infatti, venivano
controllati dall’ufficio postale passando, da ultimo, dalla Ragioneria dello
Stato e dalla Corte dei conti. «Quindi chi mi condanna è chi, con più competenze
di me, ha poi controllato quei mandati ritenendoli validi», aggiunge. Ma come
detto la colpa di Salomone, secondo la Corte dei conti, sarebbe stata quella di
non aver denunciato, dopo essersi accorta delle anomalie, continuando a
registrare i mandati di pagamento. Per i giudici contabili ci sarebbe stato,
dunque, un effettivo apporto causale. Se avesse segnalato il tutto, contestano,
il danno erariale sarebbe stato infatti arginato e il tutto scoperto anni prima.
Quel prestito, dunque, per i giudici sarebbe stato
il modo di Vernola di “comprarla”, nonostante tale evenienza sia stata esclusa
dai giudici di merito. E nonostante sia stato lo stesso cancelliere a
scagionarla, riferendo ai pm di aver tratto in inganno la donna. Salomone ha ora
presentato una revocatoria, sperando che la situazione possa risolversi. «Spero
che qualche magistrato mi ascolti – racconta ancora –. Quando arrivò la prima
condanna per me fu una doccia fredda. Fui allontanata dal lavoro per più di tre
anni, la gente mi guardava come una ladra. Ho rinunciato alla prescrizione
perché volevo dimostrare a tutti di essere innocente. Altri non l’hanno fatto. E
nonostante la sentenza di assoluzione sia passata in giudicato ad ottobre 2016,
ho ricominciato a lavorare solo a settembre dell’anno successivo. I soldi che mi
chiedono non li saprei nemmeno contare – conclude – ma dovrò pagare questa tassa
a vita, pur non avendo fatto niente».
PRESUNTO COLPEVOLE. ALFONSO SABELLA.
Sabella: «Io, innocente, per la Corte dei
conti resto il “boia del G8”». Intervista al
magistrato condannato a un risarcimento milionario per i fatti di Genova, scrive
Simona Musco il 27 Maggio 2018 su "Il Dubbio". «Fa comodo mantenere una
situazione in cui è vero tutto e il contrario di tutto. Su Genova non si conosce
la verità. Sono note le responsabilità dei criminali della Diaz e di Bolzaneto,
ma su chi ha fomentato quelle mani nessuno ha mai indagato». Il magistrato
Alfonso Sabella, giudice del Riesame a Napoli, racconta quella parentesi del G8
come una ferita aperta. Che sanguina, perché da innocente, come stabilito dal
tribunale che archiviò la sua posizione, si ritrova ora con «una condanna a
morte», come lui stesso l’ha definita: per i giudici della Corte dei conti di
Genova, Sabella, durante il G8 a capo del servizio ispettivo del Dipartimento di
amministrazione penitenziaria, deve sborsare circa 3 milioni e mezzo di euro. A
lui viene infatti addebitata una responsabilità «sussidiaria», per non aver
vigilato sull’operato di chi compì quelle violenze. Per la procura della Corte
dei conti, infatti, «vi erano molteplici elementi» di cui Sabella era a
conoscenza, «che avrebbero imposto» maggiore controllo sul sito di Bolzaneto. Il
magistrato, però, annuncia ricorso e denuncia: «Non mi hanno consentito di
difendermi. Non chiedo di essere prosciolto, voglio solo poter essere giudicato
secondo le regole in cui credo».
Lei dovrà risarcire parte del danno erariale
per i soldi che lo Stato ha dovuto liquidare ai detenuti torturati a Bolzaneto.
Quali responsabilità le attribuiscono?
«Una
responsabilità sussidiaria praticamente su ogni cosa. Ma che c’entro io con i
medici, con le visite, con i certificati falsi? Avrei dovuto fare tutto da solo,
secondo i giudici. Ma io avevo ben altri compiti e quello di controllo sulle
condotte delle forze di polizia era affidato al più alto in grado possibile.
C’erano strutture dislocate su quattro regioni ed io sono stato fisicamente
bloccato a Forte San Giuliano (sede del comando regionale ligure dei
Carabinieri, ndr) il 20 e il 21 luglio, per via degli assalti. Lì, però, non è
stato torto un capello a nessuno, mentre è dove non c’ero che sono state
commesse quelle nefandezze.
La sua posizione, nel corso del processo
penale, è stata archiviata perché non può ritenersi accertata la sua piena
consapevolezza di quanto accadeva a Bolzaneto. Com’è possibile che la Corte dei
conti ribalti questo assunto?
«Chiariamo un
punto: la Corte dei conti ha diritto a processarmi, ma io ho diritto di
difendermi. Però me l’hanno impedito. Affermano falsamente, e mi dispiace dirlo,
che tutti i testi da me richiesti fossero finalizzati a dimostrare le mie
presenze a Bolzaneto. Poi, però, dicono che tali presenze non sono provate. In
realtà i miei testi – che non sono stati ammessi – avrebbero dovuto riferire su
cose che erano responsabilità di altri. Ma è chiaro che c’è un interesse
affinché non si sappia. Il risarcimento non è proporzionato alla mia presunta
colpa, che non dicono quale sia. Nel primo invito a dedurre la richiesta era
addirittura di 12 milioni. Secondo l’accusa, io avrei avuto responsabilità
praticamente su tutte le forze di polizia. Ma io ero un funzionario della
pubblica amministrazione. Era una tesi insostenibile, così alla fine il danno è
stato quantificato in quattro milioni, da dividere tra me e il colonnello Oronzo
Doria (all’epoca dei fatti colonnello del Corpo degli agenti di custodia, ndr).
Ma la cosa allucinante è che sono stato condannato per responsabilità
sussidiaria anche in merito alle lesioni. Se fossi davvero responsabile, allora
avrebbero dovuto fare un processo penale per concorso colposo. Perchè non sono
stato processato? Per non farmi difendere.
In un’intervista ha fatto trapelare propositi
suicidari per non lasciare in eredità a sua figlia questo debito. Ci ha pensato
sul serio?
«È stato solo
un momento, un pensiero accantonato subito. Ma è chiaro che uno ci pensa, una
volta che ti mettono davanti all’alternativa “o paghi o ti ammazzi”.
Torniamo alla vicenda penale. Lei ha chiesto di
essere processato. Perché?
«Ho ricusato la
remissione delle querele e sono l’unico nella storia d’Italia a essersi
associato all’opposizione delle parti civili alla richiesta di archiviazione del
pm. Volevo avere la possibilità di produrre documenti, controinterrogare. Ora,
17 anni dopo e senza aver mai subito il processo, mi condannano a morte. Eppure
sono stato io il primo a fornire le prove per far emergere il clima di omertà
che c’era a Bolzaneto e molti sono stati condannati perché non mi hanno riferito
quanto accadeva. Non mi avrebbero mai fatto sapere quanto stava accadendo e
questo lo scrivono anche il pm e il gip.
Nessuno si è accorto di nulla?
«Nemmeno il
ministro (della Giustizia, Roberto Castelli, ndr) che visitò la caserma si
accorse di niente. Non ci facevano vedere nulla. Lì erano tutti poliziotti,
carabinieri e agenti penitenziari e tra questi nessuno ha avvisato i propri
superiori. Quegli uomini dipendevano gerarchicamente dal procuratore. E nessuno
dei pm ha pensato di andare a vedere come venissero gestiti gli arresti. Ho
visto solo una cosa: dei ragazzi in piedi – ma in alcuni momenti anche seduti -,
con il viso al muro e le mani appoggiate alle pareti. Chiesi spiegazioni e diedi
disposizione di tenere gli arrestati in quella posizione solo per il tempo
necessario a compiere le operazioni di perquisizione. Nonostante, dunque, io
abbia segnalato quella anomalia mi accollano tutte le responsabilità, anche
quelle degli altri.
Quali responsabilità ci sono?
«La prima
violazione è stata non concedere alle persone arrestate di parlare con gli
avvocati. E chi l’ha commessa? Il procuratore di Genova, con un provvedimento
illegittimo in cui vietava i colloqui prima ancora che qualcuno venisse
arrestato. Lo stesso magistrato che poi ha investigato su quei fatti. La
magistratura di Genova ha precise responsabilità, se mi avessero processato
magari sarebbero venute fuori. Forse si voleva evitare che io parlassi di fatti
connessi a quella indagine, come il piano degli arresti preventivi, condiviso
dalla magistratura. Io avevo messo nero su bianco quanto fosse sbagliato, avevo
proposto l’alternativa di portare tutti al carcere di Marassi, che non sarebbe
stato attaccabile. Ma quel piano c’era, quindi andavano tutti portati lontano da
Genova. Poi, però, venne cambiato.
Secondo lei perché?
«Non mi accorsi
che era stato modificato in corso d’opera. Forse lo scopo era proprio quello di
aizzare gli animi. Forse non doveva essere Carlo Giuliani a morire, ma un membro
della polizia. Posso immaginare chi lo volesse, ho fornito tutti gli elementi
sul punto, ma non hanno indagato.
Secondo lei i fatti di Genova e la sua condanna
davanti alla Corte dei conti sono legati?
«Non posso
mettere in relazione le due cose, non ho elementi per dirlo. Tendo a non credere
al complotto. Certo è che non capisco questo trattamento di sfavore. Sono stato
l’unico, tra quelli che non sono stati condannati, a non aver fatto carriera,
l’unico con l’avanzamento bloccato, l’unico a pagare realmente.
Perché?
«Il problema è
che io sono un magistrato indipendente. Nel decreto di archiviazione vengono
usate parole infamanti, definendo il mio comportamento «negligente», come se il
G8 lo avessi organizzato io. Siccome non potevo impugnare l’archiviazione, feci
un esposto al Csm.
Che fine fece?
«Andò perso.
Come i tabulati telefonici dei miei cellulari. Chiesi al gip Lucia Vignale di
acquisirli per accertare i miei movimenti in ogni istante, in modo da provare
dove fossi. Si trattava di 1.500 telefonate in due giorni, praticamente una ogni
172 secondi. Ma acquisiti i tabulati, tutte le celle impegnate in uscita erano
state cancellate. Dissero che non era possibile identificare la cella, perché ce
n’erano diverse. Eppure capire quale fosse il ripetitore che agganciava
Bolzaneto era un gioco da ragazzi e ancora oggi è verificabile. Quando mi
accorsi che il Csm aveva perso il mio esposto, che conteneva anche una memoria
dettagliata sui fatti di Genova e sulle omissioni dei colleghi, ho presentato
un’istanza per sapere dove fossero finite quelle carte e ho scoperto che sono
state archiviate ed espunte dal mio fasci- colo. Ma non solo: la stessa sera
venne comunicato all’Ansa, falsamente, che mi ero candidato con An alle
politiche e che avevo chiesto un’aspettativa. Così, per l’opinione pubblica, il
“boia di Bolzaneto” era stato ricompensato con un candidatura.
Come sparirono quelle carte?
«Non me lo so
spiegare. Voglio addebitare tutto questo alla mia sfortuna. Solo che mi sembra
di essere un po’ troppo sfortunato. Sono fiducioso nell’autonomia dei giudici,
ma devo prendere atto che il clima non è dei migliori. Mi auguro soltanto che la
sezione d’appello mi dia la possibilità di avere un processo, portare prove e
testimoni. Per me è importante potermi difendere. L’esito, poi, sia quel che
sia: i magistrati sbagliano anche in perfetta buona fede. Il mio scoramento è
dettato proprio da questo: ho sempre creduto nella giustizia e io, da
magistrato, ho consentito anche ai peggiori criminali di difendersi. Ma se lo
Stato ritiene di poter bypassare le proprie regole si mette allo stesso livello
della criminalità organizzata.
Ci sono ancora verità nascoste sui fatti del
G8?
«Su Genova non
è stato detto tutto. Sono note solo le verità sui criminali della Diaz e di
Bolzaneto. Ma su chi ha fomentato le loro mani indagini non ne sono state
proprio fatte. Non interessa a nessuno. Al di là di chi ha subito i pestaggi, la
vera parte offesa è la dignità di questo Paese, calpestata da questi
comportamenti ignobili. E non a caso il reato di tortura, per anni, è rimasto
congelato negli scranni del Parlamento.
Quali punti rimangono ancora oscuri?
«Che fine hanno
fatto i verbali del comitato per l’ordine e la sicurezza? E le notizie dei
servizi segreti? Perché i respingimenti alla frontiera, all’ultimo minuto, non
sono stati fatti? Perché il personale esperto è stato messo solo nella zona
rossa e fuori c’era gente magari con un solo anno di anzianità? Chi ha deciso
tutto questo e perché? Ci sono tantissime domande. Io ho provato a dire quel
poco che so, ma non sono stato ascoltato.
Cosa farà se il ricorso in appello dovesse
andare male?
«Mi rivolgerò
alla Corte europea. Non ho avuto nemmeno una contestazione chiara dei miei
addebiti, perché viene cambiata ogni volta. Una volta mi ritengono responsabile
per non essere andato a Bolzaneto, una volta per esserci andato troppo spesso,
una volta per esserci andato e non essere entrato. Insomma, non si capisce cosa
abbia fatto. Spero che i giudici europei mi ascoltino, perché in quella sede
dirò cosa non ha fatto il nostro Paese per accertare la verità sui fatti del G8.
PRESUNTO COLPEVOLE. DOMENICO ZAMBETTI.
'Ndrangheta: Zambetti, sono vittima.
Ex assessore, meritavo l'assoluzione. Crespi, sono
innocente, scrive il 23 Maggio 2018 "La Gazzettadelmezzogiorno.it". "Sono una
vittima e non sono un carnefice. Dovevo essere assolto perché non ho fatto
nulla. Speravo di chiuderla qui, con il processo in appello". Sono le parole a
caldo dell'ex assessore regionale Domenico Zambetti che, occhi lucidi per la
rabbia, ha espresso il suo rammarico per la sentenza dei giudici di secondo
grado che, comunque, gli hanno quasi dimezzato la pena inflitta dal Tribunale.
Zambetti, accusato di aver comprato 4000 voti dalla 'ndrangheta per le regionali
del 2010, oltre ad annunciare ricorso, ha notato che, vista la riduzione delle
pene a lui e ad Ambrogio Crespi, fratello dell'ex sondaggista di Berlusconi,
"qualcosa forse non ha funzionato in primo grado". Crespi ha invece affermato:
"Credo ancora nella giustizia, sono innocente. Cercherò di riprendermela andando
in Cassazione. Se la giustizia ha un suo corso, lo rispetto ma non lo
condivido".
PRESUNTO COLPEVOLE. AMBROGIO CRESPI.
Solidarietà bipartisan per il regista
Ambrogio Crespi alla vigilia della sentenza. Un processo tra dubbi e prove
fragili. Un nuovo caso Enzo Tortora per alcuni giornali. Anche Marco Pannella si
schierò per l'innocenza del regista, scrive Angelo
Amante il 20/02/2018 su "Huffingtonpost.it". Il secondo capitolo della discussa
vicenda giudiziaria del regista Ambrogio Crespi si concluderà domani, di fronte
alla corte d'Appello di Milano. Un iter lungo quasi sei anni, che a Crespi,
tirato in ballo da una serie di intercettazioni, è già costato duecento giorni
di carcere e una condanna in primo grado per concorso esterno in associazione
mafiosa. La vicenda risale alle elezioni regionali in Lombardia del 2010, le
ultime vinte da Roberto Formigoni. Il tribunale ha ritenuto Crespi colpevole di
aver procurato voti a Domenico Zambetti, assessore alla Casa di quella giunta,
servendosi di conoscenze in ambienti criminali. Un nuovo caso Enzo Tortora,
hanno scritto alcuni giornali, facendo un parallelo con il presentatore
condannato per reati che non aveva commesso dopo un lungo calvario tra carceri e
tribunali. Il processo è andato avanti tra dubbi sull'impianto accusatorio, a
causa di prove fragili e ritrattazioni da parte degli intercettati. Dal mondo
della politica è giunta una solidarietà bipartisan, che coinvolge esponenti del
centrodestra, tra cui Mara Carfagna e Gianni Alemanno, e del centrosinistra,
come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sandro Gozi. All'epoca
dell'arresto, anche Pannella si schierò per l'innocenza del regista, autore di
numerosi film e documentari, tra cui "Spes contra spem - Liberi dentro",
presentato nel 2016 alla mostra del cinema di Venezia. La sentenza di primo
grado è arrivata a febbraio dello scorso anno. Il pm aveva chiesto una condanna
a sei anni. Ne sono arrivati dodici, nonostante Crespi, in aula, "abbia ricevuto
le scuse del suo principale accusatore, Eugenio Costantino", dice l'avvocato
Giuseppe Rossodivita. Costantino ha ammesso di aver soltanto finto di conoscere
il regista nelle conversazioni intercettate dagli inquirenti. L'obiettivo era
accreditarsi agli occhi del gruppo criminale di cui faceva parte, millantando
contatti di alto livello. "Costantino le sparava a tutto spiano. Non mi spiego
perché Ambrogio sia stato condannato al massimo della pena. È stato trattato
alla stregua di un associato all'organizzazione". Dopo essere stato arrestato a
Roma nell'ottobre del 2012, il regista ha trascorso quasi sette mesi tra Regina
Coeli e Opera, due dei quali in isolamento. Per l'accusa, avrebbe contributo a
un sistema che provvedeva a raccattare voti in cambio di soldi. Denaro che
andava a finire nelle tasche dell'organizzazione, che si serviva di una rete di
"controllori" per indirizzare i consensi di interi condomini sul candidato
preferito. Zambetti avrebbe pagato circa 200 mila euro per 4 mila voti. 2.500 di
questi, stando alle intercettazioni, sarebbero stati procurati da Crespi. Il
regista nega di conoscere sia Costantino, che avrebbe incontrato per la prima
volta in carcere, che Zambetti. Crespi è stato scarcerato ad aprile 2013. Il gip
Alessandro Santangelo escludeva non soltanto ogni collegamento abituale tra
l'imputato e la criminalità organizzata, ma dava per scontata la sua volontà di
difendersi. A Crespi fu infatti offerta da Francesco Storace una candidatura in
parlamento. In caso di elezione, l'immunità penale garantita agli onorevoli lo
avrebbe messo parzialmente al riparo dall'azione della magistratura. Ma preferì
rifiutare e andare avanti nell'iter giudiziario. Crespi parla in
un'intercettazione telefonica con Alessandro Gugliotta. Sospettato di avere
legami con la 'ndrangheta, Gugliotta ha conosciuto Crespi durante l'infanzia
trascorsa nelle case popolari del quartiere Baggio, periferia Ovest di Milano:
"Agli occhi di Ambrogio, era soltanto una persona che viveva di piccoli
espedienti. Un giorno si sono rincontrati, e Gugliotta gli si è attaccato
dietro", dice ancora Rossodivita. Nella telefonata, Gugliotta chiede a Crespi di
dare una mano a sostenere Sara Giudice, una candidata al consiglio comunale di
Milano nel 2011. Richieste che Crespi liquidò evasivamente, senza offrire nulla
più che una possibile intervista sul quotidiano che allora dirigeva. O al
massimo un sondaggio, confezionato dal fratello Luigi. Crespi è accusato di aver
presentato Gugliotta a Giuseppe D'Agostino, altro uomo dei clan. «Ma non è vero.
Si tratta di una ricostruzione già smentita nel corso del processo di primo
grado», afferma il legale. Secondo la difesa, organizzata da Rossodivita assieme
al collega Marcello Elia, la tesi dei condomini "orientati" non regge. Spiega
ancora l'avvocato: "Tutti gli abitanti di un condominio votano nella stessa
sezione elettorale. Se ci fossero stati 10 o 12 condomini gestiti da malavitosi,
questo avrebbe dovuto produrre picchi di preferenze concentrati in alcune zone
della città". Non è così, sostengono gli avvocati. "Il massimo ottenuto da
Zambetti in una singola sezione sono 38 preferenze. In qualche altra, si oscilla
tra le 15 e le 20", aggiunge il legale. Sarebbe anche esagerato, aggiungono i
difensori, credere che Crespi abbia il potere di muovere 2500 voti. Nel 2006, il
regista si candidò a sindaco di Milano. A sceglierlo furono 1086 elettori. Meno
della metà di quelli che, per merito suo, avrebbero barrato il nome di Zambetti.
PRESUNTO COLPEVOLE. ILVO CALZIA.
Se 11 assoluzioni vi
sembran poche…,
scrive Simona Musco il 25 Aprile 2018 su "Il Dubbio". L’odissea giudiziaria di
un dipendente comunale. Undici processi, tutti archiviati o finiti con
un’assoluzione con formula piena. «Sei anni di calvario», dice l’avvocato Paolo
Frank raccontando la storia del suo cliente. Ilvo Calzia, ex dirigente del
settore Urbanistica del Comune di Imperia, è per tutti un recordman: indagato,
processato e assolto ogni volta, ma comunque sospeso dal lavoro, con lo
stipendio ridotto all’osso per circa tre anni, nonostante la legge Severino
richieda almeno una condanna per giustificare una sospensione. Tutto comincia
nel 2012, con l’indagine sul porto turistico d’Imperia, che coinvolge anche
l’imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone e l’ex ministro Claudio Scajola.
«Durante la fase delle indagini – spiega l’avvocato Frank Calzia è stato più
volte sentito a sommarie informazioni dalla Procura e dalla polizia giudiziaria
perché considerato una persona attendibile e onesta e anche perché si tratta di
un tecnico, un architetto competentissimo, che conosce perfettamente le norme».
Non viene sentito dunque in qualità di indagato, ma solo come persona informata
sui fatti. Una situazione che però, ad un certo punto, cambia completamente:
«quando il pm ha tirato le fila delle indagini ha chiesto la misura cautelare
per concorso in associazione a delinquere anche per Calzia», spiega l’avvocato.
Una richiesta che non convince il gip, secondo cui può essere contestato, al
limite, l’abuso d’ufficio. Viene così chiesta soltanto l’interdizione per due
mesi. «Durante l’interrogatorio – racconta il legale, Calzia ha spiegato in
maniera dettagliata la sua posizione e così, passati i due mesi, la misura
interdittiva ha perso efficacia». Il dirigente torna dunque a lavoro, convinto
che tutto torni come prima. Ma il Comune decide di chiudergli le porte in faccia
con una nuova sospensione cautelare. Motivo: «volevano attendere l’esito
dell’udienza preliminare». L’udienza preliminare si rivela ulteriormente
deleteria: Calzia viene rinviato a giudizio per abuso d’ufficio e per un
presunto falso omissivo relativo a una dichiarazione fatta su una variante al
piano regolatore. E mentre attende la fine del processo, rimane forzatamente a
casa. «La Severino – spiega il suo avvocato – prevede la sospensione solo dopo
una condanna, non basta un rinvio a giudizio. Ma nonostante questo, Calzia è
stato sospeso con lo stipendio al 30 percento». Una situazione che dura per due
anni e mezzo, fino alla fine del primo grado di giudizio, celebrato a Torino,
«perché ad Imperia non sono stati trovati tre giudici in grado di farlo»,
sottolinea Frank. Il pro- cesso si chiude con un’assoluzione con formula piena,
impugnata dal pm per quanto riguarda l’accusa di falso e poi confermata anche in
appello. Ma nonostante ciò i problemi sul posto di lavoro non sono terminati:
«una volta assolto in primo grado – spiega il legale -, Calzia si è presentato
con la sentenza in mano chiedendo il reintegro. Prima di farlo, però, ci hanno
pensato un po’, facendo consulti e prendendo tempo». Risultato: viene sì
reintegrato, ma in un ufficio diverso. Prima finisce al Patrimonio, con un
settore creato appositamente il giorno prima e privo, dunque, di mansioni da
svolgere, e poi al settore Ecologia, dove lo stipendio è più basso e per il
quale, comunque, Calzia non ha la preparazione adatta. Ma non sembra bastare:
per il dirigente arriva infatti una nuova sospensione cautelare. «Quando era al
minimo di stipendio e non lavorava ha fatto un po’ di attività privata –
evidenzia Frank -. Ma secondo il Comune non avrebbe potuto farlo, sulla base di
un regolamento interno. Quindi è stata sospeso per altri due mesi, come se la
sentenza di assoluzione per loro non fosse valida». Un calvario condito da una
trafila di indagini nate una dopo l’altra dopo quella sul porto, tutte chiuse
con archiviazione o assoluzione. «La Procura di Imperia ha setacciato tutta la
sua vita privata, sia come dirigente pubblico sia come professionista privato e
su nove processi siamo andati a giudizio solo in tre casi, finiti tutti con
un’assoluzione con formula piena», spiega Frank. Processi nati da «consulenze
fatte male», dimostrate inattendibili e «pagate con soldi pubblici». Un
particolare che si legge anche nelle motivazioni dell’ultima assoluzione,
relativa ad un presunto abuso d’ufficio per l’autorizzazione di un complesso
edilizio vicino al mare, per il quale, secondo la Procura, sarebbe stata
necessaria una autorizzazione doganale. «La normativa non prevede che venga
chiesta oltre i 30 metri rispetto alla linea demaniale – spiega il difensore -,
ma il consulente si era rifatto a vecchie cartine catastali, tanto che la reale
distanza non era inferiore a 30 metri, come contestato dall’accusa, ma
addirittura sopra i 150 metri». Un punto evidenziato anche dai giudici: il
consulente, si legge in sentenza, «ha dichiarato di non essere a conoscenza
dell’approvazione del piano regolatore del porto di Imperia: all’evidenza, egli
non lo ha, dunque, valutato nel proprio elaborato». Una svista non da poco,
essendo costata a Calvia l’ennesimo processo e l’ennesima gogna. Il dirigente ha
ora fatto causa al Comune, per vedersi risarcito il danno subito e ingigantito
dal clima forcaiolo nato a seguito dell’indagine sul porto. «È stato un capro
espiatorio», contesta ora la famiglia. Che chiede giustizia.
PRESUNTO COLPEVOLE.
OTTAVIANO DEL TURCO.
OTTAVIANO DEL TURCO
- STORIA DI ORDINARIA ITALIANITA’.
Ottaviano Del Turco. Da Wikipedia, l'enciclopedia
libera. Ottaviano Del Turco (Collelongo, 7 novembre 1944) è
un sindacalista e politico italiano. Di ideologia socialista, è stato l'ultimo
segretario nazionale del Partito Socialista Italiano (1993-1994), ministro della
Repubblica (2000-2001) e presidente della Regione Abruzzo (2005-2008), carica
dalla quale si è dimesso in seguito al suo arresto disposto dalla Procura
di Pescara per questioni inerenti alla gestione della sanità privata. È stato
membro della direzione nazionale del Partito Democratico.
Biografia.
Inizi e carriera sindacale. Dopo la licenza media
serale emigra a Roma e inizia il suo apprendistato sindacale nella sede romana
dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA). Come sindacalista di
area PSI, entra a far parte della segreteria provinciale della FIOM di Roma e
quindi approfondisce la sua conoscenza del sindacato dei Metalmeccanici entrando
a far parte dell'ufficio di organizzazione centrale della FIOM (Federazione
Impiegati Operai Metalmeccanici) della CGIL (1968). Prosegue la carriera
sindacale, prima guidando per molto tempo la corrente socialista della CGIL e
successivamente diventando segretario aggiunto durante la segreteria di Luciano
Lama (1970-1986). Durante il Congresso del PSI del 1987 a Rimini, Del Turco,
insieme a Giacomo Mancini, Franco Piro e Giorgio Ruffolo, fu protagonista di un
intervento polemico sulla corruzione nel partito. Del Turco e gli altri tre
dirigenti socialisti, con parole sgradevoli ai craxiani, parlano di corruzione
interna al partito, chiedono pulizia e invocano ordine nelle giunte locali.
Carriera politica. Nel 1992 lascia il sindacato
e un anno dopo diventa segretario nazionale del PSI subentrando a Giorgio
Benvenuto, che aveva provvisoriamente sostituito Craxi al momento dell'uscita di
quest'ultimo dalla vita politica italiana. Il partito, sconvolto dall'inchiesta
di Mani pulite, durante la sua segreteria si sfalda, diventando prima SI
(Socialisti Italiani) e poi SDI (Socialisti Democratici Italiani). Col primo
movimento, nel 1994 Del Turco viene eletto alla Camera (XII Legislatura) nel
collegio elettorale di San Lazzaro di Savena e viene nominato vicepresidente
della Commissione Affari Esteri; nella successiva legislatura viene eletto
al Senato nel collegio di Grosseto per L'Ulivo. Dal 16 maggio 1996 al 6
febbraio 1997 è presidente del gruppo dei senatori di Rinnovamento Italiano.
Durante il secondo governo Amato (2000-2001) ricopre l'incarico di Ministro
delle Finanze. La sua attività politica è legata anche alla Commissione
Antimafia, della quale è stato presidente dal 1996 al 2000. Nel 2004 viene
eletto al Parlamento europeo nella circoscrizione sud, con 180.000 preferenze,
per la lista Uniti nell'Ulivo e si iscrive al Partito Socialista Europeo. Nelle
elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 viene eletto presidente della
Regione Abruzzo, per la coalizione dell'Unione con il 58,1% dei voti, e lascia
l'incarico di Strasburgo. Nel 2007 fonda l'associazione Alleanza Riformista con
l'intento di portare lo SDI nel Partito Democratico, in seguito al congresso
nazionale dello SDI, nel quale prevale la linea del segretario nazionale Enrico
Boselli, abbandona il partito per confluire con Alleanza Riformista nel PD. Dal
23 maggio 2007 è uno dei 45 membri del Comitato nazionale per il PD. Coinvolto
in un'inchiesta giudiziaria sulla sanità abruzzese, ha presentato le dimissioni
dalla carica di Presidente della Regione Abruzzo il 17 luglio 2008. Il Corriere
della Sera, in data 14 dicembre 2008, pubblica un'intervista all'ex presidente
Del Turco, in cui questi annuncia di stare pensando di candidarsi con il
centrodestra alle successive elezioni europee: "... tornerò a fare politica
ovunque sia possibile farlo da riformista"; la cosa tuttavia alla fine non si
concretizzerà.
La questione Ortona. Negli anni in cui era
presidente della regione Abruzzo, il suo nome è legato alla vicenda del Centro
Oli di Ortona, come favorevole al progetto di tale centro petrolchimico, contro
la forte e netta opposizione della popolazione locale, allertata dal Comitato
Natura Verde, e dei produttori vitivinicoli della zona[1]. Questo tra l'altro,
proprio a ridosso del Parco Nazionale della Costa Teatina, ancora in fase di
perimetrazione definitiva. Dalle sue dichiarazioni del febbraio 2008 si evince
una forte convinzione del benessere che comporterebbero le royalty da parte
dell'ENI, nonostante le preoccupazioni dell'Istituto Mario Negri Sud che
dichiara gravi danni alla salute nel suo documento di studio.
La questione Sale Bingo. Un'inchiesta
di Report del 1º ottobre 2002, intitolata "Dietro al Bingo", rivela alcuni
retroscena torbidi sulla "industrializzazione" del gioco della tombola
(rinominata di fatto Bingo) e i coinvolgimenti politici. In particolare Milena
Gabanelli sintetizza dicendo "Imprenditori privati e multinazionali spagnole del
gioco d'azzardo che hanno fiutato l'affare nel 1999 quando sotto il governo
D'Alema il gioco della tombola diventa Bingo. Ma il decreto legge che lo rende
operativo e che trasformerebbe in illegali tutte le tombole di quartiere nasce
il 21 novembre 2000. Ministro delle Finanze Del Turco, Ministro del tesoro
Vincenzo Visco"[3]. Coinvolti anche l'ex ministro Vincenzo Scotti, che cofonda,
assieme a Luciano Consoli (in area D'Alema), "Formula Bingo", società nella
quale è presidente, che svolge consulenze per l'apertura delle sale bingo e
rapidamente ottiene 214 delle 420 concessioni promesse dalla normativa, grazie
anche all'alleanza con Codere, una multinazionale spagnola del gioco d'azzardo.
Scotti è anche presidente di Ascob, l'associazione dei concessionari. È lo
stesso Scotti, infatti, che, in Senato, preme per rendere abusive le tombole nei
circoli.
Procedimenti giudiziari. Il 14 luglio 2008 viene
arrestato dalla Guardia di Finanza a seguito di un'inchiesta della Procura della
Repubblica di Pescara, insieme a una decina tra assessori, ex-assessori,
consiglieri ed alti funzionari della Regione Abruzzo con l'accusa di
associazione per delinquere, truffa, corruzione e concussione, nell'ambito di
un'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Pescara sulla gestione
della sanità di iniziativa privata in Abruzzo. L'accusa contesta globalmente
movimenti di denaro per circa 14 milioni di euro, di cui 12,8 consegnati; la
cifra contestata a Del Turco, Cesarone e Quarta per la presunta concussione e
corruzione ammonta a 5 milioni e ottocentomila euro. L'Abruzzo è una delle
regioni italiane con il più alto debito nella sanità. L'inchiesta della procura
pescarese si riferisce alla seconda cartolarizzazione dei crediti vantati da
cliniche private nei confronti delle ASL abruzzesi. Poco dopo l'arresto si
dimette da presidente e si autosospende da membro della Direzione Nazionale
del PD[8]. Del Turco è stato detenuto nel carcere di Sulmona (AQ) ventotto
giorni, uscendone l'11 agosto a seguito di concessione degli arresti domiciliari
da scontare nel paese natale di Collelongo. Il 16 luglio 2009 la Procura di
Pescara ha disposto il sequestro preventivo di 28 tra beni mobili e immobili,
per un valore totale di oltre 10 milioni di euro, riferiti ad alcuni indagati
nella cosiddetta “Sanitopoli” abruzzese. A Ottaviano Del Turco sono stati
sequestrati due immobili, uno a Roma e l'altro in Sardegna. Il Giudice per le
indagini preliminari ha confermato i «gravi indizi di colpevolezza a carico
degli indagati per le ipotesi di corruzione e concussione». Angelini ha detto
negli interrogatori di aver versato 5,540 milioni di euro a Del Turco e gli
altri: nel decreto si legge che «l'attività investigativa non ha ancora
consentito di tracciare l'effettiva destinazione finale di tali rilevanti
risorse economiche». L'8 gennaio 2010 vengono pubblicati sulla "Stampa" gli atti
giudiziari relativi all'inchiesta sulla sanità abruzzese che portò agli arresti
nel luglio 2008 del governatore. All'articolo della Stampa risponde il 10
gennaio 2010 Sandra Amurri su Il Fatto Quotidiano. Il 22 luglio 2013 Del Turco
viene condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di
associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e
falso. Il 20 novembre 2015 la Corte d'Appello dell'Aquila condanna Del Turco a 4
anni e 2 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere e per
induzione indebita. Del Turco viene invece assolto dalle accuse di corruzione e
falso. I legali di Del Turco annunciano ricorso in Cassazione. Il 3 dicembre
2016 la Corte di Cassazione annulla con rinvio la condanna di Del Turco per
l'accusa di associazione a delinquere. Viene invece confermata la condanna per
induzione indebita. Il 27 settembre 2017 la Corte d'Appello di Perugia assolve
poi Del Turco dall'accusa di associazione a delinquere perché "il fatto non
sussiste" rideterminando la pena in 3 anni e 11 mesi (da 4 anni e 2 mesi);
inoltre l'interdizione dai pubblici uffici viene trasformata da perpetua a 5
anni. A ottobre 2018, la Corte di Cassazione condanna definitivamente Ottaviano
Del Turco a 3 anni e 11 mesi di reclusione per induzione indebita confermando la
pena decisa nel 2017 dalla Corte d’Appello di Perugia nell’appello-bis.
Nove anni e quattro processi per scoprire
che Del Turco non è un corrotto. La Corte di appello
di Perugia ha assolto l'ex governatore abruzzese dal reato di “associazione a
delinquere” con la formula dell’insussistenza del fatto, scrive Massimo Bordin
il 28 Settembre 2017 su "Il Foglio". Ci sono voluti nove anni perché quattro
processi arrivassero a sgretolare “la montagna di prove schiaccianti” evocata
enfaticamente dal procuratore capo di Pescara Nicola Trifuoggi nel 2008, quando
venne annunciato con una conferenza stampa l’arresto di Ottaviano Del Turco,
all’epoca presidente della giunta regionale abruzzese. Ieri la Corte di appello
di Perugia lo ha assolto dal reato di “associazione a delinquere” con la formula
dell’insussistenza del fatto. I giudici umbri dovevano rideterminare la pena
comminata in appello all’esponente socialista poi passato al Pd. Ormai è rimasta
solo una pena ulteriormente ridotta per un reato di induzione. In sostanza
l’amministrazione Del Turco non era quella associazione di criminali descritta
dai pm che con la loro inchiesta ne determinarono lo scioglimento e Del Turco
non è un corrotto. La sequenza dei processi ha avuto un andamento lineare almeno
da un punto di vista. Più la sede si allontanava da Pescara, più la sentenza
appariva critica con l’impianto accusatorio. Decisiva la cassazione e ancor più
quest’ultima sentenza di Perugia. L’impasto fra magistratura e politica non può
non essere considerato un motivo plausibile dell’andamento processuale. Per lo
meno non aiuta a fugare un dubbio del genere il fatto che l’evocatore della
montagna di prove, che alla fine si è sbriciolata, abbia nel frattempo, una
volta andato in pensione, rivestito il ruolo di vicesindaco e poi di candidato,
sia pure con scarsa fortuna, alla massima carica comunale.
Crolla il teorema dei pm, Del Turco assolto 9 anni
dopo. Un’odissea giudiziaria iniziata 9 anni fa, scrive Errico Novi il 28
Settembre 2017 su "Il Dubbio".
L’APPELLO CANCELLA L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE. LA
DIFESA: ORA LA REVISIONE. Mentre la Corte d’appello di Perugia assolve Ottaviano
Del Turco dall’accusa di associazione a delinquere, il Senato si accinge ad
approvare il ddl sui piccoli comuni. Del Turco viene da uno di questi,
Collelongo, nell’Aquilano. Ha preso la licenza media alle scuole serali, se n’è
venuto a Roma, si è fatto le ossa con la fatica e da sindacalista vero, che può
parlare della fatica altrui perché conosce la propria. Forse per questo i
giudici non gli avevano creduto, in primo e in secondo grado. E forse per questo
i compagni che con l’ex governatore dell’Abruzzo avevano fondato il Pd, lo
avevano scaricato il giorno stesso dell’arresto, nel luglio del 2008. Del Turco
ha il volto scavato dell’operaio di provincia, non il profilo levigato della
sinistra borghese. Di chi, come Walter Veltroni, nel pieno della tormenta gli
disse: «Spero riuscirai a provare la tua innocenza». Secondo la Corte d’appello
di Perugia, dunque, è certo che Ottaviano Del Turco, da presidente della
Regione, non ha fatto parte di alcuna associazione a delinquere. Nel ultimo
rivolo del processo sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzese, innescato dal rinvio
della Cassazione, i giudici hanno fatto cadere il capo d’imputazione più odioso
e ricalcolato la pena in 3 anni e 9 mesi. «Cade in modo rovinoso e definitivo
l’intero impianto della Procura», commenta a caldo il difensore di Del Turco,
Gian Domenico Caiazza. Non c’è la rete associativa. Restano cinque asseriti casi
di induzione indebita a dare o commettere utilità. Episodi in cui l’ex
governatore avrebbe ricevuto denaro dal suo unico accusatore, l’ex re delle
cliniche Vincenzo Angelini. Ha preso quei soldi per favorire l’imprenditore? Ha
modificato la politica sanitaria regionale per ricambiare le generose dazioni?
Niente di tutto questo. «Del Turco continuò a fare un sedere così ad Angelini».
Allo straordinario avvocato Caiazza si potrà perdonare il francesismo. I cinque
episodi corruttivi restano dunque sospesi nel nulla, ma restano e non avrebbe
potuto essere altrimenti. La Corte d’appello di Perugia era stata chiamata dalla
Cassazione solo a decidere se c’era l’articolo 416. Non avrebbe potuto
rivalutare nel merito le altre accuse.
L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE? UN FANTASMA. Cade
l’associazione a delinquere, «perché il fatto non sussiste», anche per gli altri
quattro imputati “rinviati”, come Del Turco, davanti al giudice di secondo
grado. Si tratta dell’ex segretario della Presidenza all’epoca della giunta Del
Turco, Lamberto Quarta, dell’allora capogruppo della Margherita in Consiglio
regionale Camillo Cesarone, degli ex assessori alla Sanità Bernardo Mazzocca e
alle Attività produttive Antonio Boschetti. Il sistema organizzato non c’è più.
E non si capisce appunto, come facciano a esserci i singoli 5 illeciti residui,
di induzione indebita da parte di Del Turco nei confronti di Angelini. «Viene
meno la struttura stessa dell’accusa», spiega il difensore. Non a caso ora l’ex
governatore e i suoi legali dicono: «Non è finita qui, adesso andiamo per la
revisione del processo». In modo da cancellare tutto.
OTTAVIANO NON ASCOLTA LA LETTURA DELLA SENTENZA.
Lui, Ottaviano, è a Perugia ma non se la sente di stare in aula al momento della
pronuncia. C’è suo figlio Guido, giornalista del Tg5, che in questi casi è la
sua ombra. E l’avvocato Caiazza. Sono loro due ad abbracciarlo e a comunicargli
che un altro pezzo di incubo si è dissolto. Persino l’interdizione dai pubblici
uffici è stata ridimensionata a 5 anni, da che era “perpetua”. «Resta quello
schizzo di fango esiziale», lamenta il difensore. Le cinque induzioni indebite.
Niente rispetto ai 24 capi d’imputazione contestati nel 2008 dalla Procura di
Pescara. Troppe, anzi, tutte intollerabili dal punto di vista di chi si professa
innocente.
STORIA DI UN PROCESSO, E DI UN ACCUSATORE,
ROMANZESCHI. ll 14 luglio di 9 anni fa Del Turco viene arrestato con le accuse
di corruzione, concussione, truffa, falso e associazione a delinquere. La
Sanitopoli abruzzese nasce coi botti. Finisce in carcere un’altra decina di
persone tra consiglieri regionali, assessori e alti funzionari
dell’Amministrazione. Tutto gigantesco. Ma sorretto da un solo, unico pilastro:
Vincenzo Angelini appunto. Accusa tutti, e Del Turco più di tutti, di avergli
sfilato tangenti per 5 milioni e 800mila euro. Contati. Solo per Del Turco i
capi d’imputazione sono 24, una quindicina riguardano appunto le mazzette
all’ineffabile imprenditore. Fanno, in primo grado, una condanna a 9 anni e 6
mesi. Si va in appello e, nel novembre 2015, il conto è assai più che dimezzato.
Oltre all’associazione a delinquere, restano in piedi solo 5 dei capi
d’imputazione relativi alle asserite tangenti. Il precedente conto virtuale e
immaginario di quasi 6 milioni si riduce a 600mila euro. La condanna scende a 4
anni e 2 mesi. Cadono le accuse sui reati “strumentali”. Nel caso di Del Turco
il falso, per gli altri imputati gli abusi d’ufficio. E già lì il colpo
all’impianto accusatorio è letale. Intanto perché le 5 dazioni sopravvissute del
governatore a Angelini si reggono praticamente tutte su quella, leggendaria per
così dire, della busta piena di mele con cui il magnate sanitario viene via da
casa Del Turco a Collelongo, dopo averla svuotata di bigliettoni. La prova? Foto
della busta coi bigliettoni, foto della busta con mele, foto sfocatissima che
ritrae due figure indistinguibili. Sembra Fantozzi. È la prova regina, anche per
la Corte d’appello dell’Aquila, che almeno quella mazzetta è passata nelle mani
dell’ex presidente. Il quale quel giorno, il 2 novembre 2007, era a casa, ma con
ospiti istituzionali che non ricordano affatto la misteriosa visita.
Sopravvivono altre 4 dazioni per “riverbero” dalla prima. Secondo la impegnativa
costruzione della sentenza di secondo grado, sono vere perché sarebbe provata
quella delle mele e perché, anche in questi altri quattro casi, i riscontri dei
passaggi Telepass forniti da Angelini non sono chiaramente improponibili. «Prima
di Del Turco la Regione Abruzzo sfrondava la spesa sanitaria per 50mila euro
l’anno di ‘ inattività inappropriate’, con lui si è arrivati in 3 anni a
tagliarle per 100 milioni di euro: ora capite da dove nasce questo processo?»,
urlò inutilmente Caiazza davanti ai giudici d’appello.
LA PRONUNCIA CHE LA CASSAZIONE TROVA “ILLOGICA”.
Si arriva in Cassazione. Non si possono più rivedere i cinque episodi di
induzione indebita: la Suprema corte non è giudice di merito. Ma può, e lo fa,
rilevare che l’accusa di associazione a delinquere è illogica, così come
formulata dalla sentenza di secondo grado: non ci sono i reati strumentali di
falso e abuso, ci dite allora come funzionava quest’associazione a delinquere
che non produceva alcunché? Ecco perché il 3 dicembre dell’anno scorso la
Cassazione annulla la pronuncia d’appello con rinvio, per competenza, ad altra
Corte, quella di Perugia. Va riformulato con altri presupposti o cancellato il
reato associativo.
IL LAPSUS DEL PG CHE CHIEDE UNA PENA TROPPO BASSA.
Siamo a ieri, quando puntualmente l’associazione a delinquere cade per tutti, a
cominciare da Del Turco. Nel suo caso ai 4 anni e 2 mesi della condanna
precedente vengono sottratti i 3 mesi del articolo 416, ed ecco il
rideterminazione di 3 anni e 9 mesi. Ma vorrà dire, vorrà pur dire qualcosa, il
fatto che il sostituto procuratore generale Giuliano Mignini non solo chieda di
cancellare quel capo d’ imputazione e rivedere così complessivamente al ribasso
tutte le condanne; ma che nel formulare la richiesta per Del Turco esageri
addirittura. Mignini chiede di portarla a 1 anno e 9 mesi. «È un errore,
purtroppo, solo un errore tecnico, perché il minimo per l’induzione indebita è 3
anni e poi c’è l’asserita continuazione del reato», commenta Caiazza in attesa
della sentenza. Quel lapsus però resta. «Ben rappresenta quale sia anche da
parte della Procura generale l’apprezzamento di gravità del fatto che residua
rispetto all’indagine di 9 anni fa». Nulla, appunto. Solo un ultimo schizzo di
fango.
Del Turco: «Se ce l’ho con i pm? No, ce
l’ho con il populismo giudiziario». «Mi sono liberato
di un macigno sia psicologico che morale. Ora punto alla revisione del processo
per dimostrare la mia piena innocenza», scrive Giulia Merlo il 28 Settembre 2017
su "Il Dubbio". «Ora voglio la revisione del processo, per dimostrare la mia
piena e totale innocenza». L’ex presi- dente della Regione Abruzzo, Ottaviano
Del Turco, è raggiante mentre torna in auto da Perugia, dopo la sentenza che lo
assolve dall’accusa di associazione per delinquere. Il cellulare squilla in
continuazione, mentre lo scandalo “Sanitopoli” abruzzese si sgretola, dopo quasi
dieci anni dai primi arresti. Del Turco, detenuto 28 giorni nel carcere di
Sulmona e poi agli arresti domiciliari, era stato condannato in primo grado a 9
anni e 6 mesi, ridotti in appello a 4 anni e due mesi con una sentenza che viene
poi annullata con rinvio dalla Cassazione. Fino ad ieri, quando l’ultima
sentenza della Corte d’Appello «mi ma liberato dall’aberrante accusa di essere a
capo di una associazione per delinquere».
Onorevole, è soddisfatto degli esiti della
sentenza? Rimane in piedi la condanna per induzione indebita a dare o promettere
utilità.
«Soddisfazione
è dire poco, mi sono liberato da un macigno che mi opprimeva. Lei non sa quanto
mi sia pesata, sia dal punto di vista psicologico che morale, l’accusa di essere
a capo di un’associazione per delinquere. Non trovo parole per descriverle
quanto sia importante per me la sentenza di oggi».
La vicenda è chiusa, ora?
«Sono
felicissimo di questo primo passo verso la chiusura. Lo ricordava lei: rimane in
piedi la condanna per induzione indebita, ma non è definitiva e mi batterò in
giudizio perché cada anche quella. Ora, infatti, è il momento di trarre le
conseguenze dell’assoluzione dall’accusa di associazione per delinquere: tutte
le altre ipotesi di reato si giustificavano con l’esistenza dell’associazione,
ma senza questa non hanno ragion d’essere. Questo sarà il tema del futuro
giudizio».
Quale sarà la sua prossima mossa processuale?
«Punto a
ottenere la revisione del processo. Come dicevo, il reato fondamentale a me
contestato era quello associativo ed è stato distrutto da questa sentenza. Su
questo si reggeva l’impianto accusatorio che tiene in piedi le altre ipotesi di
reato. Ora voglio ottenere la piena assoluzione».
Lei, al momento dell’arresto, era governatore
della Regione Abruzzo e dirigente del Partito Democratico. Ha ricevuto
solidarietà dai colleghi di partito, in questi anni di battaglia processuale?
«Guardi, le
posso dire di aver ricevuto moltissima solidarietà diretta, con centinaia e
forse addirittura migliaia di telefonate di solidarietà, con molti che hanno
definito vergognosa l’inchiesta contro di me. Ecco, ora penso che queste parole
possano venire pronunciate anche pubblicamente, non solo a me per telefono».
Forse, ora, sente di poter vantare qualche
credito anche nei confronti della politica?
«Assolutamente
no. La prego, mi lasci passare qualche ora a crogiolarmi nella soddisfazione di
aver smontato accuse mostruose nei miei confronti».
Nessun proverbiale sassolino dalla scarpa?
«Le dico la
verità: non esco da questa vicenda con la voglia di rimettere in discussione gli
equilibri politici di questo o quel partito, non sono quel genere di persona.
Glielo assicuro, dalla meraviglia della sentenza di oggi trarrò conseguenze
personali e non politiche».
La sua carriera politica è stata azzerata da
questa inchiesta giudiziaria. Si sente di recriminare qualcosa ai magistrati che
l’hanno indagata?
«Io sono un
militante di un grande movimento democratico e vengo dalla tradizione
socialista. Ho partecipato alle battaglie del Partito Democratico di questi anni
e non metto in alcun modo in discussione le regole e gli ideali della
democrazia. Anzi, le dico che questa sentenza rafforza la mia fiducia nella
giustizia: da oggi, la mostruosità che si chiamava associazione a delinquere non
pesa più sulle mie spalle».
Il suo non è il solo caso di politico finito
imbrigliato da inchiesta giudiziarie. E’ in atto in questo senso un conflitto
tra politica e magistratura?
«Il fatto che
l’associazione per delinquere sia caduta nei confronti miei e degli altri
imputati fortifica ulteriormente la fede nella politica, che ho conservato
intatta in questi anni. Io spero però che la sentenza rimanga impressa nella
mente di tutti quelli che hanno voluto giocare sulla pelle della politica,
perché la smettano con il populismo giudiziario».
Sanitopoli in Abruzzo, la Cassazione
annulla la condanna a Del Turco. Ora si dovrà
celebrare un nuovo processo per riscrivere la sentenza d’appello emessa dalla
Corte d’Appello dell’Aquila, scrive Sergio Rame, Sabato 3/12/2016, su "Il
Giornale". L'inchiesta e il processo sulle presunti tangenti
nella sanità abruzzese hanno di fatto stroncato la sua carriera politica. Oggi,
però, la Cassazione ha annullato la sentenza che lo aveva visto condannare per
associazione a delinquere. E delle accuse granitiche di cui aveva parlato il
procuratore capo nel giorno dell’arresto non resta più nulla. Per l'ex
governatore della Regione Abruzzo, Ottaviano del Turco, si profila così un nuovo
processo. Tutto da rifare. Si riparte dalla Corte d'Appello, ancora una
volta. "Questa vicenda e quattro processi si frantumano con questa sentenza
della Cassazione - commenta Del Turco - tutto ciò è la prova della situazione
drammatica in cui versa il sistema giudiziario. Fortunatamente sono salvo perchè
ci sono ancora molti magistrati fedeli ai principi della Costituzione". Per l'ex
governatore, ieri sera, i supremi giudici della VI sezione penale
della Cassazione hanno, infatti, disposto un processo d'appello-bis sulla
"Sanitopoli" Abruzzo trasmettendo gli atti alla Corte di Appello di Perugia.
Viene così a cadere il teorema su Del Turco che lo aveva visto condannato per il
reato di associazione a delinquere. Diventa definitiva, invece, la condanna per
induzione indebita. I giudici di Perugia, dunque, oltre a riesaminare la
questione del reato associativo, dovranno determinare la pena e le statuizioni
civili relative al reato di induzione indebita. Del Turco fu arrestato il 14
luglio 2008 assieme ad altre nove persone, tra cui assessori e consiglieri
regionali. L'ex governatore fu detenuto in carcere a Sulmona per 28 giorni e,
poi, trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. Qualche giorno dopo
l'arresto, il 17 luglio 2008, Del Turco si dimise dalla carica di presidente
della Regione e, con una lettera, si autosospese dal Pd, di cui era stato uno
dei saggi fondatori e membro della direzione nazionale. Da quel momento ha avuto
inizio il calvario giudiziario. La sentenza d'appello, che lo aveva condannato a
quattro anni e due mesi di reclusione, ha però dimezzato la pena dopo aver
demolito gran parte del castello di accuse che al primo grado erano state prese
per buone. Le accuse, come aveva dimostrato anche ilGiornale, sono sempre
provenute da un solo teste e non sono mai riuscite a dimostrare alcun passaggio
di mazzette. "Il processo ha costruito una montagna schiacciante di fango -
commenta ancora Del Turco - sono passati cinque anni dall'arresto e tutto si
risolve con macchie di fango sul viso di persone perbene". L'ex governatore non
dimentica quei ventotto giorni di isolamento in una cella a Sulmona: "Un letto,
una porta con le sbarre e quattro secondini che mi controllavano a vista. Forse
pensavano che mi sarei suicidato. Invece sono stati i processi a frantumarsi".
La parola ai Manettari.
Sanitopoli Abruzzo, per Del Turco
Cassazione conferma induzione indebita e annulla associazione a delinquere.
Dovranno essere rideterminate le pene per le tangenti dello scandalo che
coinvolse l'ex governatore e alcuni componenti della sua giunta. L'ex
parlamentare fu condannato in primo grado a nove anni e sei mesi e in secondo a
quattro anni e due. "Non trovo in questa vicenda nessun altro senso, se non la
evidente necessità di dare una parvenza, seppure grottesca, di giustificazione
alla infamia che ha travolto una giunta regionale democraticamente eletta e con
essa la vita mia e di molti di noi" dice l'imputato, scrive "Il Fatto
Quotidiano" il 3 dicembre 2016. Dovranno essere rideterminate le pene per le
tangenti della Sanitopoli abruzzese che videro l’ex parlamentare e presidente
dell’Abruzzo Ottaviano Del Turco, condannato in primo grado a nove anni e sei
mesi e in secondo a quattro anni e due. La Cassazione ha infatti annullato con
rinvio la condanna d’appello in relazione all’accusa di associazione a
delinquere, ma ha confermato le tangenti con l’imputazione di induzione
indebita che prima della legge Severino rientrava nel reato di concussione. Ad
accusare Del Turco, che fu arrestato il 14 luglio 2008 per una lunga serie di
reati tra cui anche la corruzione, l’abuso e falso, l’ex titolare della clinica
privata Villa Pini di Chieti, Vincenzo Angelini, che rivelò ai magistrati di
aver pagato tangenti per 15 milioni di euro in cambio di favori. Tra il primo e
l’appello alcune accuse sono cadute, gli episodi corruttivi sono passati da 24 a
6 e davanti ai supremi giudici è arrivata l’associazione a delinquere
finalizzata all’induzione indebita, che è stata confermata. Il giro di denaro,
alla fine, è stato quantificato per Del Turco e gli altri imputati in 800mila
euro. Tre le “dazioni” di denaro per l’ex parlamentare. Gli atti ora verranno
inviati alla Corte di appello di Perugia. Ma la prescrizione maturerà prima
della fine del prossimo anno. I magistrati umbri dovranno rideterminare
il trattamento sanzionatorio per Del Turco, gli altri imputati, tra i quali l’ex
assessore abruzzese alla sanità, Gabriele Mazzocca, e altri funzionari e
componenti della vecchia giunta di centrosinistra, caduta sotto i colpi di
questa inchiesta. Il legale di Del Turco, l’avvocato Giandomenico Caiazza, e le
difese degli altri imputati, hanno sottolineato come le accuse fossero state
mosse da un “bancarottiere seriale, condannato a più di 20 anni di reclusione
per una distrazione di fondi pari a 105 milioni di euro”. “Spero che questo
incubo termini e che a Ottaviano Del Turco sia restituita interamente la piena
dignità: è un galantuomo che non ha mai preso nemmeno un euro di tangenti, è una
‘riserva’ della Repubblica e non si può distruggere una persona senza nessuna
prova”, aveva sottolineato l’avvocato Giandomenico Caiazza nella sua arringa.
Angelini però è stato ritenuto credibile dai giudici di appello che lo hanno
assolto dall’accusa di corruzione, dopo che in primo grado era stato condannato
a tre anni e sei mesi. Per il pg della Cassazione Aldo Policastro, che durante
la requisitoria aveva chiesto la conferma della sentenza d’appello, Del Turco,
insieme con amministratori della sua giunta, ha commesso “abuso esplicito dei
suoi poteri, in riferimento alla grave situazione di dissesto finanziario in cui
si trovata l’imprenditore Angelini”. L’accusa ha definito “esplicite” le
modalità delle richieste di tangenti. Tra gli imputati e l’imprenditore, ha
proseguito il pg “non c’era nessuna par condicio contrattuale”. Quella nei
confronti di Angelini, titolare di alcune cliniche convenzionate con la Regione,
è stata una “azione preordinata per ricattarlo subdolamente” come emerge dalla
“trattativa sulla vendita della clinica Villa dei Pini”. “La Cassazione ha
confermato definitivamente il reato di corruzione, che era il cuore
dell’inchiesta: il passaggio di denaro c’è stato, e questo conferma la
correttezza del processo” dice l’ex procuratore capo della Procura di
Pescara, Nicola Trifuoggi, all’epoca capo del pool che insieme ai pm Giampiero
Di Florio e Giuseppe Bellelli, diedero il via all’indagine. “Ora la Corte
d’Appello di Perugia dovrà solo ricalcolare la pena dopo che è stato invece
cancellato il reato di associazione per delinquere – chiude Trifuoggi – ma si
tratta di un argomento tecnico per rimodulare la condanna, condanna che è
definitiva”. “L’ex procuratore di Pescara esulta per la sentenza della Corte di
Cassazione nei confronti di Ottaviano Del Turco. In fondo, lo apprezzo: sapersi
accontentare di poco una virtù” scrive in una nota il legale Caiazza. “La
Giustizia italiana, e le connesse risorse pubbliche necessarie, sono state
impegnate per anni di processi e migliaia di pagine di verbali ad occuparsi
delle strabilianti prove sul falso ideologico nella prima cartolarizzazione; su
abusi di ufficio per budget provvisori manipolati, emendamenti
legislativi segretamente modificati, documenti indebitamente sottratti alla
legittima conoscenza pubblica, ispezioni sanitarie illegittime, ed una congerie
di altre simili fandonie. Tutto questo al fine di prendere per ben 21 volte
denaro da Angelini, per oltre 6 milioni di euro, dei quali nessuno ha saputo
fornire prova nemmeno per un centesimo”. Sottolineando le sentenze della Corte
di Appello, della Cassazione, il legale ricorda che “residuano, galleggiando
incomprensibilmente il quel mare di assurdità, tre dazioni di denaro che Del
Turco avrebbe richiesto ed ottenuto Dio sola sa perché. Il dottor Trifuoggi ci
si lancia sopra, brandendole per cantare vittoria. È il degno finale di questa
tragica farsa”. “La montagna di prove che doveva schiacciarmi, si è dimostrata
per quello che era: una montagna di fango” dice Del Turco. “Quando sei sommerso
da una montagna di fango e riesci a non soffocare è quasi impossibile che non ti
rimanga addosso qualche schizzo. Già la corte di appello mi aveva assolto da
tutti i reati di abuso e di falso ideologico. E da 18 delle 21 fantasiose
dazioni di denaro che avrei ricevuto, e delle quali non è mai stato trovato un
solo euro. Ora si dissolve anche l’associazione per delinquere. Non trovo in
questa vicenda nessun altro senso, se non la evidente necessità di dare una
parvenza, seppure grottesca, di giustificazione alla infamia che ha travolto una
giunta regionale democraticamente eletta e con essa la vita mia e di molti di
noi”.
La parola ai Manettari.
Del Turco condannato ma assolto, la
post-verità di un corrotto, scrive Alberto Vannucci,
Professore di Scienza Politica, il 10 dicembre 2016 su "Il Fatto Quotidiano".
L’hanno chiamata post-verità, è l’ultima frontiera di una politica
destrutturata. Prodotto di strategie di chirurgica divulgazione di notizie
fraudolente, amplificate nella loro propagazione dai social network.
Rappresentazioni menzognere impermeabili a qualsiasi smentita, persino quella
del fact-checking, il controllo dei fatti tipico del giornalismo tradizionale,
che giunge in ritardo risultando così impotente. Nel tempo accelerato delle
nuove tecniche di comunicazione la pseudo-realtà artefatta e illusoria ha già
centrato il suo obiettivo: fissare nella mente dei destinatari, specie quelli
appartenenti a specifiche cerchie emotivamente affini (simpatizzanti, militanti,
“amici di”, etc.), un’immagine o una convinzione sulla quale qualsiasi
contro-informazione ancorata alla verità scivola come acqua. La post-verità ha
già plasmato il mondo a propria immagine e somiglianza. Siamo di fronte a forme
di abuso della credulità popolare già note come leggende metropolitane, che
vedono incrementare esponenzialmente la propria velocità e potenza diffusiva
grazie ai flussi continui di informazioni generate dai nuovi media. Altra novità
contemporanea è il loro impiego scientemente programmato da politici
opportunisti per manipolare le opinioni pubbliche e il consenso. Donald Trump,
il candidato più bugiardo nella storia d’America, non è stato eletto nonostante,
ma grazie alle sue menzogne, che nessun ragionamento razionale è riuscito a
smontare o confutare. Circa il 77 per cento delle sue affermazioni sono
risultate false o non del tutto veritiere, durante la campagna elettorale si è
calcolata la media record di una sua bugia ogni 3 minuti e 15 secondi. Una
recente vicenda italiana – in parte eclissata dal cataclisma referendario –
mostra un’applicazione autoctona, non priva di originalità, di questo meccanismo
sofisticato di disinformazione. Nel caso italiano, o meglio abruzzese, la
strategia della post-verità non è stata utilizzata per ottenere voti, ma per
la riabilitazione di un politico corrotto. Stranamente poi il suo canale
originario di diffusione, ancor prima della circolazione in rete, è stata
proprio la stampa tradizionale – a dimostrazione che le classifiche sulla
“libertà di stampa” che collocano l’Italia in una posizione sconfortante non
sono poi così ingannevoli. Alla vigilia del referendum costituzionale quasi
tutti i principali quotidiani nazionali e locali – tra le poche eccezioni
proprio Il Fatto Quotidiano – danno notizia dell’apparente assoluzione
di Ottaviano Del Turco, ex-segretario socialista, ex-membro della direzione del
Pd ed ex-presidente della Regione Abruzzo, arrestato nel 2008 per le tangenti
ricevute da un imprenditore operante nel settore sanitario. Almeno, l’innocenza
del politico ingiustamente crocifisso dalla magistratura è la post-verità
inoculata nel discorso pubblico. Difficile interpretare altrimenti i titoli che
la Repubblica, La Stampa, Il Corriere, Il Sole 24 Ore, Il Giornale dedicano al
caso, in buona sostanza: “La Cassazione annulla la condanna a Del Turco”. A
corroborare questa interpretazione la generosa concessione di spazio alle tesi
dell’avvocato difensore: “Spero che questo incubo termini e che a Ottaviano Del
Turco sia restituita interamente la piena dignità: è un galantuomo che non ha
mai preso nemmeno un euro di tangenti, è una ‘riserva’ della Repubblica”. Lo
stesso “post-corrotto” si concede un’intervista autocelebrativa su La Stampa, in
cui rievocando “l’infamia che mi ha travolto” proclama: “Mi hanno restituito
l’onore. Doveva schiacciarmi una montagna di prove. Si è ridotta a una montagna
di fango. E uno schizzo mi è rimasto addosso. Ma io sono innocente”. Soltanto
un’attenta esegesi dei testi giornalistici permette di ricostruire meglio la
natura maleodorante dello “schizzo di fango”. E’ la verità giudiziaria della
vicenda, massima approssimazione della verità fattuale cui si è giunti al
termine di un lungo e difficile procedimento. E non è cosa da poco. Si tratta
della condanna di Del Turco e complici, resa definitiva dalla Cassazione, per
cinque tangenti, corrispondenti a un totale di 850mila euro, riscosse dietro
“indebita induzione” – corrispondente al vecchio reato di concussione – e del
rinvio a un altro processo d’appello per ridefinire la pena da scontare e
rigiudicare l’accusa di associazione a delinquere. Già incombe la prescrizione,
magica rete di salvataggio per tutti i criminali in colletto bianco d’Italia, e
questo forse spiega l’esultanza dei protagonisti. Ma soltanto nel mondo
rovesciato del malaffare italiano, dove la post-verità dei corrotti si sposa con
l’acquiescenza di una stampa connivente (o collusa) e con una cittadinanza
indifferente (o confusa), può accadere che il politico colpevole conclamato di
un grave reato di quasi-concussione, col quale si è depredata la sanità
abruzzese per centinaia di migliaia di euro, celebri pubblicamente la propria
condanna definitiva come “restituzione dell’onore” e dichiari di volerla
festeggiare “a Collelongo, il mio paese, dove tanti in strada mi hanno
abbracciato commossi”. E così, in questo abbraccio solidale al corrotto, si
realizza anche simbolicamente il trionfo della post-verità all’italiana.
Sanitopoli Abruzzo, Del Turco: "Solo una
montagna di fango". Il figlio Guido: "Una via Crucis,
ma orgoglioso di essergli stato vicino". Trifuoggi: "Soddisfazione per conferma
condanna corruzione", scrive il 3 dicembre 2016 “La Repubblica”. L'ex
governatore d'Abruzzo, Ottaviano Del Turco (ansa)ROMA - "La montagna di prove
che doveva schiacciarmi, si è dimostrata per quello che era: una montagna di
fango". Così l'ex governatore dell'Abruzzo, Ottaviano Del Turco, ha commentato
la sentenza della Cassazione della notte scorsa. "Quando sei sommerso da una
montagna di fango e riesci a non soffocare è quasi impossibile che non ti
rimanga addosso qualche schizzo. Già la Corte di Appello mi aveva assolto da
tutti i reati di abuso e di falso ideologico. E da 18 delle 21 fantasiose
dazioni di denaro che avrei ricevuto, e delle quali non è mai stato trovato un
solo euro. Ora si dissolve anche l'associazione per delinquere. Non trovo in
questa vicenda nessun altro senso, se non la evidente necessità di dare una
parvenza, seppure grottesca, di giustificazione alla infamia che ha travolto una
giunta regionale democraticamente eletta e con essa la vita mia e di molti di
noi", ha concluso. "La sentenza si commenta da sola. Oggi finalmente la
Cassazione ha demolito definitivamente l'ipotesi che la giunta Del Turco fosse
un'associazione per delinquere", ha detto l'avvocato Giandomenico Caiazza. "Non
puntiamo alla prescrizione - ha spiegato l'avvocato -. La Corte di Cassazione ha
annullato con rinvio la condanna, ciò vuol dire che o la Corte d'appello di
Perugia troverà un'argomentazione diversa per ritenere che ci sia
un'associazione per delinquere, oppure ci deve assolvere". "L'assoluzione
prevale sulla prescrizione - ha insistito Caiazza - Perugia si deve pronunciare
e spiegare alla Cassazione perchè eventualmente non ritiene di assolverci.
Seppur volessimo immaginare astrattamente che la Corte d'appello volesse
ricondannarci di nuovo, con motivazioni diverse, per associazione a delinquere,
allora scatterebbe la presa d'atto della prescrizione del reato. Ma a noi non
interessa, andremo a Perugia e saremo assolti. Il giudice può applicare la
prescrizione solo nel caso in cui non ritenga doveroso assolvere". Caiazza ha
comunque espresso soddisfazione per la sentenza "È l'ennesima demolizione
definitiva dell'accusa originaria". Il figlio dell'ex governatore, Guido, ha
scritto sulla sua pagina Facebook: "La sentenza è arrivata a mezzanotte, ricevo
un mucchio di telefonate mentre cerco di prepararmi per andare a lavoro. Quello
che ha deciso la Cassazione non mi è ancora chiaro. Sto bevendo litri di caffè
per combattere l'effetto di calmanti presi nella giornata di ieri, dunque
davvero a quest'ora non ho ancora capito nulla. Ho solo compreso che ci vorranno
altri anni prima della parola fine". "Una via Crucis infinita - aggiunge Guido
Del Turco -, ma di una cosa sono felice ed orgoglioso, che mio padre mi abbia
dato la possibilità di stargli accanto, di vivere con lui le amarezze le
sofferenze in questi anni. Sono tra i pochi giornalisti ad aver letto tutte le
carte, che gridano la sua innocenza, ed il lavoro fatto per risanare la sanità
in Abruzzo. Ha pagato, sta pagando un prezzo umano troppo alto all'amore per la
sua terra. Alle parole di un bancarottiere condannato da più tribunali. Ci
vorranno altri anni per mettere la parola fine, forse, almeno per me, è una
delle ragioni per le quali vale la pena di vivere e lottare", conclude.
Soddisfazione invece è stata espressa dall'ex procuratore capo di Pescara,
Nicola Trifuoggi: "La Cassazione ha confermato definitivamente il reato di
corruzione, che era il cuore dell'inchiesta: 'Il passaggio di denaro c'è stato,
e questo conferma la correttezza del processo", ha detto l'ex procuratore capo
della Procura di Pescara, Nicola Trifuoggi, all'epoca capo del pull che insieme
ai pm Giampiero Di Florio e Giuseppe Bellelli, diedero il via all'indagine dopo
le rivelazioni dell'imprenditore della sanità Vincenzo Angelini. "Ora la Corte
d'Appello di Perugia dovrà solo ricalcolare la pena dopo che è stato invece
cancellato il reato di associazione per delinquere - chiude Trifuoggi - ma si
tratta di un argomento tecnico per rimodulare la condanna, condanna che è
definitiva". Il caso. Del Turco in appello era stato condannato a 4 anni e 2
mesi di reclusione, una pena più bassa rispetto a quella inflitta in primo
grado, paria 9 anni e mezzo. L'ex governatore dell'Abbruzzo, nell'ambito di
questa indagine, fu arrestato il 14 luglio 2008 assieme ad altre nove persone,
tra cui assessori e consiglieri regionali. Detenuto in carcere a Sulmona per 28
giorni, De Turco trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. Qualche
giorno dopo l'arresto, il 17 luglio 2008, si dimise dalla carica di presidente
della Regione e, con una lettera, si autosospese dal Pd, di cui era stato uno
dei saggi fondatori e membro della direzione nazionale.
Era il 2008 e l’allora presidente
dell’Abruzzo fu arrestato come un tangentaro e costretto alle dimissioni, senza
che nessuno, nel Pd, dicesse una parola in sua difesa.
E adesso, dopo la singolare ammissione dell’accusa, non viene chiesta
l’assoluzione, ma una semplice riduzione della pena…scrive Pierluigi Battista
per il “Corriere della Sera” il 17 novembre 2015. Adesso persino l'accusa, nel
processo d' appello a Ottaviano Del Turco, ammette che non ci sono «riscontri»
sulle presunte tangenti incassate dal governatore dell'Abruzzo costretto a
dimettersi nel 2008, dopo essere stato arrestato nottetempo, come i peggiori
malfattori: cioè, in parole povere, non si trovano, non si sa nemmeno se
esistano. Ci arrivano adesso, meglio tardi che mai. Ma si sapeva già, lo
sapevano tutti, bastava solo informarsi e non uniformarsi a priori ai bollettini
stampa della Procura. Solo l'accusa, i giornali forcaioli e i giudici della
sentenza di primo grado non se n'erano accorti: quelle tangenti non si
trovavano, il presunto corruttore è stato creduto sulla parola, anni e anni di
indagini non hanno scoperto niente, si è accusato un uomo di aver intascato
tangenti mai trovate. Non c'erano «riscontri». Un uomo è andato in galera senza
riscontri. Si è dimesso senza riscontri. All' indomani dell’arresto di Del
Turco, il procuratore Trifuoggi, nella oramai rituale conferenza stampa (è la
nuova moda) in cui chi conduce le indagini emette mediaticamente un verdetto
preconfezionato di colpevolezza, aveva detto che quei riscontri c' erano ed
erano addirittura «schiaccianti». Disse proprio così: «schiaccianti». Così
schiaccianti che per trovare queste benedette tangenti hanno chiesto più volte
supplementi di indagine: niente. L' accusatore si è fatto un videoselfie
mettendo in evidenza il contante che avrebbe consegnato a Del Turco, ma poi si è
dimenticato di accendere il registratore nel momento della consegna: anche qui
mancano i riscontri, audio e video. Si dice che per condannare, occorre avere la
certezza della colpevolezza di un imputato al di là di ogni dubbio. Ma la
mancanza di «riscontri» è stata considerata una certezza e non un dubbio.
Venerdì dovrebbe esserci la sentenza d' appello. L'accusa, appena ammessa la
mancanza di «riscontri», cioè dell'oggetto stesso del reato, ha chiesto una
riduzione della pena. Riduzione? Avremmo un primo caso di pena, ancorché
ridotta, senza «riscontri». Certe cose non possono accadere? No, in Italia
accadono. È accaduto a Del Turco che un magistrato, poche ore dopo l'arresto,
abbia parlato di prove «schiaccianti». È accaduto che i media abbiano nella
grande maggioranza fatto proprie le certezze senza «riscontri» dell'accusa. È
accaduto che una Regione d' Italia abbia cambiato equilibri senza che il Pd
spendesse una sola parola a favore di Del Turco. Questa sì, che è storia
riscontrata.
E’ morto Ottaviano Del Turco,
scrive Roberta Galeotti su "Formiche" il 14/07/2014. Lunedì 14 luglio 2008 è
morto l'uomo politico Ottaviano Del Turco. La sua storia politica avrebbe
meritato un epilogo migliore. L'ex ministro si è ritirato tra le montagne
abruzzesi, dipinge e scrive. Nell’era delle morti virali sul web dei grandi
personaggi pubblici, diamo l’annuncio della morte politica dell’ultimo
segretario nazionale del partito Socialista, ex ministro delle Finanze ed ex
presidente della Regione Abruzzo. Il 14 luglio 2008 è terminata la carriera
politica di Ottaviano Del Turco tranciata dalle accuse di Vincenzo Angelini e
dalla valanga di prove annunciata dal procuratore capo Nicola Trifuoggi. «Avrei
voluto scegliere io il momento in cui ritirarmi dalla scena politica e,
soprattutto, ritengo che la mia storia politica meritasse tutt’altro epilogo» il
commento di Del Turco all’indomani dello scandalo mediatico che lo investì,
cosiddetto Sanitopoli. Sono trascorsi 6 lunghissimi anni e, dopo un estenuante
processo, il presidente dimissionario si è visto condannare a 9 anni e 6 mesi
con un capo d’accusa modificato. A sessantanove anni l’ex presidente, ex
ministro, ex onorevole, ex senatore non può più programmare la sua vita politica
e preferisce, causa forza maggiore, «vivere qui, a Collelongo – dice ostentando
noncuranza -, a casa mia guardando dove sorge il sole, da Pescara». La sua lunga
e dignitosa storia politica comincia quando, neo licenziato alla scuola media,
iniziò il suo apprendistato sindacale nella sede romana dell’Istituto Nazionale
Confederale di Assistenza (INCA). Come sindacalista di area PSI, entrò nella
segreteria provinciale della FIOM di Roma e quindi approfondì la sua conoscenza
del sindacato dei Metalmeccanici entrando a far parte dell’ufficio di
organizzazione centrale della FIOM (Federazione operai Metalmeccanici) della
CGIL (1968). Alla guida per molto tempo della corrente socialista della CGIL,
diventò segretario aggiunto durante la segreteria di Luciano Lama (1970-1986).
Nel 1992 lasciò il sindacato e un anno dopo diventò segretario nazionale del
PSI subentrando a Giorgio Bencenuto, che aveva provvisoriamente sostituito Craxi
all’indomani dell’inchiesta Mani Pulite. Nel 1994 Del Turco venne eletto alla
Camera durante la XII Legislatura con lo SDI e venne nominato vicepresidente
della Commissione Affari Esteri; nella legislatura successiva venne eletto al
Senato e ricoprì il delicato ruolo di presidente della Commissione antimafia
(1996-2000). Durante il secondo governo Amato (2000) gli venne affidato
l’incarico di Ministro delle Finanze. Nel 2004 venne eletto al Parlamento
Europeo nella circoscrizione sud, con 180.000 preferenze, per la lista Uniti
nell’Ulivo e si iscrisse al Partito Socialista Europeo. Ebbe l’incarico di
presidente della Commissione Affari Sociali, la terza commissione per
importanza. Nelle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 venne eletto
presidente della Regione Abruzzo, per la coalizione dell’Unione con il 58,1% dei
voti, dimettendosi dall’incarico di Strasburgo. Il resto della storia l’abbiamo
raccontato in questi approfondimento. Come chiudere questa 5 giorni? Ho avuto
l’onore di conoscere Ottaviano Del Turco, volevo che poteste conoscerlo un po’
meglio anche voi! Ambivo a cercare di raccontare quello che per sei lunghi anni
si sapeva ma non si poteva dire. Ora le prove schiaccianti sono venute fuori ma
contro qualcun altro e con molto meno clamore che se avessero trovato i 6
milioni di euro di tangenti ‘consegnati‘ a Del Turco. Non conoscevo il
presidente Del Turco prima di affrontare un colloquio per la selezione del
responsabile della sua segreteria ad aprile 2005. Abbiamo lavorato insieme per
tre lunghi e duri anni. Ho potuto svolgere un master di alta politica a fianco a
lui, quando la metà degli uomini politici abruzzesi non aveva il coraggio di
incrociare il suo sguardo. E’ stato un uomo scomodo per la politica locale, non
malleabile agli accordi e alle spartizioni, affatto avvezzo ad accondiscendere
ai poteri forti. L’ex presidente della regione ha cercato di far volare alto
questo piccolo Abruzzo e, oggi, ne paga il fio. Oggi vende i suoi quadri più
preziosi per vivere e pagare le spese legali di un assurdo processo che lo ha
ucciso. Il 14 luglio 2008 è morto l’uomo politico Ottaviano Del Turco.
Così il Pd isolò Ottaviano Del Turco.
Riproponiamo il racconto della nostra Paola Sacchi,
scritto per Panorama nell’Aprile 2013. Nel giorno in cui la cassazione ha
annullato con rinvio il reato di associazione per delinquere per Ottaviano Del
Turco – caposaldo dell’intero impianto accusatorio nell’inchiesta sulla sanità
abruzzese – ecco un episodio su come l’ex governatore, ex numero 2 della Cgil di
Luciano Lama e ultimo segretario del Psi, fu di fatto isolato dai suoi
“compagni” del Pd. Ad eccezione di Enrico Letta che unico della sinistra in
Transatlantico nel 2011 andò da lui per salutarlo. Lo sfogo amaro di “Ottaviano”
e il saluto di “Enrico” nel racconto della nostra Paola Sacchi scritto per
Panorama.it nell’Aprile 2013, nei giorni dell’incarico di Letta a premier. Era
un paio di anni fa. Un pomeriggio a Montecitorio. Transatlantico affollatissimo,
tutti i big presenti. Arriva Ottaviano Del Turco, l’ex senatore eletto dal Pd,
finito nella bufera dell’inchiesta giudiziaria sulla sanità abruzzese. Solo
alcuni cronisti parlamentari, compresa chi scrive, gli si avvicinano. Ottaviano,
l’ex segretario generale aggiunto della Cgil di Luciano Lama, il socialista che
lavorò sempre per l’unità dei lavoratori, ma che sul decreto della scala mobile
difese fino in fondo le ragioni di Bettino Craxi, trattato come un appestato dai
suoi “compagni” del Pd. Chi gli passa vicino e abbassa lo sguardo, chi si
allontana, chi fa finta di aver ricevuto una telefonata sul cellulare. Del
Turco, l’ultimo segretario del Psi, li guarda con compassione. E si sfoga con il
cronista: “Guarda che roba… Ho incrociato giorni fa uno di questi signori vicino
al Senato. Pioveva a dirotto. Lui ha abbassato l’ombrello sulla sua faccia pur
di non incontrare il mio sguardo ed essere costretto a salutarmi…”. Ma a un
certo punto l’ultimo segretario di Via del Corso interrompe lo sfogo con il
cronista. Si alza dal divanetto dove è seduto. C’è Enrico Letta che è venuto a
salutarlo. L’unico (del Pd) a farlo. E quel giorno Letta neppure sapeva che le
foto, che misero Del Turco nel frullatore del processo politico, mediatico,
giudiziario fino a sbatterlo in galera, fossero taroccate! Ma il codice di un
Letta (Enrico nipote di Gianni) mette il rispetto degli altri prima di tutto.
Vedremo ora se il giovane “Enrico” saprà resistere politicamente nella
formazione del governo agli spiriti settari ed estremisti del suo partito.
Del Turco: “Sinistra complice di un
enorme errore giudiziario. Renzi si liberi dei giustizialisti”,
scrive Paola Sacchi il 3 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Parla lex governatore e
sindacalista: Il populismo giudiziario è una malattia di questa Repubblica. Chi
è stato complice della mia vicenda non può offrire latto riparatore che ha fatto
la Corte di Cassazione. Il figlio Guido, nostro caro collega, giornalista
politico del Tg5, su Facebook scherzando ha confessato di stare ancora bevendo
litri di caffè per annullare l’effetto dei calmanti presi ieri notte (tra il 2 e
il 3 dicembre) prima della sentenza della Cassazione. Ottaviano Del Turco al
telefono, che gli squilla ininterrottamente da questa mattina (3 dicembre) alle
6 risponde a Il Dubbio, dichiarando tutta la sua gioia per l’annullamento (con
rinvio) del reato più infamante, caposaldo di tutto l’impianto accusatorio
nell’inchiesta sulla sanità abruzzese, ovvero quello di associazione a
delinquere. Lex governatore parla anche del suo Sì al referendum, di Lama,
Craxi e Renzi. Onorevole Del Turco (ex di tante importanti cose: numero 2 di
Luciano Lama alla Cgil, ultimo segretario del Psi, presidente di Regione,
senatore) è soddisfatto? Sono molto contento di concludere la mia vicenda
politica con una dichiarazione che dice: io non sono il capo di un’associazione
a delinquere ma un uomo che ha dato qualcosa di sé alla storia della Repubblica,
alla storia delle istituzioni della Repubblica. È una cosa che mi riempie di
gioia, che probabilmente è anche la sanzione giusta al termine di un processo
incominciato con una montagna di fango e che finisce con una montagna di
riconoscimenti alla dirittura della mia esperienza alla guida della Regione
Abruzzo. Purtroppo non è ancora del tutto finita la sua odissea giudiziaria. La
questione fondamentale è che era rimasto in piedi un reato grande come un
palazzo: l’associazione a delinquere. Ora questo reato non c’è più. Questa è la
grande vittoria della sentenza di ieri. Una cosa che veramente mi riempie di
gioia. Si è sentito abbandonato dalla sinistra in questi lunghi e amari anni? Sì
e continua nella sua ostinazione. Perché la sinistra è stata complice di un
errore giudiziario pazzesco. E dunque quelli che sono stati complici di questo
non possono offrire l'atto riparatore che ha fatto la Corte di Cassazione. La
sinistra ha abbandonato la battaglia garantista? Sì, il garantismo è una cosa
penosa in questo Paese. Si è garantisti spesso con le cause dei tuoi amici,
invece il garantismo è una regola costituzionale fondamentale che consente una
vita e una dialettica civile mettendo insieme idee anche molto diverse. Però,
insomma non si può avere tutto dalla vita. A me piacerebbe avere una sentenza
che mi cancella i reati e che cancella dal dibattito tutti i giustizialisti
cresciuti nel corso di questi anni. C’è una formula usata da Luciano Violante
che io trovo molto bella. Violante ha parlato di populismo legato alle vicende
giudiziarie. Il populismo giudiziario è una malattia di questa Repubblica. Tutte
le sentenze che riaffermano sia i valori del garantismo sia i valori della
Repubblica sono sentenze che vanno benedette. E quella di ieri è una di queste.
Chi l’ha chiamata? Qualche nome ce lo può dire? No, intanto perché non voglio
dimenticare nessuno e ci rimarrei male, perché sono state veramente tante le
persone che mi hanno chiamato. E poi soprattutto non voglio far torto a chi
avrebbe voluto chiamarmi e non ha potuto farlo. Io ringrazierò tutti quanti, uno
ad uno, con la telematica, le lettere, le cartoline, le telefonate, tutto, non
tralascerò niente e nessuno. Telefonate bipartisan? Sì, è da stamattina alle 6
che rispondo al telefono. Lei esprime una grande storia della sinistra
riformista italiana, alla Cgil era il segretario generale aggiunto di Lama. Che
ricordi ora le vengono in mente? Non mi faccia commuovere parlandomi di Luciano,
perché è stata una delle persone più importanti della mia vita. Domenica 4
dicembre intanto si vota per il referendum. Che farà? Domenica si vota e io ho
una ragione in più per votare Sì. Anche al premier Renzi, che è segretario del
Pd, consiglia di battersi di più per il garantismo? Sì, spero che lui sia sempre
garantista. D’altro canto per essere molto rispettati quando sei garantista devi
essere molto severo con i giustizialisti. Renzi dovrebbe correggere quella
definizione su Bettino Craxi liquidato come la sinistra dell’opportunismo,
mentre Enrico Berlinguer è stato chiamato la sinistra dell’opportunità? Penso
proprio di sì! Però queste polemiche della sinistra sono cose che
drammaticamente non interessano più a nessuno. Nessuno più si entusiasma per una
rissa tra ex socialisti e ex comunisti. Ma sono storie che avrebbero bisogno di
altro. Io sono orgoglioso della mia storia dentro la quale c’è quella bella,
gloriosa, piena anche di errori, del Partito socialista. Ma io sono nato in
quella storia. E quella storia mi seguirà finché vivo.
Storia di Mike, che ha
chiesto solo “verità e giustizia per Ottaviano Del Turco”. Chiacchierata di
Chiara Rizzo su “Tempi” con l’inventore di una pagina facebook di
contro-informazione sul caso dell’ex governatore: «Non è merito mio: è solo
gente che ha voglia di sapere come funziona la giustizia».Mike Ballini è un
geometra di 34 anni di Firenze. Un tipo come tanti, che si interessa di musica e
a volte di politica: quanto di più lontano, insomma, dalle aule di un tribunale.
Eppure è lui che ha inventato una pagina facebook su un caso giudiziario sempre
più discusso, che in pochi mesi ha raggiunto 700 utenti fissi, e in una
settimana, in un tam tam incredibile, fino a 55 mila contatti. La pagina si
chiama “Verità e giustizia per Ottaviano Del Turco”: vuole diffondere notizie e
una sorta di “controinformazione”, in un momento in cui del processo all’ex
governatore dell’Abruzzo accusato di concussione si parlava solo su qualche
giornale locale, su Tempi e su Radio radicale (che segue e registra tutte le
udienze): «Non ho fatto nulla – racconta Ballini a tempi.it – e sono stupito io
stesso: ho pensato solo che facebook poteva essere uno strumento utile per
raccontare una storia di cui nessuno parlava più, dopo le prime pagine del
giorno degli arresti cautelari di Del Turco. Non ho fatto nulla, ma ho visto che
c’è solo molta gente che vuole davvero giustizia».
Cominciamo da
lei. Chi è? E perché si è appassionato a questa vicenda?
«Sono un ragazzo di 34 anni di Firenze e faccio il geometra. Il caso Del Turco
mi ha sempre colpito, lo seguivo come semplice curioso, perché mi faceva tornare
in mente un altro caso, quello di Enzo Tortora. Ci vedevo dei parallelismi:
perché anche Del Turco è stato arrestato con clamore tremendo e poi, quando
iniziavano a uscire notizie, diciamo così, “diverse” (come le indagini su
Vincenzo Angelini) tutto veniva un po’ dimenticato. Di queste ultime svolte
nell’inchiesta si leggeva poco o nulla sui giornali nazionali. Perché no? Allora
ho cominciato a spulciare i giornali locali e il web per cercare qualcosa in
più. E mi sono fatto l’idea che Del Turco fosse del tutto innocente: del tutto,
non solo un po’.»
Dica la
verità, lei è amico o parente di Del Turco.
«Assolutamente no. Non l’ho nemmeno mai conosciuto fino a ottobre dell’anno
scorso, quando avevo creato già da diversi mesi la pagina. Non sapevo nemmeno
che voce avesse, se non avessi trovato una sua intervista su Radio radicale.
Semplicemente mi sono detto che volevo fare qualcosa per far conoscere questa
vicenda, per non lasciarla finire nel dimenticatoio.»
E su che basi
si è convinto dell’innocenza di Del Turco?
«Mettendo insieme i pezzi. La sua giunta stava appianando il deficit nella
Sanità, e questo poteva dare fastidio a chi approfittava di altri tipi di
benefits, come magari un imprenditore quale Angelini, il suo accusatore. Quando
ho letto delle indagini su Angelini, mi sono persuaso. Così ho creato la pagina
Facebook. Ho ripreso tutti i piccoli articoli, gli interventi che leggevo in
giro e poi le dirette di Radio radicale e li ho resi pubblici. La pagina l’ho
avviata a maggio 2013: all’inizio contava giusto un centinaio scarso di
persone.»
E Del Turco?
Lo ha conosciuto?
«Sì, qualche tempo dopo su facebook ho preso contatti diretti con lui. Gli ho
detto: «Vorrei fare qualcosa per te, ma non per un tornaconto personale». A
ottobre 2012 ci siamo conosciuti per la prima volta di persona. E finora è stato
anche l’unico incontro. Non abbiamo parlato di carcere o della sua vicenda
giudiziaria, ma conversato di tutt’altro, ed è stato bello. Ero emozionato, e
anche lui immagino. Gli occhi si illuminavano quando parlava di musica.
Nonostante quello che gli è capitato, questa persona aveva la forza di
emozionarsi dentro, mentre noi spesso ci inaridiamo per molto meno.»
Del Turco di
recente ha voluto ringraziarla, definendo la sua pagina “una finestra sul
mondo”. «In queste
ultime settimane in cui la difesa ha iniziato a demolire le accuse, la stampa ha
ripreso a parlare della vicenda con completezza, e noi siamo arrivati a 700
persone fisse in pochi giorni. Ho ripubblicato allora alcuni articoli di
giornale. Ciò che rende facebook un motore potentissimo è che le attività delle
persone vengono condivise in un passaparola che può diventare esponenziale. Così
è successo anche per noi: abbiamo ripubblicato le immagini dei titoli che
smascheravano alcune incongruenze di questa vicenda, su Il Giornale,
Repubblica, e L’Unità. C’è stato un tam tam pazzesco. Non è merito
mio: secondo me ‘è solo gente che ha voglia che sia fatta giustizia davvero. E
questo spazio è stato un modo anche per Del Turco di raccontarsi, sebbene non
dovesse fare niente, perché pubblico tutto io. Ecco: è una finestra sul mondo.»
Cosa l’ha
colpita di più di questa sua attività?
«Ho voluto che questa pagina fosse un posto libero, dove ognuno può esprimere la
propria opinione. Ho notato così che ci sono stati molti messaggi di
incoraggiamento, ma anche altri che invece mi raccontavano altre storie: “Colgo
l’occasione di segnalare la vicenda del detenuto x o y ingiustamente carcerato”.
Ecco, per me il senso di questa pagina è proprio questo, riportare fuori dalla
sabbia, dalla cenere, vicende di malagiustizia che sono dimenticate ma non
ancora concluse, e perciò vanno raccontate, perché sino ad oggi, anche quando se
ne è parlato, lo si è fatto in modo parziale. Non mi piace invece quando qualche
utente strumentalizza questo spazio o le vicende per parlare di politica. E tra
le miriadi di post di incoraggiamento, c’è anche qualche insulto. Ma tutto
questo l’ho lasciato comunque, perché se faccio una pagina per chiedere verità e
giustizia, non sarò certo io a censurare alcunché.»
Intanto il processo
cosa dice?
Le questioni relative
alla giustizia e al suo pessimo funzionamento tornano ciclicamente d’attualità,
scrive Walter Vecellio su Notizie Radicali. L’attualità, beninteso, scandita dai
giornali e dai mezzi di comunicazione (per non dire di una classe politica, che
non perde occasione per rivelarsi e dimostrarsi sorda e miope), perché chi ha la
sventura di rimanervi impigliato, quell’“attualità” la conosce bene. E non ci si
riferisce tanto alle iniziative di Silvio Berlusconi, e alle chiassate a palazzo
di Giustizia di Milano dei suoi deputati, seguita dalla minaccia di gettare il
paese nel caos. Piuttosto si pensa a vicende come quella che ha per protagonista
Ottaviano Del Turco. E’ il 14 luglio 2008, Del Turco era presidente della
Regione Abruzzo quando viene arrestato con l’accusa di corruzione sugli appalti
sanitari regionali. Prove schiaccianti, assicurarono gli inquirenti, grazie alla
testimonianza, determinante e decisiva, dell’ex re delle cliniche private della
regione, Vincenzo Angelini. Cinque anni dopo di quelle prove schiaccianti e
inoppugnabili non c’è traccia; solo che a svelare l’inconsistenza di tutto il
castello accusatorio non sono stati gli inquirenti, che pure facilmente e
doverosamente avrebbero dovuto e potuto farlo, ma la difesa di Del Turco. Chi
doveva e poteva vedere, non ha voluto e potuto. Così sono trascorsi cinque anni.
Del Turco ha patito una lunga e dolorosa carcerazione, è stato costretto alle
dimissioni, la sua giunta travolta. Chi chiede scusa, ora? Anche se non c’è,
evidentemente, risarcimento che possa sanare tutto ciò. Quel che è più grave è
che chi sbaglia non paga mai. Intanto la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
ha nuovamente condannato il nostro paese, per irragionevole durata dei processi.
Nel caso specifico, la Corte rileva che «la procedura fallimentare di un
creditore è durata circa 16 anni e 1 mese per un grado di giurisdizione”. Segue
la formula incollata in tutte le sentenze di condanna: «La Corte a più riprese
ha trattato delle istanze che sollevavano questioni simili a quella del caso di
specie ed ha constatato una ignoranza/incomprensione dell'esigenza del «termine
ragionevole», considerando i criteri derivanti dalla sua ben consolidata
giurisprudenza in materia”. E c’è ancora chi dice che quella della Giustizia, di
come non viene amministrata, la questione del diritto e della legalità violata,
non sono le vere, grandi urgenze di questo paese, e rimprovera ai radicali
l’errore di crederlo, e di operare di conseguenza!
Il castello di carte è
venuto giù, quasi improvvisamente, con quello che Vincenzo Angelini ha chiamato
un «coup de theatre», scrive Roberto Rossi sul “L’Unità”. Perché è stato proprio
questo: un colpo di scena. Al processo contro Ottaviano Del Turco in corso a
Pescara la credibilità dell’ex re delle cliniche d’Abruzzo, nonché principale
teste, Angelini appunto, è franata in un istante. Ed è crollata proprio su
quella che era stata la prova regina: la foto o, meglio, le foto. Famose,
famosissime, la pistola fumante con la quale la Procura di Pescara ordinò
l’arresto dell’ex governatore nel luglio 2008. In tutto erano tredici e
rappresentavano il fulcro dell’accusa allora guidata dal procuratore Nicola
Trifuoggi. Le principali, tutte consequenziali, ritraevano le varie fasi del
pagamento della tangente a Del Turco: il denaro dentro una busta di carta, una
sagoma che entrava nella casa dell’ex presidente della Regione a Collelongo e,
infine, una busta identica alla prima ma piena di mele e noci. Per tutta la
durata del processo l’ex imprenditore della sanità abruzzese, a giudizio a
Chieti per bancarotta, ha messo sempre una data certa a quegli scatti: il 2
novembre 2007. Ma da ieri foto e giorno non corrispondono più. Gli scatti sono
stati fatti prima, nel 2006. Angelini, dunque, secondo le prove della difesa,
mente. Su quelle foto, su quella data, ha costruito una larga fetta della sua
credibilità, mentre la procura ha montato troppo in fretta l’accusa. Senza
quella data saltano le ricostruzioni della presunta concussione perpetrata dalla
giunta del Turco e il quadro processuale diventa uno schizzo astratto. E il
castello frana. Ma come si è riusciti a retrodatare quelle foto? Per capire come
si è materializzato il colpo di teatro si deve partire dall'analisi della
macchina fotografica di proprietà proprio di Vincenzo Angelini. Ed è quello che
ha fatto il consulente tecnico della difesa, Giacomo Gloria, sul materiale
fornito dalla Procura pescarese. Gloria non ha fatto nulla di particolare se non
analizzare la memoria della macchina stessa, una comunissima Panasonic Dmc-Fz25.
Nonostante qualche scatto sia stato cancellato a mano, nella memoria della
Panasonic ci sono 132 foto. Quasi tutti leggibili, tranne qualcuna sovrascritta.
Ogni scatto ha un nome e una numerazione progressiva, assegnato in automatico
proprio dalla stessa macchina e non modificabile se non lasciando una traccia.
Dunque, le 132 foto sono tutte consequenziali e non sono state manomesse. Le
prime ottanta non hanno una grande valore processuale. Ci sono ritratte delle
belle auto, di cui Angelini amava circondarsi. Solo una può dirsi importante: vi
si vede una signora, una collaboratrice dell’imprenditore, che legge un
giornale. Il quotidiano porta la data del 16 giugno 2006. La foto, la numero 48,
è rilevante perché permette di stabilire con certezza una data di partenza. La
macchina fotografica è stata usata sicuramente per la prima volta dopo quel
giorno. E poi, quando? Il problema è proprio questo, quando? Secondo Angelini,
gli scatti successivi, da 82 a 95, quelli della presunta tangente, porterebbero
la data del 2 novembre 2007. Cioè un anno e mezzo dopo. E queste foto hanno
elementi che consentono una datazione? No, ma le successive sì. Perché,
nonostante dalla macchina fotografica qualcuno le abbia cancellate, ci sono
degli scatti rimasti in memoria successivi a quelli della probabile mazzetta.
Sono quelli che vanno da 96 a 132. Recuperati dallo stesso tecnico della procura
ma non utilizzati dai magistrati. Ritraggono una piccola frana dovuta a una
rottura di condotta presso la zona dei depuratori di Villa Pini, la clinica più
grande posseduta da Angelini (oggi all'asta), e alcuni lavori di manutenzione.
Chi li ha fatti? La ditta Emoter. E quando? In un periodo compreso tra settembre
e novembre 2006. La difesa, guidata dall'avvocato Giandomenico Caiazza, ne è
certa. Tanto che sul banco dei testimoni ha chiamato il proprietario della
società, Filippo Colanzi, e l’architetto che diresse i lavori, Fabio Pacillo, a
confermare il tutto con fatture e bolle alla mano. Inoltre, proprio quell'area,
a seguito dello smottamento, il 30 giugno 2006 fu sottoposta a sequestro dal
Corpo forestale dello Stato e successivamente, il 14 settembre 2006
temporaneamente dissequestrata per permettere l’esecuzione dei lavori.
Addirittura l'architetto ricorda anche che la frana fu fotografata dallo stesso
autista di Angelini, Dario Sciarrelli. Se con la stessa macchina lo si può solo
supporre. Ma è un particolare secondario. Quello che interessa, invece, è altro.
Secondo la memoria della macchina fotografica, le istantanee che dovrebbero
accusare Ottaviano Del Turco furono fatte un anno e mezzo prima di quello
dichiarato in aula da Angelini, in un periodo che può essere collocabile tra il
marzo del 2006 e il novembre dello stesso anno (in base ai lavori di
riparazione, al sequestro del corpo forestale e, da ultimo, alle fatture della
Emoter). Perché, allora, Angelini avrebbe mentito? E perché la procura non ha
considerato di visionare tutta la memoria della macchina fotografica? Tra
l’altro non è l’unica manchevolezza da parte dei pm. In cinque anni di indagini,
ad esempio, non hanno mai acquisito i telepass dell’auto che la Regione aveva
messo a disposizione per Ottaviano Del Turco. È importante? Certo. Ieri,
infatti, grazie alla testimonianza degli autisti e ai loro rapporti di servizio,
con i quali registravano tutti gli spostamenti dell’ex governatore, si è intuito
che Angelini potrebbe aver mentito ancora. Perché mentre l’ex re delle cliniche,
ieri cacciato dall’aula su ordine del presidente Carmelo De Santis per ingiurie
nei confronti del collegio difensivo e della stampa, sosteneva di essere
ricevuto a Collelongo, Del Turco avrebbe potuto trovarsi altrove. Magari in
missione con la propria auto. Per capire meglio questo punto, tra l’altro, il
Tribunale ha ordinato l’acquisizione dei movimenti telepass relativi proprio
all’auto blu di Del Turco. Inoltre il tribunale ha anche ordinato di acquisire
dalla società Autostrade tutti i movimenti di entrata al casello dell’auto di
Angelini. Per poter meglio comprendere come sia possibile, ad esempio, viaggiare
a 185 chilometri orari di media sull'autostrada A25 con i lavori in corso.
Finora Angelini ha attribuito qualità magiche al suo autista. La procura gli ha
creduto. Ma l’imprenditore ha dimostrato di non essere affidabile. Il castello è
crollato. Rimetterlo in piedi sarà arduo.
PRESUNTA COLPEVOLE. MARTA VINCENZI.
Marta Vincenzi: «Caro Nogarin ti aspetta
il mio stesso calvario», scrive Errico Novi il 17
gennaio 2018 su "Il Dubbio". Parla Marta Vincenzi, ex sindaco di Genova,
indagata come il primo cittadino di Livorno per l’alluvione che ha colpito la
città. «E certo, ho suggerito a Filippo Nogarin di fare un bel respiro profondo
e di trovare un equilibrio interiore». Non è rassicurante. «No che non lo è»,
conviene Marta Vincenzi, «ma la realtà purtroppo è questa: attualmente la
normativa su protezione civile e emergenze fa ricadere una responsabilità totale
e irragionevole sui sindaci. Tutta su di loro, su di noi se penso che mi trovo a
fronteggiare una situazione come questa. Credo che le forze politiche dovrebbero
assumere un preciso impegno elettorale: dare attuazione alla legge delega di
riordino della protezione civile da poco pubblicata in Gazzetta ufficiale. Un
provvedimento quadro importante, se venisse completato con i contenuti che
servono. A partire da una più sensata condivisione delle responsabilità di
fronte a eventi meteo avversi». Marta Vincenzi è il solo amministratore di una
grande città ad aver già pagato il prezzo che ora si chiede al primo cittadino
di Livorno. Proprio mente Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo
plurimo, e chiede alla magistratura di «accertare le responsabilità», mentre
oltre al primo cittadino la Procura accusa anche il comandante della polizia
municipale Riccardo Pucciarelli della stessa ipotesi di reato, mentre insomma
davanti ai suoi occhi si dipana una sequenza che ben conosce, l’ex sindaca di
Genova solleva il nodo di una disciplina «figlia dell’abbrutimento e
dell’ignoranza». Condannata in primo grado a 5 anni di carcere per omicidio
colposo plurimo, disastro e altri reati relativi all’esondazione del torrente
Ferreggiano che il 4 novembre 2011 provocò otto vittime a Genova, Vincenzi si è
sempre considerata «innocente».
Il travaglio sarà inevitabile anche per
Nogarin?
«L’ho detto
nell’intervista al Corriere della Sera. Le norme introdotte a metà degli anni
Duemila lasciano pochi margini: sarà un iter giudiziario in salita. Nel mio caso
son passati 6 anni e si è concluso solo il primo grado».
In Italia siamo sempre più a caccia del
colpevole?
«È il mood di
questi anni: è un meccanismo di semplificazione. Ma più che sulla filosofia
vorrei concentrarmi su questioni concrete».
Ovvero?
«Le norme
appunto. Vede, io no voglio entrare nel merito dell’indagine sul sindaco di
Livorno, così come non intendo parlare del mio processo. Ma ci sono alcuni
aspetti che ricorrono, in questo tipo di vicende giudiziarie: e dipendono dal
meccanismo normativo di responsabilità nel sistema della protezione civile, che
a un certo punto si inceppa».
Dove esattamente?
«Nel libro che
pubblicherò a marzo, per il quale siamo ormai in dirittura d’arrivo con
l’editore, ricostruisco tutto. C’è stata una fase negli anni Novanta in cui la
materia è stata regolata da interventi interessanti: la legge 225 del 1992 e le
norme che definirono il cosiddetto metodo Augustus. Erano baste sul principio
della collaborazione e della condivisione di responsabilità tra una pluralità di
soggetti. Non solo i sindaci, dunque. Sulla base di quelle norme i Comuni
avrebbero dovuto adottare i piani di emergenza».
E lo fecero?
«Proprio perché
non tutti li adottavano, e nessuno controllava, si è pensato bene di stravolgere
la disciplina e di far ricadere tutta l’autorità, e di conseguenza la
responsabilità nelle emergenze dovute a eventi meteo, sui soli sindaci. Secondo
un meccanismo per cui se non ci sono vittime tutti hanno lavorato bene, in caso
di tragedia è solo colpa del primo cittadino».
Irragionevole, in effetti.
«Ci sono
macchine organizzative complesse che richiederebbero ben altra modularità
normativa. E invece il sistema spinge ormai i sindaci alla cosiddetta gestione
difensiva: si eccede nelle misure, si chiude tutto. E col cavolo, mi scusi il
francesismo, che si sviluppa la cosiddetta società della resilienza, cioè
procedure che maturano dalle esperienze condivise di una pluralità di soggetti».
Perché il legislatore è stato così
superficiale?
«Sulla scia di
un abbrutimento e di un’ignoranza in cui la politica è man mano scivolata. Qui
non c’entra la logica del potere decentrato, del federalismo, ma del
menefreghismo: se la vede il sindaco, son fatti suoi».
Crede davvero nell’attuazione della delega?
«La legge dovrà
essere riapprovata dal nuovo Parlamento, la delega cioè deve essere riaffermata
in capo all’esecutivo che verrà. Sarebbe un tema assai più degno della campagna
elettorale rispetto alle polemiche sul sindaco più o meno inadeguato,
cinquestelle o di altro partito che sia».
Sulla base di quella legge le Procure devono
per forza indagare i sindaci?
«Sì, anche se
in casi diversi dal mio, come quello delle Cinque terre che si verificò nello
stesso periodo della tragedia di, alla fine non si è andati a processo. Però è
sostanzialmente inevitabile che un sindaco sia indagato per omicidio colposo, in
casi come quelli di Genova e Livorno».
Tornerà a fare politica?
«No, ho 70 anni
e come diciamo a Genova, ’ emo già deto, abbiamo già dato. Ma voglio comunque
far conoscere le mie riflessioni su questi temi a chi la politica si appresta a
farla. Peraltro non saprei con chi stare, non mi riconosco in nessuna proposta».
Certe norme rischiano di dissuadere le persone
perbene dall’impegno pubblico?
«Il rischio
c’è. Poi c’è anche una strana legge per cui una persona perbene accetta di fare
politica nonostante si debba essere davvero un po’ matti per non darsela a gambe».
PRESUNTI COLPEVOLI. GIULIO E MARIA FRANCESCA
OCCHIONERO.
Cyberspionaggio, condannati
rispettivamente a 5 anni e 4 anni i fratelli Occhionero.
Giulio e Maria Francesca sono accusati dalla procura di Roma di cyberspionaggio
per aver «spiato» per anni migliaia di computer appartenenti a società, partiti
e istituzioni, scrive il 17/07/2018 Edoardo Rizzo su "La Stampa". Sono stati
condannati rispettivamente a 5 anni e 4 anni di carcere l’ingegnere, Giulio
Occhionero, e sua sorella Maria Francesca, entrambi accusati dalla procura di
Roma di cyberspionaggio per aver «spiato» per anni migliaia di computer
appartenenti a società, partiti e istituzioni. Per i due il pm Albamonte aveva
sollecitato condanne di 9 e 7 anni di reclusione. L’ingegnere Occhionero,
secondo la procura, avrebbe in sostanza creato una rete «botnet» che sfruttando
un virus che entrava nei computer da colpire attraverso un messaggio email, gli
permetteva di accedere e carpire informazioni da pc infettati, tra cui dati,
password e messaggi. Sono oltre 18 mila i computer «colpiti» da Occhionero: fra
questi, di 1935 pc l’ingegnere aveva anche le relative password, e quindi ne
aveva il pieno controllo, ha detto il pm in aula. Per l’accusa, all’ingegnere
nucleare Giulio Occhionero spetta la «responsabilità di avere concepito,
pianificato e alimentato dal 2001 un sistema per l’acquisizione» di un numero
enorme di dati. Tra i bersagli, c’erano i computer di grandi aziende e quelli di
istituzioni politiche ed economiche fra cui Camera, Senato, ministeri di Esteri
e di Giustizia, Partito Democratico, Enav, Finmeccanica e Bankitalia. Ma non
solo. C’erano, infatti, anche gli indirizzi mail dell’ex premier, Matteo Renzi;
quello del presidente Bce, Mario Draghi il noto conduttore della trasmissione di
Rai Uno «Porta a Porta», Bruno Vespa, il procuratore generale della Corte
d’Appello di Roma, Giovanni Salvi, e Maurizio Selli del Movimento 5 Stelle
(consigliere comunale a Civita Castellana). Non è il solo filone d’inchiesta che
coinvolge gli Occhionero. Giulio e Francesca Maria la procura di Roma contesta,
in altra indagine, anche lo spionaggio politico (un reato per il quale è
prevista la pena di 10 anni di carcere) sulla base di una informativa di oltre
250 pagine redatta dagli esperti della Polizia Postale che, grazie alla
collaborazione fornita dagli esperti dell’Fbi, sono riusciti a sbloccare i
server utilizzati negli Usa dai due fratelli e ricostruire l’intera rete creata
su 9 computer riconducibili agli Occhionero.
Spionaggio informatico, condannati i
fratelli Occhionero, scrive il 17 luglio 2018 Alessio
Porcu. Condannati i due fratelli romani arrestati lo sorso anno con l'accusa di
spionaggio informatico. Alcune loro società avevano avuto la sede
nell'appartamento in cui aveva risieduto Licio Gelli. Sospettati di incursioni
anche nei computer del Gruppo Ini e della Toti Trans.
Nulla è stato spiato da Frosinone. Più di qualcosa
invece a Frosinone è stato cercato. Si è concluso con due condanne il processo
ai fratelli Occhionero, arrestati il 9 gennaio del 2017 per la loro attività di
cyberspionaggio. (Leggi qui Le spie di Renzi e Monti stavano in via Brighindi a
Frosinone). Il giudice del tribunale di Roma Antonella Bencivinni ha condannato
l’ingegnere nucleare Giulio Occhionero a 5 anni di reclusione e la
sorella Francesca Maria Occhionero a 4 anni. Li ha giudicati colpevoli del reato
di accesso abusivo a un sistema informatico: in pratica avere violato le caselle
di posta elettronica, sia personali che istituzionali, di professionisti del
settore giuridico-economico, esponenti della politica o riconducibili ad Enti
pubblici. Al momento di procedere con l’arresto, tra le reti informatiche
‘visitate’ dagli Occhionero c’erano anche quelle di grandi aziende e di
istituzioni politiche come Camera, Senato, ministeri di Esteri e Giustizia,
Partito Democratico, Finmeccanica, Bankitalia, Comune di Roma ed Enav. Inoltre
c’erano i computer del gruppo sanitario Ini (con sedi a Veroli e Grottaferrata),
della Toti Trans (società di logistica internazionale che ha il terminal ad
Anagni: 150 dipendenti, passata al "concordato in continuità" nei mesi scorsi
confluendo nella società Sli di Frosinone), di due commercialisti di Sora. A
Frosinone Giulio Occhionero aveva la sede di alcune società: la Rogest S.r.l, di
cui è stato consigliere e sua sorella ha rivestito la carica di presidente. La
Rogest era stata costituita l’11 maggio 2004 a Frosinone in via Brighindi 44. E
lì avevano sede anche altre due società legate agli Occhionero, la Correndo
S.r.l. e la Sire Engineering S.r.l., entrambe in liquidazione. Dopo tre anni il
capitale sociale era portato da 10mila a 100mila euro e la sede legale era stata
trasferita a Roma. A quell’indirizzo, nel passato, aveva risieduto Licio Gelli,
il fondatore della loggia massonica P2 (leggi qui Gelli Licio, residente in via
Brighindi 44 a Frosinone)
La sentenza di condanna è arrivata dopo un’ora
scarsa di camera di consiglio. Giulio Occhionero è stato dichiarato interdetto
in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata
della pena. La sorella è stata interdetta dai pubblici uffici per cinque anni. I
due fratelli sono stati condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in
separata sede alle parti civili costituite, salvo una provvisionale
immediatamente esecutiva di 5.000 euro all’Enav spa, 2.000 euro al Ministero
dell’Interno, 8.000 euro al Ministero degli Affari Esteri, 495,32 euro
alla Regione Lazio e 25.000 euro al Ministero dell’Economia e Finanze. Il
sostituto procuratore Eugenio Albamonte aveva chiesto pene più severe: 9 anni
per Giulio Occhionero e 7 anni per Francesca Maria.
Alla lettura del dispositivo della sentenza, i due
fratelli, presenti in aula, non hanno detto una parola. Durante la requisitoria
aveva parlato di «quadro probatorio consolidato», confermato in sede di riesame
e poi anche successivamente dall’esito delle intercettazioni telefoniche, e
aveva fatto riferimento a migliaia di «file esfiltrati tramite virus e nascosti
in sotto cartelle». I dati carpiti sarebbero poi finiti in alcuni server
americani gestiti dall’ingegnere nucleare in cui gli inquirenti del Cnaipic,
servizio specializzato interno alla Polizia Postale, hanno recuperato oltre 3
milioni di mail intercettate. Per la Pubblica Accusa, a Giulio Occhionero andava
attribuita «una responsabilità di grado superiore per aver concepito e
ipotizzato l’intero sistema illecito, per averlo realizzato e mantenuto nel
tempo». Il magistrato ha ritenuto meno grave il ruolo della sorella che non ha
preso parte alla fase ideativa del progetto «ma sicuramente – era il punto di
vista dell’accusa – ha concorso nell’attività di accesso abusivo e acquisizione
dati».
Cyberspionaggio, la difesa dei fratelli
Occhionero: «Nessuna prova». A luglio la sentenza,
scrive Venerdì 1 Giugno 2018 Il Messaggero. La sentenza arriverà a metà luglio e
intanto oggi al processo a Giulio e Francesca Maria Occhionero, arrestati nel
gennaio del 2017 perché accusati di una presunta attività di cyberspionaggio ad
altissimi livelli, è andata in scena l'arringa delle difese, che continuano a
respingere la tesi della procura e hanno anche denunciato il pm. «Possiamo dire
che la montagna ha partorito un topolino, anche gracile di salute», hanno
replicato alle richieste di condanna della procura i legali sollecitando
l'assoluzione degli imputati. «Dall'istruttoria dibattimentale - hanno affermato
gli avvocati Stefano Parretta e Roberto Bottacchiari - non è emerso
assolutamente nulla che potesse essere riconducibile al loro lavoro». Per
l'ingegnere nucleare e la sorella, il pm Eugenio Albamonte ha chiesto condanne a
9 e 7 anni di reclusione per accesso abusivo (consumato o solo tentato) a
sistemi informatici e di intercettazione illecita di comunicazioni
informatiche. «Questo processo - hanno aggiunto i penalisti - ha dimostrato che
non si è andati oltre qualche indizio e in assenza di riscontri probatori questi
indizi non sono idonei a sostenere l'accusa. Nessuna responsabilità può essere
attribuita ai due fratelli i quali, per fronteggiare alcune difficoltà
economiche, hanno dovuto alienare alcuni beni. La procura è convinta che abbiano
carpito dati riservati a fine di lucro, ma dal dibattimento non è emersa neppure
una casella di posta elettronica, riconducibile a personalità militari o della
politica o del settore giuridico-economico, che sia stata effettivamente
violata».
I fratelli Occhionero
accusati di cyberspionaggio.
I fratelli Occhionero sono stati arrestati il 9 gennaio 2017 con l’accusa di
cyberspionaggio, la prossima udienza è prevista per lunedì 17 luglio, scrive il
15 Luglio "Il Dubbio". La parabola discendente di Francesca Maria Occhionero
inizia il 9 gennaio di quest’anno quando viene arrestata insieme al fratello
Giulio, e condotta nel carcere romano di Rebibbia. Le accuse mosse dalla procura
di Roma sono: accesso abusivo a sistema informatico aggravato, intercettazione
illecita di comunicazioni informatiche, violazione della privacy; accantonata al
momento quella di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello
Stato. In pratica i due avrebbero cercato di entrare nella posta elettronica di
18mila persone, tra cui l’attuale segretario del Pd, Matteo Renzi, l’ex premier
Mario Monti, il presidente della Bce, Mario Draghi, il cardinale Gianfranco
Ravasi, ma anche in quella di nomi altisonanti della finanza, delle istituzioni,
delle pubbliche amministrazioni, di celebri studi professionali. Il processo a
carico dei due fratelli, iniziato lo scorso 27 giugno, riprenderà il 17 luglio
davanti al giudice monocratico. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal gip l’ok
al giudizio immediato che ha consentito, alla luce delle prove raccolte nella
fase investigativa, di saltare l’udienza preliminare e di portare il processo
direttamente in aula. Entrambi lavoravano insieme in diverse società di
famiglia, compresa la Westlands Securities, fondata da Giulio due anni dopo la
laurea, nel 1998, a Malta, e che si occupa di consulenza finanziaria a
istituzioni bancarie. Lui con la passione per la matematica, lei per la
maratona. Secondo gli inquirenti i fratelli Occhionero sarebbero stati al
vertice di una centrale di cyberspionaggio che accumulava illecitamente dati
sensibili e riservati, attraverso l’utilizzo di un malware (malicious software)
chiamato Eye Pyramid, “occhio sulla piramide”, il simbolo massonico per
eccellenza. I dati sottratti dal virus informatico erano custoditi in server
negli Stati Uniti. L’indagine era partita da una segnalazione del capo della
sicurezza dell’Enav, Francesco Di Maio, che aveva rilevato nella posta
elettronica una email malevola. L’attacco malware avveniva generalmente infatti
tramite una email. Dalle carte della Procura di Roma, che ha condotto le
indagini con il Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico della
Polizia postale, e in collaborazione con l’Fbi, si legge che quella che ha poi
consentito di infettare i computer arrivava da uno studio legale, in cui si
diceva di scaricare un file pdf contenuto in allegato. Una fattura, nel caso
specifico. Dentro quel pdf in realtà era contenuto il software. Appena si apriva
il file, l’infezione del computer era avvenuta, ed esso poteva essere
controllato da remoto, senza che il proprietario se ne potesse accorgere.
Contemporaneamente il virus metteva in condizione il presunto hacker di accedere
abusivamente a tutti gli account in possesso del titolare del sistema infettato:
email, cloud, conti correnti, profili social. I due fratelli – lui ingegnere
nucleare di 45 anni, lei quarantanovenne con un dottorato in chimica – difesi
rispettivamente dagli avvocati Stefano Parretta e Roberto Bottacchiari, si sono
sempre dichiarati estranei ai fatti contestati. I legali avevano chiesto più
volte la scarcerazione dei loro assistiti, e in subordine gli arresti
domiciliari, ma il Tribunale del Riesame aveva respinto il ricorso, sui cui
aveva espresso parere contrario anche il pm Eugenio Albamonte.
Figli di Trojan, come due spioni possono
infettare vip ed enti pubblici. Scrive Umberto
Rapetto, Giornalista, scrittore e docente universitario, l'11 gennaio 2017 su
"Il Fatto Quotidiano". La cronaca ci parla di un plateale Ko di due criminali
telematici, finiti al tappeto – nomina sunt homina – entrambi con un occhio
tumefatto. I signori Occhionero sono balzati sullo schermo televisivo e sul
display di smartphone, tablet e computer, incastrati al termine di una lunga
indagine e soprattutto inchiodati dalle 47 pagine dell’ordinanza di custodia
cautelare. Intere generazioni di spie e di hacker, che hanno sudato sette
camicie per guadagnarsi un briciolo di notorietà, sono stati mortificati
brutalmente da imprevedibili Bonnie e Clide del bit. Ma cosa è successo davvero?
Chi si aspetta la solita risposta tranchant, quella che deve stare in un minuto
di servizio del TG o in duecento battute virgolettate dell’intervista su carta,
purtroppo stavolta non sarà accontentato. Una storia del genere merita di essere
assaporata con la massima calma, ma soprattutto deve essere ricostruita in un
linguaggio e in una modalità accessibili anche a chi è fortunatamente digiuno di
tecnologie, di indagini, di misteri. Questo post somiglia a certi acquisti del
periodo natalizio. E’ a rate. Una rateazione senza sorprese, se non quella –
legittima – del “ho capito anch’io” esclamato dall’immancabile “scettico blu”.
Il primo step riguarda alcune considerazioni sulla platea dei soggetti presi di
mira, il cui elenco sembra aver sbalordito l’opinione pubblica. La lunga lista
di “Very Important Person” è fin troppo scontata: avremmo dovuto restare
stupefatti se il target fosse stato rappresentato dal verduriere sotto casa,
dall’edicolante all’angolo della strada, dal benzinaio lungo il viale, dal
pensionato del piano di sopra. Le persone “catalogate” nella progressiva azione
di costante spionaggio ed ininterrotta archiviazione sono tra loro concatenate:
il ruolo istituzionale, lo status sociale, le condizioni economiche e la
posizione di spicco in un contesto aziendale rendono probabile la compresenza
nella medesima rubrica telefonica o di indirizzi di posta elettronica. Chi
immagina il puntuale assalto dei personaggi “uno ad uno”, sbaglia. Chi opera con
certi grimaldelli digitali si limita a prendere di mira un tizio di interesse e
da lì, come in certe sfortunate cordate di alpinisti, “tira giù” tutti quelli
che gli sono a qualunque titolo legati. Tutto comincia con la scelta del tallone
d’Achille e della tecnica per entrare nella vita della vittima prescelta. Il
punto debole non sta sotto la caviglia, ma nella tasca o nella borsa del
bersaglio: smartphone, tablet e computer portatili e da scrivania. Chiunque ha
un dispositivo elettronico che lo accompagna ovunque e cui sono
affidate informazioni più o meno riservate. Capito “dove” colpire, si passa
rapidamente al “come”. Il dardo avvelenato di maggior efficacia è rappresentato
dallo sconfinato arsenale di “malware”, ovvero i “malicious software” o
programmi dalle venefiche capacità operative. Una manciata di istruzioni nocive
sono capaci di “narcotizzare” gli strumenti di lavoro e di farli sfuggire dal
regolare controllo di chi ne è legittimo possessore o utente. In pratica chi
vuole colpire il suo avversario – per poi, violandone la riservatezza,
depredarlo di dati e notizie – deve riuscire ad installare il malware
sull’apparato nel mirino. Le modalità per “infettare” ricordano le pagine
dell’Odissea ed evocano il ricorso a virtuali “cavalli di Troia”, dizione
storicamente adoperata per identificare i malvagi programmini pronti a fregare
il destinatario del dono. La trappola è nascosta in un allegato ad una
mail apparentemente innocua, oppure in una App gratuita che viene consigliata da
un presunto amico, o in tanti altri modi idonei a veicolare fregature bestiali.
Il malcapitato non riconosce l’inghippo, fa clic con il mouse sulla
“graffettina” che identifica l’annesso al messaggio o magari non esita ad
installare la fatidica applicazione per il moderno telefonino intelligente ma
non troppo. Il file allegato o la App si aprono e si comportano in modo
esteriormente corretto, ma – dribblando le protezioni – entrano in azione e
mandano a segno la propria missione illecita. Cellulare, palmare o computer
ingurgitano in totale incoscienza i codici malevoli, ricevono ordini che
l’utente non ha mai impartito, spalancano la via a chi vuole sottrarre
qualsivoglia contenuto, registrano quel che viene digitato sul touch screen o
alla tastiera. In pratica il dispositivo diventa uno “zombie”, ubbidisce a chi
ha predisposto l’insidioso malware, si lascia scappare copia dei documenti
memorizzati o delle mail spedite o ricevute, mette in funzione la webcam o la
videocamera del telefonino e filma quel che rientra nella sua visuale, attiva il
microfono di portatile/tablet/smartphone improvvisandosi microspia ambientale, e
così a seguire. La vittima non ha scampo. E deve sperare che l’unico file
installato sul suo computer sia solo quello del virus. Eh, già. Perché un vero
malintenzionato potrebbe non accontentarsi di piazzare le istruzioni, ma
inserire cartelle e file (di qualunque genere, magari materiale
pedopornografico) che il proprietario di quell’arnese non ha mai nemmeno
immaginato potessero esistere… Ma su questo “dettaglio” torneremo in una
prossima puntata di questo sequel…Fermiamoci qui. Tranquilli, non mi farò
attendere.
Figli di Trojan: come, a furia di spiare,
si diventa spiati. Scrive Umberto Rapetto,
Giornalista, scrittore e docente universitario, il 12 gennaio 2017 su "Il Fatto
Quotidiano". Viene legittimamente da chiedersi da dove e perché saltino fuori
questi dannati malware. E, lo si stenterà a credere, l’humus di questo genere di
prodotti è il contesto giudiziario che rappresenta un importante committente e
al tempo stesso un alibi per il mercato. Le Procure della Repubblica se ne
servono per le indagini più impegnative (non faccio mistero dei tanti fondati
dubbi di legittimità di questo modus operandi – che personalmente non ho mai
utilizzato né genericamente “approvato”, ma mi riservo di rinviare il tema ad
una delle future tappe di questa chiacchierata). Le software house, da parte
loro, li producono dichiarando la speranza di venderli ad articolazioni
territoriali della giustizia e non disdegnando di collocarli su un più
redditizio mercato parallelo (senza arrivare al crimine organizzato, ci si può
accontentare di qualche Paese poco democratico…. Hacking Team docet). In termini
pratici il mercato non manca di opportunità e poi mille artigiani della
programmazione informatica sono sempre pronti a confezionare soluzioni
sartoriali. Non bastasse, banditelli di qualunque taglia – simili a vecchi
druidi – mescolano righe di codice per pozioni dannose da somministrare
personalmente o conto terzi al primo computer che capita. Nelle viscere della
Rete insediamenti dell’underground computing (deepweb o darknet direbbero quelli
“più giovani”) non esitano – simili all’Ikea – a proporre gratuitamente o a
pagamento kit fai-da-te per costruirsi autonomamente un malware o combinare
altri guai… Ognuno può personalizzare il proprio malware, provvedendo
direttamente o commissionando a qualche esperto il confezionamento di quel che
gli serve. Il malware soddisfa le pretese anche dei più esigenti e non di rado
fa anche qualcosa di più rispetto quel che è stato richiesto o quella che è
stata dichiarata come dinamica di funzionamento. Il programmatore, infatti, non
si accontenta del corrispettivo pattuito e si riserva sempre la possibilità di
ottenere una sorta di “mancia”. Cosa fa? Semplice. Combina la procedura in
maniera tale da ottenere una copia del materiale che verrà sottratto e il
privilegio di servirsi a proprio uso e consumo del varco aperto dal suo
committente nel dispositivo aggredito. Lo “smanettone” non si preoccupa certo di
distinguere la natura del committente, né lo scopo – più o meno nobile – che
anima chi si serve della sua “creatura”. Nessuno infatti è in grado di sapere
cosa facciano effettivamente i “trojan” (espressione gergale appioppata a questa
tipologia di programmi spia) adoperati per finalità di indagine dalle Forze
dell’Ordine o dalla magistratura. Si corre addirittura il rischio (ma spero di
esagerare) che in questo sconfortante stato di cose il programmatore o
la software house abbiano automaticamente il monitoraggio (o il controllo) delle
investigazioni in corso o comunque si trovino ad accompagnare zitti zitti chi si
occupa dei casi più delicati. Lo spionaggio dello spionaggio, che meraviglia….I
malware in questione vengono comprati a scatola chiusa e non sono accompagnati
dal classico foglietto illustrativo dove si riportano le controindicazioni dei
medicinali. Non esiste un albo certificato dei fornitori selezionati, come
vorrebbe giustamente il procuratore capo di Torino Armando Spataro, e ancor meno
esiste un “bollino” a garanzia dell’affidabilità di prodotti e servizi tecnici
(che sarebbe bello venissero ideati, sviluppati, realizzati e gestiti
direttamente da strutture statali e non da privati). Chi, quindi, può entrare
più o meno prepotentemente nella nostra vita, insinuandosi negli strumenti che
ci assicurano il tanto ambito “stay connected”? Esiste un mandante? Qual è la
finalità di simili azioni? Le domande si moltiplicano rapidamente. Facile a
prevedersi. Proprio per questo ci si ritrova a brevissimo su queste pagine per
proseguire la chiacchierata che prenderà spunto anche da osservazioni, commenti,
curiosità e opinioni di chi ci legge.
Figli di Trojan, la Cia confessa: "Da
soli non ce la facevano, ci servivano gli Occhionero".
Scrive Umberto Rapetto, Giornalista, scrittore e docente universitario, il 13
gennaio 2017 su "Il Fatto Quotidiano". L’ “intrigo internazionale” immaginato
dai tanti finti esperti, che si accalcano nei talk-show, farebbe impallidire
persino Alfred Hitchcock che quella espressione l’ha impiegata per titolare uno
dei suoi capolavori cinematografici. In tanti si sono affrettati a dipingere
appassionanti “dietro le quinte”, ipotizzando i due protagonisti della vicenda
giudiziaria come ispiratori delle migliori pagine di Tom Clancy o John Le Carrè.
Unico loro connotato corrispondente al normotipo dell’agente segreto l’essere
totalmente sconosciuti ai più. Elemento immancabile in ogni avventura epica dai
contorni informatici, invece, la disponibilità di un garage: proprio come quello
dove Steve Jobs e Steve Wozniak hanno fondato la Apple e quell’altro in cui
Hewlett e Packard hanno avviato la loro impresa. Questi due indizi hanno
sicuramente avuto un peso significativo per chi – in assenza di informazioni
dettagliate dagli inquirenti – ha voluto far credere di saperne una più del
diavolo. A questo punto mi prendo la libertà di dar sfogo – almeno per qualche
riga – alla mia irrefrenabile vena goliardica. In ogni spy-story che si rispetti
non manca mai una gigantesca organizzazione di intelligence. Talmente gigantesca
che a qualcuno è scappato il riferimento alla Gru, facendo correre il pensiero
non al servizio segreto russo “Glavnoe Razvedyvatel’noe Upravlenie”, ma
piuttosto a qualcosa di grosso da doversi spostare o sollevare. In un attimo
tutti quelli che non sapevano nulla, ma pensavano di far brutta figura a
dichiararlo, hanno giocato il jolly e non hanno esitato a sparare la sigla che
tutti si aspettavano: la Cia. Anche qui i soliti cattivi – consci che a
blaterare fossero braccia, voci o penne rubate ai campi da arare – hanno subito
compreso che i sedicenti guru dello spionaggio stessero facendo una bieca
operazione di lobbying a vantaggio dei coltivatori nostrani, magnificando
imprevedibili potenzialità della Confederazione Italiana Agricoltori il cui
sito cia.it ha spesso tratto in inganno gli appassionati di thriller. Qualche
altro ha azzardato un cenno alla Nsa ma molti interlocutori distratti hanno
detto che la sigla corretta era Nsu e che non andava nemmeno nominata per
evitare sfortune e calamità. I più dotti (o magari semplicemente meno giovani)
rammentavano che proprio la Nsu produceva l’automobile Prinz che nella
colorazione verde portava una sfiga pazzesca e che negli anni Settanta gli
studenti “si passavano” l’un l’altro urlando “tutta tua” al pari di quanto
avveniva alla vista di una suora. Riconquistando, a fatica, un barlume di
serietà, riesce difficile credere che i Servizi più potenti del mondo possano
aver assoldato (non me ne vogliano gli interessati) fratello e sorella o aver
deciso di acquistare il risultato delle loro perlustrazioni informative. Ho
provato a chiudere gli occhi e, sollecitato dal ricordo di pellicole
come “Nemico Pubblico”, ho cercato di vedere la sala operativa di Langley o
quella a Fort Meade con fior di analisti che – stremati e delusi – si lasciano
scappare “Non ce la possiamo fare da soli…. Ci vogliono gli Occhionero…”. Non
manco di fantasia, ma non ci sono riuscito. Anche a sforzarmi, proprio non ce la
faccio. Perdonatemi, ve ne prego. Fortunatamente gli specialisti
dell’intelligence, nonostante il ruolo serio e i toni seriosi che li
contraddistinguono, sono persone di grande spirito e non serberanno rancore nei
confronti di chi ha fatto abbinamenti irriguardosi. Chi ha ragionevolmente
scartato il coinvolgimento di 007 e relative strutture, rinunciando così ad
innamorarsi di incantevoli tesi complottiste, si domanda se l’operato dei nostri
angloconnazionali sia da ricondurre ad un incarico ricevuto da chissà quale
committente e vorrebbe conoscerne le ragioni. Già, c’è un mandante? E chi
potrebbe essere? Esclusi i servizi segreti, qualcuno intravede torbidi scenari
massonici. Sullo sfondo appare Corrado Guzzanti che esorta i suoi fratelli al
golpe…
Figli di Trojan, non solo gli Occhionero:
sul web un intero esercito di mancati detective.
Scrive Umberto Rapetto, Giornalista, scrittore e docente universitario, il 14
gennaio 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Quello “in grembiule” è un mondo che
conosco davvero poco (mia nonna Bigina ne aveva uno, ma lo adoperava per
cucinare) ma so che gli intrecci del nostro pianeta si annodano molto spesso con
personaggi appartenenti a logge o aggregazioni misteriose. Probabilmente chi
frequenta certi ambienti si alimenta (come i vampiri con il sangue) di dati e
notizie che garantiscano la supremazia dell’informazione. Sapere, sapere prima,
sapere qualcosa in più, sapere qualcosa d’altro: questa è la forza di chi
vuole rompere gli equilibri o crearne di nuovi, approfittando di un patrimonio
conoscitivo che assicuri una posizione di vantaggio. Considerato, però, che
certe associazioni possono contare tra i “fratelli” tanti personaggi di spicco
nelle istituzioni e nelle Forze Armate e di Polizia, sembra bizzarro che non si
avvalgano proprio dei loro affiliati che – tra l’altro – sono debitori della
loro carriera alla cerchia cui hanno aderito e che in qualche modo dovranno pur
sdebitarsi con contributi di adeguato calibro. E allora perché rivolgersi ai pur
“volenterosi” signori Occhionero? L’ombra della massoneria – così dicono e
scrivono i “ben informati” – aleggia sulla scena. L’ingegner Occhionero a quanto
pare è affiliato alla Loggia 773 “Paolo Ungari – Nicola Ricciotti Pensiero e
Azione”, da non confondersi (ho cominciato a documentarmi!) con la quasi omonima
Loggia numero 1498 “Pensiero e Azione” il cui maestro venerabile comunicava via
Facebook e i cui elenchi e documenti sono stati trovati il 5 marzo scorso in un
cassonetto dei rifiuti davanti agli uffici del dipartimento regionale
all’Energia di viale Campania a Palermo. Il Grande Oriente d’Italia – casa madre
della massoneria italiana e, come si legge sul relativo sito, “iniziatico i cui
membri operano per l’elevazione morale e spirituale dell’uomo e dell’umana
famiglia” ha formalmente “sospeso” l’Occhionero riconoscendo l’appartenenza del
soggetto al sodalizio. Probabilmente accumulare dossier riservati era
propedeutico all’acquisizione di ruoli sempre di maggior caratura nell’ambito
dell’organizzazione cui l’ingegnere aveva aderito: l’informazione come freccia
nella propria faretra, come merce di scambio, come strumento di potere. Molto
più facilmente la collezione dei dati poteva avere una destinazione commerciale.
Mi spiego meglio. Chi intraprende queste avventure (anche e soprattutto chi lo
fa senza farsi accalappiare) opera a scopo di lucro: agisce su specifica istanza
di qualche cliente, confida in una futura committenza da soddisfare con
immediatezza, non esclude nemmeno dinamiche estorsive in danno di chi ha
qualcosa da nascondere. Questa vasta gamma di possibile impiego di dati
tesaurizzati ci porta per mano dinanzi al baratro in cui è sprofondata la
nostra privacy. Non ci troviamo dinanzi a due presunti “fenomeni” (Giulio e
Francesca Maria), ma al solo effettivo e preoccupante fenomeno della “data
collection” che conta migliaia di persone tra i suoi appassionati. La speranza
di “rivendere” quel che si è scovato in maniera più o meno lecita trasforma le
ricerche in attività compulsive. E se qualcosa non lo si trova in Rete (la
cosiddetta “Open Source Intelligence” è disciplina di grande efficacia),
l’aspirante “dominus” della conoscenza globale non esita a contattare chi ha a
disposizione un terminale collegato a una banca dati giudiziaria o
investigativa. La catena di favori e cortesie (prezzolate e non) e di piccole
manovre sottobanco qualifica il livello della partita in corso, in cui farebbero
capolino anche operatori di polizia pronti a sgraffignare qualche informazione
nei database dell’ufficio (incuranti del fatto che ogni loro azione è
rigorosamente tracciata). I fratelli Occhionero sono la prima pattuglia che
viene catturata, ma in campo c’è un intero esercito di mancati detective che
somigliano ai tanti che vanno a giocare alla guerra nei boschi con il “softair”
magari dopo essere stati “obiettori di coscienza” in età di leva. Internet è la
giungla in cui vietcong digitali vanno autonomamente a caccia di nemici,
sentendosi bravi e importanti per esser riusciti ad utilizzare trappole e
ordigni virtuali e aver accumulato prede. I mercenari della guerra alla
riservatezza personale prima o poi riusciranno a vendere il loro scalpo a chi ne
farà richiesta. Basta aspettare. Le “radiografie” dei singoli individui pescati
anche a strascico non ingialliscono mai.
Figli di Trojan, i sistemi hackerati
dagli Occhionero erano protetti? Scrive Umberto
Rapetto, Giornalista, scrittore e docente universitario, il 16 gennaio 2017 su
"Il Fatto Quotidiano". Computer, tablet e smartphone sono una sorta di
cornucopia di informazioni. Il loro saccheggio è certo attività deprecabile, il
loro utilizzo improprio addirittura peccato mortale. Etica a parte, c’è poi da
fare i conti con il codice penale. Ma se i primi colpevoli fossero i vip che si
sono fatti scippare il contenuto delle loro “memorie” e delle caselle di posta
elettronica? La boutade – che potrebbe non esser tale – prende spunto dalla
lettura del codice penale e degli articoli che in questo sono stati inseriti
dall’entrata in vigore “illo tempore” della legge 547 del 1993 che ha introdotto
nel nostro ordinamento i crimini informatici. Le disposizioni che hanno
contemplato la sanzionabilità di comportamenti illeciti mandate a segno in danno
di sistemi informatici hanno – analogamente a tanti brani di musica leggera – un
ritornello ricorrente. Il refrain è quel “protetto da misure di sicurezza”, che
troviamo – sempre compreso tra due virgole – nelle diverse fattispecie di reato
come elemento indispensabile perché siano soddisfatti i requisiti delle singole
condotte delittuose. In termini pratici il reato si configura solo ed
esclusivamente se il computer destinatario delle attività criminose (ad esempio
di “accesso abusivo” di cui all’articolo 615 ter del codice penale o di
“danneggiamento” previsto e punito dal successivo 635 bis) è
opportunamente difeso da idonee precauzioni tecniche. Proviamo ad
accostare l’accesso abusivo a un sistema informatico alla ben più
materiale violazione di domicilio. Quest’ultima si realizza se chi entra rompe
lucchetti, scassina serrature, scavalca recinzioni, divelle porte blindate, fa
violenza sulle persone che si oppongono all’ingresso, quindi superando o
infrangendo le “misure di sicurezza” poste a difesa dell’immobile. Non commette
reati chi va a sdraiarsi sul prato – pur proprietà privata – antistante l’altrui
abitazione di cui è pertinenza: il padrone di casa avrà diritto di cacciarlo, di
lamentare il superamento del perimetro segnato dalle margheritine piantate sul
bordo del terreno, di chiedere il risarcimento di un eventuale danno all’aiuola,
ma nulla di più. I dispositivi elettronici su cui hanno scorrazzato i due
sedicenti hacker somigliano più alla costruzione corazzata della prima
situazione o piuttosto allo spazio semiaperto del secondo caso? La questione
delle misure di sicurezza è incredibilmente importante. Se ci sono, chi le viola
si macchia di reato. Se non ci sono, gli indesiderati visitatori non devono
rispondere di accesso indebito. Ma la storia non finisce certo qui. Le misure di
sicurezza, infatti, sono considerate obbligatorie dalla disciplina vigente in
materia di privacy. La normativa in argomento si preoccupa del fatto che enti e
aziende raccolgano o utilizzino informazioni personali sui propri computer
effettuando tali operazioni su dati riferiti ad altre persone (si pensi a quelli
dei dipendenti per una azienda o dei cittadini per un ente pubblico). Un
eventuale attacco a un archivio elettronico non danneggia tanto chi lo detiene e
lo gestisce, ma piuttosto tutti i soggetti cui i dati sottratti, copiati o
alterati si riferiscono. Per questo motivo gli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 196 del 2003 e l’allegato B al medesimo provvedimento
stabiliscono misure minime e precauzioni specifiche per chi si avvale di
strumenti tecnologici di elaborazione dati (categoria in cui rientrano dai più
piccoli ai più sofisticati arnesi digitali di uso comune per lavorare alla
scrivania o comunicare in mobilità). Il primo comma dell’articolo 169 del
medesimo d.lgs. 196/03 prevede la pena dell’arresto fino a due anni per chi,
essendovi tenuto, omette l’adozione di tali misure. Conoscono bene la sottile
linea di demarcazione tra codice penale e quello della privacy tutte quelle
imprese che, subita una aggressione informatica, hanno capito le
controindicazioni al presentare regolare denuncia. Considerato che oltre al
danno di immagine per la beffa subita, infatti, c’è il rischio di passare dalla
posizione di vittima a quella ben più scomoda di reo, parecchie aziende
preferiscono tacere sull’accaduto e sperare che i dati sgraffignati non
comincino a circolare…Tenuto conto che il virus “Eye Pyramid” utilizzato per
combinare questo ambaradan risale al 2008 e quindi erano disponibili da tempo
sistemi idonei a prevenire o neutralizzare azioni o situazioni dannose o
comunque pericolose generate dal suo entrare in azione, gli apparati
presumibilmente azzannati in modo virtuale dagli Occhionero erano protetti da
misure di sicurezza? Viste le considerazioni precedenti, sarebbe interessante
appurarlo. Tranquillizziamo subito chi è pronto a commenti feroci pensando che
si stiano cercando giustificazioni o alibi ai due personaggi. La loro posizione
giudiziaria è ancorata anche ad altri capi di imputazione come l’intercettazione
di comunicazioni telematiche (articolo 617 quater comma 1 e 4 n°1 del codice
penale), il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art.
256 comma 1 e 3 c.p.), la diffusione di programmi informatici atti ad alterare
il funzionamento di un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.). Strada in
salita per chi deve difenderli, ma percorso che offre mille spunti di
riflessione per chi vuole capire meglio cosa è davvero successo. Un pochino di
pazienza. Il sequel continua.
Giulio Occhionero scrisse a Papa
Francesco, scrive "L'Ansa" come riportato da
"L'huffingtonpost.it" il 13/01/2017. Funzionari delle Regioni Campania,
Lombardia, Marche, Sicilia e Veneto. E ancora: banche, consiglio nazionale dei
notai, il ministero del Tesoro, farmacie, alberghi a cinque stelle, agenzie di
viaggio. I fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero "monitoravano" i più
disparati settori nella loro presunta attività di cyberspionaggio. Non
tralasciando, sembra, neanche una non bene specificata lettera "da consegnare al
Papa". L'elenco delle caselle di posta elettronica hackerate dai due arrestati è
presente negli allegati all'ordinanza di custodia cautelare. Oltre ai politici,
di quasi tutti gli schieramenti, nel database degli Occhionero sono presenti
caselle di posta di dirigenti e funzionari del ministero degli Esteri, a
cominciare dall'account dell'ambasciatore ed ex ministro, Giulio Terzi, di
società come Alitalia, Poste Italiane e Trenitalia. E ancora: la banca dati
avvocati oltre ad un lungo elenco di istituti di credito come American express,
Allianza Bank, banca di Roma, Banca Mediolanum, Banca Fideuram, Bank of America,
Bim Bank, ByBank.it, Cari Parma, Civibank, csebanking.it, Fineco,
Unicreditbanca.it e Webank. Nelle carte dell'inchiesta anche una serie di
intercettazioni di telefonate tra i due fratelli e in alcuni casi di Giulio con
la madre, Marisa Ferrari. Parole che restituiscono anche un spaccato della vita
dei due. In particolare le offerte di lavoro da società di prestigio a Londra,
Berlino e Dublino ma anche una non bene specificata lettera "da consegnare al
Papa". Giulio racconta delle offerte di lavoro ricevute. In particolare in una
l'ingegnere mette a parte la sorella della proposta di lavoro "ricevuta per un
progetto che ha sede a Berlino dove verrebbe retribuito con 50 euro all'ora per
7 ore al giorno dal lunedì al venerdì e facendo un calcolo a suo dire saranno 8
mila euro e rotti al mese per 5 mesi". Stando a quanto racconta l'ingegnere
nucleare proposte di lavoro gli sono giunte da Deutsche Bank ("come Vice
President tra le 90 e le 160 mila sterline l'anno più bonus"), Ubs e Hsbc. In
una conversazione intercettata l'8 agosto scorso tra Giulio e la madre si fa,
invece, riferimento ad una lettera da consegnare al Papa. Giulio chiede: "ma
quella della lettera al papa? è sparita?" e la madre risponde:" no, non è
sparita, ti ricordi che sono andata a trovarla (riferendosi ad una amica ndr).
Sono andata trovarla le ho portato pure il regalo con la speranza e ho detto
senti un pò che cosa ha fatto e sì sì è stata consegnata". Giulio le dice
"facciamo un aggiornamento ad un certo punto mò so passati 3, 4 mesi sentiamo
che fine ha fatto sta lettera" e la madre gli dice "a settembre e che quando è
andata glielo ha detto e le ha risposto che è stata consegnata poi dice se l'ha
letta il papa perlomeno sa chi". Dalle carte emerge che Giulio fosse assai
attento a tutto ciò che riguardava la galassia delle logge massoniche. Agli atti
c'è una telefonata, sempre dell'agosto scorso, in cui emerge come l'ingegnere
nucleare fosse preoccupato per l'iniziativa del presidente della Commissione
Antimafia Rosy Bindi di chiedere, nel corso dell'audizione di Stefano Bisi (Gran
Maestro del Goi, il Grande Oriente d'Italia che sarà ascoltato dalla commissione
il 18 gennaio) l'elenco delle oltre 20mila persone iscritte. "La Bindi
pubblicherà gli elenchi della loggia sui giornali - dice Occhionero - poichè la
Commissione Parlamentare ha chiesto l'acquisizione degli elenchi a seguito della
storia della Calabria". Secondo Occhionero, "la Bindi sembrerebbe intenzionata a
passarli ai giornali".
Gli hacker di Mafia capitale.
I due fratelli Occhionero, arrestati per cyberspionaggio ai danni di decine di
politici, businessman e prelati, sono stati amministratori di società collegate
al faccendiere Salvatore Buzzi, uno dei principali imputati del processo romano,
scrive Gianfranco Turano il 10 gennaio 2017 su "La Repubblica". Tutte le strade
portano a Roma capitale. Il detto vale anche per i due fratelli hacker, Giulio e
Francesca Maria Occhionero, arrestati la mattina del 10 gennaio perché spiavano
sistematicamente politici al massimo livello, businessmen, alti prelati ed
esponenti della massoneria: da Matteo Renzi a monsignor Gianfranco Ravasi, dal
Governatore della Bce Mario Draghi al'ex premier Mario Monti fino al Gran
Maestro del Grande Oriente d'Italia Stefano Bisi. Francesca Maria Occhionero,
nata negli Stati Uniti 48 anni fa, e Giulio, classe 1971, sono stati
rispettivamente presidente del cda e amministratore della Rogest, oggi fallita,
una delle società immobiliari riferibili a Salvatore Buzzi e alla cooperativa 29
giugno finite sotto sequestro giudiziario a giugno del 2015. La Polizia Postale
ha individuato a Roma una vera e propria centrale di cyberspionaggio, che
intercettava e raccoglieva dati sensibili su personaggi noti della politica e
della finanza. In manette un ingegnere nucleare di 45 anni e la sorella di 49,
conosciuti negli ambienti dell'alta finanza, residenti a Londra ma domiciliati
nella capitale. Gli Occhionero hanno svolto il loro ruolo in Rogest per circa un
anno e mezzo fra il 2006 e il 2007. Fra gli azionisti della Rogest ci sono stati
la Edil House 80 di Andrea Munno, con un passato nell'estrema destra, la Luoghi
del Tempo di Lucia Mokbel, sorella di Gennaro coinvolto nelle inchieste su
Finmeccanica, la Sarim immobiliare, pure considerata nella disponibilità di
Buzzi, e la Casa Comune 2000 di Ladispoli, anche questa presente nelle carte di
Mafia capitale. In un'altra società, la Sire, gli Occhionero sono stati
amministratori. La Sire risulta in liquidazione con pendenze per circa 8 milioni
di euro nei confronti della regione Lazio nell'ultimo bilancio disponibile
(2008). Era invece nel diretto controllo dei fratelli Occhionero la Westland
securities, partecipata da una limited omonima con sede a Londra e dalla Owl
Investments, insediata nel paradiso offshore delle Turks and Caicos. La filiale
romana della Westland, attiva fra Italia e Stati Uniti e collegata alla maltese
Pombal, è stata cancellata nel marzo del 2015.
Cyberspionaggio, così funzionava il
meccanismo di controllo. L’indagine condotta dagli
investigatori del Centro nazionale anticrimine informatico della Polizia che ha
portato all'arresto dei due fratelli Occhionero ha scoperchiato un'attività di
dossieraggio durato anni. Che riguardava non solo esponenti di rilievo
istituzionale ma anche vittime apparentemente insospettabili. Da Sergio De
Gregorio alla Cgil di Torino fino a una società di trasporti di Frosinone
recentemente fallita, scrive Floriana Bulfon il 10 gennaio 2017 su "La
Repubblica". Il meccanismo digitale di controllo era questo: un server Command
and Control utilizzato per controllare l’azione del malware, da lì la gestione
di tutti i sistemi informatici infettati, inviando file di configurazione,
sottraendo protocolli di posta elettronica e memorizzando migliaia di documenti
da custodire negli Stati Uniti. 18327 username univoche, 1793 di queste
corredate da password, suddivise in 122 categorie: dalla politica, agli affari,
dalla massoneria ai palazzinari, fino alla Guardia di Finanza e al Vaticano. A
gestire l’ “eye pyramid”, l’occhio della Piramide, due fratelli romani, Giulio e
Francesca Maria Occhionero. Personaggi noti dell’alta finanza capitolina
trapianti a Londra che, secondo l’indagine condotta dagli investigatori del
Centro nazionale anticrimine informatico della Polizia postale in collaborazione
con la Cyber Division dell’Fbi, avrebbero coordinato una rete di computer
infettati con un malware acquisendo per anni notizie riservate e dati sensibili
di autorità di strategica importanza o di sistemi informatici protetti
utilizzati dallo Stato e da altri enti pubblici. I dati carpiti, attraverso
l’invio di una mail, e ricevuti comodamente sul pc venivano catalogati poi in
sottocartelle ciascuna con una differente tipologia: dalle password per le mail
e messenger ai preferiti del browser, dalla cronologia dei siti visitati alle
conversazioni Skype, fino ai collegamenti email tra le vittime. Tra gli spiati
appartenenti alla massoneria, raggruppati nella cartella Bros (Brothers, ossia
Fratelli ndr) quali il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi e
il presidente del Collegio dei Venerabili del Lazio Franco Conforti, e politici
e uomini d’affari racchiusi nella cartella POBU (Politicians Business ndr). Si
va dall’account Apple dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi agli
indirizzi email degli ex governatori della Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni e
dell’ora presidente della BCE Mario Draghi. E poi Mario Monti, Vincenzo
Scotti e Vincenzo Fortunato, il comandante della Guardia di Finanza Saverio
Capolupo, l’ex portavoce di Silvio Berlusconi, Paolo Bonaiuti e l’ex
ministro Maria Vittoria Brambilla. Sotto controllo anche la posta elettronica
di Ignazio La Russa e Piero Fassino, quella di Fabrizio Cicchitto fino ai
computer in uso a due collaboratori del Cardinale Gianfranco Ravasi, dal 2007
presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e pure quelli della Casa Bonus
Pastor, 89 camere a ridosso delle mura vaticane con aria condizionata, wi-fi e
tv satellitare adibite a struttura alberghiera. E poi tanti studi legali. Tra
questi quello dell’ex parlamentare Pdl Maurizio Scelli, già commissario della
Croce Rossa, lo studio Ghia che raggruppa esperti di diritto societario
fallimentare e bancario, avvocati internazionali specializzati in consulenza e
rappresentanza di enti pubblici, professori di diritto amministrativo come Mario
Macchia e legali come Elena Prezioso, dirigente dell’ufficio contenzioso
dell’Avvocatura generale del Lazio. Se l’interesse di Occhionero, scrivono gli
inquirenti, “nei confronti dei suoi fratelli massoni possa essere legato a
giochi di potere” o nel caso della cartella classificata come TABU (Taranto
Business ndr) ad affari riconducibili alla sua società, la Westland Securities,
se risultano comprensibili le mire di spionaggio di esponenti di rilievo
istituzionale, lascia ancora senza spiegazione la scelta di altre vittime. A
partire dal pc della segreteria di Lettere dalla seconda università di Napoli,
la Cgil di Torino o la Toti trans, una società di trasporti di Frosinone
recentemente fallita. Ci sono inoltre i pc di due agenzie della Reale mutua
assicurazioni di Roma e quelli dell’istituto neuro-traumatologico italiano che
vanta oltre 1000 posti letto e 1200 dipendenti e infine la MBA, la più grande
mutua sanitaria italiana per numero di soci. Nelle mire anche l’account gmail
di Sergio De Gregorio, ex senatore Pdl, ex direttore de ‘L’Avanti!’ decaduto
dall’immunità e finito ai domiciliari, e il pc di Antonio Pulcini, patron
dell’impero di palazzine a Roma, una famiglia coinvolta in varie inchieste, tra
le ultime quella di mafia Capitale. Un’attività di dossieraggio durata anni, con
il malware in continua evoluzione. Le prime cartelle risalgono al 2010, le
ultime segnalano come data di infezione agosto 2016. Lo scorso luglio, secondo i
tecnici, sono state aggiunte due nuove classi aventi il compito rispettivamente
di creare alert in base ad una lista di parole chiave e di geolocalizzare la
vittima in base all’indirizzo IP. L’indagine è partita dalla segnalazione
dell’invio di una email indirizzata a Francesco di Maio, a capo della security
di Enav, un’infrastruttura critica nazionale. La mail conteneva il virus e
seguendo quella traccia gli investigatori sono risaliti alla rete botnet che,
sfruttando il malware, riusciva ad acquisire da remoto il controllo dei computer
e dei sistemi informatici. Per i due fratelli, oggi arrestati, le accuse sono di
procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo
a sistema informatico aggravato e intercettazione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche.
Occhionero spiava i notai e "monitorava"
l'Antimafia. Una trentina i professionisti nel mirino. Quella strana telefonata
sulla Bindi: «Svelerà gli elenchi dei massoni», scrive
Massimo Malpica, Sabato 14/01/2017, su "Il Giornale". Tutti nel mirino, compresi
i notai. Nell'elenco allegato all'ordinanza si moltiplicano gli obiettivi del
lavoro di spionaggio che, secondo la Procura di Roma e la Polizia postale,
Giulio Occhionero e la sorella Francesca Maria avrebbero portato avanti da
tempo. L'elenco dei presunti spiati è diviso da uno spartiacque non
indifferente. Da una parte i 1.936 utenti dei quali, sui server riferibili agli
Occhionero, oltre ai dati informatici di accesso alle caselle email erano
presenti anche le password. Ci sono poi una serie di esponenti istituzionali che
erano finiti anche loro monitorati da Eyepyramid, il malware che Giulio
Occhionero avrebbe utilizzato per infettare i pc dei suoi bersagli. Qui c'è il
nome di Mario Monti e c'è anche quello di Matteo Renzi, il cui account Apple non
sarebbe però stato violato. Ma dall'allegato saltano fuori altre vittime
eccellenti delle attenzioni della centrale di dossieraggio. Come Stefano Fassina
di Sinistra italiana, o Nicola Latorre, senatore dem e presidente della
commissione Difesa di Palazzo Madama, o ancora l'ex ministro del Lavoro Maurizio
Sacconi, il ministro degli Esteri del governo Monti Giuliomaria Terzi di
Sant'Agata, e pure il leader di Ala, Denis Verdini, per finire con il senatore
di Ncd Paolo Bonaiuti. Colpisce, però, anche il gran numero di «bersagli» che le
presunte spie avevano individuato tra i notai. Forse per carpire informazioni
riservate da una categoria strategicamente rilevante. O forse, come fatto anche
per gli studi legali e per i commercialisti «violati» dal file Eyepyramid, per
usare quei pc «conquistati» come basi di partenza per spedire alle vittime le
email contenenti il malware che Occhionero avrebbe personalizzato. E i
destinatari, di fronte a una missiva elettronica il cui mittente era uno studio
affermato, hanno spesso abbassato la guardia. E così nell'allegato all'ordinanza
ci sono almeno una trentina di indirizzi di posta elettronica relativi ad
account email del Consiglio nazionale del notariato, riferibili a professionisti
di tutta Italia, più una quindicina di account privati di altri studi notarili.
Alcuni «deformati» nel nome (ne parliamo nello Spillo, in questa pagina), altri
riportati correttamente, come il notaio Gianluca Napoleone di Civitavecchia,
quello davanti al quale avvenne la stipula della famosa casa con vista Colosseo
dell'ex ministro Claudio Scajola. E a quanto pare finito pure lui - il notaio -
«attenzionato» chissà perché dagli Occhionero. Al netto del dubbio che a muovere
i fili dei fratelli fossero interessi d'oltreoceano, infatti, allo stato si
cerca ancora di capire quale fosse lo scopo del presunto spionaggio - anche se
Occhionero nega di aver svolto attività illegali. Di certo i primi a mettere le
mani sul malware per analizzare il metodo degli Occhionero, la società Mentat
solutions, si erano limitati un anno fa alla considerazione essenziale: «La
finalità ultima sembra quella di sottrarre informazioni riservate e documenti
sensibili e inviarli a un'entità di natura sconosciuta che gestisce la rete del
virus». Ma l'entità altro non era, allo stato delle indagini, che il pc di casa
di Giulio, dove il flusso di dati «rubati», e poi selezionati sui server
all'estero che ospitavano l'intero «malloppo» digitale, concludeva la corsa. Lì
ci arrivavano solo le informazioni che Giulio desiderava, selezionando parole
chiave nel testo delle email o in quello digitato dalle inconsapevoli vittime
sulle tastiere dei pc. Ma è ancora da accertare che cosa poi facesse l'ingegnere
di questa messe di dati e informazioni sottratte ai pc controllati grazie al
malware. Nemmeno nelle intercettazioni c'è molto che spieghi il fine ultimo di
questo rastrellamento meticoloso. Di solito Giulio e la sorella Francesca Maria
parlano di lavoro, della sua (di lui) passione per le certificazioni
informatiche, di gite al lago, di possibili trasferimenti all'estero e della
mamma. Mai di potenziali, ulteriori clienti o personaggi interessati al loro
lavoro sulle vite degli altri. Occasionalmente i due parlano anche di Rosi
Bindi, presidente della commissione Antimafia. Succede l'otto agosto scorso,
quando Giulio confida alla sorella «che la Bindi pubblicherà gli elenchi della
loggia sui giornali poiché la commissione parlamentare ha chiesto l'acquisizione
degli elenchi a seguito della storia della Calabria e la Bindi secondo lui
sembrerebbe intenzionata a passarli ai giornali».
Cyberspionaggio, il contrattacco di
Occhionero: io hackerato dai malware degli investigatori.
La posizione difensiva dell'ingegnere romano arrestato il 10 gennaio è
tecnicamente possibile e, se sarà confermata, apre le porte a un tema fra i più
sensibili della giustizia in questo momento, scrive Gianfranco Turano il 12
gennaio 2017 su "La Repubblica". L'hacker Giulio Occhionero si difende e
contrattacca: non c'è nulla di vero, afferma, nel provvedimento che lo ha
portato in carcere insieme alla sorella Francesca Maria. È stato lui a essere
hackerato dai malware degli investigatori. All'apparenza sembra una linea
difensiva delirante, consentita soltanto perché un imputato ha il diritto di
mentire pur di difendersi. Ma Occhionero è un tecnico e tecnicamente quello che
afferma è possibile. Un malware lavora con la semplicità di un tumore maligno.
Non solo imita le cellule sane. Non solo guarda, ascolta e registra ma è anche
capace di fabbricare false prove attraverso interventi attivi su sistemi
operativi, file, audio, video. In altre parole, si può costruire un profilo di
omicida, di narcotrafficante o, appunto, di hacker attraverso il trojan, il
cavallo di Troia che infetta i vari device che ormai fanno parte della vita
quotidiana di chiunque. E c'è poco da illudersi sulle possibilità di difendersi.
«Basta un'innocua foto di WhatsApp, che di solito si scarica in automatico, o un
semplice pdf allegato a una mail», dice Giovanni Nazzaro, ingegnere, consulente
di varie Procure della repubblica e direttore della rivista specializzata
Sicurezza e giustizia. «Stiamo ancora elaborando i protocolli di sicurezza per
consentire le chiamate dall'aereo, che a oggi sono vietate in Italia perché la
cybersecurity è la tempesta perfetta dal punto di vista della legge, con
infiniti profili di attenzione nazionale e internazionale». Il wi-fi in volo
però è un business con rischi di sicurezza. L'inchiesta romana sui fratelli
Occhionero è altra cosa e la posizione difensiva dell'ingegnere romano arrestato
il 10 gennaio, se sarà confermata nel prosieguo del procedimento, apre le porte
a un tema fra i più sensibili della giustizia in questo momento. E se Francesco
Cossiga, un presidente della Repubblica molto addentro agli apparati di
intelligence, diceva: «Io parto dal presupposto di essere intercettato», nemmeno
lui poteva partire dall'ipotesi che i suoi scritti e le sue parole potessero
essere manipolabili a distanza. Inoltre per l'ex ministro dell'Interno degli
anni di piombo essere ascoltato era una sorta di status symbol. Cossiga ne
sapeva abbastanza del mondo da non illudersi che i suoi colloqui sfuggissero
agli altri potenti. Sei anni dopo la morte del Picconatore, la sicurezza
informatica, gli hacker, le spiate elettroniche sono diventate merce comune che
copre una vasta gamma di clienti, dal capo di Stato al coniuge diffidente.
Niente a che vedere con il caso del perito Gioacchino Genchi o dei servizi
segreti più o meno deviati. E anche il Tiger team di Giuliano Tavaroli era
comunque una devianza partita da una grande impresa di interesse nazionale come
la Telecom. Oggi è semplicemente troppo facile fare soldi con un malware,
l'equivalente di un cavallo di Troia digitale che l'ignaro accoglie fra le mura
a rischio della sua distruzione.
Mentat Solutions, chi ha smascherato
davvero i fratelli Occhionero, scrive Simona Sotgiu su
"Formiche.net" il 17 gennaio 2017. Giulio e Francesca Maria Occhionero, i due
fratelli romani accusati di aver spiato per anni le caselle di posta elettronica
di politici, dirigenti istituzionali, avvocati, commerciali e aziende, sono
stati smascherati da un’indagine condotta dalla Polizia Postale diretta
da Roberto Di Legami (nella foto), poi sostituito da Nunzia Ciardi su decisione
del capo della Polizia, Franco Gabrielli, e coordinata dalla procura di Roma.
Secondo l’ordinanza di arresto, a sbrogliare la matassa cibernetica che dal
malware Eye Pyramid ha portato ai nomi degli arrestati è stata una società
privata, la Mentat Solutions, che ha condotto le analisi preliminari permettendo
alla procura di arrivare, poi, ai fratelli Occhionero. Ecco quale ruolo ha avuto
la Mentat Solutions nelle indagini sullo cyberspionaggio, come opera, chi sono i
proprietari e lo stato di salute contabile della società. Secondo l’ordinanza
d’arresto, firmata dal gip Maria Paola Tomaselli, le indagini che hanno portato
all’arresto dei fratelli Occhionero sono nate dalla segnalazione fatta
da Francesco Di Maio, responsabile della sicurezza della società Enav, di una
mail sospetta inviata per l’analisi tecnica “alla società MENTAT Solutions
s.r.l., che opera specificamente nel settore della sicurezza informatica e della
malware analysis” (pagina 5 dell’ordinanza che si può leggere qui). Le analisi
condotte dalla società hanno mostrato come l’account mittente che aveva inviato
la mail a Di Maio “faceva parte di una serie di account collegati a studi legali
risultati compromessi a seguito di un’infezione informatica”. Inoltre, il file
analizzato presentava molte analogie con un altro malware diffuso in passato e
già studiato nell’ottobre del 2014 dal personale della Mentat, quando l’Eni
S.p.A. era stata oggetto di messaggi malevoli al pari dell’Enav, si legge ancora
nell’ordinanza. Dalle analisi condotte dalla Mentat, si è potuta rintracciare la
tipologia di malware contenuto nella mail ricevuta dall’Enav, che
corrispondeva con la versione recente di un virus denominato “EyePyramid” usato
nel 2008 per un massiccio attacco informatico a seguito del quale erano stati
compromessi sistemi informatici appartenenti a società private e studi
professionali. I tecnici della Mentat, “grazie a un software da loro
appositamente realizzato, sono riusciti a decodificare i file trasmessi tramite
mail”, oltre a individuare il funzionamento del malware: sottrazione dei dati
mediante duplicazione, successiva cifratura e invio dei dati mediante due
modalità di trasmissione. “Per i file di dimensioni grandi vengono utilizzati
account di cloud storage; gli altri vengono trasmessi in allegato a messaggi
email inviati utilizzando account di posta elettronica aventi dominio @gmx.com”
(pag. 6), gestito dalla società statunitense 1&1 Mail & Media Inc”. Sempre
partendo dall’analisi dell’allegato malevolo – scrive il gip Maria Paola
Tommaselli – i tecnici Mentat “sono stati in grado di individuare un server
punto di riferimento per il citato malware, ossia il cosiddetto server di
Command and Control (C&C) utilizzato per la gestione di tutti i sistemi
informatici infettati e sul quale erano memorizzati i file relativi alla
configurazione delle macchine compromesse dal medesimo virus EuePyramid, oltre a
migliaia di documenti informatici abusivamente esfiltrati secondo la descritta
modalità” (pag. 6). Ma come hanno fatto i tecnici della Mentat Solutions ad
arrivare ai nomi dei fratelli Occhionero permettendo, così, alla Procura di
mettere in atto la seconda fase delle indagini, ossia le attività di
intercettazione, terminate con l’arresto dei fratelli? Sbrogliare la matassa
informatica è stato possibile, da una parte, grazie all’analisi di tutti i
malware citati in precedenza – quello inviato all’Enav, ma anche quelli già in
possesso della Mentat – con i quali si sono riscontrate “analogie presenti in
tutte le versioni del malware analizzato, compresa quella in esame. Così, fin
dal maggio 2010, tutte le versioni del programma malevolo succedutesi nel tempo,
fino al dicembre 2015, hanno sempre utilizzato la stessa licenza del componente
MailBee.NET caratterizzata dallo stesso codice univoco identificativo”. “La
licenza MailBee utilizzata dal malware è variata solamente nel dicembre 2015
quando – si legge ancora nell’ordinanza -, a seguito della richiesta effettuata
dalla Mentat di fornire le generalità del suo acquirente, la società AFTERLOGIC
Corporation (produttrice delle componenti MailBee.NET Object) ha ritenuto di
dover dare notizia a riguardo il proprio cliente”. Tale circostanza fa presumere
che a utilizzare la licenza sia stata sempre la stessa persona nel corso del
tempo, almeno a partire dal 2010. Altro dato emerso dalle analisi della Mentat
riguarda il metodo con cui il virus copiava e reinoltrava i dati carpiti dalle
macchine compromesse, ossia attraverso l’invio via mail a caselle di posta
specifiche. In particolare è stato fondamentale scoprire che il reinoltro del
contenuto delle caselle email @gmx “utilizzate per le descritte operazioni di
exfiltration” fosse verso “un account del dominio hostpenta.com, registrato
sfruttando il servizio di ‘whois privacy’ offerto dalla società statunitense
PERFECT PRIVACY, LLC, con sede a Jacksonvile (Florida), che oscura i dati
identificativi del reale titolare del dominio”. Tale dominio, risultava essere
collegato ad altri domini, come: enasrl.com, eyepiramyd.com, marashen.com,
occhionero.net e westlands.com, tutti registrati con la stessa società
statunitense (Registrar: NETWORK SOLUTIONS, LLC.), “ma sono risultati tutti
essere, a vario titolo, riconducibili a Giulio Occhionero, o a società a lui
collegate ove collabora con la sorella Francesca Maria Occhionero”. “Ulteriori
accertamenti – conclude l’ordinanza -, effettuati per tramite dell’FBI
statunitense presso la società Afterlogic Corporation, produttrice della licenza
MailBee.NET Objects, permettevano di appurare che la licenza relativa al
componente utilizzato dal malware, dal maggio 2010 al dicembre 2015, risultava
essere stata acquistata proprio da Giulio Occhionero”. La società Mentat
Solutions è di proprietà di Federico Ramondino (70% delle quote) e di Paola
D’Angelo (30% delle quote), ha iniziato le sue attività il 10 agosto 2009 e si
occupa prevalentemente della “produzione di software non connessi all’edizione,
consulenza nel settore tecnologico dell’informatica, gestione di strutture e
apparecchiature informatiche hardware – housing (esclusa la riparazione)” e ha
due dipendenti. Il conto economico al 31 dicembre 2015 indica in 203.128 euro i
ricavi delle vendite e delle prestazioni, in crescita rispetto all’anno
precedente (133.018 euro). Tra i costi della produzione, si nota una crescita
per “materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”, passate da 4.515 euro
nel 2014 a 35.348 euro alla fine del 2015. La società nel 2015 ha fatto
registrare un utile di 12.146 euro. Sono poche le informazioni rintracciabili
online sui due proprietari della società. Tra i pochi risultati, la
partecipazione come relatore da parte di Federico Ramondino alla presentazione
del libro “Futuro Ignoto” di Philip Larrey, docente di Logica e Filosofia della
conoscenza presso la Pontificia Università Lateranense e sacerdote per la
diocesi di Roma. Il libro, si legge nella quarta di copertina, “presenta 14
conversazioni con persone altamente qualificate in diversi settori della società
odierna che riflettono sull’impatto che la rivoluzione digitale sta avendo nel
loro campo specifico”. A intervenire assieme a Ramondino anche Claudio Bianchi,
definitivo “professionista nel settore Informatica e servizi”, come si legge
nella presentazione.
Hackers e cyberspionaggio dopo Eyepyramid
e Occhionero: l'esperto dagli USA. E' Massimo
Bertaccini a rispondere ad alcune domande sull'argomento spie informatiche, dal
suo ufficio di Santa Clara in California: "In futuro proliferazione ed un
affinamento degli attacchi cyber-informatici", scrive il 17 gennaio 2017
"Bologna Today". Dopo il malware Eyepyramid usato per infettare e spiare persone
"influenti" e le presunte violazioni alle elezioni Usa da parte di hacker russi,
la questione della security informatica è tornata di nuovo in primo piano. In
Italia, con l'esplosione del caso Occhionero, ci si chiede cosa possiamo fare
per proteggerci e come agiscono queste cyber-spie. Attraverso Innovami, centro
per l’Innovazione e incubatore d’impresa senza finalità di lucro con sede a
Imola, è stato raggiunto a Santa Clara in California presso la sua sede
americana Massimo Bertaccini, fondatore di Cryptolab Srl (una startup imolese,
ex-incubata presso Innovami), che produce soluzioni crittografiche per la
sicurezza informatica per fare il punto e commentare le ultime vicende in
generale, affrontare il tema della sicurezza informatica.
E’ possibile che un malware possa avere
infettato così tanti account e sistemi informatici strategici per l’Italia?
«Al netto del
clamore giornalistico per i nomi coinvolti, è certamente possibile e assisteremo
sempre più in futuro ad una proliferazione ed un affinamento degli attacchi
cyber-informatici. Personalmente sono anni che cerco di trasmettere, il concetto
di “backdoor” (possibilità di creare un gate spia all‘interno delle
comunicazioni tra 2 o più computers infettati) e “botnet” (agenti computerizzati
che controllano una rete di computers infettati) e della reale possibilità di
infettare milioni di computers nello stesso tempo. Una falla potrebbe dipendere
anche dal fatto che la cyber-security Europea e Italiana sta utilizzando
algoritmi crittografici standardizzati in America e non in Europa e non dispone
quindi (o non vuole disporre) di propri algoritmi standard per la protezione
delle comunicazioni».
C’è a suo avviso una carenza di protezione o di
strategia difensiva?
«C’è carenza di
strategia difensiva; bisognerebbe fare una campagna informativa estesa. Abbiamo
in dotazione computers molto potenti e pensiamo solo alla velocità e alle
prestazioni ma siamo titubanti nel pagare un euro in più per avere le dotazioni
di sicurezza adeguate. Oppure siamo disposti a cliccare “accept” pur di loggarci
all’interno di un social network, rinunciando totalmente alla nostra privacy.
Queste informazioni e queste disposizioni dovrebbero arrivare a livello
istituzionale con campagne informative e norme ben precise».
Quali rischi corre il sistema economico e
istituzionale italiano?
«Le
informazioni carpite dagli hackers, in larga percentuale, sono vendute per dare
un maggior vantaggio competitivo ad altre aziende o stati. Non solo: altri
governi o enti potrebbero utilizzarle per mettere a rischio l’economia e la
politica del paese. Gli scenari possono essere estremi. Si pensi che attualmente
non c’è bisogno di costruire una bomba atomica per poter utilizzare una bomba
atomica, ma è sufficiente entrare in possesso dei codici crittografici che la
fanno innescare. Questo ci fa capire quanto la Cyber security sia importante e
non solo per l’economia di un paese».
Quali sono ora le azioni principali per correre
ai ripari?
«Non conosco
quali sono state le lacune. Serve un’azione coordinata pubblico-privata. In
America, ad esempio, quando il governo si è accorto della possibilità di creare
un “super quantum computer” che può devastare la rete di sicurezza nazionale
perché immensamente più veloce di tutti i precedenti computer finora progettati
il NIST, che è l’organo deputato dal governo per la standardizzazione di nuovi
algoritmi crittografici, ha promosso un bando (con relativo premio in denaro)
che invita tutti a presentare nuovi algoritmi di post quantum computing. Noi
potremmo fare lo stesso in questo settore chiedendo l’aiuto dei privati che,
spesso, agiscono meglio degli enti governativi o delle università».
L’operazione è stata portata a termine anche in
collaborazione internazionale con l’Fbi. Quanto è importante stabilire e
coltivare questo genere di partnership?
«Prima di agire
in combinazione con altri stati dovremmo muoverci con le nostre gambe. Poi
possiamo collaborare alla pari con terzi. Oggi, inutile negarlo, enti
mastodontici come l’NSA o la CIA hanno a disposizione tecnologie e mezzi per
monitorare l’intero globo. Per non parlare di aziende private come Google,
Amazon Facebook e altri che sono sponsorizzate a suon di miliardi dal governo
per fargli da spalla. Chi ci garantisce che gli stessi che ci stanno aiutando
non siano gli artefici o i sostenitori di queste strategie di attacco? E’
risaputo oramai quale importanza abbiano gli attacchi informatici che
periodicamente si scatenano tra Russia-America o Cina-America o altri stati e
viceversa. Se prima non pensiamo a rafforzare le nostre cyber-difese per
affrontare questa corsa del gatto e del topo e a proteggere le informazioni
all’interno dei nostri confini non c’è nessuna garanzia che altri lo facciano
per noi».
«Cronaca da una cella di Rebibbia: qui si
vive all’inferno». La dichiarazione spontanea di
Francesca Occhionero, reclusa nel carcere di Rebibbia dal 9 gennaio del 2017 con
l’accusa di cyberspionaggio, scrive il 15 luglio 2017 "Il Dubbio". Sono
Francesca Occhionero, dal 9 gennaio 2017 detenuta nel carcere di Rebibbia, dove,
quindi, mi trovo a “sopravvivere” ormai da 183 giorni. Ritengo che sia
assolutamente infondato ed ingiusto quanto sostenuto per la custodia cautelare
che sto subendo: ma ciò è stato e sarà trattato nelle opportune sedi. Quel che,
invece, ora mi preme evidenziare riguarda il fatto che la detenzione avviene in
condizioni generali di assoluta, evidente e nota illegalità, e ciò rischia di
essere strettamente collegato con i fatti di causa. Sono note le condanne
inflitte dalla Cedu all’Italia per lo stato di illegalità delle carceri (per le
dimensioni delle celle e per il sovraffollamento, che dovrebbe far pensare ad un
ricorso eccessivo alla custodia cautelare in carcere). Ma sono altrettanto ben
note le condizioni concrete nelle quali i detenuti sono costretti a
“sopravvivere”, così come mi trovo io, letteralmente a “sopravvivere”.
Qualche cenno:
1) Nel cortile della mia sezione c’è una fogna a
cielo aperto, con odori insopportabili, tra sterpi da cui fuoriescono topi di
varie dimensioni; ebbene, qui si svolge l’ora d’aria!
2) Detenute che hanno piaghe e sfoghi cutanei sono
chiuse in “isolamento sanitario” per giorni, senza che si presenti un
dermatologo, nonostante il sospetto (arguibile dall’isolamento) del trattarsi di
malattie infettive. Infatti, il reparto Nido è stato isolato in quarantena per
“scabbia”.
3) Io stessa, ormai piena di sfoghi e punture di
insetti, il 7 giugno scorso chiedevo di avere un parere medico. La risposta
dell’infermiere di turno in ambulatorio è stata che il medico sarebbe stato
disponibile per il mio settore solo il martedì successivo. Insomma, ci si può
ammalare solo di martedì, ovviamente iscrizione nella lista permettendo. Cosa
analoga era successa a maggio, quando sono rimasta bloccata per un colpo della
strega dovuto a cinque mesi passati su un letto con un materasso di cui dirò.
Per i miei ponfi, non sono riuscita ad avere neanche una crema cortisonica, in
quanto, a detta dei vari infermieri di turno, sarebbe terminata da tempo. Ho
assistito io stessa un infermiere mettere del Voltaren gel su un ponfo derivante
dalla puntura di un’ape.
4) Una ragazza, che lamentava da tempo
l’insorgenza di piaghe sulle gambe, dopo un mese ha finalmente ricevuto una
visita medica e le è stata diagnosticata una micosi infettiva (si è parlato di
tigna). La stessa ragazza ha continuato a condividere i 9 mq. di cella con la
sua concellina ed a frequentare gli spazi comuni.
5) Condivido una cella di meno di 9 mq (magari lo
fossero!) con un’altra persona che dorme sul letto superiore di un letto a
castello dotato di materassi di gommapiuma usurati, bucati, bruciati, pieni di
acari e pulci, ormai scaduti da oltre 10 anni. Alla richiesta di sostituzione mi
sono sentita rispondere, con il visibile sconcerto della stessa polizia
penitenziaria, che non ci sono materassi a sufficienza.
6) Sono obbligata a nutrirmi mediante il vitto
passato dal carrello del carcere, ma con grande disgusto e sofferenza fisica. Ne
ho capito il motivo quando altre detenute che hanno lavorato in cucina me ne
hanno riferito le pessime condizioni igieniche. Pentole, teglie, mestoli e tutto
il resto viene infatti “lavato” con spugnette bisunte e praticamente senza
detersivi. Non vi è mancata la presenza di scarafaggi e persino un grosso topo.
I grandi scolapasta vengono sfilati dalle pentole in ebollizione e, con tutta la
pasta, trascinati sul pavimento anziché essere sollevati. E questo solo un
cenno.
7) Il congelatore non funziona, col risultato che
è impossibile conservare alcunché. Nella cella la temperatura è infatti ormai
prossima a quella di un forno. Il cibo si scongela e ricongela. Per non dire
che, ovviamene, gli approvvigionamenti interni sono fuori di qualsiasi logica: i
prodotti sono limitati ed i prezzi raddoppiati e triplicati.
8) Il cortile, le grate delle finestre e i
davanzali sono preda di piccioni (e dei loro escrementi) e di gabbiani. Sovente
i gabbiani attaccano i piccioni lasciando i cadaveri a marcire sui davanzali
delle finestre. Facile immaginare gli odori ed il vomitevole panorama.
9) Il carcere è teatro di continue risse e scontri
tra le detenute a causa della difficile convivenza nelle celle, la cui
assegnazione avviene inevitabilmente in funzione della scarsa disponibilità; e
così vengono fatti convivere soggetti assolutamente incompatibili tra loro e con
il carcere (molti di loro dovrebbero essere indirizzati presso altre strutture,
idonee per adeguati trattamenti psichiatrici).
10) Il bagno presente in cella è in condizioni
pietose. Lo sciacquone perde acqua ininterrottamente, la cipolla della doccia,
completamente intasata dal calcare, è un proiettile pronto a partire con la
pressione dell’acqua. Dopo esserne stata colpita una volta, d’intesa con la mia
concellina, mi faccio la doccia usando il solo tubo. Il filtro/ riduttore del
lavandino è analogamente “esploso” a causa del calcare e, data l’assenza di
tappi, è finito nello scarico. Il water è privo di coperchio.
11) Una mattina mi sono svegliata con la cella
completamente allagata a causa di un’enorme perdita dal muro del bagno (problema
che aveva già interessato la cella a fianco). Tutto galleggiava, sia nel bagno
che nella cella, le lenzuola del letto del piano di sotto erano zuppe, così come
le scarpe e tutto ciò che poggiava in terra. A nulla sono valsi i solleciti alle
assistenti di sezione, che ben poco potevano fare, se non a loro volta
sollecitare la manutenzione. L’idraulico si è presentato solo tre giorni dopo.
Nel mentre, il bagno, il water e il bidet erano del tutto inutilizzabili, e
quindi ci è stato dato l’unico suggerimento pratico possibile: «Chiudete tutti i
rubinetti dell’acqua e … usate i secchi».
Tutto ciò, anche in estrema sintesi, era la
necessaria premessa per OSSERVARE che le condanne inflitte dalla CEDU sono ben
note, ma altrettanto note sono le concrete condizioni, come quelle da me
vissute, nelle quali i detenuti e le detenute si trovano a “sopravvivere”,
spesso in condizioni davvero disumane ed inaccettabili per una società civile.
Ebbene, poiché tutto ciò è ben noto, è mio libero pensiero ritenere che
continuare a fare uso della custodia cautelare sia una forzatura inammissibile,
un abuso del diritto, una ingiustizia. Tanto più nei casi come il mio, nel quale
il rischio di fuga è formalmente escluso, quello di inquinamento è riconosciuto
come scemato, residuando, nei provvedimenti che mi hanno negato una attenuazione
della misura, solo il rischio di reiterazione, il quale però resta escluso dalla
assoluta mancanza di elementi circa i fatti di insussistenti e non provate
esfiltrazioni informatiche. Mi sembra, quindi, evidente la forzatura del
mantenimento della mia custodia cautelare in carcere, che nei vari
provvedimenti, in modo significativamente seriale, viene espressamente ancorata
alla mia (asserita) mancata resipiscenza ed alla mia mancata collaborazione,
come se una qualche norma la ponesse a buon motivo della misura cautelare!
Tralascio le altre evidenti forzature contenute nei vari provvedimenti (nei
quali, ad esempio, si fa riferimento a dati informatici esfiltrati: ma da dove
risultano tali esfiltrazioni? ma dove sono indicate negli atti di Pg?). Prima o
poi inevitabilmente emergerà che dette forzature sono solo l’evidente segno
della debolezza dell’impianto accusatorio, cui evidentemente il giudice avverte
il bisogno di porre rimedio. Tutto ciò premesso e considerato, la CONCLUSIONE
appare evidente. Infatti, quanto sopra sintetizzato induce a sospettare che le
ben note, illegali e talvolta disumane condizioni carcerarie, rispetto alle
quali non coglie il segno di alcuna reazione, vadano a conciliarsi perfettamente
con l’aspettativa che il detenuto “collabori”, anche se per legge una
collaborazione non è dovuta ed anche se (come nel mio caso) una collaborazione è
persino impossibile. Ovvio che non posso minimamente accettare l’idea che tale
sospetto possa avere un lontano fondo di verità: sarebbe a dir poco avvilente ed
irrispettoso della intelligenza e della dignità umana e professionale di chi
dovesse far uso di simili strategie. Per cui, ferma restando la incomprensibile
inerzia che accompagna le note condizioni carcerarie, voglio tenere del tutto
lontano il sospetto di un uso strumentale e distorto dello strumento carcerario,
che, diversamente ragionando, a ben vedere, si tradurrebbe in una vera e propria
tortura. Dovendo e volendo escludere l’indicato sospetto, debbo però aggiungere
che nel mio caso non ritengo si possa in alcun modo ipotizzare la attuale
sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento del mio stato di
detenzione. Come ho già detto, fuga ed inquinamento sono esclusi; e il pericolo
di reiterazione non ha ragione d’essere. Ed ovviamente la mancanza di tali
presupposti non può essere colmata con riferimento ad insussistenti e non
provati fatti di esfiltrazioni informatiche (che peraltro non sarebbero a me
riferibili): nel fascicolo non ve ne è la minima traccia e non capisco perché si
continui meccanicamente ad invocarle. Al riguardo non posso e non voglio
trattare profili tecnici, ma ritengo significativo che, salvo errori nelle
notizie di cui dispongono, io e mio fratello siamo, almeno in Italia, gli unici
imputati per “tentati” reati informatici attualmente in carcere e certamente
siamo i detentori di un record assoluto di durata di custodia cautelare
carceraria per tali reati. In conclusione, quindi, CHIEDO, in primo luogo, che
ognuno per quanto di propria competenza si attivi affinché cessino le denunciate
illegalità in ambito carcerario e, in secondo luogo, che, considerata la
insussistenza almeno attuale – dei presupposti di legge, venga rimossa o
attenuata la misura cautelare a me applicata.
Francesca Occhionero:
«Pensavo che in cella ci andasse chi commette dei reati. Invece…»,
scrive Valentina
Stella il 29 Settembre 2017 su "Il Dubbio". Francesca Occhionero, scarcerata lo
scorso 25 settembre, dopo circa 9 mesi di detenzione preventiva nel carcere
romano di Rebibbia si racconta al Dubbio. «Mi preparavo a trascorrere un’altra
notte in cella. Un’ora dopo mi sento chiamare dall’altoparlante “Occhionero
scendi a piano terra” e la guardia “prepara la tua roba e vattene perché sei
libera”». Comincia così il racconto al Dubbio di Francesca Occhionero,
scarcerata lo scorso 25 settembre, dopo circa 9 mesi di detenzione preventiva
nel carcere romano di Rebibbia, nel quale era rinchiusa perché accusata di cyber
spionaggio col fratello Giulio, che rimane a Regina Coeli. Nel provvedimento
firmato dal giudice Bencivinni si legge che viene concesso alla Occhionero
l’obbligo di firma e dimora a Roma, oltre il parere favorevole per i domiciliari
del pm Albamonte, per questi due motivi: la “condotta rispettosa” tenuta in
carcere e gli elementi emersi dall’incipit dell’istruttoria dibattimentale
“consentono di ritenere che vi sia stato un parziale ridimensionamento” della
posizione della donna. «Ho sempre avuto l’impressione di essere stata arrestata
sulla base di un fumus che non si è mai concretizzato in una serie di prove ci
racconta nello studio del suo avvocato Roberto Bottacchiari. Al giudice è
bastato da un lato che le intercettazioni fossero chiarite e dall’altro sentire
paradossalmente solo il primo teste dell’accusa, il dottor Pereno del Cnaipic
(Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture
Critiche della Polizia postale), per capire che contro di me non ci sono
elementi probanti: nessuna esfiltrazione di dati, nessun collegamento con il
malware e i server». E sul perché abbia fatto nove mesi di carcere preventivo
Francesca Occhionero si dà due spiegazioni: «Avendo avuto molto tempo di pensare
in cella, temo che abbiano strumentalizzato la mia detenzione per fare leva su
Giulio, e per acquisire conoscenza di elementi da poter poi contestare in
maniera specifica, anche se ad oggi manca ancora l’individuazione di un fatto
criminale». E sul rapporto con suo fratello, che i giornali hanno descritto
talvolta come in crisi, ci risponde: «Assolutamente, il rapporto tra me e mio
fratello è solidissimo».
Tornando al 25 settembre, le
chiediamo cosa ha fatto appena saputo di dover lasciare Rebibbia: «In pochissimo
tempo ho preparato la mia roba. Poi grandi abbracci più o meno sinceri: ho
stretto amicizie profonde che mi hanno fatto trascorrere domeniche normali.
Prima di uscire mi hanno prelevato il dna. E poi l’incontro con mio marito fuori
dal carcere. Ero emozionata ma anche tesa perché credevo che qualcuno potesse
cambiare idea e rispedirmi dentro. La prima notte non ho dormito, ero
adrenalinica, carica, non sapevo cosa fare». Il mattino invece sono subentrati
sentimenti contrastanti: «Da un lato avevo una grande voglia di uscire, di
tirare subito su le tapparelle e di andare a correre lungo il Tevere, ma poi è
subentrata l’ansia del giudizio popolare. Sono entrata in banca e mi sono
sentita gli occhi addosso di chi sussurrava nelle orecchie il mio nome,
guardandomi e pensando di non essere visto. Mi sono resa conto di avere una
popolarità negativa».
E sulla celebrità che il caso
ha suscitato: «Non mi ero resa conto subito di quello che riportavano i giornali
e le televisioni, perché nei primi giorni di detenzione non mi era stato
permesso di accedere a nulla. Poi ho notato due cose: che per la stampa mio
fratello era ingegnere nucleare, io semplicemente ‘ la sorella di’ o la runner.
Tutti avevano omesso il mio dottorato di ricerca in chimica. Poi ho letto che mi
dipingevano come “lady hacker”, “la bella spia” e mi sono resa conto che si
trattava di una montatura, di una enorme bufala che si smonterà. Ma purtroppo
qualcuno dentro e fuori il carcere ha goduto nel vedermi rinchiusa». Qualche
mese fa il Dubbio pubblicò in esclusiva una lettera dal carcere di Francesca
Occhionero in cui denunciava le pessime condizioni di detenzione: «Le prime
notti ho pianto, poi alla disperazione è subentrata la rabbia per una situazione
così surreale e shockante. Ho passato i primi venti giorni nella sezione
Camerotti, dove ci sono quelli in attesa di giudizio. Avevo paura ad uscire
dalla cella fredda e spoglia per farmi la doccia, temevo di essere aggredita.
Non capivo perché le guardie mi davano del “tu” e si rivolgevano a me con
“questa”, “quella”, palesando una chiaro atteggiamento di insufficienza. Poi
sono stata trasferita in un reparto migliore. Comunque non sono mai riuscita ad
abituarmi alla condizione di detenzione perché per me ogni giorno era l’ultimo
psicologicamente, non riuscivo a entrare nel sistema, lo rigettavo, pensavo di
uscire subito. Passavo il tempo leggendo e scrivendo, anche un libro sulla mia
vicenda, e facendo sudoku. E poi nell’ultimo mese sono riuscita a far riaprire
una palestra donata al carcere da De Rossi e Totti e ho insegnato fitness a
oltre 50 detenute». Sarà il processo a mettere un punto a questa storia ma
concludiamo chiedendo a Francesca Occhionero che idea in generale si sia fatta
di questa vicenda: «All’inizio pensavo che qualcuno doveva far carriera sulla
nostra pelle. Adesso credo che siamo un perfetto capro espiatorio, il soggetto
giusto a cui dare la colpa di qualcosa messo in piedi da altri nel passato,
essendoci altri sei malware in circolazione». Un ultimo pensiero sul carcere: «È
un mondo che non mi aveva mai incuriosita. Confesso di aver avuto un
pregiudizio, per cui se qualcuno entrava in carcere doveva aver fatto qualcosa.
Il classico luogo comune su cui mi sono dovuta ricredere. Ora dico che bisogna
pregare di non incappare nella giustizia; purtroppo si è incrinata la mia
fiducia in alcuni ambiti delle istituzioni e delle forze dell’ordine».
«Vi racconto la fantasiosa montatura sui
fratelli Occhionero». Parla l’avvocato Roberto Bottacchiari,
scrive Valentina Stella il 18 Agosto 2017 su "Il Dubbio". Qualche settimana fa
abbiamo pubblicato in esclusiva la lettera integrale che Francesca Occhionero ha
scritto dal carcere romano di Rebibbia per denunciare le condizioni disumane di
detenzione che sta vivendo insieme alle altre detenute. Oggi, mentre è in corso
anche una petizione su Change. org rivolta al Presidente Mattarella per chiedere
di porre fine alla detenzione preventiva della donna, torniamo sulla vicenda dei
fratelli Occhionero, accusati dalla Procura di Roma di aver creato una centrale
di cyberspionaggio per monitorare istituzioni, pubbliche amministrazioni, studi
professionali, imprenditori, politici di primo piano e massoni. Sentiamo il
punto di vista della difesa.
Avvocato Roberto Bottacchiari, sulla stampa è
emerso che i fratelli Occhionero sapevano di essere indagati e per questo
avrebbero sistematicamente cancellato file compromettenti. Addirittura avrebbero
negato di fornire le password e bloccato l’accesso ai loro pc lanciandosi sui
computer appena gli agenti sono entrati a casa loro.
«Si tratta di
una fantasiosa ricostruzione giornalistica. Gli investigatori sono entrati per
arrestare Giulio con un provvedimento che prevedeva anche il sequestro dei pc,
non l’accesso agli stessi, ma la polizia insisteva nel voler accedere. Questa
cosa ha indisposto Giulio che si è rifiutato di fornire le credenziali di
accesso anche per proteggere i dati dei suoi clienti. I computer devono essere
analizzati nel rispetto di tutte le regole del contraddittorio, in base alla
metodica forense che preserva dal rischio di contaminazione e cancellazione
dati. Cosa analoga è accaduta con Francesca: in maniera insistente, con
fortissima pressione, le chiedevano la password di accesso, lei rispondeva che
non aveva la password perché lavorava con la smart card. Loro l’hanno costretta
a digitare la password ma non è servito a nulla e gli investigatori hanno
sostenuto che lei abbia sfilato di proposito la smart card. Il fatto di averla
sfilata è stata una reazione di autodifesa rispetto a quello che stava
accadendo. Non è che Francesca non ha collaborato, sono gli investigatori che
sono andati contro le regole. E poi in assenza dell’avvocato: ero stato avvisato
ma nessuno mi aveva parlato di accesso ai computer».
Sta dicendo che la polizia ha operato in
maniera illegale?
«Quantomeno con
dubbia legalità: d’altronde basti pensare che la polizia postale ha inoculato,
qualche mese prima dell’arresto, un malware nel computer di Giulio. Sono entrati
con un falso aggiornamento Microsoft. Da intercettazione passiva si è
trasformata in attiva: hanno compiuto una attività di perquisizione e sequestro
e non lo hanno comunicato. Giulio comunque ha presentato una denuncia alla
Procura di Perugia che ha avviato le conseguenti indagini».
Passiamo al cuore dell’indagine: gli Occhionero
sono accusati di essersi introdotti in oltre 18000 profili e di aver conservato
in server americani i dati acquisiti illecitamente.
«Punto primo:
sul fatto che il malware appartenga a Giulio non esiste alcuna prova. Inoltre
sono state fatte anche indagini patrimoniali e non sono stati trovati soldi
estorti a qualcuno dei possibili soggetti spiati. Poi sfatiamo subito un altro
aspetto che è stato urlato dalla stampa: il computer di Matteo Renzi non poteva
essere infettato perché usava Apple mentre il software che avrebbe usato Giulio
è Microsoft. Inoltre dall’analisi dei nostri periti solo 1935 (8,2%) username
recano anche la password ma non risultano essere stati mai utilizzati;
all’interno dei 1.935 indirizzi, solo 11 (0,5%) sono relativi ad Enti; da essi,
non risultano essere mai state utilizzate le credenziali; nessun elemento
risulta transitato verso Giulio Occhionero: nessuna esfiltrazione. Rispetto a
quest’ultimo punto un grave errore è stato commesso dal Tribunale del Riesame
che scrive di dati esfiltrati. Il pm Albamonte ci ha confermato che invece nelle
contestazioni manca l’esfiltrazione».
Però addirittura nelle indagini sarebbe
intervenuta l’Fbi con i suoi potenti mezzi.
«Come si legge
espressamente nel documento che vi ho fornito, il 21 marzo 2016 la Polizia
Postale Italiana chiedeva agli americani di sapere dove Giulio avesse comprato
la licenza di un software (Corporation) che sarebbe servita, a parer loro, per
comporre il malware. L’Fbi ha risposto, specificando che tutto quello che aveva
comunicato non poteva essere usato dall’Italia in nessun procedimento legale. E
invece ce lo troviamo nell’ordinanza di custodia cautelare. Ma poi secondo il
buon senso Giulio andava a comprare la licenza dando il suo nome e la sua carta
di credito se avesse avuto intenzioni illegali? Per non dire del fatto che mai
un hacker collocherebbe i propri server nel Paese – gli Usa – con la più severa
legislazione in materia di crimini informatici. Insomma, tutto stride con la
linea dell’accusa».
Si è scritto anche che Giulio Occhionero
spiasse il pm Albamonte.
«Non è affatto
così. Semplicemente aveva incaricato una persona di procurargli gli appunti di
un intervento che Albamonte aveva tenuto in un convegno sui reati informatici».
La sua cliente è in custodia cautelare da ormai
quasi otto mesi.
««Purtroppo,
come ha ben descritto nella sua lettera Francesca, le condizioni di detenzione
sono difficili. Contro di lei sembra esserci una sorta di accanimento. Alcuni
esempi: la precedente udienza è stata segnata da un episodio che lascia
quantomeno perplessi: i fratelli Occhionero sono stati condotti in Tribunale con
le manette ai polsi, con un caldo afoso, e senza poter bere dell’acqua dalla
bottiglietta che gli volevamo offrire noi avvocati. Ma la cosa drammatica è che
la giudice era in ferie e nessuno ci aveva avvisato! Per non parlare delle
vessazioni che subisce: circa un mese fa una detenuta si è infiltrata tra i
visitatori tentando la fuga. Hanno dato la colpa a Francesca chiedendole perché
non avesse avvisato le guardie che la detenuta voleva fuggire. Dopo questo le è
stato dimezzato il piazzale dove corre. Questa cosa è fuori da ogni regolamento».
Secondo gli inquirenti ad incastrarla sarebbero
sostanzialmente due intercettazioni telefoniche: in una lei rispondendo al
fratello dice ‘ Giulio ti prego di non coinvolgere mamma nei nostri problemi……
come vedi sono dei falsi allarmi’ e la seconda in cui lei, parlando con un
tecnico informatico, dice che ha necessità di connettersi ai server Usa, dove,
secondo la relazione della Mentat, sarebbero custoditi i dati esfiltrati.
««Nel primo
caso quell’espressione è mal collocata nel contesto investigativo, non è oggetto
di acquisizione agli atti del processo e si riferiva ai problemi economici per
superare i quali la mamma aveva ampiamente contribuito, ad esempio vendendo un
villino a Santa Marinella per dividere il ricavato tra i due figli. Come si
legge chiaramente dalla trascrizione della seconda telefonata la mia cliente
dice espressamente “non sono un tecnico informatico” e chiede aiuto per entrare
nel dominio dell’azienda che dirige, ossia la Westlands.com a cui specifica che
accedono anche altri dipendenti. Quindi di quale oscuro server stiamo parlando?
Ci tengo però a dire che a riguardo della mia cliente è avvenuto un fatto
gravissimo: a Francesca il Tribunale del Riesame ha negato i domiciliari perché
si rifiuta di collaborare. Quale norma prevede questo? Un’altra motivazione è
che potrebbe reiterare il reato utilizzando lo smartphone ma i periti hanno già
stabilito che dal cellulare quel malware non può essere utilizzato».
Avvocato ascoltando la sua versione, quella dei
fratelli Occhionero sembrerebbe una montatura gigante.
«Senza il reato
di esfiltrazione di dati, di cui ripeto non si hanno prove, il reato minore che
così rimarrebbe sarebbe quello di aver tentato di utilizzare una email con
relativa password. Questa è cosa ben diversa dall’aver danneggiato il computer
di qualcuno, che è l’aggravante che giustifica la custodia cautelare, ma non vi
è stato nessuno che abbia potuto dire una simile cosa. L’Acea ha persino
rinunciato a costituirsi parte civile per non aver subito danni».
Falso e abuso d’ufficio: il presidente
dell’Anm indagato a Perugia. Le accuse si riferiscono
alla gestione dell’inchiesta sui fratelli Occhionero. Il pm disponibile ad
astenersi, come chiesto dalla difesa, ma Pignatone ha stabilito che continuerà a
seguire il processo. Il pg Salvi: «Decisione pienamente condivisa», scrive
Ilaria Sacchettoni il 21 settembre 2017 su "Il Corriere della Sera”. Il pubblico
ministero di Roma Eugenio Albamonte, presidente l’Associazione nazionale
magistrati, è indagato dalla procura di Perugia per falso e abuso d’ufficio. Le
contestazioni si riferiscono alla gestione dell’inchiesta sui fratelli Giulio e
Francesca Occhionero, arrestati a gennaio scorso e oggi a processo con l’accusa
di aver hackerato le mail di politici e manager. Proprio Giulio Occhionero ha
presentato la denuncia sfociata nell’iscrizione a «modello 21» del pm e di due
investigatori della polizia postale, Ivano Gabrielli e Federico Preno.
L’iscrizione di Albamonte nel registro degli indagati è emersa oggi nel processo
agli Occhionero. La difesa, gli avvocati Stefano Parretta e Roberto
Bottacchiari, hanno chiesto che il pm si astenga dal processo, ma il capo della
procura, Giuseppe Pignatone, non ha accolto la disponibilità del magistrato al
passo indietro. Una decisione che il procuratore generale, Giovanni Salvi, ha
«pienamente condiviso». Nel suo provvedimento Pignatone, facendo riferimento a
una giurisprudenza consolidata, sostiene che «non può confondersi l’inimicizia
fra magistrato e parte con le iniziative di quest’ultima, tesa a sottrarsi al
proprio giudice naturale; l’inimicizia deve trovare fondamento in rapporti
personali svolti in precedenza e fuori del processo». A parere del procuratore,
dall’istruttoria «risulta che l’imputato Giulio Occhionero, nel corso delle
indagini a suo carico e prima di avere accesso agli atti del procedimento, aveva
già manifestato l’intenzione di presentare un esposto contro Albamonte alla
procura di Perugia», come emerge da una conversazione intercettata il 18
novembre del 2016. Da altri colloqui carpiti in quello stesso periodo - ricorda
Pignatone in una nota sarà trasmessa domani al giudice del dibattimento
Antonella Bencivinni - «risulta che Occhionero, avendo appreso la falsa notizia
dell’imminente trasferimento di Albamonte ad altro incarico, esprimeva
soddisfazione per il fatto che lo stesso non si sarebbe più occupato delle
indagini a suo carico». Occhionero è ancora detenuto a Rebibbia. Fra gli spiati
erano anche emersi i nomi del politico Domenico Gramazio, del costruttore
Antonio Pulcini, dell’avvocato Lucio Ghia e molti altri. Violati anche il sito
dell’accoglienza del vicariato romano e i computer di società assicurative e
imprese private. Giulio Occhionero aveva ammesso durante il suo interrogatorio
di garanzia di essere un massone. Ma ha sempre sostenuto la sua innocenza,
spiegando che le molte informazioni trovate sui suoi pc gli servivano per il suo
lavoro di consulente d’azienda.
Cyberspionaggio: pm Albamonte indagato
dopo esposto Occhionero. Ma resta pubblico ministero a
processo. Il presidente dell'Anm è accusato di falso e abuso d'ufficio insieme a
due agenti della polizia postale. Pignatone conferma la designazione:
l'inimicizia tra magistrato e parte, può diventare un impedimento per un
corretto giudizio, scrive il 22 settembre 2017 "La Repubblica". Falso e abuso
d'ufficio: sono questi i reati contestati al presidente dell'Anm e pm a Roma,
Eugenio Albamonte, dalla Procura di Perugia, che indaga in seguito a un esposto
presentato nel febbraio scorso da Giulio Occhionero, l'ingegnere finito sotto
processo assieme alla sorella Francesca Maria, per una presunta attività di
cyberspionaggio ai danni di siti istituzionali e mail di politici, enti e
imprenditori, nell'inchiesta 'Eye Piramid'. Nonostante questo, Albamonte,
continuerà a rappresentare l'accusa nel processo a carico dei fratelli. Lo ha
deciso il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Pignatone, secondo il quale,
"l'inimicizia tra magistrato e parte", può diventare un impedimento per un
corretto giudizio. La notizia dell'iscrizione è emersa nel corso della prima
udienza, davanti al giudice monocratico, del processo agli Occhionero. Gli
avvocati della difesa hanno formalmente chiesto al pm di astenersi dal
rappresentare l'accusa durante il procedimento.
Il procuratore Giuseppe Pignatone, però, ha
confermato Albamonte a rappresentare l'accusa nel processo con un provvedimento
che verrà depositato in udienza. Una decisione "pienamente condivisa" dal
procuratore generale presso la Corte d'appello, Giovanni Salvi. In base a quanto
si apprende, il fascicolo nel capoluogo umbro è stato aperto contestualmente al
deposito dell'esposto, ma l'iscrizione del magistrato è arrivata alcune
settimane fa. Nel suo documento Giulio Occhionero lamenta alcuni 'abusi' fatti
dall'autorità inquirente nel corso dell'attività di indagine.
Accessi non consentiti al suo personal computer,
violazioni della privacy e altri illeciti. Su quanto denunciato, Occhionero nel
giugno scorso è stato chiamato a deporre, in presenza del suo difensore,
l'avvocato Stefano Parretta, davanti ai pm umbri L'ingegnere avrebbe confermato
le accuse. Sul fascicolo aperto, al momento, Perugia mantiene il riserbo più
assoluto. Il procuratore Luigi De Ficchy non ha voluto in alcun modo commentare
quanto emerso nell'udienza romana, anche se l'iscrizione sarebbe un atto dovuto
in seguito all'esposto. Con Albamonte risultano indagati anche due agenti della
polizia postale a cui viene contestato anche l'accesso abusivo a sistema
informatico.
Il colpo di scena ha fatto, quindi, slittare le
audizioni di alcuni testi dell'accusa che erano in programma per la prima
udienza del processo. I fratelli Occhionero, che sono detenuti dal gennaio
scorso, sono accusati di avere organizzato una colossale operazione di
cyberspionaggio ai danni anche di alte cariche dello Stato. I due avrebbero
tentato di violare anche le mail dell'ex presedente del consiglio Matteo Renzi,
del presidente della Bce Mario Draghi e dell'ex premier Mario Monti. Nei loro
confronti la Procura contesta i reati di procacciamento di notizie concernenti
la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato ed
intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche.
PRESUNTO COLPEVOLE. FILIPPO MAGNINI.
Stangata a Magnini, 4 anni per doping.
Sospeso per uso o tentato uso. "Mi sento come
Cristiano Ronaldo", scrive Riccardo Signori, Mercoledì 07/11/2018, su "Il
Giornale". È solo la virata dei 50 metri. «Ed io le gare le vincevo negli ultimi
10 metri». Fra le tante cose dette da Filippo Magnini, questa è l'unica che non
sia controvertibile. Il resto per ora è fumo o, peggio, da condannare, ha
sentenziato il tribunale antidoping di Nado Italia infliggendogli una squalifica
di quattro anni per uso o tentato uso di doping (norma 2.2 del codice Wada).
Condanna a lui e al compagno di allenamento Michele Santucci. Entrambi non certo
agevolati dalla conoscenza del medico-nutrizionista Guido Porcellini,
gratificato di 30 anni di squalifica e sotto processo penale a Pesaro. Magnini,
due volte campione mondiale dei 100 s.l., come gli altri? Speriamo, speravamo
tutti che così non fosse. Lo abbiamo visto paladino dell'antidoping per anni, ha
fondato pure il movimento I'm doping free, il tribunale penale aveva archiviato
ogni responsabilità. La Procura sportiva non gli ha creduto: inflessibile e
pesante nella richiesta (8 anni). Però che dire? Quasi, quasi, stona vederlo
incunearsi nello stesso atteggiamento difensivo di tanti dopati che si sono
detti innocenti, nonostante le squalifiche. Tutti si muovono e parlano nello
stesso modo. Scenografia un po' datata. Ci stiamo ancora trascinando il caso
Schwazer con implicazioni di non facile interpretazione. Magnini si sente
vittima, accusa e controaccusa. «La procura dice di pensare che abbiamo pensato
di fare qualcosa, anche se poi non lo abbiamo fatto: mi vien da ridere». Il
tribunale sportivo squalifica anche sul sospetto. Filippo è sempre stato un
fiume di parole, e spesso acchiappa l'immagine che fa colpo. Stavolta ci ha
provato con Cristiano Ronaldo. «Mi rivedo in lui. Ha usato una frase, dopo
l'accusa di stupro: Sono un esempio nello sport e nella vita. Io ho una ragazza
che amo e mi segue in tutto, sono in salute, e ho sempre avuto un sorriso per
tutti». Il sorriso di Magnini è passato alla storia, ma forse si spegnerebbe
pensando che CR7 ha pagato per mettere il silenzio ad una ragazza, furba o
ingenua: non giudichiamo, non è proprio un uscirne bene. Un dubbio per il nostro
ex nuotatore, che ora lotterà per la sua faccia pulita in appello o davanti al
Tas di Losanna. La sentenza è inutilmente pesante visto che Magnini ha già
chiuso la carriera, ma fa pensare non sia tanto «un accanimento, una forzatura»,
come dice il Magno, piuttosto l'ennesimo avviso ai naviganti. O ai nuotatori,
sebben la Federnuoto abbia ricordato che Filippo è stato atleta simbolo per un
Paese dotato di 5 milioni di praticanti. E di tanti campioni puliti.
Doping, Magnini è una furia: «Non c’è una
prova, siamo nel Far West». L’ex nuotatore
squalificato quattro anni: «Il pm mi ha urlato: questa è una questione
personale. Ho anche pensato volessero colpire qualcuno più in alto», scrive
Marco Bonarrigo il 6 novembre 2018 su "Il Corriere della Sera”. La rampa 28
della curva sud dello Stadio Olimpico ne ha viste tante di fughe alla
chetichella dalle stanze disadorne del Tribunale Nazionale Antidoping:
dall’uscita di servizio, attraverso il dedalo di sotterranei del campo, dentro
macchine dai vetri scuri, a occhi bassi e con un corteo di avvocati a far da
scudo. Non è il caso di Filippo Magnini. Il pluricampione del mondo di nuoto
lascia l’aula dopo 5 minuti di udienza e con 4 anni di squalifica sul groppone
ma ha voglia di parlare, quasi di urlare. Niente avvocati a fare da filtro, la
fidanzata Giorgia Palmas a guardarlo a distanza, presenza muta al fianco del
compagno di sventura Michele Santucci. «Ci hanno sbattuto sulle prime pagine dei
giornali come dopati e dopatori — attacca Filo — e adesso ci danno 4 anni perché
forse, secondo loro, avremmo tentato di doparci. Con sostanze che nessuno ci ha
mai indicato, con prove che non esistono, dopo interrogatori a dir poco
inquietanti di cui un giorno forse rivelerò i particolari». Il nemico di Magnini
ha un nome e un cognome. È l’ex pubblico ministero romano Pierfilippo Laviani
che il Coni ha designato lo scorso anno come pubblica accusa dell’agenzia
antidoping italiana. «In quale tribunale — si accalora l’ex nuotatore — un pm
può permettersi di alzarsi in piedi, sbattere i pugni sul tavolo e urlare
all’imputato “Questa è una questione personale tra me e lei?”. Siamo nel Far
West? Come può il Coni non avere paura di una situazione del genere? Come fanno
gli atleti a non temerla? Io ho accettato ogni tipo di processo ma qui fin
dall’inizio si cercava una verità precostituita». Parole durissime. Magnini
giura che mai l’accusa avrebbe fatto il nome della sostanza con cui lui e
Santucci si sarebbero dopati. Ma nelle carte dell’inchiesta si parla delle
famigerate fiale di Gh, il proibitissimo ormone della crescita che il medico
Porcellini ha effettivamente ordinato via Internet in Cina e ricevuto a Pesaro.
«Cosa significa “tentato uso”? — prosegue l’atleta — Tentato uso è se ti beccano
con la roba nello zaino o nel frigo. E allora certo che meriti la condanna. Ma
nelle carte non c’è una telefonata, una consegna, un pacco a mio nome. Niente.
Cercavano un capro espiatorio, l’hanno trovato. Ho anche pensato volessero
colpire qualcuno più in alto. Chi? Non ve lo posso dire. No, non Federica
Pellegrini, magari qualche altro atleta, magari un politico. Io la penso come
Cristiano Ronaldo. Sono stato un esempio nello sport e nella vita, ho una
bellissima famiglia, ho sempre aiutato il prossimo per cui quello che dice certa
gente non mi tocca». Nessun atleta aveva mai attaccato così duramente e
direttamente gli organi di giustizia sportiva antidoping. Organi che, al
contrario di quelli penali, mantengono blindatissimi sia i processi che le
decisioni: accesso proibito alla stampa, motivazioni delle sentenze pubblicate
solo per telegrafici estratti, procuratori e magistrati muti come pesci. Ecco,
se c’è un’esigenza che emerge dopo la squalifica choc di Magnini (e Santucci) e
dopo le sue durissime dichiarazioni è quella di procedure più trasparenti che
permettano a tutti almeno di farsi un’opinione più chiara della verità. Che, al
momento, è solo parziale: gli avvocati di Magnini (Stincardini e Compagna) hanno
annunciato ricorso sia al tribunale d’appello (servirà almeno un mese) e, se
dovesse servire, al Tas di Losanna dove le prove verrebbero vagliate a livello
internazionale. «Se devo paragonarla a una gara di nuoto — chiude Magnini —
questa mia corsa è alla prima virata, ai 50 metri. E io le gare importanti le
vincevo sempre negli ultimi dieci».
Doping, Magnini squalificato per 4 anni.
“Sentenza già scritta, io come Ronaldo”. L’ex
nuotatore azzurro è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale antidoping,
insieme al collega Michele Santucci, per "tentato uso": la richiesta della
Procura era stata di 8 anni. Paga le sue frequentazioni col nutrizionista Guido
Porcellini. L'attacco: "Vittima di una persecuzione, ma resto un esempio",
scrive "Il Fatto Quotidiano" il 6 novembre 2018. La prima sezione del Tribunale
nazionale antidoping ha squalificato Filippo Magnini per quattro anni. L’ex
nuotatore azzurro è stato riconosciuto colpevole di aver violato l’articolo
2.2 del codice Wada, nello specifico per tentato uso di sostanze dopanti. La
richiesta della Procura di Nado Italia era stata di otto anni. La stessa pena è
stata inflitta al suo collega Michele Santucci. Il due volte campione del
mondo dei 100 stile libero di Montreal e Melbourne paga le sue frequentazioni
col nutrizionista Guido Porcellini, a sua volta squalificato per 30 anni e
a processo penale a Pesaro per un presunto traffico di sostanze dopanti. Magnini
ha sempre professato la sua innocenza, forte del fatto che il tribunale penale
aveva archiviato ogni sua responsabilità. Il velocista si è ritirato un anno fa
e nel corso della sua carriera non è mai risultato positivo. Ora lui e Santucci
potranno ricorrere in appello. L’ultima chance rimane il Tas di Losanna. “E’ una
sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero”, commenta lo
stesso Magnini. “Il procuratore Laviani mi ha detto al processo, sbattendo i
pugni sul tavolo: ‘Basta, ormai questa è una questione personale‘. Parliamo di
un accanimento, di una forzatura. Faremo sicuramente ricorso”, annuncia. “Nella
giustizia ordinaria non ci potrebbe essere una questione personale, questa è una
cosa molto grave”, sostiene l’ex nuotatore azzurro. “Ci sono state
molte irregolarità, abbiamo le prove ma le diremo nelle sedi giuste – prosegue-
Ma sono molto deluso da questa giustizia sportiva, che non chiamo nemmeno più
così”. Magnini continua il suo sfogo: “Perché è successo? Ho pensato di tutto,
che il mio movimento ‘I’m doping free‘ possa aver dato fastidio a qualcuno o che
io potessi essere una pedina per colpire qualcuno più importante. Di certo qua
non parliamo di un pregiudizio nei miei confronti, ma di una persecuzione”. L’ex
nuotatore dice di rivedersi “molto” in Cristiano Ronaldo “riguardo le accuse
di stupro che gli sono state rivolte. Lui ha detto ‘Sono un esempio nello sport’
e lo sono anche io”. “Ho una bellissima famiglia e una ragazza che mi segue in
tutto e che amo. Non mi faccio toccare minimamente dalle cose ridicole che dice
certa gente, di cui non ho alcuna stima”, conclude il due volte campione del
mondo. Magnini era stato indagato insieme a Santucci dalla procura antidoping
Nado Italia nell’ottobre 2017 sulla base degli atti dell’inchiesta della procura
della Repubblica di Pesaro sul caso del medico nutrizionista Porcellini. Al due
volte campione del mondo veniva contestata la violazione degli articoli 2.2 e
2.9 (favoreggiamento) del codice Wada. A Santucci veniva contestato solo uso o
tentato uso (articolo 2.2).
Doping, Magnini e Santucci squalificati
per 4 anni. Il Tribunale antidoping ha dimezzato la
richiesta di sospensione per gli ex velocisti ma confermato l’impianto
accusatorio fermandoli per tentato uso di doping. Trenta anni al nutrizionista
Porcellini. L’ex campione: “Sentenza ridicola, scritta prima del processo. Mi
sento come Ronaldo”, scrive il 6 novembre 2018 Gazzetta.it. Dimezzata la
richiesta (otto anni) di squalifica da parte della Procura antidoping, ma oggi a
Roma la prima sezione del Tribunale antidoping di Nado Italia (Tna), presieduto
da Adele Rando, ha inflitto però a Filippo Magnini quattro anni ed altrettanti
all’altro velocista Michele Santucci per uso o tentato uso di doping (la norma
2.2 del codice Wada). Il bicampione del mondo dei 100 sl di Montreal e Melbourne
paga la frequentazione col nutrizionista Guido Porcellini, a sua volta
squalificato 30 anni e a processo penale a Pesaro. Magnini aveva professato la
sua innocenza poggiandosi anche sul fatto che il tribunale penale aveva
archiviato ogni sua responsabilità. Ma la Procura sportiva è stata inflessibile
e il solo sospetto viene punito. Adesso Magnini e Santucci potranno ricorrere in
appello, ed in ultima istanza al Tribunale sportivo (Tas) di Losanna. Dal
processo di alcune settimane fa, Magnini era uscito più ottimista: “Ho
raccontato semplicemente la verità e ora sono tranquillo. Che sono totalmente
estraneo ai fatti”. La sentenza era stata rinviata ad oggi. Magnini si è
ritirato un anno fa. Nel corso della sua carriera non è mai risultato positivo.
PARLA L’EX CAMPIONE — Così Magnini ha commentato
la squalifica: “Le parole di Filo: “Sono dispiaciuto e anche arrabbiato, ma me
l’aspettavo. So che la sentenza era stata scritta già prima del 15 ottobre,
prima che io venissi qui a parlare. Perché? Non lo so, ce lo stiamo chiedendo
con gli avvocati, stiamo pensando a chi potrei aver pestato i piedi. Non ho
fatto nulla, questa sentenza è ridicola. Il procuratore Laviani mi ha detto a
processo sbattendo i pugni sul tavolo: “Basta, ormai è una questione personale”.
Parliamo di un accanimento, di una forzatura. Non ci sono prove, anzi le prove
dimostrano il contrario. Faremo sicuramente ricorso”. Quindi Magnini fa un
accostamento: “Mi rivedo molto in una frase importante e bella di Cristiano
Ronaldo, accusato di stupro. Io come lui sono un esempio nello sport e nella
vita: ho una bellissima famiglia, ho una ragazza che amo e mi segue in tutto,
sono in salute e ho sempre avuto un sorriso per tutti, quindi sinceramente di
quello che dice certa gente non mi interessa minimamente”. E ancora: “Una cosa
mi fa ridere, anzi mi fa rabbia: la Procura dice di pensare che noi abbiamo
pensato di fare qualcosa, anche se poi non lo abbiamo fatto. È un processo alle
intenzioni e non mi sarei mai immaginato una cosa del genere: sono incazzato
nero. Se vogliamo guardare gli aspetti positivi, visto che sono sempre stato un
atleta ottimista, oggi usciamo da qui con la certezza che non si può dire né
scrivere che Magnini si sia dopato. Perché sui tre capi di accusa due sono
spariti - ha sottolineato Magnini, lasciando gli uffici del Tna allo stadio
Olimpico di Roma -. Qualunque persona che ha un po’ di cervello capisce che io
non posso aver convinto una persona di trenta anni come Michele (Santucci, anche
lui squalificato per quattro anni, ndr) a fare delle cose. L’entità della
squalifica di 4 anni? Io mi sarei arrabbiato anche per un giorno. Quattro anni
fa ridere perché viene fuori da niente. Abbiamo esempi di atleti che hanno preso
due mesi dopo essere stati trovati positivi, altri che hanno preso due anni da
recidivi. Noi abbiamo più o meno 200 controlli nazionali e internazionali tutti
a posto, e forse anche di più: quattro anni mi sembra esagerato. Non dico di
fare come negli altri Paesi, dove per una cosa del genere ti avrebbero dato una
pacca sulla spalla, ma noi non abbiamo neanche fatto il tentativo. Nessuno ha
mai pensato a questo. Io e Michele abbiamo fatto un record insieme: siamo gli
unici atleti non positivi che vengono squalificati. Voglio dare un consiglio al
Coni. Pensare che al Comitato Olimpico vada bene che un procuratore, al quale è
stato dato pieno potere, possa dire queste parole senza avere nessuna
ripercussione, mi farebbe arrabbiare parecchio fossi in loro. È una cosa molto
grave, l’indagine non è stata fatta per cercare la verità. Ci sono state molte
irregolarità nel processo. Abbiamo prove di cose accadute molto gravi e le
diremo nelle sedi giuste. Sono molto deluso da questa giustizia sportiva che non
chiamo nemmeno più così. Credo che scriverò un libro su questa vicenda. Agli
atleti dico: “state attenti, fate qualcosa perché io ho avuto paura”. Finché non
sono morto non posso accettare una cosa del genere. Siamo solo alla virata dei
cinquanta metri ed io le gare le vincevo negli ultimi dieci. Perché è successo?
Ho pensato di tutto, anche che il mio movimento “I’m doping free” possa aver
dato fastidio a qualcuno o che io potessi essere una pedina per colpire qualcuno
più importante. Se i trenta anni dati al medico Porcellini possano aver portato
il mio processo su questa strada? Forse è tutto uno schema, ma mi chiedo quale
sia il motivo. È una persecuzione, un accanimento nei miei confronti: la legge
non può essere una cosa personale, non si giudica così. Al mio amico Mornati
sono state fatte saltare le Olimpiadi di Rio e poi poco tempo fa ho avuto
ragione dalla giustizia ordinaria: così è un po’ troppo facile”.
LA NOTA FEDERALE — In una nota la Federnuoto
“esprime fiducia negli organi preposti a prevenire, combattere e perseguire il
doping. Il percorso giudiziale che coinvolge Filippo Magnini e Michele Santucci
ha espresso solo il primo verdetto e potrebbe proseguire. Pertanto la Federnuoto
chiede il massimo rispetto nei confronti degli atleti, auspicando che riescano a
dimostrare la loro estraneità alla vicenda in ulteriori sedi. La Federnuoto
ricorda altresì come Magnini sia stato - nel corso della sua straordinaria
carriera - un esempio per tutto il movimento, nonché uomo simbolo dello sport
italiano e della lotta al doping. Si coglie l’occasione per ribadire l’impegno
della Federazione Italiana Nuoto per affermare e tutelare lo sport pulito e nel
trasmettere i principi di lealtà e probità, condivisione, aggregazione e
integrazione nel nostro Paese che conta oltre 5.000.000 di praticanti”.
PRESUNTO COLPEVOLE. ALEX SCHWAZER.
VEDETE, E’ TUTTO INUTILE. NON C’E’ NIENTE
DA FARE. SE QUANTO PROVATO SULLA PROPRIA PELLE E SE QUANTO DETTO HA UN RISCONTRO
E TUTTO CIO' NON BASTA A RIBELLARSI O ALMENO A RICREDERSI SULL'OPERATO DELLA
MAGISTRATURA, ALLORA MAI NULLA CAMBIERA' IN QUESTA ITALIA CON QUESTI ITALIANI.
D'altronde di italiani si tratta:
dicono una cosa ed un’altra ne fanno. Per esempio, rimanendo in ambito sportivo
in tema di legalità, è da rimarcare come la
parola di un altoatesino vale di più di quella di un napoletano. Almeno secondo
Alex Schwazer, atleta nato in quel di Vipiteno il 26 dicembre 1984, trovato
positivo al test antidoping prima delle Olimpiadi di Londra 2012. Era il 28
giugno 2012. Due giorni dopo, un test a sorpresa della Wada, l'agenzia mondiale
antidoping, avrebbe rivelato la sua positività all'assunzione dell'Epo. «Posso
giurare che non ho fatto niente di proibito – scriveva Schwazer, il 28 giugno
2012, al medico della Fidal Pierluigi Fiorella – ti ho dato la mia parola e non
ti deluderò. Sono altoatesino, non sono napoletano». Due giorni dopo, il 30
giugno, l'atleta viene trovato positivo all'Epo. Ma l'insieme della
contraddizioni (a voler essere gentili) non finisce qui. Nella sua confessione
pubblica dell'8 agosto 2012, Schwazer ammise di aver assunto Epo a causa di un
cedimento psicologico. Era un brutto periodo, e qualcosa bisognava pur fare. Ma
le indagini dei Ros di Trento e dei Nas di Firenze contraddicono la versione
dell'assunzione momentanea. I carabinieri, addirittura, parlano di “profilo
ematologico personale”, un'assunzione continua e costante di sostanze dopanti
per la quale non è escluso che Schwazer facesse utilizzo di Epo anche durante i
giochi di Pechino 2008. Competizione, lo ricordiamo, dove l'atleta di Vipiteno,
vinse l'oro alla marcia di 50 chilometri. Infatti, questo si evince anche nel
decreto di perquisizione della Procura di Bolzano. “La polizia giudiziaria
giunge pertanto a ritenere che non possa escludersi che Schwazer Alex, già
durante la preparazione per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 (e
forse ancor prima), sia stato sottoposto a trattamenti farmacologici
o a manipolazioni fisiologiche capaci di innalzare considerevolmente i suoi
valori ematici.” Insomma: Schwazer non solo offende i napoletani e di
riporto tutti i meridionali, incluso me, ma poi, come un fesso, si fa cogliere
pure con le mani nel sacco. E dire che, oltretutto, è la parola di un
carabiniere, qual è Alex Schwazer.
"Le urine di Schwazer furono manipolate".
Una rivelazione riapre il giallo doping. Nei due
campioni ri-analizzati trovate differenze abnormi nella quantità di dna, scrive
Benny Casadei Lucchi, Sabato 28/07/2018, su "Il Giornale". «Io marcio» ha detto
un giorno, «io marcio per me stesso» ha concluso la frase dopo aver ripreso
fiato. Una pausa in mezzo. Come a separare volutamente l'«io marcio» che sa di
confessione ed evoca il giallo, i dubbi, lo sporco che ne hanno accompagnato a
tratti la carriera, dall'«io marcio per me stesso» che rappresenta invece
l'amore con cui ha comunque affrontato quella carriera. Anche se l'amore, si sa,
talvolta distrugge. Alex Schwazer è questo. È una frase spezzata in due come la
sua vita agonistica e non solo agonistica. Prima l'oro olimpico di Rio e la
gloria, poi la vergogna grande e la confessione di Londra 2012. Prima la vita da
reietto dello sport seguita alla squalifica, poi il ritorno vincente del 2016
alla vigilia dei Giochi di Rio accudito dal professor Sandro Donati, simbolo
della lotta al doping e diventato per Alex patente e certificato di pulizia.
Prima la vittoria al rientro, seguita da redenzione e applausi, poi il nuovo
sprofondo alla vigilia delle olimpiadi brasiliane. E ancora: prima la nuova
squalifica a otto anni e la fine della carriera, poi la voglia di vederci
chiaro, i dubbi su quel controllo delle urine effettuato dagli ispettori su
incarico Iaaf e deciso proprio nel giorno in cui l'atleta aveva testimoniato
contro un medico della Federazione internazionale. Una provetta rimasta troppe
ore in mano agli ispettori prima di arrivare al laboratorio di Colonia e mai
veramente anonima come invece dovrebbe, fecero subito notare i difensori di
Schwazer. Un campione di urina che al primo controllo era risultato a posto e al
secondo con una concentrazione di valori dopanti talmente minimi da non poter
aiutare la prestazione atletica. Un giallo. O Schwazer stupido all'inverosimile
da doparsi per non aver alcun beneficio o Schwazer al centro di un qualche
complotto. Anche per questo l'atleta, che nel primo caso di doping, a Londra,
aveva subito confessato, la seconda volta aveva urlato la propria innocenza
chiedendo di vederci chiaro «perché credo che lì dentro ci siano anche le urine
di altri» aveva detto, «e allora voglio l'esame del dna, non servirà per la mia
carriera ormai finita, ma per il mio onore sì...». Ed è proprio dell'esame del
dna che si è saputo ieri. Ultimo e più importante tentativo di ricomporre i
cocci dell'esistenza di questo altotesino di 34 anni. La notizia è stata data
dal quotidiano altotesino Tageszeitung e da Nando Sanvito sul il
sussidiario.net, giornalista che non ha mai smesso di voler far luce sulla
vicenda: «L'esame delle urine ha rivelato che le urine di Alex Schwazer sono
state manipolate» ha scritto dopo essere venuto a conoscenza del risultato delle
analisi svolte, su richiesta del tribunale di Bolzano, sul campione di urine.
Ovviamente non sono state trovate le tracce di altri dna, ma di quello dello
stesso Schwazer in quantità così abnormi da far sospettare il tentativo di
nasconderne altri. Il dna col tempo va infatti riducendosi in modo vistoso, per
cui è anomalo che nel primo campione, quello negativo, ci fosse un quantitativo
inferiore al secondo. Da qui la decisione del Ris di Parma e del suo comandante
Giampietro Lago (anche perito del tribunale di Bolzano) di monitorare il dna
separato in due campioni di un centinaio di volontari. Per capire se difformità
simili siano possibili. I risultati definitivi a settembre. Per ricominciare di
nuovo a ricomporre i cocci di un uomo discusso. O per buttarne via l'ultimo e
dimenticarlo per sempre.
Doping Schwazer, anomalie nelle analisi:
ora un test su 100 dna. Le analisi sui campioni A e B
risultati positivi alla vigilia di Rio de Janeiro effettuate dal Ris rilevano
discrepanze «abnormi» nella concentrazione di dna nelle due provette, scrive
Giuseppe Toti il 27 luglio 2018 su "Il Corriere della Sera". Se non siamo di
fronte al passo decisivo, poco ci manca. La vicenda di Alex Schwazer, secondo le
clamorose rivelazioni di giovedì scorso di Tageszeitung, quotidiano altoatesino
in lingua tedesca, è giunta a un momento cruciale grazie al lavoro che da molti
mesi sta portando avanti il Ris di Parma del colonnello Giampietro Lago, su
incarico del gip di Bolzano, titolare dell’inchiesta penale, Walter Pelino. Per
prima cosa, le analisi di laboratorio sui campioni A e B di urina del marciatore
azzurro — fermato per doping nel 2016, alla vigilia dei Giochi olimpici di Rio
de Janeiro, in seguito al controllo a sorpresa di gennaio di quell’anno, dopo
essersi affidato alle cure del professor Sandro Donati, memoria storica
dell’antidoping italiano — hanno evidenziato un’anomalia incredibile: la
concentrazione di dna di Schwazer nel campione B è tre volte superiore a quella
presente nel flacone A: 1.187 nanogrammi contro 437. Una discrepanza
«inspiegabile» scientificamente, che potrebbe nascondere ciò che l’entourage di
Schwazer ha sempre sostenuto con forza: la manomissione delle provette
(faticosamente ottenute dopo una battaglia durissima dal laboratorio di Colonia,
che il 7 febbraio scorso aveva addirittura consegnato un campione aperto) per
incastrare l’atleta e realizzare il «delitto perfetto». La Iaaf si è già
affrettata a dichiarare che quella differenza abnorme non ha valore, il Ris
invece continua spedito: il comandante Lago ha infatti ordinato una maxi test
sul dna di 100 individui, scelti tra sportivi e persone comuni, che hanno dato
l’assenso. Le conclusioni del Ris saranno presentate entro il 5 settembre sul
tavolo del gip Pelino: se la «discrepanza» dovesse rimanere solo per Schwazer e
non riguardare nessuno di quei cento, allora molti altri dubbi verrebbero
spazzati via.
CASO SCHWAZER. L'esame del Dna rivela la
manipolazione delle urine (esclusiva). Le urine di
Schwazer sono state manipolate. Così si evince dall'analisi del Dna che il Ris
di Parma ha effettuato sui campioni di Colonia. Una novità che cambia tutto,
scrive Nando Sanvito il 27 luglio 2018 su "Il Sussidiario". La ostinata e
disperata resistenza della Iaaf e del Laboratorio di Colonia a non cedere le
urine di Schwazer al Tribunale di Bolzano aveva una ragione più che valida:
quelle provette erano state manipolate. Così almeno si evince dall'analisi del
Dna che il Laboratorio del Ris di Parma ha effettuato su quei campioni nelle
scorse settimane. Cosa è stato trovato in quelle urine? Un Dna estraneo a quello
di Schwazer? No, non siamo più ai tempi del caffè messo nella provetta della Di
Terlizzi allenata da Sandro Donati, roba casereccia da peracottari anni 90. Nel
caso Schwazer invece si è dato per scontato che se mai tarocco ci fosse stato,
sarebbe stato fatto a regola d'arte, da professionisti del ramo e che tracce di
Dna esogeno non ne avrebbero lasciate. Allora cos'ha trovato il colonnello Lago?
Una concentrazione spaventosamente anomala del Dna di Schwazer. Bastano pochi
numeri: 437 picogrammi microlitro nel campione A, addirittura 1187 nel campione
B. Se la letteratura scientifica – prodotta dagli stessi laboratori accreditati
presso la Wada – dice che le urine conservate a -20 gradi dopo una settimana
riducono a 1/7 il valore quantitativo del Dna, dobbiamo pensare che dopo 26 mesi
debbano contenere ancora al massimo qualche picogrammo, che si possa contare su
qualche dita di una mano. Il Dna di Schwazer presenta invece una concentrazione
centinaia (campione A) o migliaia (campione B) di volte superiore alla norma. Di
fronte a questi valori assolutamente fuori-scala, i casi sono due: o Schwazer è
un alieno oppure qualcuno ci ha messo mano. E qui sta il punto. Cosa vuol dire
che ci ha messo mano? Vuol dire che ha "pompato" nelle urine di Schwazer una
quantità sproporzionata di Dna dello stesso marciatore altoatesino. Che bisogno
aveva di farlo? Questa operazione di solito la si fa quando si vuole nascondere
un altro Dna presente nelle urine, perché se è vero che centrifugando urina
contaminata da doping e congelandola e riscaldandola (coi raggi Uv) più volte,
il Dna scompare al 99,9%, in realtà quello 0,1% inquieta il manipolatore e
dunque il metodo più sicuro per non lasciare traccia è pompare altro Dna del
proprietario delle urine da inquinare. Così si elimina ogni rischio di essere
scoperti. Colpisce poi quella discrepanza tra campione A e campione B: 437
contro 1187. La Iaaf ha incaricato a Ginevra uno studio scientifico per
dimostrare che questa discrepanza non ha alcun valore, ma se così fosse perché
allora il laboratorio di Colonia e l'avvocato della Iaaf a febbraio tentarono di
spacciare per campione B il liquido contenuto in una provetta di plastica non
sigillata? Su questa discrepanza, da parte sua il colonnello Lago (carabiniere
del Ris e perito del tribunale di Bolzano) invece sta monitorando il Dna di un
centinaio di volontari a cui è stata prelevata urina, separata in due campioni:
daranno differenze? E nelle proporzioni di quella di Schwazer? Lo sapremo ai
primi di settembre quando presenterà il risultato completo della sua perizia al
Gip di Bolzano Walter Pelino. Ma queste anticipazioni suggeriscono doverose
riflessioni. Chi, come e dove ha operato la manomissione delle urine di
Schwazer? A chi potrebbero toccare gli avvisi di garanzia che il Gip di Bolzano
presumibilmente invierà una volta letta la perizia? Di questo ne parleremo nella
puntata di domani.
Atletica, doping; caso Schwazer:
condannati i medici Fidal. Il tribunale di Bolzano ha
condannato a due anni ciascuno Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto, nove
mesi per Rita Bottiglieri. Per tutti e tre l'accusa è di essere a conoscenza
dell'uso di sostanze da parte dell'ex marciatore e di non aver denunciato i
fatti. Una sentenza storica, scrive Eugenio Capodacqua il 25 gennaio 2018 su "La
Repubblica". Sapevano ed hanno taciuto. E non hanno fatto nulla per impedire che
Alex Schwazer si dopasse prima delle Olimpiadi di Londra 2012. E adesso, a sei
anni dai fatti, il tribunale di Bolzano per bocca della giudice Carla Scheide,
ha stabilito che il loro comportamento era colpevole quanto il doping
dell'atleta. Favoreggiamento del doping: così i due medici della Fidal
(federazione atletica italiana), Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto sono
stati condannati rispettivamente, a due anni di reclusione e ad una multa di
10.000 euro ciascuno. Una sentenza storica. La prima in cui vengono sanzionati
due massimi dirigenti sportivi italiani. Per i due c'è anche l'interdizione
dalla pratica della professione medica per due anni e l'inibizione perpetua da
incarichi direttivi al Coni e in società sportive. Per Rita Bottiglieri,
all'epoca impiegata nella segreteria federale, invece, la condanna è stata di 9
mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Anche per lei l'inibizione perpetua da
incarichi direttivi al Coni e in società sportive. Secondo la sentenza tutti e
tre erano a conoscenza dell'uso di sostanze dopanti da parte di Alex Schwazer,
prima dei Giochi 2012 ma non hanno denunciato i fatti. Inoltre, è stato
stabilito un risarcimento di complessivi 15.000 euro nei confronti della Wada:
12.000 euro dovranno essere pagati da Fiorella e Fischetto (6.000 a testa), e i
restanti 3.000 sono a carico della dirigente Bottiglieri. I tre, infine, sono
stati condannati al risarcimento delle spese legali sostenute dalla Wada. La
sentenza contro cui, ovviamente gli interessati hanno già detto di voler
ricorrere in appello, è stata più severa delle richieste del pm che per la
Bottiglieri aveva chiesto l'assoluzione. Era attesa anche perché costituisce una
anteprima assoluta. E' la prima volta che due medici sportivi, inseriti nella
dirigenza di una federazione, vengono condannati per favoreggiamento nel doping.
"La prima volta in cui per questo reato vengono sanzionate persone diverse
dall'atleta ed è molto importante, perché l'atleta spesso è l'ultimo anello
della catena", dice Sandro Donati, da sempre in prima fila nella lotta alla
farmacia proibita, che Schwazer ha seguito come tecnico quando, scontata la
prima squalifica, si è ripresentato per gareggiare. "Cosa farà adesso la Iaaf,
la federazione internazionale? Ignorerà la sentenza?". Fischetto è ancora medico
del settore sanitario ed ora si trova interdetto a frequentare ambienti
sportivi. "Ricordo - aggiunge Donati - che fui proprio io a indicare alla Wada
l'11 e 12 luglio del 2012 la necessità di un controllo su Alex. Lui era
colpevole per quel doping. Ed ha pagato con la squalifica (tre anni e nove mesi
in tutto, n.d.r.). Ora questa sentenza mette in luce anche le responsabilità
dell'ambiente e fa inquadrare in una prospettiva ben chiara la presunta seconda
positività dell'atleta riscontrata il 1° gennaio 2012".
Una storiaccia. Con coincidenze talmente
assurde da far pensare ad un complotto, come lamentano da mesi Schwazer e il suo
staff difensivo capeggiato dall'avvocato Brandstaetter. Come, ad esempio,
l'incarico dato dalla Iaaf alla ditta tedesca che poi ha svolto il test del 1°
gennaio a Racines, avvenuto, secondo le tesi dei difensori di Alex,
immediatamente dopo la testimonianza di Schwazer a Bolzano nella quale, svelando
tutti i retroscena chiamava in causa proprio i medici federali. Una
intercettazione durante l'inchiesta, rivelò tutta la rabbia di Fischetto: "Ha da
morì ammazzato questo crucco di merda": la frase, resa pubblica nel docufilm di
Repubblica di qualche mese addietro, dice tanto dell'atmosfera che circondava
Schwazer all'epoca. Una storiaccia che ancora non si è chiusa. E ancora una
volta mentre lo sport assolve (i protagonisti erano stati scagionati dalla
Procura antidoping del Coni) la magistratura condanna. Il che deve far
riflettere sul ruolo e le capacità di organismi che non hanno alcuna
credibilità, perché assolutamente autoreferenziali. Lo sport che controlla se
stesso non può funzionare con gli interessi in ballo. "Bella giustizia! -
commenta Donati - C'è sempre stata ostilità nei confronti di Schwazer al quale
il Tribunale Nazione Antidoping non ha mai dato la possibilita', per il presunto
secondo caso (quello del gennaio 2016 per cui il marciatore altoatesino sta
scontando una condanna a otto anni, n.d.r.), di un'udienza sportiva in Italia
davanti al TNA. Nessuna autorità italiana dell'antidoping italiana è mai
intervenuta per difendere Schwazer rispetto alle vessazioni imposte dalla Iaaf e
che il Tribunale Arbitrale Sportivo ha subito passivamente come quando ha
costretto Alex all'udienza a Rio in piene Olimpiadi e non a Losanna. E' stata
colpita vigliaccamente la persona a terra".
Alex Schwazer, il laboratorio antidoping
di Colonia nega i campioni di urina al Ris di Parma,
scrive Eugenio Capodacqua il 24 Dicembre 2017 su "Libero Quotidiano". Dalla
Germania le stanno provando tutte per rinviare un nuovo esame che potrebbe
portare una nuova svolta sul caso controverso di doping sul marciatore
azzurro Alex Schwazer. Da un anno i campioni di urina prelevati dall'atleta a
Vipiteno il 1 gennaio 2016 sono sotto sequestro, conservati e sigillati a 20
gradi sottozero nel Manfred Donike Institut di Colonia. Lo scorso ottobre, come
ricorda il Corriere della sera, il Ris di Parma per mano del
colonnello GiampieroLago ha chiesto ai responsabili del laboratorio di accertare
che in quelle provette ci fosse davvero l'urina di Schwazer, dopo che la
rogatoria internazionale del magistrato ri Bolzano, Walter Pellino, era stata
trasformata in ordinanza da un giudice tedesco. Con quella comunicazione, il
colonnello Lago aveva formalizzato la richiesta di consegna, negata solo tre
giorni fa dal direttore del laboratorio di Colonia perché dal punto di vista
tecnico quella richiesta è risultata "troppo vaga". La lettera del colonnello
dei carabinieri è tutt'altro che vaga, la procedura per l'esame del campione è
ben descritta nella disciplina internazionale, quindi ci sono pochi margini di
interpretazione da parte dei tecnici tedeschi. La vicenda del marciatore azzurro
vira sempre di più verso il mistero dalle torbide venature di politica sportiva.
Il laboratorio di Colonia è sotto la Wada, l'agenzia internazionale antidoping,
non dovrebbe temere nulla da un nuovo esame di quei campioni e potrebbe
dimostrare ancora una volta la propria imparzialità. La stessa Wada però da mesi
si è opposta alla richiesta della magistratura italiana e sulla stessa linea si
è schierata anche la Iaaf, la federazione mondiale di atletica. Gli
interrogativi trovano una risposta tanto chiara quanto amara nella parole
dell'allenatore di Schwazer, Sandro Donati: "Il laboratorio di Colonia ha
ricevuto l'ordinanza due mesi fa. Perché non ha manifestato subito i suoi dubbi?
Perché questo muro di gomma contro una richiesta che non dovrebbe suscitare
nessun problema? Cosa nascondono le autorità sportive?". Le domande retoriche di
Donati insinuano l'ennesimo dubbio sulla trasparenza degli organi
internazionali, c'è qualcuno che teme quelle nuove analisi. E qualche indizio su
nomi e cognomi comincia emergere. Come un'email dello scorso febbraio del capo
dell'ufficio legale Iaaf, Ross Wenzel, diretta al presidente della commissione
medica federale, Thomas Capdevielle, grande accusatore di Schwazer, che confessa
la sua preoccupazione per l'eventuale spostamento di quei campioni e spera di
riuscire a convincere i responsabili del laboratorio di Colonia a tenerli dove
sono. Già la scorsa estate la Wada e la Iaaf impedirono il sequestro di tutte le
provette, ma non il prelievo di due campioni. Di norma è una procedura concessa
a tanti atleti che tentano un ricorso, in questo caso invece per opporsi alla
richiesta dei magistrati italiani sono stati spesi migliaia di euro in cause
legali. La faccenda deve stare loro particolarmente a cuore, qualcuno che non ha
nessuna intenzione di far emergere la verità contro ogni ragionevole dubbio.
Caso Schwazer, 17 mesi di melina: il test
Dna ancora rimandato, scrive il 20 dicembre 2017 “La
Repubblica". Diciassette mesi di melina e ancora non si vede giorno. Il test sul
dna da cui dipende tanto del futuro di Alex Schwazer non viene ancora fatto,
nonostante ci sia un verdetto chiarissimo della Corte di appello di Colonia. E
il caso della discussa seconda positività del marciatore altoatesino,
(squalificato prima dei Giochi 2016) resta ancora senza soluzione definitiva.
Tutto rimandato all’anno prossimo, se non verranno posti altri incomprensibili
intoppi. Cosa pensare? Che l’evidente strategia dilatoria della Iaaf, la
federazione atletica internazionale, stia producendo i suoi effetti?La misero in
evidenza mesi addietro alcune email svelate dagli hacker di Fancy Bear, riprese
da molti “media”. Si trattava di 23 messaggi di posta telematica scambiati tra
il manager dei controlli antidoping della Iaaf Thomas Capdeville e il consulente
legale Ross Wenzel, oltre avvocati e altri dirigenti. Il tema era evidente:
identificare la strategia difensiva nei confronti del sequestro richiesto ed
ottenuto da parte del Tribunale di Bolzano delle provette del test del 1°
gennaio 2016, la cui positività è stata contestata dalla difesa dell’atleta
azzurro, che ha apertamente parlato di complotto. Per dirimere la questione si
sarebbe già dovuto procedere al test del dna, risolutivo per entrambe le parti.
Colpevole o innocente. Definitivamente. Ma le provette sono ancora bloccate in
Germania presso il laboratorio di Colonia. In Italia tutto sarebbe pronto, ma
quei “benedetti” 6 millilitri del campione B e 9 di quello A ancora non arrivano
nel laboratorio dei Ris di Parma. Nonostante il Gip Walter Pelino abbia fatto
tutti i passi necessari, nominando il colonnello Giampiero Lago, responsabile
del Ris di Parma come perito super partes. Questa volta c’è un evidente ritardo
nel coordinamento con Iaaf e Wada che dovrebbero essere presenti a tutte le
operazioni di prelievo, sigillatura e trasporto del liquido da analizzare. Così
siamo arrivati a Natale tra ricorsi, appelli e sentenze della magistratura
tedesca che ha stabilito alla fine la legittimità delle procedura nel rispetto
dei diritti della difesa. Ma difficilmente la vicenda vedrà una soluzione prima
di gennaio-febbraio prossimi. Eppure sarebbe interesse delle parti risolvere il
prima possibile per mettere fine alle ovvie e scandalose polemiche che hanno
coinvolto fin qui l’atletica mondiale. Dall’analisi dei fatti emerge come Iaaf e
Wada abbiano più o meno seguito la stessa strada. Ma è una circostanza
sconcertante. Infatti, se da una parte la Iaaf risulta controparte dell’atleta e
di fatto si è opposta ferocemente alle nuove analisi sulle provette; la Wada,
almeno, dovrebbe essere “neutra”. Cioè esercitare quella terzietà che è
l’elemento più discusso e mancante nel sistema antidoping mondiale. E questo
sconsolante quadro, che mina i fondamentali della giustizia, è complicato da
fatto che la Corte d’appello di Colonia non ha fissato, nella sua ordinanza, una
data precisa per la consegna delle urine da parte del laboratorio. Favorendo
così chi la vuole tirare per le lunghe. Ora si attendono ulteriori contromosse
da parte della Procura di Bolzano.
Quelle strane mail del caso Schwazer.
(Un articolo importante di Sarah Franzosini, per Salto.bz del 6 luglio 2017). Il
vento fa il suo giro. La parabola discendente di Alex Schwazer potrebbe ora
subire una svolta. I fatti: il 29 giugno scorso il colpo di scena, gli hacker
russi di “Fancy Bear” si impossessano di 23 e-mail sottratte alla Iaaf,
la Federazione internazionale di atletica leggera. Le mail vengono scambiate nel
corso di tre mesi (da gennaio a marzo 2017) fra l’antidoping senior manager
della Iaaf Thomas Capdevielle e il consulente legale Ross Wenzel, membro dello
studio di Losanna Kellerhals Carrard (che insieme a Huw Roberts, dello studio
londinese Bird & Bird, si occupa del caso Schwazer), con il coinvolgimento di
altri avvocati e dirigenti della Iaaf e del laboratorio di Colonia, dove ancora
si trovano le provette “incriminate” con i campioni di urina. Occorre
infatti ancora accertare se l’urina dell’esame sia effettivamente quella di
Schwazer e se non ci sia stato un inquinamento “esterno” o altri tipi di
alterazione. Il marciatore, infatti, sostiene che qualcuno gli abbia dato la
sostanza di nascosto o modificato la provetta. Le e-mail in questione
avvalorerebbero l’ipotesi di un complotto ordito per mettere fuori dai giochi
l’atleta, come da tempo denuncia il suo ex tecnico Sandro Donati. Il 10 agosto
2016 Alex Schwazer viene squalificato per 8 anni dal Tribunale Arbitrale dello
Sport (TAS) di Losanna – dopo aver scontato tre anni e nove mesi per il doping
all’epo (abbreviazione di eritropoietina, un ormone che controlla la produzione
di globuli rossi nel sangue) del luglio 2012 -, una sentenza che gli impedirà di
partecipare alle due discipline della marcia previste alle Olimpiadi di Rio, e
cioè i 20 e i 50 chilometri; e che porrà di fatto fine alla sua carriera
agonistica. Sono i contorni di una storia lacunosa che sfumano
ulteriormente alla luce delle ultime rivelazioni.
La prima e-mail è datata 17 gennaio 2017, giorno
in cui il giudice per le indagini preliminari di Bolzano, Walter Pelino,
stabilisce che l’esame del DNA di Schwazer si farà, complice una rogatoria
internazionale, presso il laboratorio dei Ris dei carabinieri di Parma.
L’incarico viene conferito al colonnello Giampietro Lago e al professor Marco
Vincenti, chimico dell’università di Torino e presidente del laboratorio
antidoping piemontese. Katherine Brown, legale della WADA (l’Agenzia mondiale
antidoping) di Losanna, scrive ai vertici del laboratorio di Colonia, Wilhelm
Schänzer e Hans Geyer, inviando loro una lettera del direttore antidoping della
WADA Julien Sieveking e il verbale dell’incidente probatorio chiesto dalla
difesa di Schwazer. Schänzer e Geyer prendono tempo – suscitando una certa
insofferenza da parte di Losanna – e dopo 10 giorni rispondono che contatteranno
il loro avvocato, il dottor Sartorius. Scattano i primi dubbi sulla neutralità
della WADA: l’Agenzia starebbe tentando di condizionare il laboratorio di
Colonia, accreditato peraltro dalla stessa WADA, al fine di accontentare la Iaaf
che vuole impedire l’esame del DNA di Schwazer in un circuito neutro, a Parma,
ovvero in un laboratorio che non sia controllato dalla WADA. Come evitare allora
che le analisi vengano svolte in Italia? L’idea è quella di procedere
rivolgendosi al tribunale di Colonia ma sorge un problema. La sede della Iaaf è
a Montecarlo e il Principato di Monaco non fa parte dell’Unione europea e perciò
non può intercedere presso i giudici di Colonia. Dopo diverse ipotesi vagliate
nel successivo febbrile scambio di e-mail fra i legali della Iaaf, Wada e
Colonia per cercare una soluzione, si alza bandiera bianca.
Un primo, clamoroso, espediente emerge nell’e-mail
del 9 febbraio.Ulrich Leimenstoll, avvocato della Iaaf di Colonia che si occupa
del caso Schwazer insieme al collega Björn Gercke, scrive a Ross Wenzel: “Se sei
d’accordo darei il testo della memoria al Dr. Sartorius, cosicché il laboratorio
possa lavorare su una dichiarazione ‘armonizzata’ [con la nostra]”. In sostanza
il laboratorio della città della Renania viene “imbeccato” allo scopo di
sottoscrivere una linea quanto più possibile coincidente con quella della Iaaf.
Se non è collusione questa. Il 10 febbraio Ross Wenzel contatta Thomas
Capdevielle e cita i punti principali della memoria che sarà inviata al
tribunale di Colonia. Per la Iaaf l’analisi della provetta deve avvenire
nell’ambito sportivo e dunque per evitare l’entrata in scena del Reparto
Investigazioni Scientifiche (Ris) dei carabinieri di Parma ecco il colpo di
genio: fare riferimento al fatto che Schwazer sia stato un ex carabiniere e
abbia gareggiato per l’Arma in diverse occasioni, insinuando dunque un presunto
conflitto di interessi e la minaccia di eventuali manipolazioni dei
campioni. Nel passaggio successivo della mail, tuttavia, la stessa Iaaf arriva a
ritenere difficile la condanna di Schwazer per doping intenzionale in sede
penale, in quanto “tutti gli esperti del caso concordano che non è possibile
distinguere fra uso volontario e involontario” di certe sostanze.
Ma ce n’è per tutti. Il prossimo malcapitato
finito sulla lista nera della Iaaf è il professor Donati. Ancora un botta e
risposta fra Leimenstoll e Wenzel Ross: un altro motivo per allontanare l’incubo
Ris di Parma è alludere al fatto che l’allenatore di Schwazer abbia uno stretto
contatto con la polizia italiana definita uno “sponsor”, tanto che “la scritta
‘Carabinieri’ appare regolarmente sulla maglia dell’atleta”. Qualcosa
scricchiola in casa Iaaf. Il tentativo di dimostrare una oscura connessione fra
i carabinieri, Schwazer e Donati suona quasi disperato, tanto che il legale Huw
Roberts sconsiglierà di seguire questa strategia. E infatti il passaggio in cui
si fa riferimento al presunto legame fra l’ex coach Donati e i carabinieri verrà
tolto dal testo della memoria presentato dalla Federazione per il ricorso presso
la Corte d’Appello di Colonia. Non solo. L’avvocato Sergio Spagnolo (per la Iaaf
di Milano) mette in guardia, in una mail del 14 febbraio, il nostro Ross Wenzel:
se la Iaaf continua a fare ostruzionismo circa lo spostamento delle provette la
magistratura, oltre che la stampa, potrebbe giudicare “negativamente questo tipo
di approccio”, e concludere che “i sospetti di Schwazer possano essere in
qualche modo confermati o che la Iaaf stia cercando di ‘nascondere qualcosa’”.
Ross Wenzel risponde prontamente: “Invierò senz’altro la vostra e-mail alla Iaaf
ma è escluso che la Federazione non faccia tutto quanto è in suo potere per
evitare che i campioni non sigillati vengano consegnati al laboratorio dei
carabinieri”. Poco dopo il consulente legale avverte Capdevielle: “Comincio a
chiedermi se [gli avvocati italiani] siano dalla nostra parte…”.
Nel cast dell’ingarbugliata pièce fa la sua
comparsa Luciano Barra, ex segretario della Fidal ed ex membro del Coni già noto
alle cronache, come noto è il suo risentimento nei confronti di Schwazer e
Donati. Nell’aprile 2016 Barra manda una lettera aperta al numero uno della
Fidal Alfio Giomi implorandolo di non iscrivere l’atleta altoatesino alla Coppa
del Mondo di Marcia che si sarebbe tenuta a Roma l’8 maggio successivo. In
quell’occasione Schwazer vince la 50 chilometri con un tempo di 3 ore e 39
minuti qualificandosi per i Giochi di Rio. Un trionfo effimero, visto che
a giugno verrà ancora sospeso dalla Iaaf dopo essere risultato positivo a un
nuovo test antidoping. In una e-mail di Capdevielle del 14 febbraio indirizzata
al suo interlocutore preferito, Ross Wenzel, si prospetta l’eventualità di
inviare il testo della memoria presentata ai giudici di Colonia, guarda caso, a
Barra. Il motivo? Non pervenuto, ma non è difficile intuirlo data la sua
avversione per il duo Donati-Schwazer. Il 20 febbraio l’ennesimo, significativo,
“carteggio” fra il consulente legale e Capdevielle: “Il laboratorio di Colonia
sta cercando di restare neutrale, ma sarebbe utile se fosse disposto a sostenere
in una certa misura la nostra posizione”, afferma il consulente svizzero. La
replica di Capdevielle: “Non si rendono conto di essere parte della trama contro
AS [Alex Schwazer, ndr] e delle potenziali conseguenze per loro? Hans [Geyer] ha
probabilmente bisogno di ulteriori informazioni base”. E infine il cliffhanger.
Scrive Ross Wenzel: “Credo di essere riuscito a convincerli”.
“L’antidoping e l’arroganza del potere”.
L’ex allenatore di Schwazer Sandro Donati sulle e-mail
hackerate dai russi, il plausibile complotto, l’impudenza della IAAF, le colpe
dei media e i conti che non tornano. L'intervista di Sarah Franzosini del
7.07.2017 su salto.bz:
Professor Donati, le e-mail hackerate dai
russi di “Fancy Bear” che sembrano aver svelato il cosiddetto trappolone in cui
è caduto il suo protetto, Alex Schwazer, danno nuova linfa alla vostra
instancabile ricerca della verità, qual è stata la sua reazione quando ha letto
il contenuto di questa corrispondenza?
«Mi piacerebbe
innanzitutto capire quanto è stato difficile per i media reperire queste e-mail».
Non lo è stato affatto.
«Ecco, sono
sicuro che i giornali che le hanno ricevute si siano autocensurati perché è
piuttosto singolare che non siano state ancora pubblicate su larga scala. Ma ciò
non mi stupisce».
Che intende?
«Il giornalismo
sportivo è del tutto satellitare alle istituzioni sportive. Ricordo che la
Gazzetta dello Sport fu invece la prima a dare la notizia della sentenza del TAS
di Losanna che comminò a Schwazer 8 anni di squalifica, trattando quella
sentenza come l’oro colato mentre sul Corriere della Sera, lo stesso giorno,
venne pubblicato un articolo che quantomeno evidenziava i punti oscuri della
vicenda ai quali la sentenza non aveva dato risposta. Il punto è che chi questa
manipolazione l’ha attuata la difende, mentre le Istituzioni sportive che non
l’hanno messa in pratica difendono la IAAF, per tutelare loro stessi e il
sistema sportivo, e qui sta la perversione».
Cosa rappresentano queste e-mail in termini di
strategia difensiva, a questo punto?
«Senza dubbio
un contributo nuovo. Intanto mettono in evidenza questo affannoso assemblaggio
delle forze che la IAAF ha attuato - probabilmente anche con un forte intervento
della WADA - per poter fare pressione sul laboratorio di Colonia perché le
provette con l’urina di Schwazer rimanessero dov’erano, e credo che questo
genererà nei giudici una pessima impressione su tali organismi. È chiaro che se
verrà fuori che c’è stata una manipolazione dei campioni, l’intero sistema
antidoping andrà in crisi. Il punto è che chi questa manipolazione l’ha attuata
la difende, mentre le Istituzioni sportive che non l’hanno messa in pratica
difendono la IAAF, per tutelare loro stessi e il sistema sportivo, e qui sta la
perversione. Quando gli stessi avvocati della IAAF riconoscono nelle email che
con quelle prove a disposizione non è possibile dimostrare il doping volontario
siamo già di fronte a un’ammissione che stride in maniera incredibile con quegli
8 anni di squalifica che sono stati dati a Schwazer. E poi c’è quel nome, che
non è un nome qualunque».
Si riferisce a Luciano Barra, presumo. Ma che
ruolo ha avuto lui in tutta questa storia?
«Barra è stato
il segretario generale della Federazione di atletica negli anni ’70-’80, fino al
1987, quando venne sollevato dal suo incarico proprio in seguito alla mia
denuncia riguardo la manipolazione della gara di salto in lungo di Giovanni
Evangelisti nel campionato del mondo di atletica del 1987 di Roma. In quella
circostanza la Federazione di atletica decise che bisognava, come dire,
rimpinguare il bottino dei trofei inventandosi delle medaglie. Evangelisti
(peraltro all’oscuro della trama) era un grande campione ma quel giorno non era
nelle condizioni fisiche di offrire una prestazione di alto livello. La
competizione venne quindi truccata, con i giudici che decisero la misura da
assegnare a Evangelisti in modo che vincesse la medaglia di bronzo senza
disturbare il primo posto, che fu conquistato dall’americano Carl Lewis, e il
secondo, agguantato dal sovietico Robert Emmyan. Le due superpotenze, Stati
Uniti e Unione Sovietica, dunque, non erano state toccate e l’Italia si era
“accontentata” di occupare il terzo posto. Io denunciai e dimostrai l’avvenuta
manipolazione della gara e ne nacque uno scandalo internazionale di gigantesche
proporzioni. La Federazione internazionale fu costretta ad annullare il
risultato, il Coni nominò una commissione d’inchiesta e Barra perse il suo
incarico e quindi anche la sua posizione di potere all’interno della
Federazione. Anche se è passato molto tempo da allora, è evidente dai fatti che
questo signore nutre ancora risentimenti e motivi di rivalsa nei miei confronti».
Ritiene che l’ex segretario della Fidal sia
stato un interlocutore abituale nella vicenda Schwazer?
«Sì, è chiaro
dalla serie di atti ostili diretti a Schwazer che ha esplicitato dal settembre
2015 fino all’aprile 2016 e credo che la sua opinione sia stata tenuta in grande
considerazione in determinati ambienti. Il suo nome nella e-mail, se non sarà
smentito o spiegato adeguatamente, diventa inquietante perché, come detto, Barra
si era speso molto per impedire in tutti i modi possibili il ritorno alle gare
di Schwazer. All’inizio aveva parlato di un’operazione di marketing,
successivamente, una volta fatto fare ad Alex un test di allenamento in cui era
andato fortissimo, vestì i panni del tecnico e divulgò urbi et orbi alcuni
fotogrammi per dimostrare che Schwazer non marciava ma correva, salvo poi essere
smentito dai fatti, quando Alex tornò da dominatore nelle gare con una tecnica
di marcia valutata dai giudici come perfetta. E poi ancora Barra è intervenuto
il 28 aprile 2016 presso il presidente della Fidal supplicandolo di non mettere
l’atleta in squadra per i campionati del mondo. Quali elementi a sua conoscenza
gli consentivano di attuare una simile pressione?»
Come commenta questa insinuazione, poi di fatto
depennata dalle carte ufficiali, della sua presunta connessione con i
carabinieri?
«È grottesco e
gli stessi avvocati della IAAF hanno avuto poi il buonsenso di ometterla nella
loro memoria indirizzata al giudice. Quanto all’altra insinuazione secondo la
quale i Carabinieri sarebbero pronti ad aiutarlo in quanto ex carabiniere è
piuttosto penosa e dimostra anche un’ignoranza crassa dei fatti. Ricordiamoci
che Schwazer è stato immediatamente allontanato dall’Arma dopo la positività
all’epo del 2012. Mentre altri atleti che hanno avuto problemi di doping, come
per esempio il maratoneta Alberico Di Cecco, sono rimasti carabinieri. Se questa
è una dimostrazione di favoritismo… L’impressione è quella di un’istituzione
sportiva autoreferenziale, abituata a decidere per conto proprio con i
cosiddetti organi di giustizia sportiva che in molti casi è assolutamente
sommaria e che quando si deve misurare con la giustizia ordinaria mostra
insofferenza, volontà di sottrarsi al giudizio, ritenendosi al di sopra o al di
fuori di quel circuito».
Come se ne esce, allora?
«Credo che su
questi organismi sia il caso di riflettere anche perché, muovendosi su scala
internazionale, rischiano di porsi al di sopra degli ordinamenti giudiziari
degli Stati. È indicativo che nel presentare le loro argomentazioni la
IAAF abbia scritto qualcosa come “le provette sono di nostra proprietà, inoltre
è il sistema sportivo che ha le competenze per fare le valutazioni del caso”,
omettendo di precisare che quelle competenze se le sono auto-attribuite. Sarò
ancora più chiaro: i laboratori antidoping, che sono 25 in tutto il mondo, hanno
competenza specifica per ricercare le sostanze doping. Ma nel caso Schwazer si
tratta di analizzare il DNA, che è un’altra cosa. E il DNA non è compreso nelle
ricerche dei controlli antidoping, salvo rarissimi casi, perciò vantare la
competenza esclusiva anche su questo aspetto è un’affermazione autoreferenziale
che non ha alcun riscontro con la realtà. Al contrario, nei laboratori delle
forze di polizia impegnati come sono nelle analisi relative a fatti criminali,
l’esame del DNA è una consuetudine consolidata. È chiaro dunque che il gip di
Bolzano si sia rivolto al Ris di Parma che è il principale laboratorio italiano
per l’accertamento di fatti criminali. Tornerò prima o poi sul mio passato
rapporto con la WADA, perché se pensano che sia finita qui si sbagliano di
grosso».
Ma il laboratorio di Colonia non aveva nessuno
motivo per opporsi all’esame del DNA delle provette in Italia, non è così?
«Non ne aveva.
E di fatto inizialmente Colonia non si è espressa contro un eventuale
prelevamento dei campioni. Ciò significa, a mio parere, che il laboratorio di
Colonia è estraneo a qualsiasi manipolazione ma nel contempo è diventata
sciaguratamente allarmante questa pressione eseguita dalla IAAF. Va anche
precisato che il laboratorio non è in una posizione di autonomia finanziaria sia
perché dipende dal lavoro che gli viene commissionato proprio dalle federazioni
internazionali, sia perché è coordinato e finanziato dalla WADA. Quella di
Schwazer è una storia emblematica che fa capire che l’antidoping non è ormai più
un’attività da portare avanti per il senso dell’etica e delle regole, ma è
potere, e a seconda di come questo potere viene gestito si favorisce l’uno o
l’altro, e si ‘eliminano’ a piacimento gli avversari scomodi. In ogni caso,
vede, io tornerò prima o poi sul mio passato rapporto con la WADA, perché se
pensano che sia finita qui si sbagliano di grosso».
Cioè?
«Fornirò tutti
i dettagli su ciò che io ho fatto in 13 anni per la WADA e sul fatto che
improvvisamente l’Agenzia abbia preso le distanze da me e allora la storia la
racconteremo tutta, ma adesso non è il momento perché dobbiamo portare avanti la
nostra battaglia per la verità».
Come ha vissuto quest’ultimo anno?
«In modo
terribile, essere vittime di un atto infame come questo è orrendo. Molti
dimenticano che è la seconda volta che vengo coinvolto in uno “strano” caso di
doping. Nel 1998 una mia atleta, Anna Maria Di Terlizzi, fu dichiarata positiva
alla caffeina, positività che venne contraddetta nelle controanalisi. E fu
smentita solo perché alcuni tecnici di laboratorio mi avvertirono di una
possibile manomissione del campione di urina e mi dissero di nominare per la
controanalisi un chimico che non si allontanasse mai dalle apparecchiature. Il
risultato che emerse fu clamoroso: non c’era caffeina nel campione B dell’atleta».
Basta avere un po’ di memoria storica per
collegare i fatti, dice.
«Esatto. Non è
strano che l’unico caso, nella storia dell’antidoping, in cui ci si è trovati di
fronte a un campione B risultato diverso dal campione A perché manipolato, abbia
riguardato me? E che per la seconda volta, con l’oscuro caso Schwazer, capiti di
nuovo proprio a me? Pensi che il caso di Anna Maria Di Terlizzi vorrebbero
derubricarlo a un incidente, cercando di accreditare la tesi secondo la quale il
medico durante il prelievo abbia involontariamente contaminato un campione.
Guarda caso il campione di un’atleta allenata dalla persona che aveva denunciato
la scellerata collaborazione tra il CONI, le Federazioni sportive e il professor
Conconi. Questa è l’arroganza della gestione del potere da parte
dell’antidoping. Mi viene da pensare che ormai da tempo o forse da sempre i
media non facciano il loro lavoro di osservazione critica delle istituzioni».
Non ha più allenato nessuno dopo Schwazer, come
aveva annunciato lo scorso anno?
«No, per me non
è possibile mettere a repentaglio la carriera sportiva di un altro atleta per il
fatto che io sono stato preso di mira. Ma è chiaro che se la vicenda Schwazer si
concluderà con l’emersione della verità cambieranno molte cose nel sistema
antidoping».
Per esempio?
«Farò capire a
tutti gli atleti che devono tutelarsi, hanno diritto ad avere una terza provetta
che poi potranno consegnare a un laboratorio di loro fiducia, perché ora è tutto
nelle mani di questo potere dell’antidoping che evidentemente non dà alcuna
garanzia assoluta di correttezza una volta prelevati i campioni. Quella della
IAAF è la storia recente di un presidente e di un responsabile antidoping a
libro paga dei russi e anche da questo punto di vista i media dello sport hanno
fatto una figura penosa».
Per quale motivo?
«Perché hanno
omesso di raccontare o hanno minimizzato la descrizione di questo sistema di
corruttela e le sue conseguenze. Hanno disgiunto il caso Schwazer dallo scandalo
dell’alta dirigenza della IAAF corrotta dai russi e allora mi chiedo, il
problema sono i russi o le istituzioni corrotte? Questo è il punto di vista sul
quale ho fatto ruotare tutta la mia vita, perché fin dall’inizio mi sono reso
conto del marcio che c’era nel sistema. Ma anche di questo parlerò in futuro. Mi
viene da pensare che ormai da tempo o forse da sempre i media non facciano il
loro lavoro di osservazione critica delle istituzioni, e se questo cerca di
farlo una singola persona succede che viene bersagliata e si tenta di
distruggerla anche sul piano della credibilità, come dimostra la vicenda
Schwazer. Ma hanno sottovalutato il fatto che io non avrei mollato la presa. Del
resto avevo in mano tutti gli elementi chiave per essere certo che Alex non si
era dopato, non ne aveva bisogno, perché è un fuoriclasse e perché era ben
allenato. È uscito sempre pulito da quella miriade di controlli a sorpresa che
gli hanno fatto da ottobre 2015 a giugno 2016; perché mai avrebbe preso
micro-dosi di testosterone, ininfluenti ai fini della prestazione, solo durante
le vacanze di Natale? Chiunque avrebbe dovuto capire dall’inizio che questa
storia non reggeva. Alex per me non è stato una gallina dalle uova d’oro, è un
ragazzo che mi ha chiesto aiuto e io gliel’ho fornito e continuerò a
fornirglielo in futuro se ne avrà necessità».
Vede finalmente una possibilità di riscatto per
Schwazer?
«Me lo auguro.
Alex è un ragazzo meraviglioso che nel 2012 ha commesso un errore e questo gli
rimane come responsabilità. Ma c’erano anche molte persone intorno a lui che
sapevano e hanno fatto finta di non vedere, tant’è vero che a Bolzano è in corso
un procedimento giudiziario in cui due medici sono imputati per favoreggiamento.
Schwazer si è dopato in un periodo in cui era sotto cura con degli
anti-depressivi e invece di preoccuparsi di capire le cause di questo suo
disagio chi gli stava attorno ha continuato a vederlo soltanto come un
produttore di risultati e medaglie. Ho scoperto poi, seguendolo come allenatore,
che era stato allenato in maniera ridicola ed era peggiorato al punto da perdere
ogni speranza. Nel momento in cui ho iniziato a seguire questo atleta ho capito
che aveva un potenziale e delle doti fuori dal comune. Alex per me non è
stato una gallina dalle uova d’oro, è un ragazzo che mi ha chiesto aiuto e io
gliel’ho fornito e continuerò a fornirglielo in futuro se ne avrà necessità. Il
colmo è che io stesso ho segnalato alla WADA i miei sospetti su di lui prima di
Londra 2012 con due precise email che sono in grado di esibire in qualsiasi
momento. E grazie a queste due mail è scattato il controllo che ha portato alla
sua positività. Non bastava questa credenziale per ascoltare almeno un poco le
mie parole quando, dopo l’ultimo scandalo, ho affermato con forza che era pulito
e che in questa putrida storia si sarebbe dovuto scavare molto più a fondo?»
Io mi schiero con Alex. Schwazer ha avuto
il coraggio di cadere e di risorgere con le proprie forze. Ecco perché non
crederò mai alla sua nuova colpevolezza, scrive
Susanna Tamaro il 15 luglio 2016 su “Il Corriere della Sera”. Sono stata una
praticante di atletica e l’atletica, fra tutti gli sport, è forse quello che
seguo con maggiore passione, per questo la vicenda di Alex Schwazer mi ha
colpito in modo particolare. Ricordo ancora le sue lacrime durante la conferenza
stampa del 2012, mentre ammetteva pubblicamente la sua colpevolezza. Vedendole
avevo pensato subito che quelle lacrime non avevano nulla di mediatico, c’era
una vera disperazione in quei singhiozzi fuori controllo, la disperazione di chi
si rende conto di aver tradito la parte più profonda e vera di se stesso. La
parabola di Alex era quella di un ragazzo onestamente fragile. Aveva vinto l’oro
olimpico a ventiquattro anni, con il conseguente peso di un’improvvisa fama
mondiale. Non è facile reggere la fama, bisogna essere molto forti, molto
distaccati, circondati da persone che ti amano e sono in grado di proteggerti,
ed è molto difficile esserlo a ventiquattro anni. La tensione dei media, gli
sponsor, la continua attesa di un risultato sempre eclatante possono provocare
in una persona sensibile uno stato di enorme stress. E con lo stress cresce
l’ansia. L’ansia di non farcela, di non essere all’altezza. Ed è su quest’ansia
che facilmente si insinuano i cattivi consiglieri. Quattro anni fa Alex Schwazer
dunque ha sbagliato per ragioni umanissime. Ammesso il suo errore, si è ritirato
con dignità dalla scena pubblica. In quel silenzio, in quell’ombra deve aver
sceso tutti i gradini della dannazione; toccato l’ultimo, ha preso la decisione
che solo i grandi sono capaci di prendere: la sfida di risalire contando solo
sulle proprie forze. Sono stata felice quando ho saputo che si allenava
anonimamente per le strade di Roma, in solitaria, senza sponsor, carico solo del
grande furore che alimenta le sfide con se stessi. E sono stata ancora più
felice quando, ai Mondiali a squadra di marcia del 2016, ha vinto la 50
chilometri, ottenendo la qualificazione per i giochi olimpici di Rio. In questi
tempi proni al cinismo, al menefreghismo, alle continue scorciatoie
dell’opportunismo, in questi tempi che sbeffeggiano ormai anche il minimo
barlume di coscienza e che ritengono la nobiltà d’animo nient’altro che un
antico orpello, la parabola di Alex Schwazer era un meraviglioso esempio di come
una persona degna di questo nome potesse essere in grado di cadere e di
risorgere facendo leva soltanto sulla sua forza d’animo. Per questa ragione,
quando è stata sventolata sotto gli occhi avidi dei media quella anomala
provetta giramondo — che vorrebbe ributtare l’atleta nell’arena del lerciume —
ho avuto una reazione di assoluto rifiuto. Non per Schwazer, ma per il mondo
sordidamente sinistro che sta cercando di fagocitarlo, un mondo senza scrupoli
legato evidentemente a una complessità di interessi molto lontani
dall’appassionato candore dell’atleta. E i media ci si sono tuffati con la
potenza degli avvoltoi, il becco uncinato già pronto a dilaniare le carni. Avete
visto? Anche questo non era altro che un bluff, fumo negli occhi per coprire
tutto il marcio che c’era sotto. Vi eravate illusi che ci fossero le persone per
bene? Ricredetevi! Non c’è altro che finzione sotto il sole! Grazie alle
provette, grazie alle intercettazioni, tutti prima o poi sono costretti a
mostrare il loro vero volto, che altro non è che quello della corruzione. Vite
distrutte, carriere rovinate, con il conseguente dilagare ormai inarrestabile
dell’impoverimento delle competenze in ogni campo. Nel nostro Paese, l’essere
appassionati alla propria vocazione è una condizione estremamente rischiosa. Più
energia uno mette nella propria attività infatti, meno ne mette negli
intrallazzi, e quando si accorge di questa grave carenza è spesso troppo tardi
perché, intanto, coloro che appassionati e talentuosi non sono hanno lavorato
alacremente con un unico scopo, quello di fare cadere l’incauto distratto.
Questa consorteria comprende in sé un’estesissima varietà che va dal mediocre
vicino di scrivania fino alle grandi organizzazioni opache che ormai controllano
capillarmente tutto ciò che succede nel mondo. Penso, tanto per citare qualche
esempio recente, al vergognoso caso della virologa Ilaria Capua, accusata di
essere una trafficante di virus per biechi motivi commerciali, vituperata,
insultata sui giornali, per poi venire, dopo due lunghi anni, totalmente
assolta. Naturalmente la lista di vittime è lunga e nei tempi a venire — in
questo mondo che non sa che cosa sia la giustizia ma è sempre più giustizialista
— diventerà lunghissima. I forni manzoniani mediatici forniranno sempre nuovo e
più attraente materiale da gettare in pasto agli affamati cultori del disgusto.
Perché Alex avrebbe dovuto fare una cosa così idiota? Personalmente non crederò
alla nuova colpevolezza di Schwazer neanche se mi si sventolasse sotto il naso
un ettolitro di sangue in provetta sfavillante di testosterone. Per quale
ragione una persona come lui, che avuto il coraggio di cadere e di risorgere,
avrebbe dovuto fare una cosa così totalmente idiota? So che ormai è una cosa
piuttosto fastidiosa da dire, ma esiste una complessità della persona e dunque,
se vogliamo usare una parola grossa, dell’anima, che non è piegabile
all’onnipotente forza del rendiconto, della doppiezza, della manipolazione. Da
questa complessità nascono la poesia, la letteratura, l’arte. Da questa stessa
complessità nascono gli eroi. E gli atleti — quando sono tali — appartengono nel
nostro immaginario proprio a questa categoria. Di solito non twitto, se non con
i miei canarini, ma per gli appassionati del genere sono pronta a lanciare un
hashtag: #IostoconAlex.
Atletica e doping, quelle
telefonate per fermare Schwazer. "Lasci vincere i cinesi".
Verso Rio 2016. Prima delle gare, pressioni sul marciatore poi sospeso. Sandro
Donati registrò tutto: "Era un giudice vicino ai Damilano". La procura di Roma
ha aperto un fascicolo, scrive Attilio Bolzoni il 27 luglio 2016 su "La
Repubblica". I Misteri del "caso Schwazer" non si inseguono solo lungo i
tortuosi percorsi che portano una provetta nei laboratori di Colonia. Alla
vigilia delle Olimpiadi di Riosi scopre che qualcuno ha tentato di "aggiustare"
due gare molto importanti, la Coppa del Mondo di Roma dell'8 maggio e il Gran
Premio di La Coruna di venti giorni dopo. Quel qualcuno è un giudice
internazionale di marcia. Le paure denunciate due settimane fa dal maestro dello
sport Sandro Donati ("Sono minacciato, temo per me e anche per la mia famiglia")
intorno alla nuova e assai sospetta "positività" di Alex Schwazer e alle manovre
di "consorterie criminali " legate ad alcuni dirigenti della Federazione
Internazionale di Atletica, prendono forma in alcune telefonate che sono state
segnalate all'autorità giudiziaria e alla commissione parlamentare antimafia.
Sono due conversazioni in particolare, ricevute da Donati e nelle quali il suo
interlocutore - un personaggio molto noto nel mondo dello sport - lo
"consigliava" di tenere a freno il suo atleta nelle competizioni dove sarebbe
ricomparso dopo la lunga squalifica per il doping all'Epo del 2012. La prima è
del 7 maggio scorso, a poche ore dalla Coppa del mondo di marcia di Roma sui 50
chilometri. Sono le 6,05 del mattino. Donati sta dormendo, lo squillo del
telefono lo sveglia. Sente la voce di un giudice internazionale di marcia "molto
vicino a Sandro Damilano". L'uomo si scusa per l'ora, parla della serata
precedente passata "con tutte le vecchie glorie" poi gli sussurra: "La prego,
glielo dica (ad Alex Schwazer, ndr) ancora una volta fino a prima della gara,
possibilmente lasci vincere Tallent, mi capisce?". Jared Tallent è il marciatore
australiano che appena un paio di settimane prima - il 28 aprile, giorno della
fine della squalifica di Schwazer, aveva dichiarato: "Lui è la vergogna
d'Italia, ora rientra lui e poi i russi: così è come ridere in faccia agli
atleti puliti". Il giorno dopo la telefonata mattutina - e dopo 3 anni e 9 mesi
di squalifica - Alex Schwazer trionfa alle Terme di Caracalla. Seconda
prestazione mondiale stagionale con 3h39'00, dietro di lui Tallent a più di tre
minuti e mezzo. La seconda telefonata ricevuta da Sandro Donati è del 23 maggio,
cinque giorni prima della gara di La Coruna sui 20 chilometri. È sempre lo
stesso giudice internazionale di marcia che richiama l'allenatore di Schwazer.
Questa volta gli suggerisce di non rispondere agli attacchi di alcuni atleti, "e
di non andare a cercare disgrazie con i due cinesi che sono da 1 ora e 17
minuti...". A La Coruna il marciatore altoatesino arriverà secondo dietro il
cinese Whang Zhen. Avvertimenti e pressioni. C'era molta agitazione intorno al
rientro alle gare di Schwazer e ce n'è ancora di più oggi dopo la scoperta -
comunicata solo il 21 giugno - di una nuova positività a "lievi tracce di
testosterone". Un campione di urina partito il 1° gennaio 2016 da Racines - a
pochi chilometri da Vipiteno, dove l'atleta abita - e arrivato 26 ore dopo in un
laboratorio di Colonia. Un itinerario fantasma della provetta, una
documentazione approssimativa, un ritardo estremo nella notifica del risultato.
E una difesa incomprensibilmente negata ad oltranza dalla Federazione
internazionale di atletica. Alex Schwazer e i suoi avvocati non hanno mai potuto
discolparsi davanti ai giudici, fornire controprove, rappresentare le proprie
ragioni. Lo faranno soltanto il 4 agosto prossimo a Rio, luogo e data imposti
dalla stessa Federazione Internazionale di Atletica che si è sottratta
all'udienza che si sarebbe dovuta svolgere a Losanna proprio oggi. Un processo
senza processo. Un vero intrigo, per i tempi e le modalità di esecuzione. Che ha
convinto la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi a convocare il 14
luglio scorso Sandro Donati a Palazzo San Macuto - audizione integralmente
secretata - e che ha portato lo stesso allenatore di Schwazer a presentarsi
qualche ora dopo nelle stanze del procuratore capo Giuseppe Pignatone e del suo
aggiunto Lucia Lotti. Aperto un fascicolo. Ma non sono soltanto quelle due
telefonate a rendere maleodorante questa vicenda di sport che si presenta ogni
giorno di più come una storia di malaffare, incrocio fra interessi economici e
criminali tenuti insieme da una piccola grande Cupola di burocrati e
faccendieri. È lo spaccato di un mondo che alla vigilia delle Olimpiadi di Rio
vi racconterà Repubblica in un documentario dal titolo Operazione Schwazer, le
trame dei signori del doping, 20 minuti che ricostruiscono tutte le stranezze
del controllo di Capodanno effettuato a Racines, il fondo melmoso dove si
muovono alcuni personaggi dell'atletica italiana, i clamorosi casi di corruzione
che coinvolgono i loro amici che erano ai vertici della federazione
internazionale. E poi medici "supervisori" per l'antidoping sotto processo per
avere favorito il doping, data-base con i nomi di tutti quelli in fila alla
farmacia proibita, clan familiari dove spudoratamente si ritrovano controllori e
controllati. Maurizio Damilano, presidente della commissione marcia della Iaaf.
Sandro Damilano, allenatore della nazionale cinese. Due fratelli.
Atletica, caso Schwazer; Donati: "Dal
mondo dello sport un silenzio assordante".
L'allenatore del marciatore altoatesino è stato ascoltato presso la Commissione
Antimafia della Camera. Il precedente: "Diciannove anni fa seguivo una
ostacolista pugliese, Annamaria Di Terlizzi, e fu manipolata la sua urina.
Stavolta, probabilmente, l'hanno fatta in maniera un po' più professionale".
Tas: "L'atleta ha il 20% di chance di andare a Rio", scrive "La Repubblica" il
14 luglio 2016. Sandro Donati va all'attacco. Il tecnico di Alex Schwazer,
coinvolto nel noto caso di doping e sospeso dalla Federazione internazionale di
atletica leggera, è stato ascoltato presso la Commissione Antimafia della Camera
dei Deputati. Al termine le sue parole sono dure: "Il sostegno è venuto dalle
procure della Repubblica e dalla Commissione parlamentare antimafia, ma sul caso
Schwazer dalle istituzioni sportive ho sentito un silenzio assordante o ironie
di pessimo gusto. Schwazer è stato descritto come un bipolare, un uomo dalla
doppia personalità. Io lo conosco da oltre un anno e chi lo frequenta lo trova
un ragazzo semplice, coerente, che non ha nulla di strano, eppure è stato creato
un quadretto: 'Se lo ha fatto in passato lo avrà fatto di nuovo'. In questo modo
si cerca di coprire l'enormità di questo controllo antidoping assurdo, con una
tempistica che da sola rappresenta la firma dell'agguato". Donati ha poi
replicato a chi gli chiedeva perché le istituzioni sportive italiane non
difendano Schwazer: "Perché non vogliono mettersi contro la Iaaf -ha spiegato-
una istituzione internazionale. Mi sono rivolto pubblicamente a Sebastian Coe
affinché dia una spallata per il cambiamento: non può lasciare all'interno gente
compromessa, gente che ha preso dei soldi per nascondere i casi di doping. Io
con questa schifezza non ho niente a che vedere e invece mi ritrovo mail
intimidatorie: non mi rendevo conto che allenare Schwazer, un fenomeno assoluto,
farlo andare così forte senza doping sarebbe diventata una esperienza esplosiva,
destabilizzante. Una iniziativa rivoluzionaria che è stata stroncata".
L'iniziativa parlamentare nasce da un vasto gruppo di deputati e senatori che
vogliono appurare "la veridicità delle affermazioni rese a mezzo stampa dal
professor Donati circa la sequela di minacce, intimidazioni e diffamazioni
ricevute telefonicamente, via mail e attraverso alcuni media, prima e dopo la
gara di Schwazer del 9 maggio scorso, e successivamente all'avvio della
segnalazione alla Wada". In merito anche i Ros hanno aperto un'indagine. "Credo
ci sia un interesse di più procure sull'argomento - ha aggiunto Donati - Tutti
hanno ormai capito il fatto inusitato su una positività a un controllo fatto a
gennaio, una sorta di bomba a orologeria riscossa a giugno. Tutto ciò è assurdo.
Per me è il secondo agguato perché ne ho subito un altro 19 anni fa quando
seguivo una ostacolista pugliese, Annamaria Di Terlizzi, e fu manipolata la sua
urina. Stavolta, probabilmente, l'hanno fatta in maniera un po' più
professionale". Schwazer spera ancora di partecipare all'Olimpiade di Rio ma è
una corsa contro il tempo vista la sospensione inflittagli dalla Iaaf. "Abbiamo
incaricato un avvocato svizzero per il ricorso al Tas di Losanna, ci ritroveremo
con un dossier nostro che arriva stamattina - ha concluso Donati - e verrà
esaminato tra oggi e domani da qualcuno in fretta e furia. Quello sarà il
giudizio sul quale si deciderà la sorte di un grande campione". "Il professore
Donati ci ha raccontato il lavoro fatto in questi anni ed è emerso un quadro
abbastanza imbarazzante. Ci ha parlato molto marginalmente della vicenda
Schwazer: il punto non è la nuova squalifica ma il modo in cui questa vicenda si
inserisce in un contesto assai opaco, ambiguo, vischioso. Di questo è bene farsi
carico". Queste le parole del vicepresidente della Commissione Antimafia,
Claudio Fava, al termine dell'audizione. "Ci sono molti elementi di opacità in
questa vicenda - ha aggiunto Fava - Non solo in Italia. Curvature strane che
sfuggono alla nostra comprensione. Oltretutto ci sembra che la vicenda Schwazer
possa essere un pedaggio che sta pagando Donati per il lavoro e le denunce fatte
nel tempo. Oggi abbiamo ascoltato Alessandro Donati, ora parleremo della vicenda
doping in ufficio di presidenza e ragioneremo su quanto può essere fatto -
aggiunge Fava - Penso ci siano funzioni e cariche che possono occuparsene: dal
ministro della Giustizia a quello della Cultura e delle attività sportive, alla
Sanità. E' una questione trasversale che attraversa più campi di interesse,
funzioni e responsabilità: occorre uno sguardo più attento e vigile". "Non
sembra ci sia criminalità organizzata dietro tutto questo - ha aggiunto Fava -
Sembra ci siano invece poteri forti, interessi e menzogne nel modo con cui le
inchieste di doping vengono usate per premiare o per colpire: questo è un
sospetto più che legittimo e sul quale occorre muoversi sul piano istituzionale.
Il problema del doping è un tema che pesa come una cappa, che ricatta,
costringe, occlude e condiziona il mondo dello sport, non soltanto nel nostro
Paese. Ci sono organismi internazionali che possono farsene carico, ma per
quanto riguarda il Coni, la Procura antidoping e la vicenda degli atleti
italiani c'è una responsabilità e un dovere di vigilanza". "Io penso che per
Schwazer ci siano poche possibilità che il Tas decida di bloccare la sospensione
della Iaaf e lo faccia gareggiare a Rio. Se devo dare una percentuale direi non
più del 20%". Lo ha dichiarato l'avvocato Guido Valori, membro del Tas. "Il
giudice - spiega Valori - dovrà decidere tra due pesi differenti. Da una parte
c'è una positività che ha un peso enorme e dall'altra ci sono una serie di
irregolarità procedurali. Penso sia difficile che il Tas ritenga che i vizi di
procedura abbiano invalidato il controllo risultato positivo, onestamente è una
ricostruzione difficile da fare anche per il poco tempo a disposizione. La
difesa ha qualche punto a suo favore e tra questi c'è sicuramente il mancato
rispetto dell'anonimato ma mi sembrano pochi per far gareggiare un atleta
positivo e che oltretutto ha anche grandi possibilità di vittoria. C'è poi il
forte rischio di dovergli togliere la medaglia. Per essere chiari per bloccare
la sospensiva decisa dalla Iaaf, Schwazer dovrebbe avere buone possibilità di
vincere poi il processo che ci sarà dopo l'estate" conclude il membro Tas.
Caso Schwazer, quelle
strane provette e il 5 luglio è vicino.
In cinque punti, tutti i misteri sul caso in attesa delle risposte della Iaaf.
Fra 7 giorni le controanalisi, l'11 luglio scade il termine di iscrizione per i
Giochi, scrive Nando Sanvito su "Sport Mediaset" il 28 Giugno 2016. Quello che
si sta muovendo attorno alla Procura di Bolzano comincia a dare qualche elemento
in più sulla vicenda Schwazer e i dubbi invece di scemare purtroppo aumentano.
Riepiloghiamo alcuni di questi elementi.
1 - Un prelievo di urina da
parte di due Doping Control Officers tedeschi il 1° gennaio finito alle 8.35 di
mattina a Calice di Racines finisce con le provette portate a destinazione
quando il laboratorio antidoping di Colonia è chiuso per festività e dunque
rimangono nell'ufficio degli ispettori dalle ore 15 fino alle 6 di mattina del
giorno seguente. Che succede in quelle 15 ore? Come mai, inoltre, contrariamente
alla prassi quel giorno Schwazer è l'unico atleta controllato?
2 - Correttamente viene
indicato il nome del luogo del prelievo sul formulario, ma perché tale dato
arriva al laboratorio di Colonia? Come si può garantire l’anonimato in queste
condizioni, dato che a Racines abita un solo atleta?
3 - La negatività del test
viene pubblicizzata sul sistema Adams e dopo due ulteriori prelievi (24 gennaio
e 1 febbraio) il profilo ormonale è completato, eppure per un paio di mesi nulla
si muove e solo il 14 aprile arriva l’ordine al laboratorio di Colonia di
effettuare il test IRMS. Il 13 maggio viene comunicato alla IAAF che il test ha
dato esito positivo stabilendo la presenza di 2 metaboliti del testosterone
sintetico. Perché la IAAF aspetta fino al 21 giugno a dare la notizia della
positività e perché rifiuta di anticipare le controanalisi previste per il 5
luglio sapendo che l’11 si chiudono le iscrizioni per le Olimpiadi?
4 - Alla obiezione che un paio
di metaboliti del testosterone sintetico non bastano a giustificare un’attività
dopante l'accusa potrebbe rispondere tirando in ballo le cosiddette microdosi,
ma allora perché negli altri 14 test antidoping non c'è traccia della sostanza?
5 - Si può escludere che un
set di provette possa essere preventivamente contaminato di metaboliti del
testosterone sintetico se la stessa Azienda che li produce (Berlinger) in un
comunicato del mese scorso riconosce (a proposito della denuncia di Grigory
Rodchenkov della Rusada sulla manipolazione di provette alle Olimpiadi di Sochi)
che “il caso è la prova di un atto criminale condotto da professionisti,
pianificato dietro le quinte, con un coinvolgimento dei Servizi Segreti Russi,
che ha implicazioni non solo sulle provette, ma anche sull'intera catena di
custodia e procedure collegate”?
Vedremo se la risposta della
IAAF alla memoria difensiva dei legali di Schwazer darà risposte a queste
domande. La beffa finale sarebbero delle scuse per un test antidoping invalido
per vizio procedurale, riconosciuto tale quando i termini di iscrizione
alle Olimpiadi saranno già scaduti. Alla buona fede della IAAF non crederebbe
nessuno e dopo essere stata decapitata dei vertici che mercanteggiavano
sull’antidoping non potrebbe sopportare un altro colpo mortale alla sua
credibilità.
Caso Schwazer: la Iaaf, i
sospetti e i chiarimenti attesi.
Procedure insolite e un accanimento anomalo sul marciatore altoatesino, scrive
Nando Sanvito su "Sport Mediaset" il 24 Giugno 2016. Schierati e divisi: i media
italiani -a volte anche testate dello stesso gruppo editoriale- hanno
posizioni molto diverse sul caso Schwazer. C'è chi ipotizza un disturbo bipolare
della personalità del marciatore altoatesino, dando per scontata la trasparenza
della procedura antidoping utilizzata nei suoi confronti. C’è chi invece ha
seri dubbi su quest’ultima. Se infatti, come trapela dalla Iaaf, la Federazione
internazionale di atletica, il ricontrollo della provetta incriminata di urina è
avvenuto per un automatismo del sistema informatico antidoping, perché allora
-si chiedono costoro- a differenza di ogni altro campione d’urina testato in
pochi minuti al momento del prelievo quello del marciatore viene invece lavorato
per tre giorni? E perché viene di nuovo analizzato quattro mesi dopo senza la
presenza di un prelievo fatto in competizione da incrociare? Ad aprile infatti
Schwazer non era ancora tornato a gareggiare. Dunque il minimo che si può dire è
che la procedura sia stata oggettivamente anomala. Tanto accanimento poi
autorizza sospetti se la Iaaf è la stessa che delega il controllo antidoping
della gara dell'altoatesino a Roma proprio al medico indagato dalla Procura di
Bolzano per il caso Schwazer. Insomma sia in caso di innocenza che di
colpevolezza la Iaaf deve comunque spiegare perché Alex sia stato trattato in
modo anomalo rispetto alla procedura standard. Senza chiarimenti ogni sospetto è
autorizzato, specie per una Iaaf già pesantemente screditata in questi mesi da
corruzioni e scandali anche sull'antidoping.
La conferenza stampa,
scrive Ezio Azzollini il 22 giugno 2016 su “Io gioco pulito. Il fatto
Quotidiano”. La Conferenza Stampa di Alex Schwazer e del suo avvocato e
di Sandro Donati in merito al nuovo scandalo legato al doping che ha coinvolto
il marciatore italiano.
PER IL LEGALE NON C’E’
COINVOLGIMENTO – Ecco le parole dell’Avvocato di Alex Schwazer: “Notizia
incredibile, impossibile, devastante, che non possiamo accettare. Alex con
questa vicenda non ha nulla a che vedere, nessuna responsabilità. Noi adesso
cercheremo di acclarare la verità anche per un interesse di giustizia. Per noi
inconcepibile tutta la vicenda, strano che una prova che a gennaio era negativa,
5 giorni dopo che Alex vince a Roma, venga riaperta e classificata positiva a
sostanze anabolizzanti che nulla hanno a che vedere con uno sport di resistenza.
C’era una pressione enorme, a causa di chi ostacolava il rientro di Alex alle
competizioni: vicenda brutta e sporca, faremo una denuncia penale contro
ignoti. Alex spera ancora e confida di poter andare alle olimpiadi, e Donati
spiegherà quale è stato negli ultimi due anni il percorso olimpico trasparente.
Alex ha segnalato alla Wada di essere disponibile ai controlli 24 ore su 24, e i
controlli sono stati tantissimi. Vedere a 4 mesi dal 1 gennaio, dopo un
controllo negativo, vedersi confutato un test positivo agli anabolizzanti ci
lascia furiosi. Alex ha fatto un percorso esemplare, non può accettare di essere
rimesso in discussione. Combatteremo con tutte le nostre forze. Ha sbagliato
Alex, ma ha fatto un percorso di umiltà, di riabilitazione, non se lo merita,
non pensavo che ci fossero tali prove di cattiveria umana.
LE DICHIARAZIONI DI SCHWAZER –
“Sarò sintetico per non essere accusato di nuovo di fare teatro. Sono di nuovo
qua a metterci la faccia per rispetto a chi mi è stato vicino. Ma stavolta non
devo scusarmi perchè non ho fatto nessun errore. Da un anno e mezzo ho fatto il
contrario dello sbagliare, allenandomi con Donati, per fare l’impossibile per
dimostrare che il mio ritorno è pulito. Oggi non ci sarà nessuna scusa perchè
non c’è nessun errore. Informato ieri di questa positività, è un incubo per me
perchè è la peggiore cosa che poteva succedere, ma posso giurare che si andrà in
fondo, perchè ho investito troppo in questo ritorno. So che molti non mi
volevano alle Olimpiadi, così come non volevano che vincessi a Roma. Io so
benissimo che un atleta già trovato positivo ha poca credibilità, so che per
qualcuno le mie parole lasciano il tempo che trovano, ma a fianco a me c’è
Donati, che ha impegnato una vita contro il doping, io spero che ci pensiate due
volte prima di attaccare lui e altre persone che mi sono state di fianco.
LE PAROLE DI SANDRO DONATI –
“Considerando il passato, Alex è l’identikit perfetto di chi disillude,
tradisce, si dopa all’insaputa dell’allenatore. Quale pretesto migliore avrei
avuto per lasciarlo adesso, per chiamarmene fuori? Ma io non lo farò mai. Con
Alex abbiamo intrapreso un progetto unico al mondo. Abbiamo messo a disposizione
delle istituzioni sportive più di trenta controlli presso la sanità pubblica,
non abbiamo mai ricevuto risposta. La mancata risposta non è una volontà di
mantenere l’ambiente pulito, ma una provocazione. Mi sono reso conto che
l’atleta positivo per doping diventa la preda su cui il sistema sportivo può
dimostrare la propria durezza e inflessibilità. Peccato che avvenga solo sui
soggetti più deboli. Passava il tempo e mi rendevo conto che attiravo su Alex
l’odio che hanno nei miei confronti per le mie battaglie. Ci vuole un bel fegato
per far passare Alex come un soggetto anabolizzato, che avrebbe un braccio
quanto due delle cosce di Schwazer. Se quell’urina avesse destato sospetti,
avrebbero provveduto a fare immediatamente quello che invece hanno fatto mesi
dopo. Forse aveva a che vedere con il risultato di Roma. Non serve che vi dica
quanti dirigenti della Iaaf in passato sono stati sospesi per faccende legate
alla compravendita di positività e negatività. Olimpiade? I tempi della
giustizia sportiva appaiono rapidi rispetto alla giustizia ordinaria, ma sono
tremendamente lenti per una preparazione che già sarà condizionata in maniera
pesante. La settimana che ha preceduto i campionati del mondo è stata un
calvario, hanno tentato di dimostrare che anzichè allenarsi Alex avesse
sostenuto una gara, cosa contraria alla squalifica. E’ stata una settimana
passata nell’angoscia che venisse fermato, anzi di vedersi reiterare la
squalifica, una specie di profezia”.
I lati oscuri,
scrive Andrea Corti il 24 giugno 2016 su “Io gioco pulito. Il fatto Quotidiano”.
Sono passate poco più di 24 ore dalla deflagrazione del caso riguardante Alex
Schwazer: il marciatore altoatesino, rientrato trionfalmente alle gare a
maggio dopo la squalifica per 3 anni e 9 mesi in seguito a una positività
all’Epo nel 2012, non ha superato un controllo antidoping effettuato lo scorso 1
gennaio in seguito ad una nuova analisi di un campione che era stato
inizialmente classificato come negativo. L’allenatore di Schwazer, da più di un
anno a questa parte, è il Professor Alessandro Donati, il guru dell’antidoping
italiano, che ha accettato di fare da garante nel percorso di Alex verso
l’obiettivo dichiarato, quelle Olimpiadi di Rio per le quali un mese fa il
marciatore aveva strappato il pass. Donati ha spiegato la sua opinione su questa
spinosa vicenda a ‘Io gioco pulito’: “Il lato più oscuro è senza dubbio la
tempistica, e la decisione di rianalizzare il campione. E’ un qualcosa di
incredibile, perché il primo campione è stato analizzato dal più importante
laboratorio antidoping, quello di Colonia. Ho studiato il report e il campione è
stato sotto analisi per tre giorni: non parliamo dunque di un’analisi
superficiale. Quel campione è stato giudicato negativo, al punto che la Iaaf lo
ha inserito tra i vari documenti che le hanno poi permesso di dare l’ok al
rientro di Schwazer alla Federatletica. A questo punto è subentrata una volontà
esterna, che ha fatto riaprire questo campione e andare a cercare il pelo
nell’uovo, ammesso che ci fosse visto che ciò che è emerso è un valore di
testosterone bassissimo, di pochissimo superiore alla norma. Bisognerà chiarire
anche altri lati oscuri, come anche la tempistica della fine delle analisi,
avvenuta cinque giorni dopo la vittoria di Alex a Roma. Poi mi chiedo: perché
questa analisi non è stata resa nota? Perché Fidal e federazione internazionale
di atletica non sono state informate? Perché l’atleta continuava a gareggiare?
Non posso poi parlare di altri lati oscuri, che saranno inseriti in una denuncia
penale, per ora contro ignoti”. Poi Donati ha raccontato un retroscena relativo
alle due gare a cui Schwazer ha partecipato nel mese di maggio, che gli hanno
consentito di ottenere la qualificazione per le Olimpiadi: “Personaggi molto
importanti con un ruolo importante mi hanno suggerito che sarebbe stato un bene
che Schwazer a Roma avesse fatto vincere Tallent. Poi a La Coruna mi è stato
detto che sarebbe stato bene non seguire l’attacco di due atleti cinesi. La
persona che mi ha dato questi consigli la conosco: può darsi che abbia captato
il clima dell’ambiente e giudicato inopportuno e pericoloso battere Tallent e il
cinese. Nella peggiore delle ipotesi, invece, questa persona è stato un
messaggero degli interessi di altri. Si tratta di una persona interna
all’organizzazione italiana, ma tutti i particolari verranno inseriti nella
denuncia. Interessi legati al mondo delle scommesse? Non credo nella maniera più
assoluta. Ma un atleta come Schwazer, con un potenziale atletico enorme che ne
farebbe l’uomo da battere a Rio e non solo nei 50 km, che subentra quando
nessuno se lo aspettava sposta degli equilibri. E’ logico che ci siano interessi
economici: dietro gli atleti ci sono contratti, allenatori e interi Paesi che
investono dei soldi”. Ma Donati non vuole parlare di complotto: “Come
carattere non faccio riferimento a complotti, anche quando subii un’imboscata ad
Anna Maria Di Terlizzi nel 1997, quando l’urina di questa atleta fu manipolata
in un controllo antidoping. Anche in questo caso non parlo di complotto, ma di
una successione di avvenimenti inquietanti. Con queste tempistiche ci ritroviamo
alla vigilia delle Olimpiadi con un atleta bombardato psicologicamente. Sono
assolutamente convinto che Alex non sia colpevole: perché ce lo avevo sempre
davanti e perché non aveva assolutamente nessun interesse ad assumere un
dosaggio così ridicolo e minimo di un anabolizzante. Se si sceglie di prenderlo
lo si fa in quantità decisamente superiori. Questo dosaggio minimo può derivare
da varie situazioni. Non capisco perché ci sia stata questa grande attenzione,
questo sforzo fatto all’esterno del laboratorio di Colonia. Dico che Colonia non
ha lavorato da sola, c’è stata una ‘manina’, una volontà esterna che ha chiesto
al laboratorio tedesco di rianalizzare un campione. Non so nemmeno se a Colonia
sapessero che si trattativa di un campione precedentemente classificato come
negativo”. Al termine dei mondiali di 50 km di marcia vinti da Schwazer a Roma
l’8 maggio scorso Donati si era sfogato con i giornalisti presenti
a Caracalla, assicurando di essere stato protagonista con l’atleta di una
vera lotta contro l’odio: “Non parlavo a vanvera. Non si tratta di odio
personale, ma di contrapposizione di interessi. Io da nostalgico vorrei delle
istituzioni sportive che difendano la correttezza e le regole e che non
facessero solo finta. D’altra parte si desidera che non venga disturbato il
manovratore. E’ un odio che non ha nulla a che vedere con l’emotività di noi
esseri umani”. Infine Donati ha voluto evidenziare un qualcosa che non si
aspettava: “Con sorpresa ho notato che dei giornalisti che in passato hanno
attaccato me e Schwazer anche pesantemente e in maniera cattiva hanno scritto
manifestando la loro perplessità di fronte alla positività di Alex. Ciò mi ha
fatto enormemente piacere e dimostra come in questa vicenda ci siano tanti,
troppi, lati oscuri”.
Atletica, doping: Donati,
un uomo contro tra polemiche e molti nemici.
Sullo sfondo del caso Schwazer
i rapporti tempestosi con la Iaaf e la Wada. Ieri il tecnico italiano ha puntato
l'indice contro la mancanza di credibilità della Federatletica internazionale,
scrive il 23 giugno 2016 “La Gazzetta dello Sport”. Lo scontro fra Sandro
Donati, la Wada e la Iaaf non nasce ora con la positività di Alex Schwazer al
testosterone. Viene da lontano. Ieri, il tecnico italiano ha puntato l'indice
contro la mancanza di credibilità della Federatletica internazionale, citando il
caso dell'ex presidente Lamine Diack e della sua famiglia, impegnati nella
"truffa e compravendita di positività, insieme con l'ex capo dell'antidoping",
alludendo a Gabriel Dollè, coinvolto anche lui nello scandalo russo su cui
indaga anche la giustizia francese, mentre altri tre funzionari Iaaf sono stati
di recente sospesi per aver avuto un ruolo nella corruzione. Sulla Wada, ha
invece sottolineato i "suoi meriti per molte iniziative", ricordando però
l'articolo del New York Times che ha rivelato una denuncia rivolta all'Agenzia
Mondiale Antidoping da una discobola russa, Darya Poshchalnikova, medaglia
d'argento a Londra, che fu lasciata cadere. Prima dello scoppio dello scandalo
dovuto all'inchiesta giornalistica della tv tedesca ARD. Un'inchiesta, quella
guidata dal giornalista Hajo Seppelt, che è stata la madre della vera e propria
rivoluzione antidoping di questi mesi, con le istituzioni sportive costrette a
dare risposte finalmente categoriche al problema, fino alla clamorosa esclusione
dell'atletica russa, confermata negli ultimi giorni, dall'Olimpiade di Rio de
Janeiro. Ma dove tutto è cominciato? Non va dimenticato che le denunce di Donati
non si sono concentrate soltanto sull'Italia dai tempi del salto allungato di
Evangelisti e del doping degli anni '80, ma hanno guardato anche all'estero, ai
tempi in cui la Federatletica internazionale era diretta da Primo Nebiolo. Più
recentemente, nei suoi rapporti con la Iaaf, è chiaro che l'inchiesta di Bolzano
ha avuto un ruolo importante. La federazione internazionale, sin dal primo
momento successivo all'epo di Schwazer, è sempre stata solidale con il suo
medico Giuseppe Fischetto, finito sotto processo per favoreggiamento
nell'inchiesta condotta dal pm Giancarlo Bramante. Un processo in cui Donati è
stato citato come teste dell'accusa e della stessa Wada, costituitasi parte
civile. Fischetto si è autosospeso, all'inizio dell'inchiesta giudiziaria, da
medico della Fidal, ma ha continuato a esercitare il suo ruolo di delegato
antidoping in grandi manifestazioni internazionali, Mondiali a squadre di marcia
di Roma compresa, senza però far parte della struttura di intelligence che ha
lavorato in queste ultime settimane su alcuni casa scottanti, e sull'analisi bis
del campione di Alex Schwazer, che ha portato alla nuova positività. Diverso è
il discorso che riguarda la Wada. Sandro Donati ha collaborato con l'agenzia
mondiale antidoping per anni con una numerosa serie di lavori che sono tuttora
rintracciabili sul sito ufficiale. Ma negli ultimi mesi si è acceso uno scontro
sulla sua qualifica di "consulente", negata dal nuovo direttore generale Olivier
Niggli, che ha sostituito proprio in questi giorni nella carica David Howman.
Sulla vicenda si è trovata poi una composizione con un comunicato condiviso. Ma
che non ha riempito la distanza fra Donati e la "nuova" Wada, che, in
particolare, non ha gradito l'impegno del tecnico a fianco di Schwazer,
accusato, in maniera neanche troppo nascosta, di non aver detto tutta la verità
sui suoi rapporti con Michele Ferrari. La stessa Wada, insieme con la Iaaf, si è
poi opposta allo sconto di pena per Schwazer in base alla sua collaborazione. Un
no che ha lasciato quindi la squalifica intatta fino al 29 aprile scorso. Prima
che il caso testosterone riaprisse per l'ennesima volta la storia.
Marco Bonarrigo
per il “Corriere della Sera”.
«Il laboratorio di Colonia ha lavorato bene. Non contestiamo il suo operato. E
non ricorriamo alla fantapolitica: non c' è nessun complotto, nessuno ha messo
questa o quella polverina nelle bevande o nel cibo di Alex per incastrarlo. La
sua positività all' antidoping è il frutto di un accanimento mirato sui campioni
biologici che ha deformato il risultato delle analisi. L' obiettivo era colpire
lui per colpire me. Ci sono dei mandanti. Lo dimostreremo». A 48 ore dall'
esplosione del caso Schwazer, Sandro Donati tiene fede alla promessa e resta a
fianco del suo atleta in Alto Adige: «Alex è provato ma vivo. Abbiamo parlato a
lungo. Adesso è a fare una sgambata di una decina di chilometri nei prati dietro
casa». La difesa del marciatore prepara le prime scadenze: a fine giugno il
deposito delle memorie, il 5 luglio le controanalisi. L' obiettivo è più che
ambizioso: far valere l'articolo 5.1 del Codice Wada, l'unico in grado di
annullare la squalifica. Il solo modo per farlo è invalidare la procedura con
cui il laboratorio di Colonia ha trovato testosterone sintetico nelle urine del
marciatore. Lo staff di Schwazer mostra i referti del controllo che
smentirebbero le tesi procedurali fatte trapelare dalla Iaaf: la positività come
primo clamoroso successo del passaporto steroideo (adottato solo nel 2015) su un
atleta di vertice. Si sarebbe trattato di un ricontrollo mirato, lo scorso
maggio, del campione prelevato il 1° gennaio. Questo sulla base di un allarme
automatico lanciato dal sistema informatico. Caro recidivo hai cercato di
fregarci: ma noi ti abbiamo beccato. I referti in mano a Schwazer indicano però
una verità diversa: il suo campione di urine di Capodanno sarebbe stato invece
«torturato» per tre giorni subito dopo il prelievo (dal 2 al 4 gennaio) quando
il test ormonale standard dura pochi minuti. Alla fine dei tre giorni, sulla
base del referto di Colonia («Nulla da segnalare: atleta rieleggibile»), la Iaaf
ha dato il via libera alle competizioni. Poi l'altra anomalia: lo stesso
campione di urine viene rimesso sotto torchio il 10 aprile, quando il passaporto
biologico ancora non era validabile per l'assenza dal primo controllo in
competizione. Perché? E perché la procedura, anormalmente lunga, resta aperta
fino al 13 maggio, quando viene accertata la positività. E perché a Schwazer
viene permesso di gareggiare a La Coruña a fine maggio notificandogli la
squalifica solo il 21 giugno? Che tesi utilizzerà la difesa? Alcune sono
ipotizzabili. Le apparecchiature per la spettrometria di massa avrebbero una
potenza così elevata da rilevare anche tracce infinitesimali di steroidi. Quelli
dovuti a una banale contaminazione alimentare, ad esempio. O quelli, sostengono
altri, rimasti «fissati» nell' organismo a lunghissimo termine: Schwazer ammise
di aver assunto testosterone nel 2010. Quante probabilità ci sono di vincere una
battaglia del genere, scardinando l'antidoping mondiale?
STAVOLTA NIENTE SCUSE
di Benny
Casadei Lucchi per “il Giornale” il 23 giugno 2016. Maglietta bianca. Sguardo a
pezzi. Nessuna lacrima. Ore 18 e una manciata di minuti. Alex ancora lì. Dietro
una scrivania a Bolzano. Quattro anni dopo. A parlare di doping. Il suo doping.
O siamo di fronte a un grande coglione o siamo di fronte a un grande complotto.
Stavolta non ci sono vie di mezzo. Alex Schwazer positivo a uno steroide
anabolizzante dopo aver chiesto e ottenuto, unico al mondo, di poter essere
controllato a sorpresa 24 ore su 24. Per dire. Trentacinque test in pochi mesi,
uno su due dedicato agli anabolizzanti, controllato anche ieri mattina a
Vipiteno, ore sette, dopo notte insonne seguita alla cartella ricevuta con
l'esito degli esami, toc toc, sono un ispettore della Iaaf, prego pipì. Ci
sarebbe da ridere, c' è solo da piangere. Ma Alex non piange. «Stavolta non devo
chiedere scusa di niente, perché non ho fatto niente. Se sono qui a metterci la
faccia è per rispetto di me stesso e di chi mi è vicino». Con lui la manager
Giulia Mancini, con lui l'allenatore e paladino della lotta antidoping Sandro
Donati, con lui i legali che annunciano battaglia e denuncia penale contro
ignoti «perché qui c' è stata cattiveria, è una vicenda profondamente ingiusta e
vogliamo la verità». Contro di lui, invece, c' è il mondo. Martedì 21 giugno,
ore 18 e 50, gli ispettori antidoping della Iaaf notificano tutto ad atleta e
allenatore. L' esame sangue e urine effettuato a Vipiteno la mattina del primo
gennaio, negativo all' epoca, riesaminato in maggio, il 12, è diventato
positivo. La Gazzetta dello Sport pubblica tutto. È un risveglio traumatico. Per
i sognatori e quelli del partito diamogli un'altra chance, per gli scettici e
quelli del via per sempre dallo sport. Visibilmente scosso appare anche il
presidente del Coni Giovanni Malagò che nel giorno della consegna della bandiera
a Federica Pellegrini, si ritrova nel mezzo di una bufera, col cerino acceso,
«certo che c'è qualcosa di molto particolare sulla tempistica...» dirà. La
sequenza è infatti sotto gli occhi di tutti: la bomba che scoppia nel giorno del
Quirinale, la bomba che deflagra al secondo controllo, il 12 maggio, quattro
giorni dopo la bella vittoria di Schwazer nella 50 km mondiale di marcia e pass
per Rio conquistato, la bomba che scheggia i buoni sentimenti tredici giorni
dopo la fine della squalifica per doping di tre anni e mezzo. Alex è positivo a
scoppio ritardato. A un anabolizzante sintetico che serve a chi vuole muscoli e
non contro la fatica dei marciatori. Questo spiega Donati, questo sottolineano i
legali, questo racconta il ragazzo a cui non dobbiamo credere perché, come dice
lo stesso Alex levandoci dall' imbarazzo, «capisco che credere a un ex dopato
sia difficile, però Sandro Donati che ha dedicato la vita contro il doping è
ancora qui accanto a me... E poi io quella stessa sostanza l'ho anche provata,
prima dei Giochi di Londra, in quell' anno in cui ho provato di tutto e l'avevo
messa da parte, non mi dava effetti. E allora ditemi voi, perché mai dovrei da
una parte rendermi disponibile a controlli a sorpresa 24 ore su 24 e poi doparmi
con qualcosa che non mi serve e che non mi aveva dato effetti?». Un grande
coglione o un grande complotto. Non se ne esce. Perché «tra l'altro la quantità
rilevata è minima» precisa Donati, e perché «sarebbe stato facile presentarmi
qui davanti a tutti voi e fare la figura di quello che si leva di torno e che
non sapeva niente. Invece io non lo lascio, Schwazer paga le mie lotte, l'odio
nei miei confronti per quanto fatto contro il doping doveva trovare una
vendetta. Eccola». Ancora: «E le incongruenze sono tante, la tempistica è
anomala e ci era stato chiesto da persone importanti di non vincere a Roma e La
Coruña (2° nella 20 km), forse questo ha dato fastidio. E ricordo la settimana
prima della 50 km, la Procura Antidoping aveva cercato di dimostrare che una
prova su strada era stata una gara e non un allenamento e Alex ha rischiato che
la squalifica s'allungasse... Abbiamo toccato molti interessi...l'indagine sul
doping russo è partita anche da Bolzano». Parole pesanti, che più pesanti
diventano e più, incredibilmente, lasciano aperto uno spiraglio: che davvero ci
sia del losco, un complotto, roba brutta e alla fine Rio non salti. «È un incubo
per me, è la peggior cosa che mi potesse succedere - confida Alex -, ma andrò
fino in fondo. Probabilmente qualcuno non vuole che vada alle Olimpiadi, a Roma
c' erano state pressioni perché non vincessi. Però credo ancora di potercela
fare, darò il 100% per chiarire e farcela» e se poi vogliono, fa capire, mi levo
di torno.
LA PIPÌ AL QUIRINALE E IL
WATERBOARDING DELL' ANTIDOPING
di Maurizio Crippa per “il Foglio” il 23 giugno 2016. Visto come ragionano gli
organi di giustizia, ci aspettiamo che prima o poi qualcuno incrimini la
marciatrice Elisa Rigaudo - come quel famoso professore di Bergamo - per essere
stata sorpresa a fare pipì nei giardini del Quirinale. Paradosso, ma neanche
troppo. Ieri gli ispettori dell'Associazione internazionale delle federazioni di
atletica leggera, in pratica la spectre delle Olimpiadi, si sono presentati a
casa Mattarella per effettuare un controllo antidoping a sorpresa sulla Rigaudo,
mentre partecipava alla consegna del tricolore ai portabandiera italiani in
partenza per Rio 2016. I corazzieri li hanno gentilmente mandati a cagare, e il
test su sangue e urine rimandato a quando l'Elisa è rientrata con gli altri alla
Casa delle armi al Foro Italico. Ma il vulnus resta. E va bene che con gli
olimpionici non si sa mai, e che Alex Schwazer dopo le lacrime e la
riabilitazione l'hanno beccato (l'avrebbero) positivo un'altra volta. E va bene
che le squalifiche per doping sono rimaste l'unico tipo di sanzioni che
l'occidente riesca ad applicare a chicchessia, ad esempio alla Russia di Putin.
Ma al Quirinale? Durante una cerimonia ufficiale? Gli energumeni della Iaaf
affermano di essersi mossi in base al whereabout, il protocollo che impone agli
atleti di essere sempre reperibili per i controlli a sorpresa (provassero un po'
con le centrali iraniane). Ma detta così, sembra il waterboarding applicato allo
spirito olimpico. A meno che sia il nuovo protocollo -trasparenza della luminosa
epoca Raggi.
L’ANTIDOPING AL QUIRINALE
LA FA FUORI DAL VASO
di Filippo Facci per il “Libero Quotidiano” il 23 giugno 2016. Drogarsi prima di
parlare con Mattarella, o subito dopo averlo fatto: c' è una logica, proprio
volendo. Ma l'idea di fare un controllo antidoping proprio al Quirinale, come ha
cercato di fare ieri la Federazione internazionale di atletica, beh, andrà
giustamente archiviata come una gaffe o come una smaliziata prova di stupidità:
roba che l'antidoping andrebbe fatto a loro, quelli della Federazione
internazionale. Forse la notizia già la conoscete: ieri, giorno in cui iniziava
ufficialmente la spedizione italiana di Rio, giorno in cui appunto era prevista
la cerimonia di consegna del tricolore da parte del Presidente della Repubblica,
giorno in cui peraltro scoppiava un altro caso di doping legato ad Alex
Schwazer, ieri, insomma, la International Association of Athletics Federation
(Iaaf) ha pensato di presentarsi al Quirinale per controllare le urine di una
marciatrice presente alla cerimonia, Elisa Rigaudo. Al Quirinale, sì. E li hanno
messi alla porta, ovvio, anzi, non li hanno neanche fatti entrare. Nota:
l'estate scorsa, durante una spedizione sul Monte Bianco, il campione del mondo
di karate Stefano Maniscalco continuava a dire allo scrivente che, anche a 4000
metri, doveva sempre rendersi disponibile alla Federazione in base al
"whereabout", cioè una sorta di indicazione che gli atleti devono lasciare per
essere reperibili per eventuali controlli antidoping; a me e agli altri pareva
una pazzia, ma probabilmente aveva ragione. Gli ispettori non andarono sul Monte
Bianco, ma sul Colle ieri ci sono andati. Fine della nota. E, ieri, era
bellissima l'espressione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, mentre un
corazziere lo avvertiva: ci sono i commissari con le provette, sì, proprio qui
nei giardini del Quirinale, sì, proprio mentre c'è la cerimonia che precede la
partenza per le Olimpiadi. Va da sé: agli ispettori hanno risposto che la
raccolta di sangue e urine, forse, potevano andarsela a fare da un'altra parte,
per esempio al Foro Italico dove più tardi hanno intercettato la povera Rigaudo.
La quale, intervistata da Repubblica online, più tardi ha detto: «L' ispettore
non sapeva che il Quirinale era un posto molto importante». Era un tedesco:
l'orgoglio di Mattarella ne avrà avuto nocumento. La Rigaudo, invece, pare abbia
detto al tizio della Federazione: «Scusi, ma è come se lei volesse fare il test
a degli atleti mentre sono a casa della Merkel». Incidente diplomatico? Ma no,
niente, figurarsi: the sport must go on, il Doping controller officer (Dco)
successivamente ha potuto officiare in una sala igienicamente idonea negli
uffici del Coni. Così, nella giornata di ieri, si sono registrate tre notizie.
La prima: Alex Schwazer è risultato positivo al controllo antidoping. La
seconda: Elisa Rigaudo è risultata negativa al controllo antidoping. La terza:
Sergio Mattarella è risultato.
DUE TECNICI SPECIALIZZATI,
48 ORE DI LAVORO, UNA PROCEDURA COSTOSA E SPECIALIZZATA: LA ...
di Marco Bonarrigo per
il “Corriere della Sera” il 23 giugno 2016. Due tecnici specializzati, 48 ore di
lavoro, una procedura costosa e specializzata: la spettrometria di massa per
rapporto isotopico. Lo scorso 13 maggio, per dichiarare positive le urine di
Alex Schwazer, i biologi del laboratorio Wada di Colonia hanno utilizzato lo
stesso metodo che smaschera chi adultera il whisky per vendere al prezzo dei
pregiati «single malt» i banali «blended». Hanno ionizzato la pipì del
marciatore bombardandola con un fascio di elettroni per poi spararla all'
interno di un analizzatore di massa. Il risultato? La percentuale di carbonio-13
ha dimostrato la presenza di precursori del testosterone sintetico estranei all'
organismo. Per i tedeschi è il risultato esemplare dell'efficacia della più
avanzata arma contro il doping: il passaporto steroideo, complementare a quello
sanguigno per accerchiare i bari. In vigore dal 1° gennaio 2015 (quando Alex era
fermo per squalifica) il passaporto di Schwazer è nato con il primo controllo a
sorpresa fuori competizione, lo scorso dicembre a Roma. Per validarlo servivano
dai tre ai sei test, di cui uno in competizione: quello della vittoria in Coppa
del Mondo a Roma dello scorso 8 maggio. In ogni esame si valutavano parametri
diretti e indiretti (testosterone assoluto, rapporto con epitestosterone) per
costruire una «curva di normalità» sempre più raffinata. L'aggiunta del tassello
dell'8 maggio ha messo fuori range il controllo dell'1 gennaio a Vipiteno: i
test a sorpresa nei giorni festivi non sono rari, perché chi si dopa li
considera strategici. L' ipotesi di complotto durante la procedura di esame
sarebbe smentita dal rigoroso protocollo operativo. L' analisi di gennaio è
stata fatta a Colonia su campioni «ciechi». Accertata la negatività, i parametri
steroidei sono stati trasferiti alla Iaaf per costruire un profilo ormonale
anonimo. Il 13 maggio, ricevuto l'ultimo esame, il sistema Iaaf ha segnalato in
automatico l'anomalia a Colonia, che con Roma e Montreal è la struttura più
avanzata al mondo sul fronte ormonale. Allarme rosso. A quel punto è scattato il
bombardamento ionico che ha isolato (in quello che restava della provetta A) il
testosterone sintetico su un'urina sempre anonima: positività netta - non
massiccia - e impossibile da contestare. Ok, ma cosa ha fatto Alex Schwazer per
risultare positivo? Nessun tecnico o dirigente di laboratorio si sbilancia. Ma
le possibilità sono sostanzialmente tre. La prima è la più drammatica per chi in
Alex ha creduto. Quantità e qualità dei precursori del testosterone sono
compatibili con un micro dosaggio continuativo: un piano organizzato di doping.
Steroidi in un atleta di endurance, con masse muscolari ridotte? Farsi di
testosterone aumenta la resistenza agli allenamenti duri e migliora il recupero.
L'ipotesi è agghiacciante perché presuppone un tradimento totale dell'allenatore
Donati e dello staff medico e un supporto medico e farmacologico parallelo. La
seconda ipotesi, non meno agghiacciante per ragioni opposte, è la contaminazione
dolosa: i tecnici ammettono che le quantità ritrovate sono compatibili con
un'assunzione unica anche involontaria - avvenuta in un range temporale di
alcuni giorni prima del controllo - di testosterone per via orale. Insomma,
qualcuno potrebbe aver piazzato il farmaco in un alimento o una bevanda per
incastrare Alex. La terza ipotesi è la contaminazione. Non alimentare (ci
sarebbero altri precursori) ma piuttosto da integratori, che però Schwazer ha
sempre detto di non utilizzare. Ora la palla passa alla giustizia sportiva.
Analisi del campione B entro il 5 luglio o prima, se la difesa riuscirà a
chiedere un anticipo. Se la positività fosse confermata, come accade sempre
nella giustizia sportiva tocca all' atleta l'onere di provare con fatti concreti
la sua innocenza. Una sfida al cui confronto la 50 chilometri olimpica è una
passeggiata.
Doping Schwazer, perché
serve essere garantisti.
Se si è dopato va radiato. Ma il test che lo inchioda è sospetto. E va chiarito,
scrive Gabriele Lippi su “Lettera 43” il 22 Giugno 2016. Déjà vu. A pochi metri
dal traguardo più ambito, il marciatore si ferma. A colpirlo non è una crisi di
fame o la disidratazione dopo quasi 50 chilometri sotto il sole, ma un test
antidoping che fa piombare su di lui la più infamante delle accuse che possano
esistere per un atleta. Ad Alex Schwazer era già successo prima di Londra 2012,
ed è ricapitato a 45 giorni dalla cerimonia di inaugurazione di Rio 2016. Epo,
allora, anabolizzanti adesso. Sembra di vedere un film già visto, eppure le
differenze tra le due situazioni sono più delle analogie. Allora, scoperto, Alex
si presentò in conferenza stampa, da solo, senza un solo membro della Fidal a
fargli compagnia. Pianse lacrime amare, ammise ogni responsabilità, raccontò di
essere andato a spese proprie fino in Turchia per acquistare 1.500 euro di
eritropoietina e assumerla poi a casa sua per mesi, ingannando anche la
fidanzata Carolina Kostner, che per quel peccato di ingenuità/negligenza/amore
avrebbe pagato con una squalifica di 16 mesi (poi ridotti a 12). Spiegò di
averlo fatto perché «tutti lo facevano, e mi sentivo impotente». Apparì come un
uomo solo, schiacciato dalla pressione, un atleta che si sentiva costretto a
vincere e unico baluardo di un'atletica italiana con poco talento e un livello
di programmazione inferiore agli altri. Qualcuno provò compassione, altri no, ma
sulla sua colpevolezza non potevano esserci dubbi. Oggi è tutto diverso. La
provetta che incastra Schwazer è stata prelevata a gennaio e, la prima volta, ha
dato esito negativo. A maggio, poco dopo la sua vittoria nella 50 km del
Mondiale a squadre di Roma, a pass olimpico strappato, un nuovo test sullo
stesso campione. Positivo, stavolta, con valori di testosterone 11 volte
superiori alla media. Non uno scarto minimo, ma qualcosa di enorme, passato
inosservato al primo controllo e trovato solo con le contro-analisi. In mezzo,
tra quei due esami, Schwazer ha ricevuto 15 visite degli ispettori Iaaf (la
federazione internazionale di atletica leggera), Wada (l'agenzia mondiale
antidoping) e Nado (l'agenzia italiana antidoping). Tutti rigorosamente
negativi. In un anno, da quando nel maggio 2015 ha deciso di tornare a
gareggiare, affidandosi alle cure di Sandro Donati, ha subito 47 controlli
antidoping, senza risultare mai positivo. Ora è facile cadere nella tentazione
della gogna mediatica e invocare la radiazione. Chi scrive ha sempre sostenuto
la tesi della 'seconda chance', l'ideologia della redenzione. Eppure, la prima
tentazione nella notte del 22 giugno, è stata quella di fare mea culpa,
scagliarsi contro Schwazer, chiedere scusa a Gianmarco Tamberi e a chi, come
lui, aveva espresso pareri durissimi sulla sua possibile partecipazione a Rio.
Perché chi gli aveva concesso un'apertura di credito si sente ancora più tradito
di chi, al contrario, non l'ha mai perdonato e mai lo perdonerà. Ci si sente
persino un po' sciocchi ad averci creduto. Ma in un mondo giusto, Schwazer
merita la sospensione di un giudizio che stavolta potrebbe essere quello finale.
La merita non per le lacrime versate nel 2012, non per l'oro di Pechino 2008,
non perché a lui ci si aggrappa per una medaglia in più in un'Olimpiade
destinata a dare poche gioie all'Italia. La merita in quanto essere umano. La
storia dello sport è tristemente piena di truffatori dopati, ma conta anche
drammi umani legati a giudizi sommari e vittime innocenti di casi tuttora
irrisolti. La fine di Marco Pantani, morto da solo in una camera d'albergo dopo
esser stato trattato come un paria per un ematocrito sopra il limite che ancora
oggi è velato dall'ombra del complotto, dovrebbe far riflettere. Così come
quella, fortunatamente con esito diverso, di Andrea Baldini, fiorettista
italiano costretto a fermarsi mentre si preparava all'Olimpiade di Pechino 2008
da favorito assoluto perché nelle sue urine fu trovato del furosemide, un
diuretico non dopante ma usato anche come coprente di altri farmaci. Baldini
sostenne di non aver mai assunto quella sostanza, gli esami approfonditi non
trovarono traccia di doping, e pochi mesi dopo fu riabilitato. Tornò e si laureò
campione del mondo, ma quei Giochi di Pechino, nessuno glieli ha mai potuti
restituire. Schwazer, a differenza di Pantani e Baldini, ha già sbagliato una
volta, è vero, ma quel conto l'ha già pagato. Ora va giudicato per questo nuovo
caso, e la lezione migliore, in queste ore, nel mucchio di chi lo chiama
«stupido» e invoca la sua radiazione, arriva dal silenzio di Tamberi, dal
richiamo al garantismo di Filippo Magnini, o dalle parole dello spadista Paolo
Pizzo, un altro che non è mai stato soft nei giudizi sul marciatore e su
chiunque si dopi. «Se fosse vero, sarebbe molto molto grave». Se fosse vero,
appunto. Occorre andarci piano, ascoltare le spiegazioni del marciatore, che ha
convocato una conferenza stampa per le 18 del 22 giugno, e del suo avvocato
Gerhard Brandstaetter, che parla di «accuse false e mostruose». In gioco non c'è
solo la carriera di un atleta, ma la vita di un ragazzo di 31 anni e la
credibilità di un allenatore come Sandro Donati, che su Schwazer si è giocato
tutto. Se non volete farlo per Alex, fatelo almeno per lui. Aspettate. Poi, se
tutto sarà confermato, radiazione a vita sia. Altrimenti chiederemo conto alla
Iaaf di come un test negativo a gennaio possa risultare con valori 11 volte più
alti della norma a maggio.
Donati: “Ho combattuto la
mafia del doping sono minacciato e vivo nella paura”.
L’allenatore di Schwazer:
“Racconterò tutto ai pm”, scrive Attilio Bolzoni l'11 luglio 2016 su "La
Repubblica". Sempre più solo e sempre più accerchiato, questa mattina ha parlato
con "qualcuno che gli sta intorno" e l'inquietudine che l'ha accompagnato nei
suoi ultimi drammatici giorni è diventata paura. Confessa Sandro Donati: "Sì, ho
paura che possa accadere qualcosa di molto brutto a me o alla mia famiglia".
Paura di cosa, professore? "Anche di perdere la vita". Non è soltanto una storia
di qualificazioni olimpiche e di record, di allori e di medaglie. Una vicenda
che è stata rappresentata come uno scandalo dello sport in realtà fa tanto odore
di mafia, di clan, di soldi. E mistero dopo mistero si sta trasformando in un
affaire internazionale dove le provette di urina s'intrecciano con grandi affari
e grandi interessi, appetiti di consorterie criminali, intrighi e vendette.
Sandro Donati esce allo scoperto, non si arrende, attacca. E denuncia: "Non mi
sono piegato ed ecco perché adesso temo il peggio. Già la mia carriera di
allenatore è stata stroncata 29 anni fa quando feci le prime denunce sul doping,
ma oggi le contiguità fra alcune istituzioni sportive e ambienti malavitosi sono
ricorrenti e dimostrabili". Da Vipiteno, il ritiro scelto per allenare Alex
Schwazer per le Olimpiadi di Rio e suo quartiere generale anche dopo l'assai
sospetta positività al doping del marciatore che è finito in un gorgo fangoso,
svela i suoi timori e annuncia: "Andrò al più presto alla procura della
repubblica di Roma a rappresentare certe situazioni, ho molte cose da dire ma
nei dettagli preferisco informare prima i magistrati. Per colpire me è stato
macellato un atleta innocente che in passato ha sbagliato, ma che è un campione
immenso che avrebbe sicuramente vinto a Rio la medaglia d'oro sia sui 20
chilometri che sui 50".
Chi l'ha voluto fermare?
"Questa storia porta con sé un
messaggio molto chiaro: chiunque parla va messo fuori gioco, chi rompe il muro
dell'omertà che c'è sul doping deve comunque pagarla cara".
Ci spieghi meglio: da dove
provengono queste minacce per la sua vita?
"Più persone mi hanno
sottolineato come sia stato un grande azzardo da parte di Alex Schwazer accusare
gli atleti russi di doping. Ed è evidente il rapporto di corruttela reciproco
che ha contrassegnato la relazione fra alcuni dirigenti della Iaaf (la
Federazione internazionale di atletica) e le autorità sportive russe,
finalizzato ad insabbiare o a gestire in maniera addomesticata i casi di
doping".
E cosa c'entra tutto questo
con la sua paura?
"Io ho avuto un ruolo
fondamentale, collaborando con la procura della repubblica di Bolzano e con il
Ros dei carabinieri, nell'individuazione di un gigantesco date base che era
nelle mani di un medico italiano che collaborava e collabora ancora con la Iaaf.
Nel date base c'erano centinaia di casi di atleti internazionali con valori
ematici particolarmente elevati. E, tra questi, un gran numero di russi. Ho
portato all'attenzione della Wada (l'agenzia mondiale antidoping) quel data base
e nel frattempo la magistratura francese ha aperto un'indagine per riciclaggio e
corruzione nei confronti del vecchio presidente della Iaaf Amine Diack che è
stato arrestato ".
Lei sta dicendo quindi che
la sua azione contro il doping ha provocato una rappresaglia?
"Ne sono sicuro. E ho
cominciato a ricevere strane telefonate e anche strane mail che ho già
consegnato alla magistratura. Una mi diceva: "Ho da comunicarti informazioni che
ti riguardano, un accademico tedesco possiede documenti che dimostrano il tuo
coinvolgimento nella vicenda del doping dei russi". Era firmata da una certa
Maria Zamora, un nome e una persona che non conosce nessuno. Ho fatto le mie
ricerche e sono arrivato alle conclusioni che la parte corrotta della Iaaf e i
russi sono un tutt'uno".
Ma perché questo
accanimento contro di lei?
"Perché c'è un sistema che non
tollera che l'antidoping venga fatto da soggetti esterni alla sua
organizzazione, in questo caso la Iaaf. La vicenda è stata in questo senso
un'operazione quasi "geometricamente perfetta". Che lancia un avviso a tutti: di
doping non si deve parlare, ce ne dobbiamo occupare solo noi istituzioni
sportive e chi ne parla fuori fa sempre una brutta fine".
È una legge molto mafiosa,
quella del silenzio.
"Il silenzio è la legge in
quel mondo. C'è anche una complicità politica, ma non solo in Italia, in tutti i
Paesi. Le manovre di isolamento nei miei confronti sono iniziate fra marzo e
aprile di quest'anno quando hanno messo in circolo alcune informazioni
false, secondo le quali io avrei avuto un ruolo marginale nella Wada. Un
tentativo di delegittimarmi, il mio rapporto con la Wada è sempre stato
intensissimo fin dal 2003. Eppure qualcuno ha scritto che io ero "un
millantatore". Poi è arrivato il resto. L'8 maggio - il giorno prima che Alex
vincesse a Roma la gara dei 50 chilometri per la qualificazione a Rio - qualcuno
mi ha telefonato dicendomi "che sarebbe stato meglio che Alex arrivasse
secondo". Una ventina di giorni dopo lo stesso personaggio mi ha ritelefonato
consigliandomi di "non rispondere all'attacco dei marciatori cinesi" nella 20
chilometri. C'è gente che vuole condizionare i risultati, gente che ha interessi
altri. Io, dopo 35 anni di attività, posso dire che non ho mai visto tanta
coalizione di forze e tanti segnali inquietanti come in questa vicenda di Alex".
Professor Donati, lei è da
una vita che combatte contro il doping. Ma davvero l'hanno lasciato sempre solo?
"Qualche mese fa alcuni
deputati della Commissione Cultura della camera mi avevano invitato per
un'audizione. Mi sono preparato, poi le istituzioni sportive hanno lavorato per
depennare il mio nome. Silenzio. Vogliono solo il silenzio".
Come sta Alex Schwazer?
"È un ragazzo serio. È
aggrappato a una piccola speranza che vede in me. Ma è così sereno che l'altro
giorno mi ha detto: " Prof, se non mi vogliono, io farò altro". Io però non mi
arrendo anche se vivo nel terrore. Ho paura ma non piego".
"Cosa ho visto in quella stanza...": Lo
sfregio, l'avvocato spiega come hanno umiliato Schwazer,
scrive “Libero Quotidiano” il 9 agosto 2016. Una notte da incubo, per Alex
Schwazer, volato a Rio de Janeiro per l'incontro con il Tribunale arbitrale
dello sport di Losanna che dovrà decidere se concedergli la possibilità di
partecipare ai giochi dopo il - controverso - caso di doping che lo ha
coinvolto. Il Tas ha deciso di non decidere: il verdetto slitta a venerdì, il
giorno in cui Alex dovrebbe affrontare la sua prima gara, la 20 chilometri. Un
nuovo sfregio contro l'azzurro, arrivato al culmine di un tesissimo incontro,
durante il quale l'allenatore, Sandro Donati, avrebbe dato in escandescenza,
urlando, abbandonando la stanza sbattendo la porta, per poi tornare, sempre più
scorato. "Il verdetto pare già scritto", hanno detto da ambienti vicini ad Alex.
E a tratteggiare il clima che si respira, ci ha pensato l'avvocato dell'atleta,
Gerhard Brandstaetter, che spiega che cosa ha visto nella stanzetta dove hanno
"processato" il suo assistito: "Il clima è un po' da santa inquisizione, ma noi
siamo convinti di aver ragione. Adesso speriamo di trovare un giudice che ce la
dia". L'udienza è durata quasi 10 ore, un'eternità. "Alex era molto stanco e
provato, ha preferito tornare in hotel. Domani si allenerà e aspetterà
fiducioso". Ma la fiducia, purtroppo, è pochissima: la Iaaf, la federazione
internazionale di atletica, avrebbe chiesto otto anni di squalifica per il
marciatore. Un piano perfetto per farlo fuori. Tanto che la difesa di Schwazer
al Tas, si è appreso, ha assunto i contorni di un attacco totale proprio alla
Iaaf. Nel mirino della difesa i macroscopici vizi procedurali relativi ai
controlli del campione positivo, prelevato lo scorso primo gennaio. Inoltre, per
dimostrare che la sostanza trovata nelle urine di Alex fosse stata piazzata, la
difesa ha presentato un modello logico-matematico che si basa sui tempi di
dimezzamento del testosterone sintetico nella quantità rilevata. L'obiettivo è
dimostrare che i controlli subiti da Schwazer subito dopo il primo gennaio
avrebbero dovuto rilevare sostanze dopanti. Ma in un clima da "santa
inquizione", giusto per ripetere le parole dell'avvocato, ogni dimostrazione
potrebbe rivelarsi inutile.
Il campione che l'Italia ha abbandonato.
"Libero Quotidiano" per Schwazer: "Preso per il culo",
scrive di Fabrizio Biasin
il 10 agosto 2016. Noi ancora non lo sappiamo, ma
Alex Schwazer ha ammazzato qualcuno. Non c’è altra spiegazione. Tra l’altro non
deve avere ucciso «uno qualunque», un povero cristo, semmai il parente di
qualcuno che conta: un bis-nipote del presidente Iaaf (federazione
internazionale di atletica leggera), lo zio di un capoccione della Wada
(l’agenzia mondiale antidoping). Viceversa non si spiega l’accanimento, il
trattamento ai limiti della presa per il culo (e perdonateci il «culo», ma
quando ci vuole ci vuole) che il mondo dell’atletica sta riservando al nostro
marciatore e, di riflesso, anche a noi italiani. Schwazer conoscerà il suo
destino - ovvero la decisione sul farlo o non farlo gareggiare a Rio - «entro
venerdì», che poi è il giorno della 20 km, una delle due gare alle quali
vorrebbe partecipare (per provare a vincerle, tra l’altro). L’ha deciso il Tas
(Tribunale Arbitrale dello Sport), chiamato a trovare una risposta al seguente
domandone: è Alex un dopato recidivo e quindi figlio di buona donna? Si è
effettivamente «strafatto» di anabolizzanti l’1 gennaio scorso e merita quindi
pernacchie e radiazione (8 anni, richiesta della Iaaf)? Avremmo dovuto scoprirlo
nella notte italiana di lunedì ma, «chi comanda», ha scelto di rimandare
ulteriormente ogni decisione (il primo rinvio senza senso è del 27 luglio,
firmato dai «soliti» responsabili Iaaf). Non vi sentite parte in causa? Son
fattacci del marciatore e peggio per lui? Forse avete ragione, ma perdete due
minuti dietro a questa vicenda allucinante e vediamo se cambiate idea. Alex
Schwazer - 31 anni, altoatesino, faccia da sberle - è uno sculettatore con i
fiocchi e, infatti, marcia che è una meraviglia. La «povera» atletica leggera
italiana se ne accorge ben presto, si attacca alla gallina dalle uova (e dalle
medaglie) d’oro e ben fa. Non stiamo ad annoiarvi con l’elenco dei trionfi, ci
limitiamo a citare il 1° posto di Pechino 2008, conquistato triturando gli
avversari. Quattro anni dopo, alla vigilia dei Giochi di Londra, il «patinato»
fidanzato della pattinatrice Carolina Kostner, viene giustamente sputtanato
sulla pubblica piazza: è dopato, si fa di Epo, deve essere fermato. Così accade:
Schwazer si becca, tra una cosa e l’altra, 45 mesi di squalifica, gli amici gli
girano le spalle, la fidanzata lo molla. Praticamente è solo come un cane. Solo
un tale gli tende la mano, Sandro Donati, paladino della lotta al doping,
tecnico capace, uomo di sport che non piace al mondo dello sport per la sua
petulante denuncia contro un sistema sporco e corrotto. «Ti alleno io», gli
dice. «Grazie», risponde Alex. I due si fanno un mazzo così marciando lungo le
strade provinciali, ben lontano dai campi di gara a loro preclusi. Schwazer
viene guardato dagli altri come «sozzo e imperdonabile», ma se ne frega, ritrova
forma e tempi, quindi alla prima occasione dopo la riabilitazione (Roma,
Mondiale a squadre dell’8 maggio scorso) conquista vittoria e crono utile per
volare a Rio. Una favola straordinaria? Neanche per idea. Il 21 giugno salta
fuori una provetta, quella relativa alle analisi a sorpresa dell’1 gennaio
scorso: il test che a suo tempo diede esito negativo, improvvisamente si
trasforma in positivo. Alex viene sospeso. E fa niente se gli altri 19 controlli
a cui si è sottoposto negli ultimi due anni hanno certificato la sua «purezza»:
Alex, per chi comanda, è come il lupo che perde il pelo e bla bla bla. In
conferenza stampa il marciatore, Donati e l’avvocato Brandstaetter sono
incazzati come iene e gridano la loro innocenza. Spuntano telefonate registrate
in cui si «consiglia» a Schwazer di non vincere «perché è meglio così». Come se
non bastasse, l’ennesimo test (quello del 22 giugno) è negativo: Alex chiede e
ottiene udienza al Tas. Il resto è storia di oggi:
il-rinvio-del-rinvio-della-sentenza-sulla-vera-o-presunta-positività-relativa-a-un-test-che-era-negativo-ma-poi-è-risultato-positivo.
Una situazione grottesca, un trattamento indegno. Il tutto condito da un
silenzio bestiale: non tanto quello dei tifosi (c’è chi grida al complotto, chi
semplicemente denuncia «l’indecenza» del trattamento riservato al nostro
marciatore), quanto quello dei nostri «comandanti», dei capi-spedizione, dei
responsabili del Coni. Nessuno tra quelli «che contano» che alzi un dito e dica:
«Squalificarlo è vostra facoltà, umiliarlo proprio no». Niente di niente: vince
l’indifferenza, il mutismo rotto solo da Donati che, lunedì, dopo 7 ore di
udienza, se n’è andato dall’aula di Rio sbattendo la porta. «Hanno già deciso»,
ha detto a mezza bocca. Sul volto la smorfia di chi inseguiva un sogno. Fabrizio
Biasin
Doping, Schwazer: il Tas ha deciso otto
anni di squalifica: «Sono distrutto, chiedo più rispetto per me».
La sentenza ai danni del marciatore azzurro notificata alle parti, accolta la
richiesta della Federazione internazionale per la positività di inizio gennaio,
scrive Gaia Piccardi, inviata a Rio de Janeiro, il 10 agosto 2016 su “Il
Corriere della Sera”. La lunga marcia finisce qui, sul lungomare scintillante di
Copacabana dove Alex Schwazer sparisce nel buio pesto della notte brasiliana con
il morale a pezzi («Sono distrutto»), inseguito dai fantasmi di un verdetto
impietoso: otto anni di squalifica per doping-bis. Ha gli occhi scavati, le
labbra serrate, nessuna voglia di parlare: «Dovreste avere più rispetto per me
come persona». Sale in taxi, destinazione sconosciuta. In mattinata si era
allenato sotto la pioggia, 40 km inseguito da Sandro Donati in bicicletta e
aggrappato alla certezza che il Tas lo avrebbe riammesso ai Giochi di Rio, che
avrebbe potuto indossare una maglia della nazionale italiana ed entrare in una
stanza del villaggio, parte integrante della spedizione olimpica, di nuovo
atleta e non più reietto. L’udienza fiume (9 ore) di lunedì, dopo due giorni di
camera di consiglio, invece ha prodotto il verdetto più scontato in presenza di
positività al testosterone. La fine della carriera. La fine di tutti i sogni.
Gliel’ha detto la manager storica, Giulia Mancini. Alex si è seduto e ha fissato
il pavimento per un’ora, livido. Poi ha rotto il silenzio: «Potete andare?». Si
è fatto una doccia, ha indossato pantaloncini e maglietta. È uscito per correre.
Non è più tornato. Solo nella notte raggiunto dall’agenzia di stampa Agi ha
detto: «Non mi sembrava che l’udienza fosse poi andata così male, per questo ho
voluto crederci fino alla fine. Non conosco ancora le motivazioni ma mi pare si
siano limitati ad una semplice cosa tecnica. Credevo di poter partecipare alle
Olimpiadi di Rio, è da oltre un anno che lavoro e facendo parecchi sacrifici,
soprattutto economici». Il miracolo di ribaltare il risultato già scritto di una
partita in trasferta, contro avversari enormi - la Iaaf con il direttore del suo
laboratorio antidoping, Thomas Capdeville, presenza del tutto irrituale in una
procedimento che di rituale non ha avuto nulla sin dall’inizio, a partire dallo
spostamento dell’udienza da Losanna a Rio -, è fallito. Le spiegazioni di coach
Sandro Donati, argomentate con dati/tabelle/istogrammi relativi al monitoraggio
antidoping a cui Alex è stato sottoposto ogni 15 giorni dall’anno scorso
(«Un’iniziativa destabilizzante per un ambiente corrotto e una federazione, la
Iaaf, priva di credibilità»), non sono state accolte. La veemenza con cui sono
state esposte, forse scambiate per la furia iconoclasta con cui questo
professore di Monte Porzio Catone da tutta la vita sta cercando di combattere un
sistema che è convinto sia malato nel midollo, respinte al mittente. La tesi
della Federatletica internazionale è accolta in toto: Alex Schwazer si è dopato
per la seconda volta dopo la positività all’epo del 2012, nelle sue urine il
primo gennaio scorso c’era il testosterone sintetico che gli costa otto anni di
squalifica, la pena applicata di default a un recidivo. Le incongruenze sulla
conservazione del campione, la comunicazione tardiva, l’accanimento con cui è
stato esaminato più volte? Inesistenti. La tesi del complotto ipotizzata a gran
voce da Donati in questo ultimo, drammatico, mese? Fantasia. La marcia
s’interrompe, questa volta per sempre, nel luogo che più stride con la
costernazione profonda della coppia di fatto Alex&Sandro, saldati dalle
circostanze e abbattuti all’ultimo assalto alla diligenza. Dietro l’hotel Best
Western dove si consuma il dramma sportivo e umano di Schwazer e Donati, le
mille luci del lungomare più glamour di Rio e dell’Olimpiade, il luogo dei
tanga, delle infradito e delle caipirinhe. Dentro, nella stanzetta che atleta e
allenatore dividono in questa trasferta per risparmiare le spese, solo rabbia,
lacrime e tristezza. Se Alex, a 30 anni, può inventarsi un’esistenza tra Calice
e Vipiteno («È scioccato ma adulto, affronterà la vita fuori dall’atletica» dice
il prof, stravolto), magari puntellandosi all’affetto della nuova fidanzata
(Carolina Kostner tace, sullo sfondo), non c’è dubbio che Donati non si darà
pace fino all’ultimo dei suoi giorni: «È una vicenda grottesca, umiliante per
Alex e chi gli sta accanto. La battaglia ora passa sul piano giudiziario: ci
sono già due Procure, Bolzano e Roma, che indagano». Doveva finire sul traguardo
dell’Olimpiade, magari già nella 20 km di marcia di domani. E invece il sipario
cala così, come una pietra tombale su questa tragedia shakespeariana. Mai finita
anche adesso che è finita.
Doping, il Tas ha deciso: Schwazer
condannato a 8 anni. "Sono distrutto". Il Tribunale di
arbitrato sportivo ha emesso il proprio verdetto: non correrà la marcia 50km
venerdì 19 agosto. La sentenza arriva dopo la positività a uno steroide
sintetico rilevata in un controllo del 1 gennaio scorso. Donati: "Gli hanno
stroncato la vita". Tamberi lo attacca di nuovo, scrive il 10 agosto 2016 “La
Repubblica”. Il Tas demolisce la carriera di Alex Schwazer. Il Tribunale di
arbitrato sportivo ha condannato il marciatore altoatesino a una squalifica di 8
anni per la nuova positività a uno steroide sintetico rilevata in un controllo
del 1 gennaio scorso. Il verdetto arriva dopo l'udienza fiume di due giorni fa
in cui Schwazer aveva esposto le proprie ragioni, chiedendo l'audizione di
alcuni testimoni via skype e producendo una importante documentazione attraverso
schede powerpoint e test. Il Tas ha accolto tutte le richieste che la Iaaf aveva
fatto e quindi non ha concesso alcuna attenuante al marciatore altoatesino che
sognava le Olimpiadi di Rio de Janeiro, obiettivo che si era prefissato da oltre
un anno, quando aveva iniziato la collaborazione con Sandro Donati, il paladino
della lotta al doping. "Sono distrutto", è la prima frase con cui Schwazer
commenta il verdetto. Per poi aggiungere: "Non mi sembrava che l'udienza fosse
poi andata così male, per questo ho voluto crederci fino alla fine. Di quelle
dieci ore che abbiamo parlato dove Donati ha presentato il suo power point, non
è rimasto nulla, solo una grande amarezza. Non conosco ancora le motivazioni ma
mi pare si siano limitati ad una semplice cosa tecnica. Credevo di poter
partecipare alle Olimpiadi di Rio, è da oltre un anno che lavoro e facendo
parecchi sacrifici, soprattutto economici". Il tecnico Sandro Donati, in
conferenza, lo difende con convinzione: "E' evidente un fine persecutorio nei
confronti si Alex. Di riffa o di raffa dovevano eliminare Schwazer. Non parlerò
della mia persona, ho una certa età. Ad Alex hanno stroncato la vita. Stamattina
ha marciato per una quarantina di km a una velocità che tolti uno o due
marciatori nessuno saprebbe tenere nemmeno in gara. E' evidente che era facile
incolpare uno con un precedente. Poi avete visto con quale tecnica, anche medici
interessati da procedimenti giudiziario, si siano affrettati a definirlo persino
"bipolare". Alex è lineare, coerente, semplice, affidabile. Ha sbagliato una
volta, con sua quota di responsabilità coinvolgendo anche la Kostner in una cosa
in cui non entrava niente. Ma in quel periodo è stato abbandonato a sé stesso.
Non gli è stato dato un allenatore adeguato. Qualcuno gli ha prescritto un
antidepressivo per email. Sapevano che aveva incontrato il dott. Michele Ferrari
e nessuno è intervenuto. Gli hanno permesso di andare in Germania per un mese.
Tutti si sono sottratti, il Coni e la federazione". Ora cosa sarà di voi? "Alex
è cresciuto tanto in questi anni e ha l'equilibrio per affrontare la vita anche
fuori dall'atletica. Lui dopo Rio l'avrebbe abbandonata comunque dopo Rio. C'è
stata un'opera di delegittimazione di Schwazer appena ha iniziato a lavorare con
me, con foto mandate in giro. Ex miracolati di Conconi. Alex marcia alla grande,
non gli è mai stato alzato un cartellino rosso. Si è pagato tutto di tasca sua,
e lo hanno accusato di fare marketing". Chi invece è tornato ad attaccare
Schwazer è Gianmarco Tamberi, a Rio per seguire le gare nonostante l'infortunio
che gli ha impedito di essere tra i protagonisti del salto in alto: "Mi chiedete
se 8 anni sono giusti? Non sono io a dovermi esprimere, ma Schwazer è stato
trovato positivo due volte, e questo non sono io a dirlo...". L'atleta azzurro
ribadisce la sua posizione: "Mi ero espresso prima di questa nuova positività,
ho sempre pensato che un'atleta pizzicato per doping non debba più vestire la
maglia azzurra perché non rappresenta più i valori della nazionale". Anche Elisa
Di Francisca, argento nel fioretto a Rio, non è tenera con l'altoatesino: "Non
ho mai barato, non ho mai pagato nessuno per farmi vincere. Ho la coscienza
pulita perché non mi sono mai dopata in vita mia. Questa è la mia linea e lo
sarà sempre, i risultati li voglio ottenere solo attraverso i miei sacrifici.
Sta a ognuno di noi comportarsi bene". L'ultima chance, ma ormai i Giochi
saranno passati, sarà quella di andare fino all'ultimo grado di giudizio che è
la Corte Federale svizzera. Il 31enne marciatore di Calice di Racines farà
richiesta di esame del Dna. Alex Schwazer era stato trovato positivo all'esame
antidoping del primo gennaio 2016 solamente a seguito di un test di laboratorio
effettuato oltre tre mesi dopo l'esame che inizialmente aveva dato esito
negativo. Gravi - secondo la difesa - sono stati i ritardi nella comunicazione
all'atleta da parte della Iaaf. Infatti, sono trascorsi oltre 40 giorni dal
momento della positività riscontrata, il 13 maggio, alla notifica, avvenuta il
21 giugno. "Siamo delusi ma andremo avanti a trovare la verità con l'esame del
Dna e quant'altro. Otto anni perché è recidivo. Non sappiamo ancora le
motivazioni". Così all'Agi l'avvocato Thomas Tiefenbrunner, legale di Alex
Schwazer, alla notizia della squalifica di otto anni inflitta al marciatore
altoatesino.
LO HANNO FOTTUTO.
"Sotto shock", paura per Schwazer: nella notte, la sua tragica reazione, scrive
“Libero Quotidiano” l’11 agosto 2016. Carriera e Olimpiadi cancellate, con un
metaforico tratto di penna. Fottuto. Fregato. Massacrato. Otto anni di
squalifica per Alex Schwazer, che era volato a Rio de Janeiro per il ricorso al
Tas e per sperare in queste Olimpiadi. La situazione in cui lo avevano cacciato
era disperata, ma lui ci credeva ancora. Ancora un pochino. Ma niente da
fare. La caccia alle streghe si è conclusa così, con una punizione esemplare che
lo uccide sportivamente e che arriva per un caso molto, troppo sospetto. E Alex
ha reagito male. Nel peggiore dei modi, rinchiudendosi in se stesso. L'unica
frase pubblica che gli è uscita dalla bocca è stata: "Sono distrutto". È un
ragazzo fragile, Schwazer, lo dimostra quella sua tragica e indimenticabile
conferenza stampa in cui, nel 2012, ammise tutte le porcherie di doping che
aveva fatto. Porcherie che oggi, probabilmente, non ha fatto. Per nulla. Sono in
pochi a credere che si sia dopato ancora, sotto lo sguardo attento di
mister Sandro Donati, per giunta, l'uomo che ha lottato tutta la vita contro il
doping e che proprio per questo, forse, oggi ha pagato. Nella notte italiana,
Schwazer ha anche disertato la conferenza stampa convocata nella terrazza
dell'albergo dopo lo squalifica. Se ne è andato via da solo, cercando il mare,
un luogo in cui nessuno lo guardasse. Secondo il racconto della Gazzetta dello
Sport si è seduto a un tavolo alla Casa dos Marujos, senza consumare
nulla, guardando fisso la tv che proiettava Svizzera-Usa di beach volley. Solo,
per più di un'ora, con la maglietta azzurro indosso, come se dovesse iniziare ad
allenarsi, da un momento all'altro. Poi si è alzato e si è infilato in un taxi
insieme alla sua manager, Giulia Mancini. Poi c'è mister Donati, che racconta:
"Ho informato io Alex della squalifica, è rimasto in silenzio per venti
minuti, senza parlare". Dunque una nuova rivelazione, che aggiunge ulteriore
puzza di marcio al marcio di questa storia: "Nell'udienza del Tas, abbiamo
scoperto che il famoso controllo antidoping a sorpresa era stato pianificato e
comunicato agli ispettori del prelievo 15 giorni prima. Una situazione
incredibile, mettendo a rischio la riservatezza del controllo. Perché
controllarlo il primo gennaio e non il 28 dicembre? Perché l'obiettivo era
quello di effettuare tutto il primo gennaio, con il laboratorio chiuso, e con la
possibilità di tenere la provetta un giorno intero prima di portarla a Colonia".
Un complotto, appunto. Gli indizi sono tanti, troppi. Una carriera bruciata,
finita, calpestata, umiliata. Schwazer aveva pagato tutto quello che doveva
pagare. Ora dovrà pagare anche un conto che forse non gli spetta. Gli resta solo
la giustizia penale, dove dovrà dimostrare che ci sia stato un sabotaggio o una
sottomissione. Impresa ardua. Si inizierà col test del Dna. Ma sarà sempre
troppo tardi. Per le Olimpiadi di sicuro, e forse anche per tutto il resto.
Schwazer senza scampo: 8 anni di
squalifica. Accolta la richiesta della Iaaf, l'azzurro chiude con la marcia. Ma
i sospetti restano, scrive Benny Casadei Lucchi,
Giovedì 11/08/2016, su "Il Giornale". Il Tas, nel tardo pomeriggio di Rio, ha
comunicato la propria decisione e, anche se prevista, è choc. Alex Schwazer è
fuori da tutto. Otto anni di squalifica. Senza se, senza ma, uno schiaffo
all'uomo e ai suoi uomini, in primis Sandro Donati, paladino della lotta al
doping finito anche lui in queste sabbie mobili del sospetto. Ricaduto,
coinvolto, fregato, gli estremi del giallo e del due pesi e due misure
resteranno per sempre perché questa seconda positività di Alex, fin dalla
tardiva comunicazione a giugno, dopo mesi a rimpallarsi provette e controlli, è
e resterà tinta di giallo. Il controllo del 1° gennaio, la presenza minima di
anabolizzanti riscontrata, la provetta non anonima, con indicato il paese di
Alex, Racines, unico atleta al mondo a vivere lì, per cui persino negato
l'anonimato nei controlli. E poi l'incredibile tempistica che ha portato la Iaaf
a comunicare la positività solo a fine giugno, quando ormai i tempi per appelli,
difese, tentativi di far valere le proprie posizioni erano, e infatti si sono
rivelati, vani. Inutile il viaggio a Rio, inutile la presenza dei suoi legali,
di specialisti, di video che avevano monitorato giorno per giorno l'assenza di
doping nel suo sangue. Inutile allenarsi con tristezza e la pena nel cuore lungo
le vie di Copacabana. Schwazer torna a casa, ma questo è solo l'inizio di una
lunga marcia verso altro. Domani avrebbe potuto correre la 20 km, la settimana
dopo giocarsi tutto nella sua 50. Ora dovrà iniziare ben altro allenamento:
reggere il peso di un simile epilogo. Perché la vicenda ha dell'incredibile.
Squalificato alla vigilia della marcia di Londra 2012, risqualificato
definitivamente alla vigilia di quella di Rio. Quattro anni più tardi, dopo
averne scontati tre di fermo, dopo essere tornato alle competizioni lo scorso 8
maggio, dopo aver vinto la marcia mondiale di Roma, dopo aver fatto capire al
mondo che avrebbe ipotecato la medaglia d'oro ai Giochi. Niente Giochi, invece.
Vicenda surreale perché non ci si può sbilanciare da una e dall'altra parte.
Perché Alex era stato trovato positivo e in più aveva mentito la prima volta. E
perché la positività agli anabolizzanti riscontrata il 1° gennaio dai
controllori della Iaaf è emersa solo dopo un secondo controllo il 12 maggio,
quattro giorni dopo la marcia vittoriosa di Roma, ma comunicata a fine giugno.
Per cui c'è tanto di cui sospettare. Da una parte e dall'altra.
Però poi, nonostante i dubbi, ci sono loro.
Quelli che, comunque, stanno dalla parte della ragione. Posti esauriti, dato il
gran numero.
Rio 2016, la russa Efimova in lacrime:
vince l'argento ma piovono insulti, scrive Mario di
Ciommo il 9 agosto 2016 su “La Repubblica”. Yulia Efimova ha vinto la medaglia
d'argento nei 100 metri rana, ma ad attenderla fuori dalla vasca non c'erano
applausi e complimenti: solo fischi e insulti. La nuotatrice russa, riammessa in
extremis ai Giochi dopo il ricorso al Tas, ha vissuto una serata surreale dopo
la conquista della sua seconda medaglia olimpica. "Non c'è medaglia che possa
cancellare l'amarezza del vedere che tutto il pubblico è contro di te, - ha
dichiarato tra le lacrime la Efimova - ho commesso degli errori nella mia vita e
la prima volta ho pagato con la squalifica di sedici mesi, ma la seconda volta
non è stata colpa mia. Sono pulita". Anche Lily King, medaglia d'oro nella
specialità, non è stata molto indulgente con la russa e durante la semifinale le
ha mostrato il dito medio in vasca. "Che giorno triste per lo sport. Permettere
ai dopati di gareggiare è una cosa che mi spezza il cuore e mi fa letteralmente
incazzare", è stato invece il commento di Michael Phelps alla medaglia della
Efimova, diventata un vero e proprio caso. Il clima di tensione ha richiesto
l'intervento del Cio. Il Comitato Olimpico Internazionale ha chiesto agli atleti
di rispettare gli avversari non solo con i comportamenti sui campi di gara, ma
anche nelle loro dichiarazioni.
Pubblica gogna (dei perdenti) per i
dopati. Altro che tregua olimpica. Rivolta di tifosi e
atleti con i riabilitati dal doping. Dotto duro: "Li guardi e vorresti dargli un
pugno", scrive Benny Casadei Lucchi, Mercoledì 10/08/2016, su "Il Giornale". Per
la città olimpica, per il parco olimpico, nei palazzetti olimpici, ovunque si
aggira uno spettro che non è solo il doping, ma anche il modo in cui atleti
puliti e pubblico lo stanno vivendo. Monta l'amarezza, c'è tensione, e siamo ai
fischi, agli insulti. Nel nuoto i casi Sun Yang ed Efimova e Morozov, ieri in
batteria e semifinale nei 100 stile con il nostro Luca Dotto, hanno trasformato
il bordo vasca in un'arena di cose brutte. S'insultano fra loro gli atleti
divisi tra puri o al momento puri e sporchi o al momento ex sporchi. Caricando a
pallettoni i tifosi sugli spalti. Per dire. Luca Dotto dopo le batterie dei 100
ha detto: "Le Federazioni che dovevano prendere delle decisioni stanno perdendo
la faccia e hanno stancato noi e il pubblico. E poi quando ci sono un paio di ex
dopati che tolgono un posto in semifinale o finale a persone pulite, che lottano
tutta la vita per quel posto... ecco... quando li guardo in camera di chiamata,
mi viene da prenderli a ceffoni. Però sono ormai qui, non gli si può sparare
alle gambe altrimenti l'avremmo già fatto, per cui cerchiamo di batterli perché
vale doppia soddisfazione". Per dire: il Cio ieri ha saputo solo uscirsene con
un inutile e ovviamente inascoltato "gli avversari vanno rispettati". Luca
infatti non fa nomi, ma è ovvio che si riferisca a Sun Yang argento davanti a
Detti nei 400, o al russo Morozov, finito nel rapporto Wada e però riammesso dal
Tas e ieri in batteria con lui nei 100 stile. Per dire: con cruda schiettezza
australiana, Mack Horton, l'altro giorno ha vinto l'oro dei 400 davanti al
cinese misterioso e sospetto e "non stringo la mano a un ex dopato". O come il
caso Efimova, trovata positiva al meldonium e poi riammessa dal Tas e ieri notte
seconda tra i fischi e gli insulti nei 100 rana. E il morso di Phelps l'ha
accolta appena uscita dalla vasca: "Triste che i positivi siano stati
autorizzati a gareggiare di nuovo. Mi si spezza il cuore e mi fa letteralmente
incazzare". E il francese Lacourt sul cinese Sun Yang: "Ma se fa la pipì
viola...". Questo nel nuoto. L'atletica si prepara ad ugual cosa perché lo sport
più rappresentativo della rassegna a cinque stelle è anche e purtroppo il più
rappresentativo del doping. Per dire: Justin Gatlin velocista duro a invecchiare
e soprattutto duro a darsi per vinto dopo i malanni del doping, è l'uomo che più
di tutti, sulla carta e crono alla mano, può rendere difficile la vita a re
Usain Bolt. E non a caso il re, un giorno sì e l'altro pure, se ne esce con
frasi contro i dopati. Ieri ha detto "stiamo estirpando l'erba cattiva". Per cui
anche qui ci si chiede come atleti e spalti accoglieranno l'americano trovato
positivo due volte. Ugual cosa ci si domanda per Asafa Powell, anche lui finito
nelle maglie dell'antidoping per uso di stimolanti. E che dire di Sandra
Perkovic, fuoriclasse del disco, dopata nel 2011 e campionessa olimpica nel 2012
e oggi qui a difendere quella medaglia? O della cinese Li Yong che a Roma, tre
mesi fa, ha stravinto la 20 km di marcia e poi l'ha persa perché squalificata un
mese per positività e tutto è stato fatto di fretta ed eccola qui mentre
Schwazer si sta dannando l'anima per essere riammesso? Già, la triste e lunga e
logorante vicenda del marciatore. Ieri notte, appena usciti dall'interminabile
audizione con Alex davanti al Tribunale di arbitrato sportivo in trasferta a
Rio, i suoi legali hanno detto sconsolati "Alex proseguirà con gli allenamenti,
la sentenza verrà comunicata entro venerdì, termine massimo per consentirgli di
prendere parte alla 20 km di marcia". Il suo allenatore, Sandro Donati, si è
lasciato scappare un preoccupante "pronti a una sentenza già scritta". Gli
avvocati hanno comunque fornito tutte le evidenze a sostegno della tesi
difensiva: vizi di forma, la provetta etichettata con il nome del paese,
Racines, dove vive un solo atleta al mondo, cioè Alex, per cui diritto
all'anonimato violato. Quindi prove video che illustrano l'andamento ormonale
monitorato spontaneamente per mesi, anche nel periodo in questione (il test del
1 gennaio scorso). Il problema, visto lo spettro che s'aggira per l'olimpiade, è
però un altro. Comunque vada a finire, Alex ha perso. Perché se i giudici
confermeranno la decisione Iaaf, addio olimpiade e carriera. Dovessero invece
dargli ragione e riammetterlo in tempo utile per la 20 km e, soprattutto, per la
sua 50, andrà scortato mentre marcia. Il pubblico di Rio ha scelto: la squadra
degli ex dopati non ha bandiera e non ha casa.
Ricostruiti in un docufilm tutti i
misteri dell'incredibile marcia di Alex Schwazer. Un
instant movie firmato da Attilio Bolzoni e Massimo Cappello con la regia di
Alberto Mascia che contiene inedite intercettazioni telefoniche. Su tentativi di
pilotare gare internazionali di atletica e sui segreti del doping russo.
I signori del doping alla prova di una
vera inchiesta, scrive il 4 agosto 2016 Elisa
Marincola su "Articolo 21". Il docufilm pubblicato oggi sul sito di Repubblica
aiuta a capire meglio non solo la vicenda del marciatore Alex Schwazer, ma anche
il funzionamento, o non funzionamento, della macchina dell’antidoping nazionale
e mondiale. Che alla fine sembra ora rivedere anche i propri stessi risultati,
ridimensionati dal risultato pubblicato sempre oggi del test a sorpresa
sull’atleta effettuato lo scorso 22 giugno, che dimostra ancora una volta
l’assoluta assenza di sostanze nel suo fisico. Il ventesimo esame in poco più di
un anno, con uno solo, curiosamente, risultato positivo. La cronaca è nota ai
più, ci limitiamo a ricordare che Alex Schwazer era stato già sospeso per tre
anni e nove mesi complessivi dopo essere stato trovato positivo a un test alla
vigilia dei giochi di Londra. Colpa ammessa pubblicamente e scontata in silenzio
e in solitudine. Ma non del tutto abbandonato, perché presto accanto a lui si è
schierato una figura indiscussa dello sport pulito: l’allenatore Sandro Donati
che proprio per la sua inflessibile battaglia contro le pratiche di doping
diffuse molto oltre l’immaginabile ha sacrificato la sua carriera, messo
praticamente al bando da incarichi prestigiosi che pure proprio per le grandi
capacità tecniche avrebbe meritato. E proprio grazie al sostegno tecnico e umano
di Donati, Alex ha ripreso ad allenarsi fuori dai circuiti ufficiali che gli
erano vietati, ha ricostruito il suo fisico ma soprattutto la sua anima e la sua
autostima, sempre sotto stretto controllo del suo mister, che lo ha costretto a
marce forzate e analisi continue. Fino all’8 maggio, quando, finita la
squalifica, corre sui 50 km alla Coppa del mondo di Roma e vince
indiscutibilmente. E poi, all’improvviso, a un mese e mezzo da quella bella
medaglia d’oro, la rivelazione di quel famoso prelievo la mattina di capodanno,
con due risultati contrastanti usciti a distanza di mesi, con percorsi sospetti,
ma in tempo per fermare la sua partecipazione a Rio. Fino a far arrivare
avvertimenti che sanno anche di criminalità organizzata a Donati, tanto da
muovere la commissione parlamentare antimafia a convocarlo per raccogliere la
sua denuncia. Firmata da Attilio Bolzoni e Massimo Cappello (già autori insieme
del docufilm Silencio sulla mattanza di giornalisti in Messico), “Operazione
Schwazer. Le trame dei signori del doping” è un’inchiesta giornalistica che
rivela una serie di falle, incongruenze, intrecci d’interessi macroscopici nel
sistema dell’antidoping nazionale e mondiale, ma anche nella gestione occulta di
risultati di gara forse non sempre così limpidi e meritati. Non vogliamo dare
giudizi su settori e vicende che non conosciamo e su cui la magistratura
italiana ha da tempo aperto diversi fascicoli d’indagine. Notiamo semplicemente
che non sono serviti mesi e mesi di polemiche, inchieste interne alle autorità
sportive internazionali, scandali pubblici e privati, denunce e scontri persino
tra governi, a mettere in fila i pezzi di una realtà malata (se anche criminale
lo dimostreranno gli inquirenti) come è riuscito a fare in appena 20 minuti di
video un bel prodotto giornalistico realizzato praticamente a costo zero, con il
lavoro da inviato di Bolzoni, i rimborsi spese per trasferte e poco altro
coperti dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, e l’impegno a titolo
praticamente volontario dello stesso Massimo Cappello e del regista Alberto
Mascia e di quanti in questi mesi sono stati al fianco di Schwazer e di Donati e
da anni denunciano con loro la marea incontrastata del doping, che sta
avvelenando un mondo che per sua natura dovrebbe esaltare lo stato fisico più
sano. Sembra un ossimoro, ma lo sport, vissuto sotto i riflettori in ogni
momento della giornata e delle carriere di chi lo pratica soprattutto da
professionista, lussuosamente finanziato da sponsor che tutto sanno e nulla
dicono, raccontato fin nelle alcove da giornali, tv, siti web che pagano
miliardi di diritti per pochi secondi o anche solo per un solo scatto, si rivela
oggi forse la periferia più oscura e volutamente dimenticata, dai media, dalle
istituzioni internazionali, e anche dalla politica che tanto severa invece
appare verso chi si fuma in santa pace una cannetta senza far male a nessun
altro se non a se stesso (meno comunque dei milioni di fumatori di sigarette che
inquinano anche noi). Ora, dopo aver sentito le intercettazioni e visto
documentazioni e testimonianze messe in fila da Bolzoni e Cappello, resta da
chiedersi: i giudici sportivi che faranno? La Iaaf avrà qualcosa da dire? E
tutti quei colleghi di Schwazer pronti a crocifiggerlo? Senza voler giudicare
nessuno, ma qualche dubbio su intrecci di conflitti d’interesse e dossier già
noti da almeno tre anni (sempre ascoltando gli intercettati) e insabbiati fino
ad oggi dovrebbe averlo chiunque. L’udienza finale del Tas (il Tribunale
arbitrale sportivo) sul caso Schwazer, decisiva per la sua partecipazione alle
competizioni delle Olimpiadi di Rio, è ora spostata all’8 agosto nella città
brasiliana, ad appena quattro giorni dalla 20 km di marcia, prima gara a cui il
marciatore potrebbe partecipare se fosse riconosciuta la sua innocenza. Per chi
non lo sa, il ricorso di Schwazer ha un costo: 40mila euro tra spese legali,
controanalisi e viaggi. Naturalmente senza sponsor. Cercare la verità è cosa per
ricchi, ma né Alex e né il suo allenatore Sandro Donati lo sono.
Caso Schwazer: le intercettazioni delle
telefonate del giudice Maggio a Donati, scrive il
4/08/2016 Luca Landoni. Oggi è uscito l’atteso docufilm di Repubblica a cura
di Attilio Bolzoni. Una ricostruzione minuziosa del caso legato ad Alex
Schwazer a partire dalle irregolarità del modulo del controllo antidoping del 1°
gennaio 2016 (quello da cui risultò l’ultima positività) e che riportava la
scritta Racines (luogo di residenza di Schwazer, NdR) rendendolo di fatto non
anonimo, fino alle famose intercettazioni che per la prima volta possiamo anche
ascoltare. Potete vedere il docufilm in versione integrale subito sotto. Intanto
però vi trascriviamo il contenuto delle intercettazioni di quello che Donati
aveva definito “un giudice internazionale di marcia vicino al Damilano” e che da
oggi ha il nome che molti immaginavano ma non potevamo ancora mettere nero su
bianco per ovvi motivi: Nicola Maggio, già al centro di un caso clamoroso di
sospette decisioni secondo le accuse del collega Robert Bowman. Ecco il
testo. Telefonata Uno: ore 6 di mattina giorno della gara di Roma (7 maggio),
rintracciabile al minuto 7:30 del docufilm: «Buongiorno sono Maggio. Disturbo,
immagino, a quest’ora.Ieri sera stavamo qui alla cena con tutte le vecchie
glorie. Allora lei per cortesia stia calmo. L’unica cosa, la prego, glielo dica
ancora una volta (immaginiamo ci fosse stato un precedente contatto a voce, NdR)
fino a prima della gara, possibilmente lasci vincere Tallent, mi capisce?»
Telefonata Due, 23 maggio, 20 giorni prima della gara di La Coruna, minuto 8:38
del docufilm: “Gli dica di fare una gara bella tecnicamente, di non andare a
cercare disgrazie con i due cinesi che sono da 1 ora e 17 perché non ha senso”.
Dunque alla fine Donati i nomi li ha fatti. Passiamo ora alle intercettazioni
del dottor Giuseppe Fischetto, medico della Federazione Italiana, che parla “con
un amico”. Fischetto, grande accusato da Schwazer nel processo di Bolzano,
cionondimeno è stato responsabile antidoping alla Coppa del Mondo di Marcia di
Roma, e secondo le parole di Donati gestiva e aggiornava il database gigantesco
con tanti nomi dei russi, e sempre in Russia veniva inviato a svolgere una
grande quantità di missioni.
Ecco il testo. Telefonata Uno, 18 giugno 2013, ore
21:40, al minuto 10:55 del docufilm. Interlocutore un amico.
– Sono Giuseppe Fischetto, come stai?
– O Giuseppe ciao come stai?
– Un po’ incazzato con la giustizia, avrai sentito
che sono venuti a sequestrarci i computer, di tutto di più. Son venuti da me,
da Rita (Bottiglieri, NdR), prima a casa da Fiorella (l’altro medico al centro
del caso, NdR) sempre per la vicenda Schwazer. Hanno fatto un sequestro di tutto
il materiale informatico che abbiamo a casa e in Fidal alla ricerca dell’idea
che qualcuno possa aver sostenuto Schwazer
– Ma questo su iniziativa di chi, Giuse’?
-Del giudice di Bolzano, Va be’ so’ una rottura di
palle perché m’han tolto tutti gli hard disk e ci sono anche tante cose
confidenziali internazionali eh… che io spero non ci siano fughe di notizie
perché succede un casino internazionale: sai metti che vengon fuori dei dati dei
russi più che non dei turchi più che non degli altri, perché io sono nella
commissione mondiale, tu lo sai, della Iaaf.
L’ex procuratore capo di Bolzano Guido
Rispoli spiega che il database cui si accenna conteneva dati ematici sospetti di
molti atleti russi ed è stato poi usato come materiale probatorio centrale nelle
indagini seguenti che hanno portato ai noti fatti culminati nell’esclusione
paventata della Russia dai prossimi Giochi Olimpici.
Telefonata Due, 18 giugno 2013, minuto 13:32 del
docufilm, interlocutore Rita Bottiglieri:
GF: Ciao, ‘ndo stai?
RB: Sono a (?). Ora evidentemente la Procura di
Bolzano vuole cercare riscontri riguardo alle (ambizioni?) del marciatore.
GF: Io son preoccupato del materiale informatico
di tutta un’attività internazionale riservata, capito?
RB: E va be’, Giuseppe…
GF: Questo crucco comunque addamorì ammazzato,
devono incularsi la Kostner.
Da segnalare che nel video segue la telefonata del
giornalista Bolzoni a Fischetto che però non risponde dicendo di essere
all’estero. Gli si chiedeva se gli sembrava normale che lui fosse giudice nella
gara di Schwazer, dopo che il marciatore lo aveva accusato.
Telefonata Tre, 27 giugno 2013, minuto 15:15 del
docufilm, interlocutore un impiegato della Fidal:
GF: La sai l’Ultima? Ho appena chiuso il telefono,
sai chi ma ha chiamato? Lamine Diack (ex-Presidente della Iaaf che nel 2015
sarebbe stato arrestato per corruzione, NdR) dandomi il massimo supporto,
dicendomi di andare avanti.
Impiegato Fidal: Anche qui c’è la solidarietà di
tutti, di chiunque.
Donati chiosa: “E questo è l’ambiente da cui è
partito l’ordine di rifare il controllo antidoping a Schwazer.
"Forse non ci vedremo più" Schwazer
saluta l'allenatore. Dopo la squalifica a 8 anni, per
Alex Schwazer è il momento della riflessione. Il marciatore ha deciso di
lasciare Copacabana, scrive Claudio Torre, Venerdì 12/08/2016, su "Il Giornale".
Dopo la squalifica a 8 anni, per Alex Schwazer è il momento della riflessione.
Il marciatore ha deciso di lasciare Copacabana e di rientrare in Italia. Ma
dietro le spalle si lascia amarezza e quella sensazione di impotenza di chi
voleva gareggiare e adesso si ritrova a dover restare fermo e probabilmente a
rinunciare alla sua carriera. E così ha salutato il suo allenatore Sandro
Donati, l'uomo che lo aveva fatto rinascere. Lo ha guardato in aeroporto e gli
ha detto: "Mi sa che è l'ultima volte che ci vediamo...". Una frase che, forse,
più della sentenza del tas lascia intender quanto sia ormai definitiva la
decisione di Schwazer di mollare tutto. "Alex è cresciuto, saprà cosa fare", ha
affermato Donati. "Al momento - spiega Schwazer dopo il suo arrivo in Italia -
non ho ancora le idee chiare su cosa farò, fino a mercoledì speravo, perché sono
innocente. Ho dato tutto per essere qui sperando di gareggiare. Sinceramente non
pensavo alla conferma della squalifica. Adesso tornerò a casa e farò i miei
dovuti ragionamenti, ma è ancora presto".
Doping, Alex Schwazer sfida la paura del
vuoto: «Con Kathia cambio vita». Il marciatore dopo la
mega squalifica: «Non so cosa farò, ma lei è il mio esempio. Appena arrivato a
Vipiteno scalerò il passo Giovo in bici: non so stare fermo», scrive Marco
Bonarrigo il 11 agosto 2016 su “Il Corriere della Sera”. Il taxi per l’aeroporto
è arrivato, Alex no. È uscito presto a camminare sulla spiaggia di Copacabana,
quella dove mercoledì mattina ha svolto l’ultimo allenamento della carriera: 36
chilometri sotto il diluvio con Sandro Donati a ruota in bici. Dodici ore
dopo la sentenza di squalifica Alex Schwazer ha ancora occhiaie profonde e viso
scavato, ma è più sereno.
Come sta?
«Come uno che deve chiudere un capitolo della sua
vita in fretta per non farsi male. Non voglio scappare, devo cambiare. Spero di
essere capace».
Lei ha un precedente, una lunga squalifica per
doping. Non le ha indicato delle vie di uscita?
«È diverso. Nel 2012 è stato faticoso ma più
facile: ero colpevole, imbroglione, dopato. Mi sono salvato tornando nel mio
mondo, che adesso non esiste più. Ora sono una vittima. Dopo la positività ho
passato una settimana allucinante. Mi ha salvato la lotta per la verità che
abbiamo iniziato con Sandro Donati. Ma abbiamo perso. Lui continuerà a lottare,
con tutto il mio appoggio. Io devo cambiare vita. Subito».
Non era preparato? Come poteva pensare di
sconfiggere la federazione internazionale?
«Sono — anzi ero — un atleta, mica un avvocato.
Quando affronti una gara lo fa sempre per vincere, anche se hai poche speranze».
Cosa farà adesso?
«Non lo so. Durante la squalifica ho provato col
ristorante, gli anziani, l’università. Ho sempre fallito e mi spaventa fallire
ancora. Allenamento è massacrarsi di fatica per un obiettivo altissimo. La
maggior parte dei lavori è routine, allenamento di scarico. Non riesco a
immaginarlo».
Ci sarà un progetto che aveva in mente per il
fine carriera.
«Un lavoro nello sport. Ma mi viene da ridere: che
mestiere può fare un dopato nel mondo dello sport? Allena i ragazzi?».
Nel 2012 il doping le costò anche la fine del
rapporto con Carolina Kostner. Oggi al suo fianco c’è Kathia.
«In questi mesi di allenamento a Roma e poi in
queste settimane di angoscia lei è stata un riferimento fondamentale. È una
relazione importante, vorrei fosse quella della vita. Amore a parte, ammiro la
sua indipendenza: si è costruita un’attività e l’ha portata avanti da sola fin
da ragazza. Vorrei essere capace di fare così: inventarmi un mestiere normale
con l’entusiasmo che ci mette lei ogni mattina. Kathia non sa nulla di sport, di
controlli, di doping. Con Carolina era tutto in comune. Solo vivendo in mondi
diversi riesci a non impazzire».
Continuerà a marciare?
«Continuerò a correre e pedalare. Non posso stare
fermo, mi viene troppo da pensare. Quando Sandro mi ha detto che avevamo perso,
sono andato a camminare sulla spiaggia. Non sono scappato dalle telecamere, io
posso dominare i pensieri solo muovendomi. Marciare no: mai più, nemmeno per un
metro. La marcia non è libertà, ma controllo maniacale dei movimenti del corpo:
le gambe, le braccia, le spalle. La marcia è dolore e agonismo. Non sarò mai più
un marciatore».
Scrittori e intellettuali la sostengono, la
maggior parte dei suoi colleghi la odia.
«Non ricambio il loro odio, anzi lo capisco.
L’atletica è tutti contro tutti. Dare del dopato a un collega è il miglior modo
per giustificare che vai più piano di lui o sei meno popolare. Non odio Tamberi:
lui non sa chi sono, cosa ho vissuto. Non può capire, per lui e per gli altri
sono solo un dopato. Pazienza».
La prima cosa che farà arrivato in Italia?
«Prenderò un treno per Bolzano e il bus fino a
Vipiteno. Poi salirò in bici e scalerò il Passo Giovo».
Resterà a Vipiteno?
«È la mia terra, ci sono i miei genitori. Non
potrei mai lasciarla».
Guarderà le gare olimpiche di marcia?
«Le ho cancellate dalla mente».
Alex Schwazer è innocente (ma non ho le
prove). Dubbi, perplessità e qualche riflessione sulle
accuse che hanno portato alla squalifica del marciatore italiano, scrive
Gianluca Ferraris l'11 agosto 2016 su "Panorama".
Io so, ma non ho le prove.
Io so che Alex Schwazer è innocente.
Io so che Alex non prendeva più nemmeno
un’aspirina, terrorizzato com’era da qualsiasi traccia di farmaci nel suo
sangue.
Io so che Alex una notte ha urlato per un banale
ascesso, perché l’oppiaceo con cui noi comuni mortali sediamo il nostro mal di
denti lui non volle vederlo nemmeno da lontano.
Io so che Alex, dopo l’annuncio di voler tornare
in attività, ha passato indenne oltre 40 controlli, la maggior parte dei quali a
sorpresa.
Io so che non ha senso assumere «una lieve
quantità» di testosterone il 31 dicembre senza esserti dopato né prima né dopo,
e con il ritorno in pista lontano più di quattro mesi.
Io so che prelevare un campione di urina l’unico
giorno in cui i laboratori dell’antidoping sono chiusi (permettendo così a mani
ignote di trattenere la provetta con sé per 24 ore) è quantomeno strano.
Io so che mancano alcuni documenti di viaggio
della fialetta. E che quando questa ricompare in un laboratorio di Colonia,
invece di un codice numerico che dovrebbe rendere anonimo l’atleta, sopra c’è
scritto Racines, Italia. Maschio che gareggia su lunghe distanze, superiori a 3
km. A Racines ci sono 400 abitanti. E un solo marciatore.
Io so che il primo controllo su quella fialetta fu
negativo.
Io so che qualcuno, mesi dopo, suggerì al
laboratorio una seconda analisi, che risultò lievemente positiva.
Io so che la Wada, l’agenzia mondiale antidoping
che ha stanato Lance Armstrong e gli olimpionici russi, la più alta autorità del
pianeta in materia, non ha partecipato ai controlli e alle analisi su Alex,
interamente gestiti dalla Federazione internazionale di atletica.
Io so che i vertici vecchi e nuovi della
Federazione internazionale di atletica sono stati a lungo chiacchierati per aver
chiuso un occhio nei confronti dei tesserati russi, gli stessi che Alex e il suo
coach Sandro Donati hanno contribuito a denunciare.
Io so che Donati è un mago delle tabelle di
allenamento e un eroe della lotta al doping.
Io so che negli anni Novanta, quando Donati
scoperchiò il cosiddetto sistema Epo, due degli atleti che allenava furono
vittima di un caso di provette manipolate.
Io so che Alex, nonostante tre anni e mezzo di
lontananza dalle piste, marciava ancora più veloce di tutti.
Io so che alla vigilia di una gara a La Coruna
Donati ricevette pressioni perché Alex non infastidisse i marciatori cinesi
candidati alla vittoria.
Io so che Alex in quella gara arrivò secondo, e
che gli ispettori controllavano da vicino ogni suo passo per cogliere una
qualsiasi irregolarità stilistica che lo avrebbe fatto squalificare.
Io so che l’allenatore dei cinesi è Sandro
Damilano, fratello dell’ex marciatore Maurizio. E che prima della 50 chilometri
di Roma, lo scorso maggio, qualcuno a lui vicino chiese a Donati di «lasciare
vincere Tallent», l’atleta australiano che più aveva contestato il ritorno in
pista di Alex.
Io so che Liu Hong, altra marciatrice cinese
allenata da Damilano, dopo quella stessa gara fu trovata positiva
all’higenamine, un vasodilatatore naturale, ma venne squalificata solo per un
mese. Adesso lei è a Rio per gareggiare mentre Alex no.
Io so che subito dopo questa imbarazzante fila di
coincidenze saltò fuori la presunta positività di Alex. Che però gli venne
comunicata oltre un mese dopo, in piena preparazione preolimpica e con un
margine davvero ristretto per organizzare una difesa tecnico-legale decente.
Io so che non assistevo a una simile solerzia
investigativa, e a un simile tentativo di sobillare i media, dai tempi
dell’incendio del Reichstag o dell’arresto di Lee Harvey Oswald. O per restare
in ambito sportivo, da quel mattino cupo a Madonna di Campiglio che spezzò per
sempre la carriera di Marco Pantani.
Io so che colpire Pantani e Schwazer, sportivi
amati dal pubblico ma ragazzi fragili dentro, è facile. Troppo.
Io so che in molti avevano bisogno di punire in
maniera esemplare chi ha avuto il coraggio di sfidare il sistema. Quello stesso
sistema che poi si ripulisce la coscienza in favor di telecamera con il Refugee
Team e i palloni regalati alle favelas.
Io so che Alex si è pagato da solo la
preparazione, le divise, gli scarpini, il viaggio per Rio. Che ha finito i
risparmi e che ha lavorato come cameriere per mantenersi gli allenamenti. Che
dormiva in un tre stelle dietro al raccordo anulare e si faceva testare i tempi
su una pista comunale, accanto a runner della domenica e anziani che portavano a
passeggio il cane.
Io so che ha confessato i suoi errori del passato,
e li ha pagati tutti.
Io so che si stava rialzando senza chiedere aiuti
o riguardi, ma solo una seconda possibilità.
Io so che a Rio 2016 quella seconda possibilità è
stata data ad atleti dal curriculum sportivo molto più «stupefacente» del suo.
Io so che nessuno di quelli che contano, dal Coni
alla Fidal passando per i buonisti a gettone del mondo politico e degli
editoriali qualunquisti, ha ancora speso una parola se non di difesa almeno di
umana solidarietà per Alex.
Io so che Alex non ha la forza misurata per
disperarsi restando saggio. Come non la ebbe Pantani.
Io so che a Rio 2016 Alex sarebbe arrivato sul
podio nella 50 km e forse anche nella 20 km.
Io so che su quel podio Alex avrebbe pianto di
gioia. Che sarebbe stato disposto a dimenticare.
Io so che invece oggi piange di rabbia in un bar
fuori dal villaggio olimpico, come un emarginato. E che sarà condannato a
ricordare.
Io so che qualcuno dovrebbe vergognarsi per aver
rovinato una vita.
PRESUNTO COLPEVOLE. MARCO PANTANI.
Le Iene show. Puntata del 3 ottobre 2018, ore
21,00 in diretta Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, tra informazione ed
intrattenimento, tornano con lo storico programma di Italia 1, scrive Simone
Lucidi Mercoledì, 3 Ottobre 2018 su maridacaterini.it. Si parla della morte
di Marco Pantani. Ci sono molte incongruenze nella ricostruzione della scomparsa
del ciclista, prima tra tutte le pallina di cocaina presente per terra accanto
al cadavere. La madre di Pantani sostiene che sia stato ucciso. Già prima di
morire, Pantani aveva denunciato di essere stato incastrato e di non essersi mai
dopato. Qualcuno avrebbe scambiato o modificato le fialette di sangue
analizzate. La morte di Pantani fu archiviata come “overdose”, ma la stanza del
campione era totalmente in subbuglio. Cosa è successo davvero? La pallina di
cocaina e le varie dosi trovate nella stanza non erano presenti, secondo i
testimoni ascoltati, ma sono visibili nel filmato della polizia. Le cose erano
spostate, non lanciate. Persino il lavandino era stato smontato e posizionato
all’ingresso, mentre nel video risulta integro ed al suo posto. Pantani quel
giorno aveva telefonato alla reception dell’albergo per chiedere di chiamare
i carabinieri perchè c’erano “alcune persone che gli davano fastidio”. La
cocaina rilevata nel corpo di Pantani è 10-20 volte superiore rispetto alla dose
letale. Marco avrebbe dovuto mangiare diversi boli di droga o berli. Si sospetta
dunque che qualcuno gli abbia sciolto la cocaina nell’acqua senza che lui se ne
accorgesse. Secondo il medico intervistato dalle Iene il corpo sarebbe stato
spostato ed i segni e le ferite presenti in faccia, sulla schiena e sulle
braccia sarebbero stati provocati da qualcun altro. L’inviato Alessandro De
Giuseppe intervista Pietro Buccellato, usciere che aprì la porta della stanza di
Pantani con la forza e trovò il corpo. Anche lui conferma di non aver trovato la
pallina di cocaina e che il lavandino era stato divelto. C’era un secondo
ingresso nell’albergo e qualcuno poteva essersi introdotto ed essere andato via
da lì. Le telecamere non funzionavano e la porta era aperta ed agibile.
L’Ispettore di polizia, Daniele Laghi, interrogato non risponde. La scomparsa di
Pantani rimane avvolta nel mistero.
Marco Pantani, come è morto veramente?
Video Iene, infermiere 118: “Non c'erano tracce di cocaina”. Nella puntata de Le
Iene Show, Alessandro De Giuseppe si occupa della morte di Marco Pantani,
avvenuta la sera del 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini, scrive il 4
ottobre 2018 Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". A tredici anni dalla morte
di Marco Pantani restano i dubbi sull'ipotesi di suicidio accreditata dai vari
processi sul caso. Sono molti i punti oscuri della vicenda. A dare voce ai dubbi
della famiglia del ciclista è stato il programma “Le Iene” che ha intervistato
il titolare dell'albergo in cui Pantani è stato trovato morto, oltre a uno degli
operatori del 118 che per primi hanno trovato il corpo del campione di ciclismo
nella camera di albergo, Anselmo Torri. Quest'ultimo ad esempio ha smentito la
presenza di una pallina di cocaina che è presente nei filmati della polizia.
«Ero in servizio quella notte, ci hanno detto di un'urgenza. Abbiamo trovato
tutto in disordine, siamo saliti sul soppalco e abbiamo trovato il corpo di
Pantani riverso per terra. Abbiamo trovato dei farmaci, intorno al cadavere non
c'era niente, neppure la pallina di coca. Mi sono confrontato anche con i miei
colleghi». Nelle riprese della polizia ci sono tante tracce di cocaina, non
trovate invece dagli infermieri. I sanitari del 118 presenti quando fu trovato
il corpo affermano di non averla vista. Anche per questo la madre di Pantani
sostiene: «Marco è stato ucciso». Clicca qui per visualizzare il video del
servizio delle Iene sulla morte di Pantani. (agg. di Silvana Palazzo)
Marco Pantani e lo scandalo doping. Che cosa è
davvero avvenuto al campione di ciclismo, che ancora oggi occupa un posto
d'onore nel cuore degli italiani? Nel corso di questi numerosi anni di distanza
dalla sua morte, ancora si indaga su quanto avvenuto davvero quel giorno. I
familiari del Pirata non hanno mai creduto alla tesi di suicidio, individuata
invece dalle autorità nazionali. Secondo la famiglia ed alcuni amici infatti ci
sarebbero dei punti oscuri tutti ancora da chiarire. Lo scorso maggio infatti i
Pantani si sono rivolti all'avvocato Sabrina Rondinelli per fare luce sul caso,
per risalire a quanto avvenuto anche il 5 giugno del '99. Si tratta del
penultimo giorno del Giro d'Italia, data in cui il sangue di Pantani avrebbe
dimostrato la presenza di sostanze dopanti. Le Iene ripercorrono ancora una
volta il caso di Marco Pantani nella puntata in onda questa sera, mercoledì 3
ottobre 2018. Non si tratta della prima volta che il programma di Italia 1 si fa
carico della vicenda, dato che lo scorso maggio ha affrontato alcuni punti
chiave legati alla presunta positività del ciclista. Secondo l'ex massaggiatore
del campione, Roberto Pregnolato, la sera precedente alla tappa di Madonna di
Campiglio il valore dell'ematocrito di Pantani sarebbe stato di 48, ovvero due
punti al di sotto del valore massimo previsto dalla legge. "Uno che è primo in
classifica e viene controllato in ogni momento, si prepara in tempo se è fuori
norma, ma Marco non lo era", ha sottolineato infatti ai microfoni delle Iene.
Alcune ore più tardi invece il valore è schizzato fino a 53, ma a danneggiare
ulteriormente lo stato d'animo del Pirata è stato il processo in diretta subito
all'istante dai giornalisti, che lo avrebbero aspettato all'esterno dell'hotel.
La battaglia legale della famiglia Pantani. Il
sangue delle provette di Marco Pantani è stato alterato. Ne è convinta la
famiglia del ciclista, che a vent'anni di distanza dalla sua morte cerca ancora
di riabilitare il suo nome. Un'ipotesi confermata da Renato Vallanzasca, che ha
riferito alle autorità come la camorra avrebbe minacciato un medico perché
alterasse il test del sangue. L'avvocato Sabrina Rondinelli, incaricato
quest'anno di svolgere le pratiche per la riapertura del caso, ha infatti
sottolineato come in realtà la morte di Pantani risalga a Madonna di Campigno ed
all'anno 1999. Si parla di un decesso morale, dato che la scomparsa del Pirata è
avvenuta solo cinque anni più tardi. Secondo il legale tra l'altro all'epoca dei
fatti non sarebbero stati fatti gli accertamenti utili per appurare l'omicidio
volontario, mentre alcuni rilievi sulla scena del crimine escluderebbero
l'ipotesi di suicidio. Al centro delle indagini anche quel viaggio misterioso
proposto ai genitori di Marco Pantani, il giorno precedente al ritrovamento del
corpo del ciclista. "La nostra famiglia non si è mai fermata", afferma Tonina,
la mamma di Pantani, a Panorama. "Sono convinta che con l'avvocato Rondinelli
riusciremo, finalmente, a portare all'attenzione della magistratura le troppe
stranezze che circondano la morte di mio figlio", ha aggiunto.
GIALLO PANTANI: 200 ANOMALIE, IL J’ACCUSE
DI DE RENSIS. Scrive il 31 luglio 2016 Andrea
Cinquegrani su “La Voce delle Voci”. “Un caso che presenta almeno 200 anomalie,
la morte di Marco Pantani. Un’archiviazione costruita su macroscopiche
illogicità. Come credere alla storia dei poliziotti che mangiano un cono Algida
durante il sopralluogo e inconsapevolmente gettano la carta nel cestino? O dei
tre giubbotti che qualcuno ha a sua insaputa lasciato nel residence? Poi le
analisi di Marco a Madonna di Campiglio: come può un gip non trasferire gli atti
a Napoli quando ci sono le verbalizzazioni di camorristi che parlano
espressamente di corruzione per taroccare quelle provette? Ma si sa, la camorra
non corrompe, minaccia di morte…”. Un fiume in piena, l’avvocato Antonio De
Rensis, ai microfoni di Colors Radio per puntare l’indice contro un mare – è il
caso di dirlo – di anomalie nella tragica vicenda del campione, scippato di quel
Giro già stravinto nel 1999, per via delle scommesse di camorra che avevano
puntato una montagna di soldi sulla sua sconfitta (e quindi il Pirata “doveva
perdere”, a tutti i costi); e poi “suicidato” nel residence “Le Rose” di Rimini,
perchè, con ogni probabilità, dava fastidio, “non doveva parlare”, su quel mondo
nel quale non dettano legge solo le scommesse della malavita organizzata
(capace, a fine anni ’80, di “far perdere” uno scudetto già vinto al Napoli di
Maradona), ma anche quella del doping, come dimostra il fresco “caso Schwazer”,
con il suo manager, Sergio Donati, minacciato di morte per il timore che possa
alzare il sipario su colossali traffici e affari innominabili che costellano il
“dorato” mondo sportivo. E’ attesa in questi giorni – la previsione era per fine
luglio, prima settimana di agosto – la decisione del gip di Forlì circa il
destino dell’inchiesta sul giro d’Italia ’99 taroccato e la sconfitta del Pirata
decisa “a tavolino” dalla camorra per via dell’enorme giro di scommesse, come
hanno descritto prima Renato Vallanzasca, poi svariati “uomini di rispetto” dei
clan campani, a cominciare dal collaboratore di giustizia Augusto La Torre,
leader delle cosche di Mondragone abituate a grossi affari esteri (già ad inizio
anni ’90 investivano in alberghi e ristoranti scozzesi, epicentro Aberdeen: i
“deen don”, come scriveva già allora la stampa britannica) e in vena di
riciclaggi spinti. Il legale del pentito La Torre – che ha raccontato per filo e
per segno i colloqui con altri tre big boss – è Antonino Ingroia, l’ex
magistrato di punta del pool di Palermo, poi passato, con poca fortuna, in
politica (quindi avvocato e consulente per la Regione Sicilia targata Rosario
Crocetta). Una decisione, quella del gip di Forlì, che a non pochi addetti ai
lavori pare scontata: la trasmissione degli atti alla Direzione Distrettuale
Antimafia di Napoli per competenza, visto che sono in ballo i clan di camorra,
la regia del giro taroccato è made in Campania, non pochi boss hanno già
verbalizzato su quelle storie e ancora possono farlo (insieme ad altri
collaboratori). C’è tutto un bagaglio di conoscenze & competenze, quindi, alla
Dda di Napoli, per poter agire al meglio e far luce sul giallo Pantani.
Un’archiviazione “tombale”, a questo punto, suonerebbe non solo come una
schiaffo alla famiglia Pantani, ma a tutti gli italiani e a quel minimo di
Giustizia che – pur ridotta a brandelli – ancora esiste. E soprattutto affinchè
non venga un’altra volta calpestata, come è già capitato e continua a capitare
in tanti misteri e buchi neri della nostra “democrazia” altrettanto taroccata,
proprio al pari di quel maledetto Giro. L’intervista con l’avvocato Antonio De
Rensis, legale della famiglia Pantani, è stata rilasciata a Colors Radio,
l’emittente romana diretta da David Gramiccioli, in vita da un anno ma già con
indici d’ascolto molto elevati, con solo in Italia, ma anche all’estero.
Impegnata soprattutto sul fronte dei diritti civili, dei diritti spesso e
volentieri negati e calpestati nel nostro Paese, per dar voce a chi è in attesa
di giustizia, o di quella salute portata via dagli interessi di baronie e case
farmaceutiche. Uno stupendo spettacolo, diretto e interpretato da Gramiccioli,
“Vorrei avere un amico come Rino Gaetano”, dedicato alla musica e all’arte
civile di un artista al quale l’allora mainstream dichiarò guerra (in tutti i
sensi, fino ad ammutolirlo nel senso letterale del termine), è appena andato in
scena a Napoli, nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, altro avamposto che lotta non solo per la sua sopravvivenza, ma per
fare cultura nel deserto partenopeo, sempre più cloroformizzato dal neomelodismo
“arancione”. Uno spettacolo che seguendo il fil rouge di poteri, mafie &
massonerie, legava storie e misteri d’Italia, dal caso Montesi al giallo Moro,
passando per il Vajont, con una serie di rivelazioni da novanta, autentico
regalo per la memoria collettiva: una risorsa da coltivare come pianta sempre
più rara. Ecco, di seguito, l’intervista a De Rensis, che potete ascoltare
direttamente dal sito di Colors Radio, cliccando fra i programmi sulla
casella Voce on Air.
PARLA L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA PANTANI:
“Marco Pantani non era forse il più forte. Ma
certo il più amato, mai uno più di lui nella storia del ciclismo. Ogni
pomeriggio 10 milioni di italiani davanti alla tivvù a vedere il Giro o il Tour.
Forse ha cominciato ad essere un problema anche allora. Il ciclismo forse non
era abituato a digerire un fenomeno del genere. Paradossalmente anche questo può
essere stato un problema…”.
“Stiamo aspettando le decisioni del gip di Forlì,
per fine mese, primi di agosto. Ma è una vicenda che si descrive da sola, nel
suo percorso giudiziario”.
“Qui ci sono dichiarazioni scritte, nero su
bianco, in cui boss della camorra, come Augusto La Torre, citato da Roberto
Saviano nel suo Gomorra, dice espressamente che i medici incaricati delle
analisi, quella mattina, furono corrotti. Specifica, non minacciati, ma
corrotti. Come se non ci fosse intimidazione, quindi estorsione. Lo sanno tutti,
tu non puoi difenderti, dalle richieste della camorra, se non rischiando la
vita. La camorra vive di intimidazioni: o lo fai o ti ammazzo”.
“Queste carte, queste verbalizzazioni non sono le
uniche. C’erano anche quelle di Rosario Tolomelli, che fu intercettato,
dichiarazioni riportate anche in tivvù, e poi quelle di Renato Vallanzasca. E
adesso noi, di fronte a questi elementi così chiari, siamo in attesa di capire
se il procedimento potrà essere trasmesso alla Direzione Distrettuale Antimafia
di Napoli. Se il suo vicino di casa dice di lei appena un decimo di quello che è
stato detto, lei viene ovviamente indagato. Qui abbiamo un capoclan che dice che
chi ha fatto i controlli quella mattina a Madonna di Campiglio è stato corrotto,
e noi stiamo ancora a chiederci se dobbiamo archiviare o andare avanti! Io mi
chiedo, non tanto come avvocato quanto come cittadino: ma noi cittadini possiamo
andare avanti così?”.
“Ci sono dei camorristi che dicono questa roba?
Tu, Forlì, mandi le carte a Napoli e poi vediamo che cosa succede. Stiamo
scherzando? Ma si può sapere in che Stato viviamo? E’ proprio qui che la vicenda
di Pantani ci fa capire a che punto siamo arrivati. Fa capire che tutto ciò che
dovrebbe essere normale, da noi diventa difficile, quasi impossibile”.
“Domanda. Perchè? Perchè io ho dovuto leggere
nell’archiviazione per i fatti di Rimini (la “morte” di Marco nel residence “Le
Rose” di Rimini, ndr), nero su bianco, che un gip della procura dice ‘può darsi
che la carta del gelato Algida è stata gettata inconsapevolmente da un
poliziotto nel corso del sopralluogo’? Ma è possibile pensare che quel 14
febbraio il poliziotto fosse impegnato a mangiare un cornetto durante il
sopralluogo? Ecco, io mi chiedo: questa roba qui è normale?”.
“Possibile leggere, nell’archiviazione del gip,
‘può darsi che i tre giubbotti siano stati portati inconsapevolmente nel
residence dal marito della manager di Pantani’, il quale ha negato di aver mai
visto quei giubbotti in vita sua? E’ una roba normale? Siccome secondo me non lo
è, la vicenda Pantani si descrive da sola”.
“Quello che posso dire è una sorta di promessa che
ho fatto e che ora rinnovo. Io mi sento un uomo libero, non ho scheletri
nell’armadio, quel poco che ho fatto come avvocato me lo sono sudato, per questo
posso fare una promessa: che farò tutto quello che è umanamente possibile per
raggiungere la verità. Non ho poteri speciali perchè non solo un avvocato, ma
tutto quello che sarà possibile io lo farò. E sa perchè? Non perchè sono
fanaticamente convinto di avere ragione io. Ma perchè se mi si dice che facendo
l’ispezione il poliziotto ha buttato nel cestino la carta del gelato, allora
vuol dire che ho ragione io!”.
“Se mi avessero confutato con ragioni logiche, io
avrei detto a me stesso ‘amico mio, ti sei sbagliato'; ma se uno mi vuol
confutare dicendo che uno ha portato i giubbotti inconsapevolmente – come quelli
che pagavano le case a loro insaputa – che la carta gelato l’hanno buttata
inconsapevolmente nel cestino mentre facevano il sopralluogo, allora vuol dire
che ho ragione io! E vado avanti. Perchè quando una spiegazione non è logica, e
tale spiegazione viene data da una persona che deve per forza usare la logica
nel suo lavoro, vuol dire che le tue argomentazioni l’hanno messa in difficoltà.
Se lei mi mette in difficoltà e io le rispondo fischi per fiaschi… La questione
è tutta lì”.
“La gente è tutta con noi. Tutti ricordano Marco
con enorme affetto. Il ciclismo forse non era preparato per un impatto così
forte, una tale passione anche per chi non seguiva quello sport. E forse tutto
ciò ha creato problemi collaterali. Ci sono tante sfaccettature, nella vicenda
di Marco, che con ogni probabilità non lo hanno aiutato”.
“Ma chi lavora per la giustizia deve estraniarsi
da tutti questi condizionamenti ed esaminare esclusivamente i fatti. I fatti ci
dicono che verosimilmente quel giorno a Madonna di Campiglio le provette delle
analisi vennero alterate. E che nella vicenda della morte di Marco a Rimini
molti fatti devono ancora essere approfonditi”.
“Probabilmente quella mattina nel residence la
situazione è sfuggita di mano a quelli che erano con Pantani. Non mi voglio
addentrare ora in dettagli, ma può darsi che l’evento morte non fosse previsto.
Ma l’intera vicenda giudiziaria è stracolma di anomalie. Una per tutte. Alle 10
e 30 Marco telefona alla reception e dice ‘in camera ci sono delle persone che
mi danno fastidio, per favore chiamate i carabinieri’. Che poi arrivano alle 20
e 30. Mi chiedo: se io vado in un qualunque albergo a Roma, telefono alla
reception e chiedo l’intervento dei carabinieri, scommetto che arrivano prima
delle 20 e 30!”. “Questa è solo una delle oltre 200 anomalie del caso Pantani”.
“Le risposte a tutti i quesiti? Sono solo e unicamente nei fatti”.
5 GIUGNO 1999. Pantani e il
mistero di Campiglio.
L’Antimafia sentirà i pm di Forlì. Una commissione d’inchiesta
sul Giro 1999? Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare: «Sentiremo
i magistrati e faremo le nostre valutazioni». Il procuratore Sottani: al
corridore «minacce credibili», scrive Alessandro Fulloni il 31 marzo 2016 su "Il
Corriere della Sera". «Pantani è un simbolo dello sport italiano che merita
verità e giustizia. Sentiremo i magistrati di Forlì e faremo le nostre
valutazioni. Del resto si sa che le mafie hanno sempre avuto grande interesse
per il mondo dello sport e la gran mole di denaro che ruota intorno alle
scommesse clandestine». Non si sbilancia, la presidente della commissione
parlamentare Antimafia Rosy Bindi: ma non è improbabile né lontano il via a una
commissione d’inchiesta mirata a fare luce su ciò che accadde il 5 giugno 1999 a
Madonna di Campiglio, quando Marco Pantani venne fermato prima del via della
tappa del Giro perché trovato con un ematocrito più alto di quello consentito.
Che la camorra lo abbia stoppato, con «reiterate condotte minacciose e
intimidatorie» nei confronti «di svariati soggetti a vario titolo coinvolti
nella vicenda del prelievo ematico» del corridore, è uno scenario che al
procuratore di Forlì Sergio Sottani e al pm Lucia Spirito che hanno coordinato
l’inchiesta -la seconda, avviata nel settembre 2014 dopo che una prima era stata
archiviata a Trento nel 2001 - «appare credibile». Ma il movente di queste
minacce resta «avvolto nel mistero, anche se qualche squarcio, nonostante il
tempo trascorso, si intravede». «Tuttavia gli elementi acquisiti non sono idonei
a identificare gli autori dei reati ipotizzati». Quelli di truffa ed estorsione
e non la corruzione - di cui ha parlato un pentito - cancellata dalla mannaia
della prescrizione che ha indotto la procura a chiedere l’archiviazione di un
procedimento pur condotto con scrupolo dai due pm, dal loro nucleo di polizia
giudiziaria e dai carabinieri della tutela della salute di Roma. A stabilire che
destino avrà l’inchiesta - i cui atti sono stati trasmessi da Sottani alla
Direzione distrettuale antimafia di Bologna - sarà la decisione, attesa a
giorni, del gip di Forlì Monica Calassi. Che potrebbe percorrere tre strade:
accogliere la richiesta d’archiviazione, fissare un’udienza per la raccolta di
nuovi elementi, o chiedere un’indagine della Procura antimafia. Intervento,
questo, rilanciato dalle novità investigative presenti nelle carte firmate da
Sottani. Su tutte, le dichiarazioni di un pentito di camorra, Augusto La Torre,
in passato braccio destro di «mammasantissima» campani come Antonio Bardellino,
prima, e Francesco «Sandokan» Schiavone, poi. Agli inquirenti il collaboratore
di giustizia racconta di una conversazione avuta nel carcere di Secondigliano
con altri capi clan detenuti al 41 bis, vale a dire il carcere duro. Il pentito
parla del caso Pantani - ma non ricorda se prima o dopo i fatti di Campiglio -
con Francesco Bidognetti (al vertice dei Casalesi), Angelo Moccia (a capo
dell’omonimo clan di Afragola) e Luigi Vollero (detto il Califfo, numero uno a
Portici). Dal terzetto arriva la conferma che Pantani è stato fatto fuori dal
Giro per volere dei clan operanti su Napoli. Punta il dito sui Mallardo di
Giugliano: solo loro «possono averlo fatto. I tre mi dissero che il banco, se
Pantani vinceva, saltava e la camorra avrebbe dovuto pagare diversi miliardi in
scommesse clandestine. Come quando si verificò con Maradona e il Napoli degli
anni Ottanta». La Torre ricorda quella sua delusione dopo la squalifica al Giro:
ma come, pure lui «aveva preso la bumbazza»... E gli altri, di rimando: «Ma
quale bumbazza e bumbazza... L’hanno fatto fuori sennò buttava in mezzo alla via
quelli che gestivano le scommesse...». A verbale usa peraltro parole che
avvicinano chirurgicamente la prescrizione: «Escludo nella maniera più assoluta
che i medici siano stati minacciati: si tratta unicamente di corruzione». In
quelle carte (leggi il documento della procura di Forlì) c’è pure quanto
ribadito da Rosario Tomaselli, affiliato ai clan recluso nel 1999 a Novara con
Renato Vallanzasca - il primo a parlare di interessi della camorra sul Giro -
che al telefono con la figlia, senza sapere di essere intercettato nell’ambito
di un’altra indagine dei carabinieri di Napoli, sostiene che «la camorra ha
fatto perdere il Giro a Pantani, cambiando le provette e facendolo risultare
dopato». E quando la ragazza insiste - «ma è vera questa cosa?» - lui ribadisce:
«Sì, sì, sì, sì, sì». Un sì categorico, ripetuto cinque volte. Quanto al
prelievo ematico vero e proprio, i carabinieri del Nas parlano, in
un’informativa, di condotta «tutt’altro che trasparente e lineare» dei tre
medici che fecero l’accertamento. Non ci sono solo quelle discrepanze sugli
orari i cui tempi renderebbero possibile - sono le tesi degli ematologi
ascoltati dagli investigatori - l’alterazione dei risultati. Piuttosto, quelle
parole sono motivate dal fatto che gli investigatori hanno accertato la
presenza, nella stanzetta in cui venne fatto il prelievo, di una quarta persona,
il responsabile del team medico: l’olandese Wim Jeremiasse, commissario Uci e
istituzione al Tour, alla Vuelta e alla corsa rosa. Che l’olandese facesse parte
del gruppo - circostanza mai emersa nella prima indagine su Campiglio - lo
rivela il suo autista, Simone Cantù, mai sentito prima del 2014. Ma i tre medici
ascoltati dagli investigatori e direttamente coinvolti nel prelievo o non
ricordano la sua presenza o addirittura non lo conoscono. Circostanza che
insospettisce i carabinieri. Che chiedono al gip di intercettarli in vista
dell’interrogatorio. Richiesta però bocciata dal gip che «non ravvisa la
sussistenza dei gravi indizi» del reato su cui si indaga: appunto l’estorsione.
Ma torniamo al 5 giugno. Ore 9 e 15. Cantù avvicina l’olandese nella hall
dell’hotel in cui sonno stati fatti i prelievi per ricordargli l’imminente avvio
della tappa. Jeremiasse si volta in lacrime: «... oggi il ciclismo è morto...».
E poi prosegue: «Marco Pantani ha valori non regolari». Impossibile che il
commissario Uci possa spiegare altro: sei mesi dopo morirà - «in circostanze non
proprio chiare», scrivono i carabinieri - in un incidente in Austria. Dov’era
andato per fare da giudice in una gara di pattinatori su ghiaccio. Sprofondò con
l’auto in un lago ghiacciato, il Weissensee, su cui stava spostandosi alla testa
di un piccolo corteo di macchine. La sua auto giù per 35 metri nell’acqua
gelida, inghiottita dal cedimento improvviso della superficie: Wim venne trovato
cadavere dai sommozzatori che lo recuperarono circa un’ora dopo. La donna che
era con lui, Rommy van der Wal, sopravvisse miracolosamente dopo avere cercato
invano di estrarlo dall’abitacolo. Nel frattempo sono le Camere a interessarsi
di ciò che accadde a Madonna di Campiglio. Se l’approfondimento parlamentare
dovesse decollare, avrebbe certo un passo differente da quello giudiziario. «È
opportuno che venga chiarito se, effettivamente, le indagini devono fermarsi per
la prescrizione oppure se ci sia modo di appurare i fatti anche a distanza di
tanti anni. Se la magistratura non può andare avanti, è opportuno - riflette
Ernesto Magorno, deputato Pd - che il parlamento verifichi l’esistenza di altri
percorsi giudiziari da seguire». «Altrettanto inquietante è il ruolo della
criminalità organizzata - osserva un altro parlamentare pd, Tiziano Arlotti -
che emergerebbe nell’ambito delle scommesse sportive: un quadro già confermato
in molte altre inchieste, che però merita di essere approfondito dalla
commissione». Daniela Sbrollini, responsabile nazionale Sport del Pd, incalza:
«bisogna fare di tutto perché emerga la verità». Non sono solo queste
sollecitazioni ad aver indotto Bindi a chiedere l’audizione dei pm forlivesi: la
presidente dell’Antimafia da tempo sta pensando ad approfondimenti su sport,
criminalità organizzata e doping. Intrecci attorno ai quali ruota, appunto, «una
gran mole di denaro». A opporsi all’archiviazione è Tonina Pantani, la mamma del
Pirata. Che attraverso Antonio De Rensis, il battagliero legale della famiglia,
ha depositato l’opposizione alla richiesta della procura di Forlì. Lo stesso
atto che pende davanti al gip di Rimini, chiamato a decidere sul destino
dell’indagine bis sulla morte del vincitore di Giro e Tour 1998: archiviazione o
supplemento di indagini.
Pantani, il caso doping e
il mistero dei valori del sangue. Al di là dell’ipotetico complotto, una
certezza: per 10 anni i dati del corridore presentano anomalie,
scrive Marco Bonarrigo il 29 marzo 2016 su "Il Corriere della Sera". La parola
fine a quel romanzo tragico che è la vita di Marco Pantani è questione di
giorni. I tribunali di Rimini e Forlì stanno per archiviare (su richiesta dei
piemme) le inchieste sugli episodi chiave della vicenda del ciclista: la morte
(14 febbraio 2004) e l’espulsione dal Giro d’Italia del 5 giugno 1999. E se il
procuratore di Rimini Giovagnoli non ha dubbi (overdose di cocaina), quello di
Forlì Sottani si arrende a un «movente avvolto nel mistero con elementi
acquisiti non idonei a identificare eventuali colpevoli». Ma ritiene «credibile»
che qualcuno abbia minacciato chi eseguì il controllo del sangue di Campiglio
inducendolo a truccare le provette per incassare i soldi delle scommesse. Questo
qualcuno sarebbe la Camorra. Nelle 30 pagine di motivazioni l’ipotesi è
costruita da alcuni ex fedelissimi del Pirata (massaggiatore, fisioterapista),
da due tifosi che avevano orecchiato minacce in una pizzeria, da Renato
Vallanzasca e da quattro camorristi piuttosto confusi. Quanto basta però a
risollevare l’eterna ipotesi del complotto. Intanto dagli archivi dei tribunali
di Trento e Forlì escono i faldoni dei due processi penali subiti dal Pirata:
per l’ematocrito alto alla Milano-Torino e per Madonna di Campiglio. In entrambi
i casi Marco fu assolto in appello perché il reato ipotizzato (frode sportiva)
non era sostenibile. Ma le carte dimostrano come il sangue di Pantani sia stato
un profondo, costante mistero in 10 anni di carriera. Lo dicono i file
dell’Università di Ferrara (dominus Francesco Conconi) dove Pantani si recò
regolarmente dal 1992 al 1996. Conservati a suo nome o con curiosi pseudonimi
(Panzani, Panti, Ponti, Padovani...) mostrano oscillazioni impressionanti:
l’ematocrito passava dal 41-42% al 52-56% con una coincidenza perfetta tra
qualità dei risultati ottenuti e valori alti. E quando Pantani viene ricoverato
alle Molinette dopo lo spaventoso incidente alla Milano-Torino, il suo 60,1%,
fisiologicamente inspiegabile per i periti, costringe i medici a somministrargli
litri di diluente per scongiurare una trombosi. Del controllo di Campiglio ora a
tutti vengono in mente dettagli inediti. Ma, interrogato dagli inquirenti, il
medico di Pantani, Roberto Rempi, ammise che l’atleta si controllava da solo il
sangue, che l’ematocrito la sera prima era altissimo (tra 48 e 49) e Marco
totalmente fuori controllo dal punto di vista sanitario. Su Campiglio rispunta
l’accurata e documentata perizia dell’Università di Parma: il Dna del sangue era
di Pantani, il diluente nella provetta non ebbe effetto sul risultato mentre
«l’assunzione esogena di eritropoietina artificiale» spiegava «virtualmente i
parametri modificati nel campione di sangue 11.440». A completare il quadro,
ecco la lettera «personale e non protocollata» che nel settembre 2000 Pasquale
Bellotti, responsabile Commissione Scientifica Antidoping, inviò al segretario
generale del Coni e alla Federciclismo alla vigilia dei Giochi di Sydney, dove
Pantani fu convocato a dispetto di una salute non buona e di un percorso
inadatto. Scriveva Bellotti: «Il quadro ematologico di Pantani, verificato ieri
a Salice Terme, è estremamente preoccupante. Il regolamento attuale non ci
consente di bloccarlo, ma 3 dei 5 parametri sono fortemente alterati e pongono a
rischio la sua salute». Pantani aveva ematocrito al 49% e ferritina da malato:
1.019 ng/mL. La federazione rispose affermando che l’atleta aveva superato tutti
i controlli antidoping. Il Coni, risentito, invitò Bellotti a occuparsi di
altro. Marco Pantani, lui, mentalmente era forse già un ex atleta.
Campiglio 1999, la svolta. Il p.m.: “La
camorra fermò Pantani? E’ credibile”, scrive Luca
Gialanella il 14 marzo 2016 su “La Gazzetta.it" Confermate le anticipazioni,
dalle parole di Vallanzasca in poi: fu un clan camorristico a intervenire per
arrivare all’alterazione del controllo del sangue del Pirata la mattina del 5
giugno 1999. E’ tutto scritto nelle pagine dell’inchiesta della Procura di
Forlì, che l’ha chiusa con la richiesta di archiviazione: gli autori dei reati
non possono essere identificati. Ma la storia dello sport? Una
“cimice” nell’abitazione di un camorrista, le indagini della polizia giudiziaria
della Procura della Repubblica di Forlì, guidata dal procuratore Sergio Sottani.
Le intercettazioni ambientali e finalmente i riscontri, nomi e cognomi, che
svelano, secondo la ricostruzione degli inquirenti, quanto avvenne la mattina
del 5 giugno 1999 nell’hotel Touring di Madonna di Campiglio, alla vigilia della
penultima tappa con Gavia, Mortirolo e arrivo all’Aprica. Il controllo del
livello di ematocrito di Marco Pantani in maglia rosa. L’esclusione del Pirata
dal Giro d’Italia per ematocrito alto, 51,9% contro il 50% consentito allora
dalle norme dell’Uci, la federciclismo mondiale. L’inizio della fine sportiva e
umana dello scalatore di Cesenatico. “Un clan camorristico intervenne per far
alterare il test e far risultare Pantani fuori norma”: è l’ipotesi che segue il
pm di Forlì. Parole che in questi anni avevamo sentito più volte, dalla famosa
frase del bandito Renato Vallanzasca in carcere (“Un membro di un clan
camorristico in carcere mi consigliò fin dalle prime tappe di puntare tutti i
soldi che avevo sulla vittoria dei rivali di Pantani. ‘Non so come, ma il
pelatino non arriva a Milano. Fidati’) al lavoro di indagine della Procura di
Forlì, che il 16 ottobre 2014 riaprì l’inchiesta sull’esclusione di Pantani da
Campiglio con l’ipotesi di reato “associazione per delinquere finalizzata a
frode e truffa sportiva”. Indagine già svolta nel 1999 a Trento dal pm Giardina,
e archiviata. Scommesse contro Pantani, scommesse miliardarie (in lire) che la
camorra non poteva perdere. Da qui il piano di alterare il controllo del sangue.
La Procura di Forlì ha ricostruito tutti i passaggi, ha sentito decine di
persone, in carcere e fuori. Ha avuto la prova-regina da cui partire, con
l’intercettazione ambientale di un affiliato a un clan che per cinque volte
ripete la parola “sì”, alla domanda se il test fosse stato alterato. Ma i
magistrati sono andati oltre, hanno ricostruito la catena di comando, sono
arrivati ai livelli più alti dell’associazione criminale. “Sono emersi elementi
dai quali appare credibile che reiterate condotte minacciose ed intimidatorie
siano state effettivamente poste in essere nel corso degli anni e nei confronti
di svariati soggetti che, a vario titolo, sono stati coinvolti nella vicenda del
prelievo ematico”, scrive il pm Sottani. “Tuttavia gli elementi acquisiti non
sono idonei ad identificare gli autori dei reati ipotizzati”. Ecco la richiesta
di archiviazione. Eppure forse uno dei più grandi misteri dello sport mondiale
ha trovato una verità, almeno parziale. A distanza di 17 anni. E i legali della
famiglia Pantani stanno lavorando per capire se possano esserci spiragli per
qualche azione in campo civile e sportivo.
"Fu la Camorra a far perdere il Giro a
Pantani". Esclusiva di Davide Dezan per Premium Sport
del 14 Marzo 2016. Un detenuto vicino alla Camorra e a Vallanzasca, una
telefonata intercettata e l'indiscrezione esclusiva raccolta per Premium Sport
dal nostro Davide Dezan. Sono i nuovi ingredienti del "caso Pantani" e di
quanto, mano a mano, sta uscendo sul Giro perso dal Pirata nel '99, quando fu
fermato per doping a Madonna di Campiglio. Riportiamo qui sotto il testo
dell'intercettazione. L’uomo intercettato è lo stesso che, secondo Renato
Vallanzasca, confidò in prigione al criminale milanese quale sarebbe stato
l’esito del Giro d’Italia del ’99, ovvero che Pantani, che fino a quel momento
era stato dominatore assoluto, non avrebbe finito la corsa. Dopo le
dichiarazioni di Vallanzasca, e grazie al lavoro della Procura di Forlì e di
quella di Napoli, l’uomo è stato identificato e interrogato e subito dopo ha
telefonato a un parente. Telefonata che la Procura ha intercettato e che Premium
Sport diffonde oggi per la prima volta, in esclusiva assoluta.
Uomo: “Mi hanno interrogato sulla morte di
Pantani.”
Parente: “Noooo!!! Va buò, e che c’entri tu?”
U: “E che c’azzecca. Allora, Vallanzasca ha fatto
delle dichiarazioni.”
P: “Noooo.”
U: “All’epoca dei fatti, nel ’99, loro (i
Carabinieri, ndr) sono andati a prendere la lista di tutti i napoletani che
erano...”
P: “In galera.”
U: “Insieme a Vallanzasca. E mi hanno trovato pure
a me. Io gli davo a mangià. Nel senso che, non è che gli davo da mangiare: io
gli preparavo da mangiare tutti i giorni perché è una persona che merita. È da
tanti anni in galera, mangiavamo assieme, facevamo società insieme.”
P: “E che c’entrava Vallanzasca con sto Pantani?”
U: “Vallanzasca poche sere fa ha fatto delle
dichiarazioni.”
P: “Una dichiarazione...”
U: “Dicendo che un camorrista di grosso calibro
gli avrebbe detto: ‘Guarda che il Giro d’Italia non lo vince Pantani, non arriva
alla fine. Perché sbanca tutte ‘e cose perché si sono giocati tutti quanti a
isso. E quindi praticamente la Camorra ha fatto perdere il Giro a Pantani.
Cambiando le provette e facendolo risultare dopato. Questa cosa ci tiene a
saperla anche la mamma.”
P: “Ma è vera questa cosa?”
U: “Sì, sì, sì… sì, sì.”
Tonina Pantani: «È stata ridata la
dignità a Marco». La madre parla dell'intercettazione
secondo la quale la Camorra avrebbe fatto risultare positivo il ciclista di
Cesenatico al controllo antidoping: «Finalmente tutti sapranno che l’avevano
fregato», scrive “Tutto Sport” lunedì 14 marzo 2016. «Non mi ridanno Marco,
logicamente, ma penso gli ridiano la dignità, anche se per me non l’ha mai
persa». Tonina Pantani parla dell'intercettazione di un detenuto che sostiene
che la Camorra abbia fatto perdere il giro al figlio, Marco. «Le parole di
questa intercettazione fanno male, è una conferma di quello che ha sempre detto
Marco, cioè che l’avevano fregato. Io mio figlio lo conoscevo molto bene: Marco,
se non era a posto quella mattina, faceva come tutti gli altri. Si sarebbe preso
quei 15 giorni a casa e poi sarebbe rientrato, calmo. Però non l’ha mai
accettato, non l’ha mai accettato perché non era vero. Finalmente la gente ora
potrà dirlo, anche se tanta gente sapeva che l’avevano fregato. Io sono molto
serena oggi: finalmente sono riuscita e sono riusciti a trovare queste cose».
Legale famiglia Pantani: «A Madonna di
Campiglio non doveva essere fermato». Antonio De
Rensis, legale della famiglia del ciclista di Cesenatico: «Noi speriamo anche
che si giunga a delle responsabilità ma in ogni caso ritengo che la storia di
quella mattina verrà ridisegnata». Scrive “Tutto Sport” martedì 26 gennaio 2016.
Marco Pantani a Madonna di Campiglio, al Giro d'Italia, nel giugno del 1999, non
doveva essere fermato. Lo ribadisce l'avvocato Antonio De Rensis, legale della
famiglia del ciclista di Cesenatico, in una intervista andata in onda stamane
durante la trasmissione Rai della Tgr Emilia-Romagna 'Buon Giorno
Regione'. "Credo - sottolinea il legale - che siano emersi dei fatti che in ogni
caso disegnano gli avvenimenti di quel giorno a Campiglio in maniera diversa.
Ricordo che Marco nel pomeriggio tornando a casa si fermò all'Ospedale Civile di
Imola. L'ematocrito era tornato a 48.2 ma soprattutto le piastrine che a
Campiglio (dove il pirata venne sottoposto ad un controllo Uci, ndr) erano
100.000, all'Ospedale di Imola erano 170.000. I due esami sono totalmente
incompatibili, dobbiamo solo capire se è più attendibile quello fatto in una
stanzetta di un hotel a Campiglio o in un Ospedale Civile della Repubblica
italiana". La Procura di Forlì sta ancora indagando su quello che è accaduto a
Madonna di Campiglio, indagine della quale anche la Direzione distrettuale
antimafia di Bologna si occupa per la presunta interferenza della Camorra e di
un giro illegale di scommesse nell'esclusione di Marco Pantani nel Giro
d'Italia. "Credo anche con grandissimo impegno - sottolinea De Rensis - lo dico
da spettatore esterno. La sensazione che noi abbiamo sempre avuto quando abbiamo
colloquiato con il Procuratore Capo e il Sostituto, è stata sempre quella di
essere ascoltati, non siamo mai stati un elemento di fastidio per loro e questo
ci ha dato una grande soddisfazione". Da questa indagine ribadisce l'avvocato
della famiglia Pantani "noi ci aspettiamo che il Procuratore Capo e il Sostituto
con il loro lavoro intenso e molto serio, ridisegnino i fatti. Noi speriamo
anche che si giunga a delle responsabilità ma in ogni caso ritengo che la storia
di quella mattina verrà ridisegnata perché Marco Pantani, noi sosteniamo e ne
siamo fermamente convinti, non doveva essere fermato". Nel filone di indagini
che riguarda la Procura di Rimini sulla morte di Marco Pantani, riaperto un anno
e mezzo fa, il legale della famiglia Antonio De Rensis, nell'intervista Rai
ribadisce che "l'indagine non è chiusa, anzi - aggiunge - devo dire che dopo la
richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero sulla quale deciderà il
Giudice delle indagini preliminari, che dovrà fissare un'udienza, abbiamo avuto
ancora più conforto, perché leggendo le carte di quell'indagine abbiamo capito
che forse abbiamo ragione noi". Sul caso, il legale ha ricordato che "non
soltanto qualche giorno dopo la riapertura, il Pubblico Ministero incaricato si
è chiamato fuori (il 9 settembre ha chiesto di astenersi da quell'indagine) ma
anche il Gip che era stato nominato per decidere sulla richiesta di
archiviazione, ha chiesto di astenersi per cui adesso è stato nominato un altro
Gip che mi risulta essere arrivato a Rimini da poco e che speriamo abbia la
forza di fare chiarezza su questa indagine che ha decine di punti da chiarire:
uno per tutti, ricordo che il consulente del Pubblico Ministero ha detto nella
sua relazione, ma addirittura anche a un quotidiano nazionale, che le sue
conclusioni potrebbero essere completamente smentite facendo ulteriori esami e
dice anche quali, e che si può fare molto di più. Davanti a queste cose faccio
fatica a pensare che si possa archiviare questa indagine". "Ho molta fiducia
nelle indagini - ha concluso De Rensis riferendosi a entrambi i filoni di
indagini - in particolar modo ho grande fiducia sul fatto che la Procura di
Forlì possa ridisegnare gli avvenimenti di quella mattina".
Caso Pantani, il legale: «Ora assegnino a
Marco il Giro d’Italia 1999». L’avvocato Antonio De
Rensis: «Ci opporremo alla richiesta di archiviazione e cercheremo di agire
anche in funzione di una riscrittura della storia di quel Giro», scrive “Tutto
sport” martedì 15 marzo 2016. Come l'inchiesta riaperta sulla sua morte a dieci
anni di distanza, anche quella sulla fine sportiva di Marco Pantani si è
conclusa con una richiesta di archiviazione. Come i colleghi di Rimini, i Pm di
Forlì hanno definito gli accertamenti ritenendo di non aver elementi per
sostenere un processo. L'ombra di un intervento della camorra sul Giro d'Italia
del 1999 è rimasta tale, un sospetto, forse anche credibile, ma non
percorribile, né perseguibile penalmente. Come avvenuto a Rimini, anche a Forlì
la famiglia potrà opporsi alla decisione, che spetterà infine ad un Gip.
L'inchiesta bis sul complotto nella corsa rosa era nata dall'idea che Pantani il
5 giugno a Madonna di Campiglio fosse stato incastrato dalla criminalità
organizzata: bisognava, secondo questa ipotesi, eliminare chi stava dominando il
Giro e per farlo si sarebbe alterato il valore dell'ematocrito nel sangue del
ciclista di Cesenatico, favorito nelle puntate degli scommettitori. E' su questo
che ha insistito l'avvocato Antonio De Rensis, il legale della madre di Pantani,
Tonina Belletti. Ha ottenuto prima la riapertura in Romagna dell'indagine
archiviata dalla Procura di Trento, quindi che della vicenda si interessasse
anche la Dda di Bologna con il Pm Enrico Cieri, tenuto informato periodicamente
dai magistrati forlivesi, il capo Sergio Sottani e la sostituta Lucia Spirito,
sugli sviluppi degli accertamenti. E' lo stesso legale a spiegare che i Pm hanno
"sì ritenuto credibile" che ci sia stata un'alterazione dei test, "ma forse non
si può andare oltre". Risultato, richiesta di archiviazione nel merito, conferma
il legale. Sul punto la procura non ha fatto commenti. A quanto si è appreso,
nell'atto si farebbe riferimento ai reati di estorsione e minacce a carico di
ignoti e di questi però non è stato possibile individuare gli eventuali
responsabili e pertanto se ne è chiesta l'archiviazione, nel merito. La procura
nella richiesta aggiunge che, rispetto ad altri reati teoricamente ipotizzabili,
essi sarebbero comunque prescritti. Nell'indagine sono state sentite varie
persone, tra cui la mamma del Pirata, giornalisti e medici. Uno snodo poteva
arrivare a ottobre 2014, quando fu convocato Renato Vallanzasca. Agli inquirenti
l'ex 'bel René' riferì che nel 1999 fu avvicinato in carcere da un esponente
della camorra che, visto il ruolo di prestigio di Vallanzasca all'interno della
mala italiana, era desideroso di fargli un 'regalo', e cioè di non farlo
scommettere, come stavano facendo tutti, sulla vittoria di Pantani, perché il
Pirata quel Giro "non lo avrebbe finito". Anche questa persona è stata sentita
dagli investigatori. E c'è, agli atti dell'inchiesta, una telefonata
intercettata in cui il detenuto, dopo l'interrogatorio, parla con un parente.
Racconta di Vallanzasca e di quando dichiarò che "un camorrista di grosso
calibro gli avrebbe detto: guarda che il Giro d'Italia non lo vince Pantani, non
arriva alla fine" e che "quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il Giro
a Pantani. Cambiando le provette e facendolo risultare dopato". E quando il
parente domanda, "Ma è vera questa cosa?", la risposta è un sì, ripetuto cinque
volte. Parole che "fanno male", a Tonina Pantani, secondo cui "è una conferma di
quello che ha sempre detto Marco, cioè che l'avevano fregato. Io sono molto
serena oggi: finalmente sono riuscita e sono riusciti a trovare queste cose". Ma
non è bastato. L'uomo sarebbe stato riconvocato per chiarire, ma quel poco che
ha detto non avrebbe convinto chi indagava sulla possibilità concreta di fare
passi in avanti. Sulla richiesta di archiviazione, l'avvocato della famiglia
Pantani Antonio De Rensis ha commentato: «È una grande sconfitta - spiega a
Sportface.it - per chi all’epoca non è riuscito a capire che ci fosse qualcosa
di strano, che i controlli antidoping fossero alterati. E poi questa seconda
richiesta di archiviazione rappresenta comunque un atto di accusa, perché
conferma la presenza dell’infiltrazione camorristica. Non ci sono più dubbi.
Futuro? Ci opporremo alla richiesta di archiviazione. In secondo luogo
cercheremo di agire anche in funzione di una riscrittura della storia di quel
Giro d’Italia 1999, perché Marco Pantani non l’aveva vinto, l’aveva stravinto.
Possibilità che a Marco venga assegnato quel Giro? Io penso di sì, o almeno noi
combatteremo per avere almeno una co-assegnazione ad honorem postuma (dopo la
squalifica di Pantani fu Ivan Gotti a vincere quell’edizione maledetta della
Corsa Rosa, ndr). D’altronde, i fatti sono chiari. Non c’è solo
l’intercettazione che sta girando in queste ore, ma una serie di dichiarazione
univoche di altre persone informate sui fatti. Novità sull'indagine relativa
alla morte di Pantani? Anche qui siamo in fiduciosa attesa: stiamo aspettando la
decisione del Gip e anche su questa indagine attendiamo risposte che ad oggi non
sono ancora arrivate».
Pantani: 17 anni per avere giustizia, è
grama la vita degli avvoltoi. Onore ai giudici di
Forlì e un abbraccio fortissimo a Tonina e Paolo Pantani: non hanno mai smesso
di difendere Marco dalle palate di fango piovutegli addosso da chi non gli
chiederà mai abbastanza scusa, scrive Xavier Jacobelli su “Tutto Sport” lunedì
14 marzo 2016. Ci sono voluti diciassette anni, perché la verità su quel giorno
a Madonna di Campiglio venisse a galla ed è merito dei magistrati della Procura
di Forlì se, finalmente, è venuta a galla. Così come le parole di Tonina
Pantani non hanno bisogno di nessun commento, tanto ammirevoli sono stati la
tenacia e il coraggio con i quali la mamma di Marco e Paolo, il papà, in tutto
questo tempo, per tutto questo tempo, hanno gridato al mondo che Pantani non
avesse mai barato in quel Giro che stava dominando. Diciassette anni aspettando
giustizia. E, se riascoltate Marco parlare durante la conferenza-stampa
susseguente l’esclusione dalla corsa, leggete nella sua voce tutto lo choc che
ha provato, il dolore immenso che l’ha squassato, infilandolo nel tunnel della
depressione che l’ha portato alla morte il 14 febbraio 2004, a Rimini, Hotel
delle Rose. In attesa di avere giustizia anche per questa vicenda, il pensiero
corre a tutti quelli che il giorno dopo Campiglio e nel tempo che è venuto dopo,
hanno sputato fango su Marco. Quelli che il giorno prima Marco pedalava nella
leggenda e il giorno dopo veniva scaricato come un pacco postale. Dovunque
siano, non chiederanno mai abbastanza scusa. E’ grama, la vita degli avvoltoi.
GIALLO PANTANI.
"Pantani è tornato", ecco il libro di De
Zan. Da dieci anni, Davide De Zan, giornalista e
grande amico di Marco Pantani, indaga per scoprire cosa si nasconde dietro alla
morte del Pirata, avvenuta il 14 febbraio 2004 e troppo frettolosamente
archiviata come overdose di cocaina, un altro modo per dire suicidio.
Collaborando con la madre di Pantani, che da sempre sostiene la tesi
dell’omicidio, e con i legali della famiglia, De Zan ha raccolto documenti e
prove che accertano quanto sta emergendo ora e che hanno convinto la
magistratura a riaprire il caso. In questo libro racconta non solo quello che
ora tutti sanno, e che in buona parte nasce da sue scoperte, ma anche i
retroscena di come si è arrivati a questo punto. Un’indagine nell’indagine che
lascia senza parole. E che squarcia il velo su un secondo inquietante aspetto
della vicenda: la cacciata di Pantani in maglia rosa per doping a Madonna di
Campiglio. È lì che Marco ha cominciato a morire, ed è lì che iniziano i
misteri. Ci sono molti elementi nuovi, raccolti dall’autore e qui presentati per
la prima volta, che ridisegnano lo scenario di quel giorno e svelano i tratti di
un complotto. Anche su quello incombe un’inchiesta giudiziaria.
"Un'indagine sconvolgente su un campione ucciso
due volte": la storia raccontata dal nostro Davide. Tutti ricordano le immagini
di Marco Pantani
scortato dai carabinieri a Madonna di Campiglio il 5 giugno 1999. Un numero, 53,
il valore del suo ematocrito al controllo, gli costa un
Giro d’Italia condotto
trionfalmente. Per qualcuno, quel giorno crolla un mito. Per Pantani è il mondo
stesso a crollare. Insieme alla maglia rosa gli sfilano l’onore, e un gran pezzo
di vita. È una discesa agli inferi, che il Pirata compie scalino dopo scalino e
si consuma il 14 febbraio di cinque anni dopo nel residence di Rimini dove viene
trovato morto. Overdose è il verdetto del giudice. Qualcosa di molto simile a un
suicidio per il resto del mondo. Qualcuno continua a nutrire dubbi su quella
conclusione ma servono nuovi elementi e molto coraggio per spingere la
magistratura a riaprire il caso. Tre persone non hanno mai smesso di lottare per
restituire l’onore a Marco Pantani e trovare finalmente la verità. Tonina, la
mamma, che ha sempre rifiutato la versione ufficiale. Antonio De Rensis,
l’avvocato della famiglia, che ha messo testa e cuore in questa battaglia. E
Davide De Zan, un
giornalista ostinato, che di Marco era amico. Grazie a un lavoro d’inchiesta
puntiglioso e serrato, dettagli, fatti e clamorose dichiarazioni si accumulano
sotto gli occhi dell’autore e qui vengono documentati e analizzati nella loro
sconvolgente evidenza. È così che hanno preso corpo due parole: complotto e
criminalità organizzata. Due parole che gettano la loro lunga ombra fino al
tragico epilogo, e impongono di evocarne una terza, ancora più terribile:
omicidio. A Campiglio hanno ucciso il campione, a Rimini l’uomo. Un solo uomo
ucciso due volte. "Tutti i ragazzi che mi credevano devono parlare" esortava
Marco Pantani in un messaggio ritrovato dopo la sua morte. Finalmente i ragazzi
hanno parlato. Pantani è tornato. Adesso, fate giustizia.i Marco Pantani. Gli
ultimi giorni del Pirata
Liti, fughe e sospetti incrociati. La
ricostruzione degli ultimi 40 giorni di Marco secondo i racconti dei genitori,
del medico, della manager e del "tutore". E la strana "eclissi" del soggiorno
milanese, scrive Davide Di Santo su “Il Tempo”. Quello
strano e fragile cerchio magico torna a riunirsi intorno a Marco Pantani qualche
giorno dopo il primo dell’anno. È il gennaio del 2004, ultima salita della vita
del Pirata. Unico assente è il padrone di casa Michael Mengozzi, gestore di
discoteche della riviera, professionista della notte scelto come custode a tempo
pieno di Pantani. Intorno al tavolo della casa di Predappio siedono Tonina e
Paolo, genitori di Marco, il dottor Giovanni Greco del Sert di Ravenna,
diventato nel tempo anche il medico personale del campione, e la manager Manuela
Ronchi in compagnia del marito Paolo Tomola e del figlio piccolo. Secondo quanto
raccontano i protagonisti prima e durante il processo agli spacciatori di
Pantani, il campione non ne vuole sapere di essere ricoverato. «Sono adulto e ho
il diritto di essere libero», ripete. Tutti i precedenti tentativi di metterlo
in una struttura specializzata per la cura delle dipendenze erano andati in
fumo. I rapporti tra Michael e la famiglia Pantani sono già erosi dai sospetti,
così come quello tra Marco e l’uomo della notte di Predappio. Si tratta di una
vecchia conoscenza della famiglia. Mengozzi era andato qualche volta a caccia
con Paolo, il padre di Marco, e quando si era sparsa la voce dei problemi di
droga del campione si era presentato al chiosco di piadine della signora Tonina.
In passato, dicevano di lui, aveva aiutato un altro ragazzo della zona a
sconfiggere la dipendenza con una ricetta semplice ed efficace che userà anche
con Marco: aria buona, cibo genuino, battute di caccia e qualche ragazza. In
quel periodo il Pirata non ha problemi a procurarsi la droga. Rotoli di
banconote in tasca, milioni sul conto, basta sfuggire qualche ora al controllo
per acquistare grandi quantità di polvere bianca. Quella sera alle suppliche dei
genitori risponde minimizzando la gravità della sua dipendenza: bastano le cure
del dottor Greco e magari cambiare aria per un po’, in Spagna o in Sud America.
Ancora una volta niente di fatto. Arriva il compleanno di Marco, Michael la sera
del 13 gennaio organizza una cena con amici vecchi e nuovi. Pantani si presenta
in forte stato confusionale, alterato dalla droga. Pochi giorni prima aveva
prelevato 10mila euro in contanti, usati per la coca e per Barbara, nome d’arte
di Elena Korovina, escort russa. È lei cosiddetta Dama Nera. La serata è un
fallimento, il festeggiato è stravolto e delira, il giorno successivo i genitori
chiamano Greco che propone un trattamento sanitario obbligatorio. Paolo e
Tonina, persone semplici, taciturno lui, sanguigna lei, si oppongono, ancora una
volta. Il 15 il marito della Ronchi arriva in macchina a Predappio per prendere
Pantani e portarlo nella loro casa di Milano. Passa giorni tranquilli, senza
consumare la «sostanza», come la chiamava lui. Continua a rifiutare il ricovero
ma si dice favorevole e una vecchia proposta della manager, un periodo in
Norvegia accanto Renato Da Pozzo, atleta e motivatore. Allo stesso tempo, però,
cerca in tutti i modi una scusa per tornare a Predappio o in riviera.
L’occasione si presenta il 26 gennaio, prende l’auto della manager per andare a
Cesenatico a prendere l’attrezzatura da montagna da usare per un’escursione col
padre della Ronchi. Nella valigia preparata da mamma Tonina anche i famosi
giubbotti da sci, poi spuntati misteriosamente a Rimini. Durante il viaggio
preleva 22mila euro e fa il pieno di coca e di crack, che consuma di nascosto a
casa della manager fino a quando i coniugi lo vedono parlare con la tv. Dice di
essere in comunicazione subliminale con il presentatore Rai Massimo Giletti. Il
marito di Manuela trova la droga e la getta nel water. La situazione è
esplosiva, in casa c’è anche un bambino. Venerdì 30 gennaio c’è l’atteso
incontro con il dottor Ravera in una clinica di Appiano Gentile. La data fissata
per il ricovero è il lunedì successivo, il 2 febbraio. Marco dopo il colloquio
ha una crisi nervosa, piange e si chiude nel mutismo. Il giorno successivo il
“cerchio”, senza Greco e Mengozzi, si riunisce a Milano in casa della Ronchi.
Quando arrivano Tonina e Paolo la tensione è già alta, con Marco e Manuela che
discutono animatamente. Pantani è lucido, e determinato a fare di testa sua. I
toni salgono ulteriormente, i genitori vogliono convincere Marco al ricovero
immediato, senza aspettare il lunedì, oppure a partire subito per Cesenatico. La
lite inizia nell’appartamento e continua sulle scale. Paolo alza le mani, il
figlio lancia le valigie appena fatte per la scale, la madre ha un malore e si
accascia al suolo. Marco indica la guancia e provoca il padre: «Picchia, picchia
qua». Emergono vecchi rancori, il Pirata accusa i genitori di aver fatto di
tutto per allontanare Christina, la sua ex fidanzata danese che non vuole più
saperne di lui, e maledice il «complotto» di cui è stato vittima a Madonna di
Campiglio, l’esclusione dal Giro d’Italia del ’99 per ematocrito fuori norma
dopo la quale il campione non è stato più lui. Marco torna in casa, chiama il
118: «venitemi a prendere, mio padre mi ha picchiato». I medici arriveranno ma
potranno assistere solo Tonina. Nelle mani del padre resta il cellulare Nokia di
Marco, lui è già andato via, al Jolly Touring Hotel di Milano. Ci rimarrà,
secondo le ricostruzioni ufficiali, dieci giorni, barricato nella propria stanza
con le serrande chiuse, tra cartoni di pizza e lattine di Coca Cola. Eppure,
come svelato da Il Tempo la ricevuta dell’albergo riporta ben quattro notti,
quelle dal 2 al 5 febbraio, in cui Pantani ha pagato la doppia per intero e non
uso singola. Forse c’era qualcuno con lui, o forse la stanza era occupata da
qualcun altro mentre Marco era altrove. In quei quattro giorni, a differenza dei
precedenti e dei successivi, non risultano telefonate dalla sua stanza.
Un’eclissi inspiegabile. Il 6 febbraio Pantani lascia un messaggio nella
segreteria di Manuela: «Sono nell’albergo che tu sai, i cagnolini tornano
all’ovile». Il giorno successivo chiama Greco, dice di essere in un periodo
terribile, costretto a centellinare i pochi farmaci rimasti. Il medico telefona
alla Ronchi e le manda un fax con la prescrizione - che resterà nella
disponibilità di Pantani – da portare a Marco insieme a qualche vestito pulito.
Lei lo chiama: «Vengo ma devi farti ricoverare». Lui replica: «Sono adulto,
decido io della mia vita». Si accordano che sarà il marito della Ronchi - sempre
più esasperato dalla situazione - a lasciare al personale della reception la
sportina con i medicinali appena acquistati, i cambi e la ricetta, lei resterà
in auto per evitare ogni contatto. Così avviene. Marco richiama la Ronchi alle
8.30 di lunedì 9 febbraio. Chiede di raggiungerlo per organizzare un soggiorno
nella sua casa di Saturnia. Lei risponde che sarà in hotel alle 14 ma Pantani fa
retromarcia, replica che sta pagando il conto con l’intenzione di andare verso
casa. «Da allora non l’ho più sentito e non riesco a spiegarmi le ragioni per
cui si sia recato nell’hotel in cui poi è stato trovato senza vita», dirà la
Ronchi. Quello che emerge dagli atti è che Marco sale su un taxi, a
Milano, direzione Rimini. Con sé una bustina di plastica e pochi oggetti, e
senza quei famosi giubbotti da sci inspiegabilmente trovati nell’appartamento D5
del residence Le Rose. Alle 21.30 del 14 febbraio lo studente trapanese Pietro
Buccellato, che fa il turno alla reception, entra nella stanza con un
passepartout, sale le scale del soppalco e vede riflesso sullo specchio il
cadavere di Marco Pantani riverso sul pavimento. In mezzo a queste poche
evidenze - alcune delle quali messe in discussione dall’esposto presentato dalla
famiglia Pantani che ha permesso alla procura di Rimini di riaprire il caso - il
mare di dubbi e incongruenze di cui abbiamo scritto da questa estate a oggi,
oggetto della nuova inchiesta per omicidio volontario. Per coprire i tanti,
troppi tasselli rimasti vuoti nel mosaico degli ultimi giorni di Marco Pantani.
Pantani, il mistero della fuga di Milano.
Pochi giorni prima di morire isolato in hotel ma forse c’era qualcuno con lui Il
giallo delle telefonate. Marco non aveva le sim: una ha contattato la madre,
continua Davide Di Santo.
Si allungano nuove ombre sugli ultimi giorni in vita di Marco Pantani. Alcuni
documenti di cui Il Tempo è venuto in possesso fanno emergere uno
scenario inedito: il Pirata potrebbe non essere stato solo durante una parte del
suo soggiorno al Jolly Touring Hotel di Milano. Siamo tra il 31 gennaio e il 9
febbraio 2004, penultima tappa dell’esistenza di Pantani, trovato morto il
giorno di San Valentino dello stesso anno nel residence Le Rose di Rimini.
Ufficialmente per overdose, anche se dopo l’esposto presentato dall’avvocato
della famiglia Pantani, Antonio De Rensis, la procura romagnola indaga per
omicidio volontario. Secondo quanto ritenuto finora, Pantani si sarebbe
volontariamente isolato con i suoi demoni per nove giorni dopo la «fuga» dalla
casa milanese della manager Manuela Ronchi e dagli stessi genitori che da
Cesenatico erano venuti a prenderlo. Una lite, vecchi rancori e qualche
schiaffo, Pantani va via senza valigie e senza cellulare e prende una camera. Ma
dalla fattura dell’albergo milanese, rinvenuta a Rimini dopo la morte, emerge
che per il 31 gennaio e il primo febbraio sono stati messi in conto - solo per
la camera - 132 euro a notte. Il pernotto sale a 180 euro per i quattro giorni
successivi per poi tornare a quota 132 dal 6 all’8 febbraio, ultima notte
passata al Jolly Touring. Da escludere che l’oscillazione sia dovuta a un cambio
di tariffa per un periodo di alta stagione: non si spiegherebbe il ritorno alla
cifra di partenza. È possibile che l’«appartamento», così viene chiamato nella
ricevuta, sia stato preso come doppia a uso singola e che il prezzo sia salito,
in quei quattro giorni, perché c’era un ospite in stanza. L’avvocato De Rensis
dovrà capire cosa c’è dietro questa ennesima anomalia che non ha suscitato la
curiosità degli inquirenti, prima e durante il processo ai pusher del Pirata.
L’albergo, però, è passato alla catena Nh e scovare registrazioni e ingressi a
dieci anni di distanza non sarà facile. Pantani, inoltre, era senza cellulare.
Per comunicare usava il telefono dell’hotel, come si evince anche dal conto di
1.960,15 euro saldato a fine soggiorno e che comprende qualche centinaio di euro
per pasti e frigo bar. Il 7 ad esempio chiama il suo medico, Giovanni Greco,
perché rimasto a corto di farmaci, che gli saranno poi portati alla reception
dalla Ronchi. Eppure c’è un buco di quattro giorni nel quale non risultano
chiamate, un’«eclissi» che coincide con le date in cui si può ipotizzare la
presenza di un’altra persona nella stanza. Con chi era Pantani? Per comunicare
può aver utilizzato un altro cellulare? A questi interrogativi si aggiunge la
possibilità che Marco, se la camera era in uso a due persone, in quei quattro
giorni sarebbe potuto anche trovarsi altrove. La questione delle chiamate è
centrale. Il campione romagnolo aveva in uso quattro numeri, quattro sim usate
alternativamente con il suo Nokia Communicator, rimasto al padre Paolo. Da una
delle sue utenze, non quella abituale ma usata ad esempio tra l’11 e il 12
gennaio per chiamare lo spacciatore Fabio Miradossa e l’amico Michael Mengozzi a
Predappio, parte una chiamata la sera dell’8 febbraio, l’ultima passata a
Milano. È una telefonata riportata dai tabulati alle 22.20 e 55 secondi. Il
destinatario è la madre di Marco, Tonina Belletti, e la chiamata dura 0 secondi:
il cellulare della donna è spento, lei e il marito sono in viaggio per la
Grecia. Ebbene, quella sim non è mai state trovata, come le altre due che non
erano nel cellulare. Non risultano tra gli oggetti repertati al Le Rose, come
Il Tempo ha potuto verificare, e neanche tra gli oggetti personali
riconsegnati alla famiglia. Chi aveva quelle schede? Chi ha chiamato quella sera
la signora Pantani e perché? Domande, queste, che nessuno si è fatto in questi
dieci anni. E che attendono risposta.
Mamma Pantani: "Ma perché i poliziotti
vogliono querelarci?". L'avvocato della famiglia del
Pirata sulle persone sentite nell'inchiesta di Rimini: "O gli credi o li
indaghi. Non si va avanti facendo passare tutto", scrive Luca Gialanella su
“La Gazzetta.it”. Il gioco si sta facendo duro. Antonio De Rensis, l'avvocato
della famiglia Pantani che è stato decisivo nella riapertura delle inchieste a
Rimini e Forlì, sbotta durante la presentazione del libro Pantani è tornato,
scritto dal giornalista televisivo Davide De Zan: "Sto ultimando l'istanza per
chiedere lo spostamento dell'inchiesta da Rimini a Bologna. La decisione spetta
alla Procura Generale di Bologna. Il clima non è più sereno. E bisogna avere
risposte, al più presto". De Rensis si riferisce alla decisione di cinque
poliziotti, che indagarono nel 2004 sulla morte di Pantani, "di procedere in
giudizio contro quanti diffondono notizie lesive della nostra reputazione".
Mamma Tonina Pantani, presente con il marito Paolo, aggiunge decisa: "Perché
questa decisione dei poliziotti? Se sono puliti, e lo sono, perché si comportano
così? In questi dieci anni ho avuto tante difficoltà, ne ho passate di tutti i
colori, ma non ho mai abbandonato la mia idea che Marco sia stato ucciso. Io
voglio avere delle risposte che ancora non ho avuto. Abbiamo offeso la Polizia?
Se la Polizia vuole, perché non unire le nostre forze? Perché vogliono
querelarci? E comunque sappiano che io non ho paura". De Rensis sposta la
discussione sul piano giuridico: "Due di quei poliziotti sono già stati chiamati
a testimoniare e in futuro potrebbero essere chiamati tutti a farlo. È la prima
volta, per quanto ne so io, che dei testimoni, appartenenti alla Polizia e che
sono persone informate sui fatti, si ergono al ruolo dimostrato ieri con quel
comunicato diffuso dall'Ansa, durante un'indagine in corso. I poliziotti hanno
parlato di linciaggio mediatico. Se lo fai a indagine aperta, e l'inchiesta è
svolta da altri poliziotti, posto che gli essere umani sono fatti di conscio e
inconscio, questo non aiuta certo il clima. Sono veramente stupito. Il
procuratore capo Giovagnoli è un galantuomo, ma l'indagine è fatta di tanti
compartimenti. A Rimini non c'è serenità". Ci sono state testimonianze nuove,
come quelle dei tre infermieri "i primi a intervenire nella stanza di Pantani",
che hanno posto il problema della pallina di coca e pane davanti al corpo di
Marco: i tre affermano di non averla mai vista, l'hanno detto nella
testimonianza giurata all'avvocato De Rensis e poi l'hanno ripetuto in Procura.
Loro lasciano la stanza alle 21.20, ma nel video della Polizia Scientifica, che
inizia alle 22.45, la pallina c'è. "La pallina di cocaina è il grimaldello
dell'indagine, essendo venuta fuori da testimoni che non erano mai stati sentiti
dieci anni fa e che spontaneamente sono venuti a cercarmi per raccontare la loro
verità - continua il legale -. La pallina è l'emblema dell'indagine: in uno
spazio di 81 centimetri per 250 centimetri, gli infermieri hanno detto che non
c'era. Servono risposte: o gli credi o li indaghi, ma non si va avanti lasciando
passare tutto, e mettendoci una X sopra. Visto che ci sono orari e circostanze,
e sappiamo quando sono andati via gli infermieri, o questi hanno detto una
bugia, e allora devono essere indagati, o bisogna credergli. Esigo delle
risposte. Andiamo a dare le risposte, il movente poi verrà da solo. La notte del
14 febbraio 2004, l'ambulanza che è intervenuta era partita da Riccione. Era San
Valentino, era sabato sera, ci avrà messo almeno quindici minuti? Ebbene, la
volante della Polizia che partiva da Rimini è arrivata dieci minuti dopo".
Quindi il video della Scientifica: "Un girato di due ore e 56 minuti è diventato
un video di 51 minuti, interrotto 35 volte, di cui una per 30 minuti, con gli
investigatori che mettono anche una mano davanti all'obiettivo per non fare
inquadrare. Io voglio una risposta. E se dirlo vuol dire essere querelato,
allora io sono fiero di essere querelato. Il filmato parla, eccome. Uno che vede
Marco Pantani nella stanza capisce tante cose, dalle ferite, dalle macchie di
sangue, dalla posizione", conclude l'avvocato De Rensis.
"Sparirono 5 schede sim di Marco".
Pantani, tutti i dubbi di mamma Tonina. L'intervista:
"A Milano, e non solo, successero molte cose strane". Tonina Pantani svela tutti
i dubbi sugli ultimi giorni di Marco ad Affaritaliani.it con Lorenzo
Lamperti. Chiamate misteriose, sim scomparse, incomprensibili spese d'albergo,
depistaggi e tanto altro. Gli ultimi giorni di Marco Pantani (ricostruiti
cronologicamente in un articolo di Libero) nascondono molti misteri per
ora insoluti. A partire da quel periodo trascorso a Milano, poco tempo prima di
quel maledetto 14 febbraio del 2004. Ora Tonina Pantani, la mamma di Marco,
ripercorre i dubbi su quell'ultimo oscuro periodo in un'intervista ad
Affaritaliani.it.
Signora Pantani, partiamo dal 26 gennaio
quando la manager di Marco, Manuela Ronchi, racconta che il marito andò a
prenderlo perché non stava bene. Che cosa successe?
«Il
26 gennaio il marito della Ronchi venne a prenderlo a Predappio con me presente.
Tutte le volte che Marco non stava bene arrivavano a prenderlo e se lo portavano
a casa, non perché. Tanto lei come Mingozzi, l'amico dal quale Marco era andato
spesso a stare. Il 26 gennaio comunque Marco arrivò a casa e mi disse che doveva
fare la valigia».
Si ricorda che cosa si portò dietro?
«Sì,
prese una valigia di quelle a righe, non era un trolley. Non era una valigia
molto grande e dentro c'erano solo tre giubbotti e due maglioni. Io stupita gli
chiesi se era tornato a casa solo per quelle poche cose, lui mi rispose che se
gli sarebbero servite altre cose le avrebbe comprate».
Secondo le testimonianze il 30 gennaio
Marco parlò con il professor Ravera e rifiutò di entrare in clinica per
disintossicarsi.
«Io
anche sta cosa qui l'ho saputa dalla Ronchi. Sono cose che dice lei, io non ho
mai saputo nulla del professor Ravera».
Il 31 gennaio invece si racconta che ci fu
una lite molto accesa, con lei presente, a casa della Ronchi. Che cosa successe?
«Al
nostro arrivo a Milano nacque una grossa discussione al termine della quale io
svenni. Quando tornai dall'ospedale Marco era sparito. Tra l'altro è stato detto
che io e mio marito tornammo subito a casa quella sera ma non è assolutamente
vero. Ho ancora la ricevuta dell'albergo dove abbiamo dormito».
Quella sera non riuscì più a entrare in
contatto con Marco?
«No,
la Ronchi ci disse che aveva telefonato a tutti gli alberghi e che non si
trovava. Tra l'altro non aveva portato con sé il telefono quindi era
irraggiungibile. Dopo anni poi sono tornata per capire dove Marco aveva
alloggiato e ho visto che l'hotel si trovava vicino all'ufficio della Ronchi».
Vista la discrepanza nelle ricevute di
pagamento dell'hotel (132 euro per i primi giorni, 180 per i successivi) crede
che qualcuno possa aver alloggiato con lui?
«Non
lo so, l'ho pensato subito anche io quando ho visto quelle ricevute e ho notato
subito che il pagamento non era uguale per tutti i giorni».
Poi lei non sentì più Marco?
«No,
non l'ho più sentito. Ci telefonò la sua manager mentre eravamo a pranzo per
dirci di firmare un fax per mandare il dottore a comprargli delle medicine. La
cosa mi stupì perché Marco non era uno che prendeva delle medicine. Invece qui
hanno detto che aveva persino mandato uno che lavorava nell'hotel a comprargli
le medicine, cosa che il portiere dell'albergo mi ha poi smentito».
L'8 febbraio però risulta che da una delle
schede di Marco partì una chiamata verso di lei...
«La
storia del telefonino mi ha messo molti, molti dubbi. A me Marco non mandò
nessun messaggio, magari l'avesse fatto. Come faceva a chiamarmi se non aveva
dietro il telefono? Nell'ultimo periodo Marco abitava a Predappio dall'amico
che aveva chiesto a mio marito un telefono per tenerlo sotto controllo. L'amico
poi fece intendere che Marco si era suicidato e non venne al funerale. Mi
ricordo che mi chiese di guardare il telefono di Marco e dopo un po' me lo diede
indietro. Un'altra cosa strana è che sparirono da casa non tre, ma cinque schede
telefoniche che appartenevano a Marco. E penso che da una scheda telefonica si
possano capire molte cose, anche perché Marco usava molto il telefono».
Le sembra che ora le indagini stiano
andando nella direzione giusta?
«Guardi,
non lo so. Purtroppo mio figlio non me lo dà indietro più nessuno, io spero solo
si possa arrivare alla verità anche per evitare che altre cose brutte come
quella successa a lui non succedano più a nessuno».
Tonina Pantani ad Affari: "Ci sono tante
cose che non posso dire...". "Prima di uscire sui
giornali penso che il procuratore che sta facendo le indagini doveva avvisare
l'avvocato e me". Tonina Pantani, la mamma del Pirata, intervistata da
Affaritaliani.it, commenta le parole del procuratore Paolo Giovagnoli,
secondo il quale non ci sono elementi che facciano pensare all'omicidio per la
morte di Marco Pantani. "Le cose non stanno così, ne sono convintissima. Anche
perché ci sono tante cose che non posso neanche dire". E ancora: "Io so com'è
mio figlio. So quali sono le sue abitudini, conosco tutta la sua storia. Ne
hanno dette tante, ma non è così. Ne ho dovute mandar giù di cose brutte. Ma non
ce l'ho con nessuno. Voglio solo delle risposte e voglio solo vivere in pace gli
ultimi anni che mi sono rimasti".
Il procuratore Paolo Giovagnoli ha
dichiarato che non ci sono elementi che facciano pensare all'omicidio per la
morte di suo figlio Marco. Come ha accolto questa notizia?
"Di questo non so niente. L'ho letto sui giornali.
Ma prima di uscire sui giornali penso che il procuratore che sta facendo le
indagini doveva avvisare l'avvocato e me".
Lei non è stata avvisata?
"No".
Lo ha saputo dalla stampa...
"Sì".
Lei continua ad essere convinta che le
cose non stanno così?
"Io sono convintissima, anche perché ci sono tante
cose che non posso neanche dire. Se sono dieci anni che lotto per questa cosa e
se ho speso un capitale è perché penso che qualcosa non funzioni e che non sia
andata così. Altrimenti avrei lasciato perdere".
Allora perché i magistrati continuano a
dire il contrario?
"Lo sapessi! Non lo so. Io non punto il dito su
nessuno, non so se le indagini sono state fatte bene oppure no. Dico solamente
che come mamma voglio sapere come è morto mio figlio. Ho diritto, io come
cittadina italiana, di sapere come è morto mio figlio. Poi se le cose sono
andate diversamente me ne farò una ragione però io ho diritto ha delle risposte
alle domande che ho fatto da dieci anni".
E finora queste risposte non sono
arrivate...
"Nemmeno una".
Lei ha ancora fiducia nella giustizia
italiana?
"Io ho fiducia perché spero che qualcosa venga
fuori. Io ho fiducia. Non dico che il procuratore di prima abbia lavorato male,
dico solamente che io come mamma voglio delle risposte. Quando mi daranno queste
risposte me ne farò una ragione e basta".
Lei non crede al fatto che non sia stato
omicidio...
"Non ci ho mai creduto".
E forse non ci crederà mai...
"Io so com'è mio figlio. Mio figlio è mio figlio.
So quali sono le sue abitudini, conosco tutta la sua storia. Ne hanno dette
tante, ma non è così. Ne ho dovute mandar giù di cose brutte ma io mio figlio lo
conosco bene".
Che cosa l'ha delusa maggiormente in
questi anni?
"L'indifferenza".
Di chi?
"In generale. Non do colpe a nessuno io, voglio
solo delle risposte. Non ce l'ho con nessuno. Voglio solo vivere in pace gli
ultimi anni che mi sono rimasti".
Vallanzasca sentito in carcere sulla
morte di Marco Pantani. In una lettera dal carcere
alla madre del Pirata, la tesi del giro di scommesse truccate gestito dalla
criminalità, scrive “Il Corriere della Sera”. Renato Vallanzasca, martedì, ha
risposto ai carabinieri che lo hanno sentito in carcere sulla morte di Marco
Pantani. A differenza del silenzio davanti al pm di Trento Bruno Giardina e alla
mamma di Marco Pantani, il «bel René» — che fu capo della banda della Comasina —
ha risposto ai carabinieri che lo hanno sentito su delega del pm di
Forlì-Cesena, Sergio Sottani: sua la decisione di riaprire il caso, archiviato,
sul presunto complotto ordito ai danni del Pirata per alterarne le analisi del
sangue del 5 giugno ‘99 a Madonna di Campiglio ed escluderlo dal Giro d’Italia
che stava dominando. Dal fitto riserbo che circonda l’indagine forlivese si è
appreso solo che le indagini cercano i primi riscontri alle nuove dichiarazioni
di Vallanzasca. Vallanzasca sostenne all’epoca di essere stato avvicinato in
carcere a Opera (Milano) da uno sconosciuto sedicente membro di un clan di
camorra. Il quale lo avrebbe invitato a puntare milioni sul Giro d’Italia ma non
su Pantani. «Non mi permetterei mai di darti una storta. Non so come, ma il
pelatino non finisce la gara». Suggerimento insistito, anche mentre il Pirata
dominava il giro. Il 5 giugno 1999, l’affondo: «Visto? Il pelatino è stato fatto
fuori. Squalificato». Secondo Vallanzasca, dunque, dietro la morte del ciclista
ci sarebbe stato un complotto: è quanto scritto anche nella lettera spedita dal
carcere alla signora Pantani: «Quattro o cinque giorni prima che fermassero
Marco a Madonna di Campiglio — le parole del malavitoso contenute nella missiva
— mi avvicinò un amico, anche se forse lo dovrei definire solo un conoscente,
che mi disse: “Renato, so che sei un bravo ragazzo e che sei in galera da un
sacco di tempo. Per questo mi sento di farti un favore”. Ero in vero un po’
sconcertato ma lo lasciai parlare. “‘Hai qualche milione da buttare? Se sì,
puntalo sul vincitore del Giro! Non so chi vincerà, ma sicuramente non sarà
Pantani”». La tesi di Vallanzasca è che le scommesse clandestine sulla vittoria
finale del Pirata erano talmente tante da poter «sbancare» chi le gestiva. E
poiché si trattava della criminalità, era stato più facile eliminare il campione
dalla competizione. Esattamente la tesi sulla quale sta indagando la Procura di
Forlì.
Il capitolo Pantani si arricchisce sempre più di
nuovi capitoli. L'ultimo e forse più importante in ordine di tempo è l'ulteriore
interrogatorio sostenuto da Renato Vallanzasca in carcere, nel quale l'ex
malvivente avrebbe confessato di aver identificato il detenuto che nel 1999 gli
consigliò di non puntare sulla vittoria del Pirata, scrive “TGCom 24”.
All'interno del carcere di Bollate, infatti, a Vallanzasca sono state sottoposte
dieci diverse fotografie di detenuti tra i quali, alla fine, si trovava il
camorrista che gli annunciò l'esclusione di Pantani al Giro. Il "bel René"
dunque, ha riconosciuto l'uomo, che ora si trova dentro il carcere di Novara.
Anni fa invece, l'ex boss si rifiutò di fornire qualsiasi tipo di commento sulla
vicenda, per poi spedire una recente lettera alla mamma di Marco, nella quale
confidava di aver ricevuto la seguente soffiata: "Non posso dirti quello che non
so, ma è certo che 4 o 5 giorni prima di Madonna di Campiglio sono stato
consigliato vivamente di puntare contro il tuo ragazzo".
Pantani, si riapre il caso Giro ‘99: tra camorra,
scommesse e Vallanzasca, scrive Francesco Ceniti su “La Gazzetta.it”. A inizio
settembre, la Procura di Forlì ha aperto un fascicolo per “associazione per
delinquere finalizzata a frode e truffa sportiva”. Il ruolo del famoso bandito
milanese. Associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla frode
sportiva. Dieci parole per riportare l’orologio indietro di oltre 15 anni. La
Procura di Forlì ha aperto a inizio settembre un fascicolo a carico d’ignoti con
questa ipotesi di reato in relazione all’esclusione subita da Marco Pantani il 5
giugno 1999 a Madonna di Campiglio, durante il Giro d’Italia. In poco più di un
mese le inchieste sul Pirata si sono raddoppiate: a fine luglio c’è stata la
riapertura del caso sulla morte (s’indaga per omicidio volontario) da parte
della Procura di Rimini. Campiglio e Rimini. Rimini e Campiglio. Per anni la
famiglia del Pirata, i tantissimi tifosi del campione rimpianto e molti sportivi
hanno ripetuto come un mantra il nome delle due località: "È stato prima fregato
e poi fatto fuori". Adesso gli interrogativi, i dubbi, i tanti sospetti saranno
chiariti (si spera) dagli inquirenti. A Forlì l’indagine è condivisa dal
Procuratore capo Carlo Sottani (da sostituto a Perugia si è occupato di vicende
scottanti come le inchieste sulle Grandi opere e il G8) e dal pm Lucia Spirito.
Già affidata la delega per gli interrogatori: il pool è coordinato dal
maresciallo Diana dei carabinieri. Da loro bocche cucite, ma una cosa è filtrata
da Forlì: ci sono tutti gli elementi per andare fino a fondo a uno dei punti più
controversi della vita di Pantani. L’inizio della fine, per molti. Compresa
mamma Tonina: "Senza Campiglio non ci sarebbe stato mai Rimini". Difficile
sostenere il contrario. Ma perché Forlì ha deciso d’indagare 15 anni dopo? E
perché l’ipotesi parte con una inquietante associazione per delinquere? Domande
che hanno una risposta e rimandano a un cognome che ha segnato la cronaca nera
della storia italiana: Renato Vallanzasca. Le indagini — Da settembre a oggi,
gli inquirenti hanno già ascoltato diverse persone informate sui fatti. Quali
fatti? Quelli legati all’esclusione dal Giro di Pantani: una vicenda che secondo
l’accusa potrebbe avere dei mandanti pericolosi (clan della camorra) e degli
esecutori sul posto. Di certo, chi è sfilato in Procura ha raccontato di un
clima tesissimo durante la corsa rosa, con continue minacce anonime che
arrivavano a chi stava intorno al Pirata. Minacce chiare: non doveva concludere
la gara. E si arriva all’episodio di Cesenatico. Il Giro d’Italia arriva a casa
del Pirata il 25 maggio 1999. La mattina dopo, i giornalisti sono allertati:
"Pantani è fuori, ha saltato il controllo del sangue". Non sarà così, il
capitano della Mercatone Uno passa quel test, ma i commissari dell’Uci lo
vorrebbero lo stesso squalificare per un ritardo di circa 20’ sull’ora prevista
per il prelievo. Alla fine tutto si risolve, ma l’ispettore dell’Unione
ciclistica internazionale, Antonio Coccioni, lo ammonisce pubblicamente: "La
prossima volta non te la caverai". Ecco, per Forlì l’ipotesi di reato inizia
quel giorno. Nel senso che la criminalità organizzata aveva già deciso che
Pantani non doveva giungere a Milano. Certo, è tutto da dimostrare che le parole
di Coccioni siano legate a questa volontà. Possono essere solo una coincidenza,
ma chi indaga ha le idee chiare: la storia è legata alle scommesse clandestine
ed è stata già narrata da Vallanzasca.Pantani, nel film lo choc di Madonna di
Campiglio Il banco a rischio sbanco — Nel 1999 in Italia le scommesse sul
ciclismo non esistono. Meglio: sono clandestine, le gestisce la criminalità
organizzata. Quando la camorra si rende conto di aver accettato troppe puntate
su Pantani vincente, è troppo tardi. Lui si dimostra il più forte. Si parla di
decine di miliardi di lire, il banco rischia di saltare. C’è un solo modo per
evitare il flop, trasformandolo in un affare d’oro: non far trionfare Pantani.
Ma il Pirata straccia gli avversari e la sfortuna sembra aver cambiato
direzione. Sembra. In realtà per gli inquirenti la camorra pianifica per tempo
la cacciata di Pantani. E qui arriviamo a Vallanzasca: il bel Renè nel 1999 si
trova nel carcere di Opera (Milano) per scontare uno dei 4 ergastoli rimediati
per le scorribande negli Anni Settanta. È avvicinato da un altro detenuto che
non conosce. Dice di essere un affiliato a un importante clan della camorra e
gli suggerisce di puntare tutti i risparmi sui rivali di Pantani. Vallanzasca
strabuzza gli occhi: "Sai chi sono?". Risposta disarmante: "Certo, non mi
permetterei mai di darti una storta. Non so come, ma il pelatino non finisce la
gara". Il Giro è iniziato da poco: nelle tappe successive Pantani domina.
Vallanzasca è scettico, ma l’altro insiste: "Fidati". E il 5 giugno il detenuto
dalla dritta giusta va all’incasso: "Hai sentito? Il pelatino è stato fatto
fuori, squalificato". Vallanzasca ha raccontato questo episodio nella sua
autobiografia, uscita a fine 1999. E nei mesi successivi è stato sentito da
Giardina, p.m. di Trento, titolare di un fascicolo dopo Campiglio. Fascicolo che
all’inizio vedeva Pantani parte lesa (gli avvocati ipotizzavano lo scambio di
provette), ma poi fu lui a finire indagato per frode sportiva. L’accusa finirà
nel nulla, come quelle delle altre sei Procure che lo misero nel mirino per lo
stesso motivo, inseguendo un reato che non esisteva (fu introdotto nel 2000).
Vallanzasca non rispose a Giardina: troppo paura, il clan era pronto a
vendicarsi. Vallanzasca 2014 — Adesso le cose potrebbero cambiare: nei prossimi
giorni il procuratore Sottani andrà a Milano per interrogare Vallanzasca una
seconda volta, ma questa volta gli investigatori hanno già un’idea sull’identità
di quel detenuto e quindi del clan a cui era affiliato. Le deduzioni sono state
fatte ricorrendo ai registri penitenziari del tempo e grazie ad alcune
acquisizioni di filmati tv recenti, dove Vallanzasca a telecamere spente
racconta dei particolari inediti. Non solo, tra le persone sentite anche
giornalisti, gente vicina a Pantani e soprattutto medici che hanno spiegato come
era possibile e semplice alterare l’ematocrito di quel 5 giugno (trovato a
51,9). Il sangue sarebbe stato deplasmato e la firma di questa operazione si
troverebbe nel valore delle piastrine, piombate a livelli di un malato.
Piastrine che invece erano normali (come l’ematocrito: sempre a 48) la sera del
4 giugno, quando il ciclista si fece l’esame del sangue nella sua stanza
d’albergo per verificare se era nella norma (50 il valore consentito dall’Uci),
e il 5 pomeriggio, quando si fermò a Imola per fare un test prima di arrivare a
casa e iniziare la sua lenta discesa verso Rimini. Questa ipotesi ipotizza un
complice in grado di operare sulla provetta (che non era sigillata). Ecco perché
saranno interrogati anche i dottori che hanno effettuato il prelievo al Giro e
l’ispettore Coccioni. L’inchiesta è all’inizio. Il procuratore Sottani ha
informato da settimane il collega Giovagnoli che indaga sulla morte di Pantani,
segno che nulla si può escludere: neppure una correlazione diretta tra i due
fatti. Campiglio e Rimini sono distanti 414 chilometri e meno di 5 anni. Da ieri
viaggiano fianco a fianco nel nome di Marco.
Marco Pantani con ematocrito alto nel ’98. Ma fu
cacciato il gregario Forconi, scrive Paolo Ziliani
su Il Fatto Quotidiano
del 23 ottobre 2014. L'anno prima della squalifica di Madonna di
Campiglio, al posto del Pirata fu spedito a casa il collega grazie a un presunto
scambio di provette. Panorama parlò della vicenda nel '99, ma non ci furono
reazioni. Il complotto contro Pantani? Certo
che c’è stato. Ma la mala, la camorra e il mondo delle scommesse c’entrano poco;
per rispetto della memoria di Marco – e con buona pace di
Vallanzasca –i complottisti
dovrebbero essere cercati altrove: nei
palazzi del Coni, della
Federciclismo, degli
organizzatori del Giro, dell’Università
di Ferrara. Ricordate il professor
Conconi? Era il rettore
dell’Università di Ferrara cui il Coni aveva affidato, a inizi anni ’80,
l’assistenza medica degli atleti di ciclismo, sci di fondo, canottaggio, nuoto e
altre discipline. Ingaggiato per combattere il doping, fece invece – per la
gioia del Coni – esattamente il contrario: studiò nuove forme di doping e le
fece mettere in pratica portando lo sport italiano a trionfi
impensabili. Riconosciuto colpevole dei reati contestatigli dal
Tribunale di Ferrara (sentenza
del 16 febbraio 2004), ma salvato dalla prescrizione, Conconi fu il primo a
somministrare Epo a
Pantani negli anni dal ’93 al ’95. Il collega del Pirata raccontò tutto al suo
ex ds, che rilasciò un’intervista. Non ci furono smentite né querele. Nel file
DLAB sequestrato nel suo computer a Ferrara si vede come nel ’94 l’ematocrito
di Pantani passa da 40,7 (prima del Giro) a 54,5 (durante il Giro). Pantani
esplode, vince il 4 giugno a Merano,
il 5 sul Mortirolo e il
13 giugno, all’indomani della conclusione, il suo ematocrito è da ricovero: 58%.
Poi Marco va al Tour e
finisce terzo. Al ritorno dalla Francia Conconi lo “testa” e l’ematocrito è
assestato a 57,4. Gli sbalzi di valori di Pantani, dovuti al pompaggio di Epo,
sono drammatici: come il ricovero al
Cto di Torino, dopo la caduta alla Milano-Torino del
‘95, evidenzia (valori oltre il 60%). È triste dirlo, ma Pantani passa tutta la
carriera con l’Epo nel sangue: parlare di complotto per il fattaccio di
Madonna di Campiglio, il 5
giugno 1999, è quindi una presa in giro. Anche perché Marco, l’anno prima,
ha vinto il Giro in modo strano. Come ci raccontò
Ivano Fanini in un’intervista
uscita su Panorama nel 1999, “nessuno sa che anche l’anno prima, al
Giro del ’98, Pantani
avrebbe dovuto essere mandato a casa. Invece al posto suo fu cacciato
Riccardo Forconi, un gregario.
Che il giorno dopo, visto che era un mio ex corridore – era stato con me 6 anni
all’Amore & Vita – venne a trovarmi in ufficio e mi raccontò tutto: “Hanno
fatto uno scambio di provette e hanno mandato a casa me, che alla Mercatone sono
l’unico ad avere i valori bassi”. Riccardo era un modesto gregario, uno da
20-30 milioni di lire l’anno. Beh, dopo quell’episodio, e quella squalifica, si
è costruito una villa sulle colline di Empoli: e si è fatto una posizione”. Per
la cronaca: Pantani vinse quel Giro con 1’33” di vantaggio su
Tonkov, russo della Mapei. La
mattina della cronometro finale, che Pantani corre come una moto (lui
scalatore finirà terzo), dopo un controllo a sorpresa di tutta la Mercatone Uno,
il gregario Forconi, centesimo in classifica, viene mandato a casa con
l’ematocrito oltre i 50: il tutto l’ultimo giorno e prima di una crono in cui
non avrebbe nemmeno dovuto aiutare il suo capitano. Strano, non vi pare? Ma non
è finita. Dopo l’intervista a Fanini, il giudice
Guariniello apre un’inchiesta
per fare luce sulla vicenda. Chiede di recuperare la provetta incriminata (di
Forconi? Di Pantani?), all’ospedale Sant’Anna
di Como dov’è
depositata, per stabilire di chi effettivamente sia il Dna. Sorpresa:
la provetta non c’è più, è sparita. Guariniello deve archiviare. Dopo due mesi
dalla morte di Pantani, la sua ex fidanzata al settimanale Hebdo: “Si dopava e
sniffava cocaina”. Domanda: se voi vincete un Giro d’Italia e qualcuno vi
accusa di averlo fatto con l’inganno, fate finta di niente? Ebbene:
dopo l’intervista a Fanini (che fece i nomi dei testimoni del racconto di
Forconi, come il ds Salvestrini) non
arrivò né a lui né a chi scrive non si dice una querela per diffamazione, ma
nemmeno una richiesta di rettifica, di precisazione. Meglio far finta di niente:
così magari l’anno dopo il teatrino si ripete nell’indifferenza dei più. Deve
averlo pensato, Pantani. Anche la mattina del controllo a sorpresa
(sic) all’hotel Touring a Madonna di Campiglio. Christine
Jonsson, 37 anni, danese, fu la dama bionda di Pantani negli
anni belli e negli anni bui: “Marco si dopava e prendeva la coca – raccontò la
fidanzata, che oggi vive in Svizzera, a Hebdo, settimanale svizzero, due mesi
dopo la morte di Pantani – stando con lui ho sempre avuto l’impressione che
prendesse dei farmaci. Era la sua scelta, pagava di tasca sua i prodotti: diceva
che bisognava prendere delle porcherie per avere successo. Aveva sempre dei
prodotti in un contenitore di plastica nel frigorifero. Talvolta si faceva delle
punture e io lo aiutavo tenendogli il braccio”. Ancora: “Dopo la cacciata dal
Giro cominciò a prendere la cocaina:
mi chiese di farlo con lui. Ero disperata perché io ho paura delle droghe.
Marco ne assumeva delle quantità industriali. La famiglia se ne accorse e pensò
che la colpa fosse mia”.
Giallo, la morte di Pantani e i misteri della Rosa
Rossa. Strano suicidio, quello di Marco Pantani. Così strano da spingere la
magistratura a riaprire l’inchiesta a dieci anni di distanza da quel 14 febbraio
2004. Più che un suicidio, scrive l’avvocato Paolo Franceschetti, sembra un
omicidio “firmato”, con implacabile precisione, dall’ “Ordine della Rossa
Rossa”. Fantomatica organizzazione segreta internazionale, secondo alcuni
studiosi sarebbe una potentissima cupola eversiva di tipo esoterico, con fini di
potere, dedita anche all’oscura pratica dell’omicidio rituale. «Un’ipotesi
sempre scartata come irrealistica dagli inquirenti», scrive nel suo blog lo
stesso Franceschetti, autore di studi sulla presunta relazione tra crimini e
occultismo iniziatico, incluso il caso del cosiddetto “mostro di Firenze”. Di
matrice rosacrociana, fondata sul simbolismo della Cabala e dell’ebraico antico
come la londinese “Golden Dawn” rinverdita dal “mago” Aleister Crowley, secondo
alcuni saggisti la “Rosa Rossa” sarebbe una sorta di super-massoneria deviata e
criminale. Problema: non esiste una sola prova che questa organizzazione esista
davvero. Solo indizi, benché numerosi. Chi esegue una sentenza rituale di morte,
per “punire” in modo altamente simbolico un presunto “colpevole” o addirittura
perché pensa – magicamente – di “acquisire potere” dall’uccisione “satanica” di
un innocente, secondo Franceschetti ricorre sistematicamente a pratiche sempre
identiche: in particolare la morte per impiccagione (la corda di Giuda,
traditore di Cristo), con la vittima fatta ritrovare inginocchiata, e la morte
per avvelenamento (o overdose di droga). Decine di casi di cronaca, tutti
contrassegnati da circostanze ricorrenti: manca sempre un movente plausibile,
non si trova l’arma del delitto, i nomi delle vittime hanno spesso origine
biblica, la somma dei “numeri” (data di morte, data di nascita) riconduce a
numeri speciali, per la Cabala, come l’11 e i suoi multipli. Oppure il 13, il
numero della morte dei tarocchi. E poi, la “firma”: Pantani fu ritrovato morto a
Rimini all’hotel “Le Rose”. Accanto al corpo, un biglietto in codice dal
significato criptico: “Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le rose
sono rosa e la rosa rossa è la più contata”. Sul caso Pantani, sono stati
scritti fiumi di parole, reportage, libri. Tra chi non ha mai creduto alla tesi
del suicidio c’è un giornalista come Andrea Scanzi, che sul “Fatto Quotidiano”
scrive: «Troppe incongruenze. La camera era mezza distrutta, c’era sangue sul
divano, c’erano resti di cibo cinese (che Pantani odiava: perché avrebbe dovuto
ordinarlo?)». Inoltre, il campione aveva chiamato per ben due volte la
reception, parlando di «due persone che lo molestavano», ma l’aneddoto è stato
catalogato come “semplici allucinazioni di un uomo ormai pazzo”. In più, Pantani
«fu trovato blindato nella sua camera, i mobili che ne bloccavano la porta,
riverso a terra, con un paio di jeans, il torso nudo, il Rolex fermo e qualche
ferita sospetta (segni strani sul collo, come se fosse stato preso da dietro per
immobilizzarlo, e un taglio sopra l’occhio)». Uniche tracce di cocaina, quelle
ritrovate su palline di mollica di pane. Indagini superficiali: «Non esiste un
verbale delle prime persone che sono entrate all’interno della camera, non è
stato isolato il Dna delle troppe persone che entrarono nella stanza». Dettaglio
macabro e particolarmente strano, il destino del cuore di Pantani: «Venne
trafugato dopo l’autopsia dal medico, che lo portò a casa senza motivo (“Temevo
un furto”) e lo mise nel frigo senza dirlo inizialmente a nessuno», scrive
Scanzi. Prima di morire, a Rimini il ciclista aveva trascorso cinque giorni,
«per nulla lucido, accompagnato da figure equivoche. Avrebbe anche festeggiato
con una squadra di beach volley poco prima di morire: chi erano?». Altre
domande: «Perché il cadavere aveva i suoi boxer un po’ fuori dai jeans, come se
lo avessero trascinato?». Certo, aggiunge Scanzi, Pantani morì per overdose di
cocaina, «ma troppi particolari lasciano pensare (anche) a una messa in scena».
L’autopsia, peraltro, confermò che le tracce di Epo nel suo corpo erano minime,
«segno evidente di come il ciclista non avesse mai fatto un uso costante di
sostanze dopanti». E poi, tutte quelle “incongruenze”, reperibili in
libri-denuncia come “Vie et mort de Marco Pantani” (Grasset, 2007) e “Era mio
figlio” (Mondadori, 2008). E poi, soprattutto: «Che senso aveva quel messaggio
in codice accanto al cadavere?». Colori e rose, “la rosa rossa è la più
contata”. Anche i suoi amici, ricorda Franceschetti, dissero che la morte di
Pantani in quell’hotel non può esser stata casuale: forse Marco voleva «lasciare
un messaggio a qualcuno», perché «era un uomo che non faceva nulla a caso».
Meglio ancora: «Non era lui che voleva lasciare un messaggio, ma chi l’ha
ucciso», chiosa l’avvocato, sempre attento ai possibili “segni invisibili”:
«Probabilmente c’è un significato anche nel fatto che sia morto a San Valentino,
giorno in cui tradizionalmente si regalano rose alla fidanzata». Pantani
“costretto” ad andare in quel preciso albergo affinchè poi il delitto fosse
“firmato”? «Ovviamente, dire che dietro un delitto c’è la “Rosa Rossa” significa
poco: essendo la “Rosa Rossa” un’organizzazione internazionale, e contando
centinaia di affiliati in Italia, è come dire che si tratta di un delitto di
mafia o di camorra». Un’affermazione «talmente generica da essere pressoché
inutile a fini investigativi». Tuttavia, «dovrebbe essere un buon indizio
perlomeno per non archiviare la cosa come suicidio». Franceschetti considera
«evidente» l’origine «massonica» degli attacchi a Pantani, citando l’anomalo
incidente che, anni prima, lo vide protagonista a Torino: fu travolto da un’auto
che era penetrata in un’area interdetta al traffico, lungo la discesa della
collina di Superga, quella dove si schiantò l’aereo del Grande Torino. La
basilica di Superga, sull’altura che domina la città, fu costruita nel 1717,
«anno in cui venne ufficialmente fondata la massoneria». Basta questo,
all’avvocato, per concludere che si tratta di «una firma manifesta, specie alla
luce delle stranezze di quell’incidente». Tra gli “incidenti non casuali”,
Franceschetti inserisce pure quello ai danni del cantante Rino Gaetano: come
anticipato in modo inquietante dal testo di una sua canzone, “La ballata di
Renzo”, peraltro gremita di “rose rosse”, l’artista morì a Roma nella notte del
2 giugno 1981 dopo esser stato rifiutato da 5 diversi ospedali.
«Statisticamente, le probabilità che un cantante descriva la morte di qualcuno
perché viene rifiutato da 5 ospedali, e che poi muoia nello stesso identico modo
sono… nulle». Molto strana, aggiunge Franceschetti, è anche la tragica fine del
ciclista Valentino Fois, della stessa squadra di Pantani: anche lui muore per
cause da accertare, ma alcuni giornali parlano subito di overdose, «e già questo
fa venire qualche sospetto». Premessa: in Italia, muoiono per omicidio circa
2.500 persone all’anno. E altrettante finiscono suicide. Giornali e Tv si
disinteressano della stragrande maggioranza di questi episodi. «Quando però su
un fatto scatta l’attenzione dei media, in genere questo è un segnale che sotto
c’è dell’altro. Quindi viene spontanea la domanda: perché i giornali si
interessano alla morte di un ciclista poco conosciuto come Fois?». Premesso che
nello sport professionistico il doping (entro certi limiti) è pressoché
inevitabile, Franceschetti sospetta che Fois sia morto «per aver “tradito”, come
Pantani». Ovvero, i due avrebbero «pagato con la vita la loro maggiore pulizia e
onestà intellettuale rispetto al resto dell’ambiente in cui vivevano». Secondo
Franceschetti, c’è anche «non il sospetto, ma la certezza» che la verità non
verrà mai a galla. Del resto, «la maggior parte delle famiglie di queste vittime
non saprà mai la verità, la maggior parte muore senza che i familiari sospettino
un omicidio». E racconta: «Io stesso, dopo il primo incidente che mi capitò,
pensai ad un caso. E dopo il secondo pensavo che ce l’avessero con la mia
collega e che avessero manomesso contemporaneamente sia la mia moto che la sua
per maggior sicurezza di fare danni a lei. In altre parole, potevo morire senza
sapere neanche perché, e pochi avrebbero sospettato qualcosa». E aggiunge: «Ogni
volta che prendo l’auto sono consapevole che lo sterzo potrà non funzionare, che
un’auto che viene in senso inverso all’improvviso potrà sbandare e venire verso
di me, o magari che potrò avere un malore nell’anticamera di una Procura come è
successo al capo dei vigili testimone della Thyssen Krupp». La storia italiana,
aggiunge l’avvocato, è troppo gremita di “coincidenze”, depistaggi e collusioni:
le bombe nelle piazze, Ustica, Moby Prince. «In quei casi i familiari delle
vittime ormai hanno capito, ma negli altri?». La storia infinita del “mostro di
Firenze”, ad esempio, sembra il frutto di un “normale” serial killer solitario.
Secondo Franceschetti, invece, tutti quegli omicidi non sono altro che precise
esecuzioni rituali, settarie ed esoteriche, meticolosamente pianificate da un
clan criminale protetto da amicizie potenti. «Ho telefonato ai genitori di
Pantani prima di scrivere questo articolo», scriveva Franceschetti nel 2008.
«Dal loro silenzio successivo al mio fax presumo che abbiano pensato che io sia
un folle, magari un mitomane in cerca di pubblicità. E’ normale che lo pensino,
come è normale che la maggior parte delle persone che leggeranno queste righe le
prendano per un delirio». Continua Franceschetti: «Un mio amico medico legale, a
cui ho raccontato le mie “scoperte”, mi ha lasciato di stucco quando mi ha
detto: “Sì, Paolo, lo sapevo. Tutti quei suicidi in carcere per soffocamento con
buste di plastica sono impossibili dal punto di vista di medico-legale”».
L’esoterismo «è un linguaggio: se non lo conosci è come camminare per le strade
di una nazione straniera, vedi le scritte ma non ti dicono nulla, sembrano segni
innocui e invece sono messaggi precisi”». Difficile parlarne, «perché ti
prendono per matto». E il guaio è che, «quando capisci il sistema», è
problematico «continuare a fare la vita di sempre senza impazzire».
Strano suicidio, quello di Marco Pantani, scrive
“Libreidee”. Così strano da spingere la magistratura a riaprire l’inchiesta a
dieci anni di distanza da quel 14 febbraio 2004. Più che un suicidio, scrive
l’avvocato Paolo Franceschetti, sembra un omicidio “firmato”, con implacabile
precisione, dall’ “Ordine della Rossa Rossa”. Fantomatica organizzazione segreta
internazionale, secondo alcuni studiosi sarebbe una potentissima cupola eversiva
di tipo esoterico, con fini di potere, dedita anche all’oscura pratica
dell’omicidio rituale. «Un’ipotesi sempre scartata come irrealistica dagli
inquirenti», scrive nel suo blog lo stesso Franceschetti, autore di studi sulla
presunta relazione tra crimini e occultismo iniziatico, incluso il caso del
cosiddetto “mostro di Firenze”. Di matrice rosacrociana, fondata sul simbolismo
della Cabala e dell’ebraico antico come la londinese “Golden Dawn” rinverdita
dal “mago” Aleister Crowley, secondo alcuni saggisti la “Rosa Rossa” sarebbe una
sorta di super-massoneria deviata e criminale. Problema: non esiste una sola
prova che questa organizzazione esista davvero. Solo indizi, benché numerosi.
Chi esegue una sentenza rituale di morte, per “punire” in modo altamente
simbolico un presunto “colpevole” o addirittura perché pensa – magicamente – di
“acquisire potere” dall’uccisione “satanica” di un innocente, secondo
Franceschetti ricorre sistematicamente a pratiche sempre identiche: in
particolare la morte per impiccagione (la corda di Giuda, traditore di Cristo),
con la vittima fatta ritrovare inginocchiata, e la morte per avvelenamento (o
overdose di droga). Decine di casi di cronaca, tutti contrassegnati da
circostanze ricorrenti: manca sempre un movente plausibile, non si trova l’arma
del delitto, i nomi delle vittime hanno spesso origine biblica, la somma dei
“numeri” (data di morte, data di nascita) riconduce a numeri speciali, per la
Cabala, come l’11 e i suoi multipli. Oppure il 13, il numero della morte dei
tarocchi. E poi, la “firma”: Pantani fu ritrovato morto a Rimini all’hotel “Le
Rose”. Accanto al corpo, un biglietto in codice dal significato criptico:
“Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le rose sono rosa e la rosa
rossa è la più contata”.
Sul caso Pantani, sono stati scritti fiumi di
parole, reportage, libri. Tra chi non ha mai creduto alla tesi del suicidio c’è
un giornalista come Andrea Scanzi, che sul “Fatto Quotidiano” scrive: «Troppe
incongruenze. La camera era mezza distrutta, c’era sangue sul divano, c’erano
resti di cibo cinese (che Pantani odiava: perché avrebbe dovuto ordinarlo?)».
Inoltre, il campione aveva chiamato per ben due volte la reception, parlando di
«due persone che lo molestavano», ma l’aneddoto è stato catalogato come
“semplici allucinazioni di un uomo ormai pazzo”. In più, Pantani «fu trovato
blindato nella sua camera, i mobili che ne bloccavano la porta, riverso a terra,
con un paio di jeans, il torso nudo, il Rolex fermo e qualche ferita sospetta
(segni strani sul collo, come se fosse stato preso da dietro per immobilizzarlo,
e un taglio sopra l’occhio)». Uniche tracce di cocaina, quelle ritrovate su
palline di mollica di pane. Indagini superficiali: «Non esiste un verbale delle
prime persone che sono entrate all’interno della camera, non è stato isolato il
Dna delle troppe persone che entrarono nella stanza». Dettaglio macabro e
particolarmente strano, il destino del cuore di Pantani: «Venne trafugato dopo
l’autopsia dal medico, che lo portò a casa senza motivo (“Temevo un furto”) e lo
mise nel frigo senza dirlo inizialmente a nessuno», scrive Scanzi. Prima di
morire, a Rimini il ciclista aveva trascorso cinque giorni, «per nulla lucido,
accompagnato da figure equivoche. Avrebbe anche festeggiato con una squadra di
beach volley poco prima di morire: chi erano?». Altre domande: «Perché il
cadavere aveva i suoi boxer un po’ fuori dai jeans, come se lo avessero
trascinato?». Certo, aggiunge Scanzi, Pantani morì per overdose di cocaina, «ma
troppi particolari lasciano pensare (anche) a una messa in scena». L’autopsia,
peraltro, confermò che le tracce di Epo nel suo corpo erano minime, «segno
evidente di come il ciclista non avesse mai fatto un uso costante di sostanze
dopanti». E poi, tutte quelle “incongruenze”, reperibili in libri-denuncia come
“Vie et mort de Marco Pantani” (Grasset, 2007) e “Era mio figlio” (Mondadori,
2008). E poi, soprattutto: «Che senso aveva quel messaggio in codice accanto al
cadavere?». Colori e rose, “la rosa rossa è la più contata”. Anche i suoi amici,
ricorda Franceschetti, dissero che la morte di Pantani in quell’hotel non poteva
esser stata casuale: forse Marco voleva «lasciare un messaggio a qualcuno»,
perché «era un uomo che non faceva nulla a caso». Meglio ancora: «Non era lui
che voleva lasciare un messaggio, ma chi l’ha ucciso», chiosa l’avvocato, sempre
attento ai possibili “segni invisibili”: «Probabilmente c’è un significato anche
nel fatto che sia morto a San Valentino, giorno in cui tradizionalmente si
regalano rose alla fidanzata». Pantani “costretto” ad andare in quel preciso
albergo affinchè poi il delitto fosse “firmato”? «Ovviamente, dire che dietro un
delitto c’è la “Rosa Rossa” significa poco: essendo la “Rosa Rossa”
un’organizzazione internazionale, e contando centinaia di affiliati in Italia, è
come dire che si tratta di un delitto di mafia o di camorra». Un’affermazione
«talmente generica da essere pressoché inutile a fini investigativi». Tuttavia,
«dovrebbe essere un buon indizio perlomeno per non archiviare la cosa come
suicidio». Franceschetti considera «evidente» l’origine «massonica» degli
attacchi a Pantani, citando l’anomalo incidente che, anni prima, lo vide
protagonista a Torino: fu travolto da un’auto che era penetrata in un’area
interdetta al traffico, lungo la discesa della collina di Superga, quella dove
si schiantò l’aereo del Grande Torino. La basilica di Superga, sull’altura che
domina la città, fu costruita nel 1717, «anno in cui venne ufficialmente fondata
la massoneria». Basta questo, all’avvocato, per concludere che si tratta di «una
firma manifesta, specie alla luce delle stranezze di quell’incidente». Tra gli
“incidenti non casuali”, Franceschetti inserisce pure quello ai danni del
cantante Rino Gaetano: come anticipato in modo inquietante dal testo di una sua
canzone, “La ballata di Renzo”, peraltro gremita di “rose rosse”, l’artista morì
a Roma nella notte del 2 giugno 1981 dopo esser stato rifiutato da 5 diversi
ospedali. «Statisticamente, le probabilità che un cantante descriva la morte di
qualcuno perché viene rifiutato da 5 ospedali, e che poi muoia nello stesso
identico modo sono… nulle». Molto strana, aggiunge Franceschetti, è anche la
tragica fine del ciclista Valentino Fois, della stessa squadra di Pantani: anche
lui muore per cause da accertare, ma alcuni giornali parlano subito di overdose,
«e già questo fa venire qualche sospetto». Premessa: in Italia, muoiono per
omicidio circa 2.500 persone all’anno. E altrettante finiscono suicide. Giornali
e Tv si disinteressano della stragrande maggioranza di questi episodi. «Quando
però su un fatto scatta l’attenzione dei media, in genere questo è un segnale
che sotto c’è dell’altro. Quindi viene spontanea la domanda: perché i giornali
si interessano alla morte di un ciclista poco conosciuto come Fois?». Premesso
che nello sport professionistico il doping (entro certi limiti) è pressoché
inevitabile, Franceschetti sospetta che Fois sia morto «per aver “tradito”, come
Pantani». Ovvero, i due avrebbero «pagato con la vita la loro maggiore pulizia e
onestà intellettuale rispetto al resto dell’ambiente in cui vivevano». Secondo
Franceschetti, c’è anche «non il sospetto, ma la certezza» che la verità non
verrà mai a galla. Del resto, «la maggior parte delle famiglie di queste vittime
non saprà mai la verità, la maggior parte muore senza che i familiari sospettino
un omicidio». E racconta: «Io stesso, dopo il primo incidente che mi capitò,
pensai ad un caso. E dopo il secondo pensavo che ce l’avessero con la mia
collega e che avessero manomesso contemporaneamente sia la mia moto che la sua
per maggior sicurezza di fare danni a lei. In altre parole, potevo morire senza
sapere neanche perché, e pochi avrebbero sospettato qualcosa». E aggiunge: «Ogni
volta che prendo l’auto sono consapevole che lo sterzo potrà non funzionare, che
un’auto che viene in senso inverso all’improvviso potrà sbandare e venire verso
di me, o magari che potrò avere un malore nell’anticamera di una Procura come è
successo al capo dei vigili testimone della Thyssen Krupp». La storia italiana,
aggiunge l’avvocato, è troppo gremita di “coincidenze”, depistaggi e collusioni:
le bombe nelle piazze, Ustica, Moby Prince. «In quei casi i familiari delle
vittime ormai hanno capito, ma negli altri?».
La storia infinita del “mostro di Firenze”, ad
esempio, sembra il frutto di un “normale” serial killer solitario. Secondo
Franceschetti, invece, tutti quegli omicidi non sono altro che precise
esecuzioni rituali, settarie ed esoteriche, meticolosamente pianificate da un
clan criminale protetto da amicizie potenti. «Ho telefonato ai genitori di
Pantani prima di scrivere questo articolo», scriveva Franceschetti nel 2008.
«Dal loro silenzio successivo al mio fax presumo che abbiano pensato che io sia
un folle, magari un mitomane in cerca di pubblicità. E’ normale che lo pensino,
come è normale che la maggior parte delle persone che leggeranno queste righe le
prendano per un delirio». Continua Franceschetti: «Un mio amico medico legale, a
cui ho raccontato le mie “scoperte”, mi ha lasciato di stucco quando mi ha
detto: “Sì, Paolo, lo sapevo. Tutti quei suicidi in carcere per soffocamento con
buste di plastica sono impossibili dal punto di vista medico-legale”».
L’esoterismo «è un linguaggio: se non lo conosci è come camminare per le strade
di una nazione straniera, vedi le scritte ma non ti dicono nulla, sembrano segni
innocui e invece sono messaggi precisi». Difficile parlarne, «perché ti prendono
per matto». E il guaio è che, «quando capisci il sistema», è problematico
«continuare a fare la vita di sempre senza impazzire».
Marco Pantani per Paolo Franceschetti fu ucciso da
un complotto, scrive Sonia Paolin su “Delitti”. E’ la tesi di Paolo
Franceschetti, esperto di massoneria ed esoterismo Marco Pantani aveva dato
fastidio a molti poteri forti che si sono uniti per eliminarlo. La morte di
Marco Pantani? Frutto di un complotto che pare da lontano e che mescola misteri
ed esoterismo, medicina, poteri forti e massoneria. A sostenerlo è Paolo
Franceschetti, noto esperto della materia che insieme a Fabio Frabetti e
Stefania Nicoletti da qualche tempo ha anche aperto un blog specifico, "Indagine
sulla morte di Marco Pantani". Diverse le colpe di cui si sarebbe macchiato il
campione, tutte punite con la sua morte: parlava senza peli sulla lingua senza
aver timore di nessuno, infangando il sistema del doping, delle case
farmaceutiche e delle sponsorizzazioni; vinceva troppo, non voleva piegarsi alle
regole del gioco, e non permetteva a nessuno di dirgli quando e come vincere;
destabilizzava anche gli equilibri geopolitici internazionali. Ora, intervistato
sul blog di Vice, la trasmissione di approfondimento e inchiesta di Sky Tg24,
Franceschetti ha chiarito i suoi sospetti: “La stranezza di questo caso è sempre
stata considerare la morte di Marco come un suicidio e non un omicidio. La morte
di Marco è un stato un omicidio eccellente, con coperture e depistaggi
eccellenti. È sempre stato chiaro, a chiunque, non solo a me. Credo proprio che
in questo momento qualcuno stia tremando. Magari stanno pensando a un cambio di
potere, ai vertici, qualcosa così. I gruppi di potere a cui dava fastidio
Pantani. Basta vedere la sua storia per vederlo. Nella sua vita si è messo
contro un sacco di gente. con battaglie, anche in tribunale. Pantani era
scomodo, sosteneva verità che normalmente nel mondo dello sport non vengono
portate avanti”. E cita fatti già noti, peraltro già accantonati da molti: “Il
declino di Pantani iniziò quando rifiutò la sponsorizzazione della Fiat (divenne
testimonial di Citroen, ndr). Quella decisione gli è costata cara. C’è la droga
poi, il doping, ma anche altro. Tanto per dirtene una c’è anche la pista
americana. Marco vinceva tutto, forse troppo. Gli americani tengono parecchio
alla loro immagine nel mondo e in quel momento avrebbero voluto che Armstrong
diventasse il loro nuovo numero uno. Pantani si era messo in mezzo”. E qui si
arriva ai mandanti: “C’è la firma dell’organizzazione che ha commissionato il
fatto, che è l’ordine della Rosa Rossa. E’ uno degli ordini più potenti nel
mondo, e i suoi componenti di grado più elevato sono ai vertici di banche,
multinazionali, istituzioni di alto livello. Non sono teppisti da quattro soldi.
Sono ovunque. Pantani muore all’hotel Le Rose, di fianco al cadavere, sul
comodino, la polizia trova un bigliettino su cui c’è scritta una sorta di
poesia, di filastrocca. “Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le
rose sono rosa e la rosa rossa è la più contata.” Poi c’è la data del delitto.
Marco muore il giorno di San Valentino. San Valentino è il santo dell’amore e
quindi delle rose, e se fai la somma dei numeri che compongono la data, uno per
uno, il numero finale è 13. Se guardi i tarocchi il tredici corrisponde alla
morte, e i tarocchi sono ovviamente un’espressione dell’esoterismo”.
L’omicidio massonico. Tutti lo vedono, tranne gli
inquirenti, scrive Paolo Franceschetti. Gli omicidi commessi dalla massoneria
seguono tutti un preciso rituale e sono – per così dire - firmati. Dal momento
che le associazioni massoniche sono anche associazioni esoteriche, in ogni
omicidio si ritrovano le simbologie esoteriche proprie dell’associazione che
l’ha commesso; simbologie che possono consistere in simboli sparsi sulla scena
del delitto, o nella modalità dell’omicidio, o nella data di esso. Questo
articolo è però necessariamente incompleto, nel senso che sono riuscito a capire
la motivazione e la tecnica sottesa ad alcuni delitti solo per caso, con l’aiuto
di alcuni amici, giornalisti, magistrati o semplici appassionati di esoterismo.
Ma devo ancora capire molte cose. La mia intenzione è di fornire però uno spunto
di approfondimento a chi vorrà farlo. Evitiamo di ripercorrere i principali
omicidi, perché ne abbiamo accennato nei nostri precedenti articoli
(specialmente ne“Il testimone è servito” e in quello sul mostro di Firenze).
Facciamo invece delle considerazioni di ordine generale. I miei dubbi sul fatto
che ogni omicidio nasconda una firma e una ritualità nacquero quando mi accorsi
di una caratteristica che immediatamente balza agli occhi di qualsiasi
osservatore: tutte le persone che vengono trovate impiccate si impiccano “in
ginocchio”, ovverosia con una modalità compatibile con un suicidio solo in linea
teorica; in pratica infatti, è la statistica che mi porta ad escludere che tutti
si possano essere suicidati con le ginocchia per terra, in quanto si tratta di
una modalità molto difficile da realizzare effettivamente. Così come è la
statistica a dirci che gli incidenti in cui sono capitati i testimoni di Ustica
non sono casuali; ben 4 testimoni moriranno in un incidente aereo, ad esempio,
il che è numericamente impossibile se raffrontiamo questo numero morti con
quello medio delle statistiche di questo settore. L’altra cosa che mi apparve
subito evidente fu la spettacolarità di alcune morti che suscitavano in me
alcune domande. Perché far precipitare un aereo, anziché provocare un semplice
malore (cosa che con le sostanze che esistono oggi, nonché con i mezzi e le
conoscenze dei nostri moderni servizi segreti, è un gioco da ragazzi)? Perché
“suicidare” le persone mettendole in ginocchio, rendendo così evidente a
chiunque che si tratta di un omicidio? (a chiunque tranne agli inquirenti,
sempre pronti ad archiviare come suicidi anche i casi più eclatanti). Perché nei
delitti del Mostro di Firenze una testimone muore con una coltellata sul pube?
(anche questo caso archiviato come “suicidio”). Perché una modalità così
afferrata, ma anche così plateale, tanto da far capire a chiunque il
collegamento con la vicenda del mostro? Perché firmare i delitti con una rosa
rossa, come nel caso dell’omicidio Pantani, in modo da rendere palese a tutti
che quell’omicidio porta la firma di questa associazione? Ricordiamo infatti che
Pantani morì all’hotel Le Rose e che accanto al suo letto venne trovata una
poesia apparentemente senza senso che diceva: “Colori, uno su tutti rosa arancio
come contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la più contata”. Ricordiamo
anche che Pantani ebbe un incidente (per il quale fece causa alla città di
Torino) proprio nella salita di Superga, ovverosia la salita dove sorge la
famosa cattedrale che fu eretta nel 1717, data in cui la massoneria moderna ebbe
il suo inizio ufficiale. Se questi particolari non dicono nulla ad un
osservatore qualsiasi, per un esperto di esoterismo dicono tutto. Tra l’altro la
collina di Superga è quella ove si schiantò l’aereo del Torino Calcio, ove morì
un’intera squadra di calcio con tutto il personale al seguito. Altra coincidenza
inquietante, a cui pare che gli investigatori non abbiano mai fatto caso. Perché
far morire due testimoni di Ustica in un incidente come quello delle frecce
tricolori a Ramstein, in Germania, destando l’attenzione di tutto il mondo? La
domanda mi venne ancora più forte il giorno in cui con la mia collega Solange
abbiamo avuto un incidente di moto. Con due moto diverse, a me è partito lo
sterzo e sono finito fuori strada; mi sono salvato per un miracolo, in quanto
l’incidente è capitato nel momento in cui stavo rallentando per fermarmi e
rispondere al telefono; Solange, che fortunatamente è stata avvertita in tempo
da me, ha potuto fermarsi prima che perdesse la ruota posteriore. Ora, è ovvio
che un simile incidente – se fossimo morti - avrebbe provocato più di qualche
dubbio. Magari a qualcuno sarebbe tornato in mente il caso dei due fidanzati
morti in un incidente analogo qualche anno fa: Simona Acciai e Mauro Manucci. I
due fidanzati morirono infatti in due incidenti (lui in moto, lei in auto)
contemporanei a Forlì. Nel caso nostro, due amici e colleghi di lavoro morti
nello stesso modo avrebbero insospettito più di una persona e sarebbero stati un
bel segnale per chi è in grado di capire: sono stati puniti. Per un po’ di tempo
pensai che queste modalità servivano per dare un messaggio agli inquirenti:
firmando il delitto tutti quelli che indagano, se appartenenti
all’organizzazione, si accorgono subito che non devono procedere oltre. Inoltre
ho pensato ci fosse anche un altro motivo. Lanciare un messaggio forte e chiaro
di questo tipo: inutile che facciate denunce, tanto possiamo fare quello che
vogliamo, e nessuno indagherà mai realmente. Senz’altro queste due motivazioni
ci sono. Ma ero convinto che ci fosse anche dell’altro, specie nei casi in cui
la firma è meno evidente. La risposta mi è arrivata un po’ più chiara quando ho
scoperto che Dante era un Rosacroce (dico “scoperto” perché non sono e non sono
mai stato un appassionato di esoterismo). Ora la massoneria più potente non è
quella del GOI, ma è costituita dai Templari, dai Rosacroce e dai Cavalieri di
Malta. E allora ecco qui la spiegazione dell’enigma: la regola del contrappasso.
Nell’ottica dei Rosacroce, chi arriva al massimo grado di questa organizzazione,
ha raggiunto la purezza della Rosa. Nella loro ottica denunciare uno di loro, o
perseguirlo, è un peccato. E il peccato deve essere punito applicando la regola
del contrappasso. Quindi: volevi testimoniare in una vicenda riguardante un
aereo caduto? Morirai in un incidente aereo. Volevi testimoniare in un processo
contro il Mostro di Firenze? Morirai con l’asportazione del pube, cioè la stessa
tecnica usata dal Mostro sulle vittime. La regola del contrappasso è evidente
anche ad un profano nel caso di Luciano Petrini, il consulente informatico che
stava facendo una consulenza sull’omicidio di Ferraro, il testimone di Ustica
trovato “impiccato” al portasciugamani del bagno. Petrini morirà infatti colpito
ripetutamente da un portasciugamani. Nel mio caso e quello della mia collega il
“peccato” consiste invece nell’aver denunciato determinate persone appartenenti
alla massoneria (in particolare quella dei Rosacroce). Per colmo di sventura poi
andai a fare l’esposto proprio da un magistrato appartenente all’organizzazione
(cosa che ovviamente ho scoperto solo dopo gli incidenti, decriptando la lettera
che costui mi inviò successivamente). Che è come andare a casa di Provenzano per
denunciare Riina. Nel caso di Fabio Piselli, invece, il perito del Moby Prince
che doveva testimoniare riguardo alla vicenda dell’incendio capitato al
traghetto, costui è stato stordito e messo in un’auto a cui hanno dato fuoco,
forse perché il rogo dell’auto simboleggiava il rogo della nave. Talvolta invece
il simbolismo è più difficile da decodificare e si trova nelle date, o in
collegamenti ancora più arditi, siano essi in casi eclatanti, o in banali fatti
di cronaca. Nel caso del giudice Carlo Palermo che il 02 aprile del 1985
tentarono di uccidere con un’autobomba a Pizzolungo (Trapani). Il giudice
Palermo era stato titolare di un’ampia indagine sul traffico di armi ed aveva
indagato sulla fornitura di armi italiane all’Argentina durante la guerra per le
isole Falkland, guerra scoppiata proprio il 02 aprile 1982 con l’invasione
inglese delle isole. L’autobomba scoppiò quindi nella stessa data, e tre anni
dopo (tre è un numero particolarmente simbolico). Ed ancora per quanto riguarda
l’omicidio di Roberto Calvi. Come ricorda il giudice Carlo Palermo: “Nella
inchiesta della magistratura di Trento un teste (Arrigo Molinari, iscritto alla
P2), dichiarò che Calvi – attraverso le consociate latino-americane del Banco
Ambrosiano – aveva finanziato l’acquisto, da parte dell’Argentina, dei missili
Exocet e in definitiva l’intera operazione delle isole Falkland”. I primi
missili Exocet affondarono due navi inglesi (la Hms Sheffield e Atlantic
Conveyor). Il 18 giugno 1982 Roberto Calvi fu trovato morto impiccato a Londra
sotto il ponte dei frati neri (nome di una loggia massonica inglese). Inoltre il
ponte era dipinto di bianco ed azzurro che sono i colori della bandiera
argentina. Nel caso del delitto Moro la scena del delitto è intrisa di
simbologie, dal fatto che sia stato trovato a via Caetani (e Papa Caetani era
Papa Bonifacio VIII, che simpatizzava per i Templari e a cui mossero le stesse
accuse rivolte a quest’ordine) alla data del ritrovamento, al fatto che sia
stato trovato proprio in una Renault 4 Rossa. Se Renault Rossa sta per Rosa
Rossa, la cifra 4 farebbe riferimento al quatre de chiffre (ma forse anche al
numero di lettere della parola “rosa”). Il mio articolo termina qui. Non voglio
approfondire per vari motivi. In primo luogo perché non sono un appassionato di
esoterismo e scendere ancora più a fondo richiederebbe uno studio approfondito e
molto tempo a disposizione, che io non ho. Il mio articolo è dettato invece
dalla voglia di indurre il lettore ad approfondire. E dalla voglia di dire a
chiunque che molti misteri d’Italia, non sono in realtà dei misteri, se si sa
leggere a fondo nelle pieghe del delitto. La conoscenza approfondita
dell’esoterismo e del modo di procedere delle associazioni massoniche
garantirebbe agli inquirenti, il giorno che prenderanno coscienza del fenomeno,
un notevole miglioramento dal punto di vista dei risultati investigavi. Questo
consentirebbe anche di capire alcuni meccanismi della politica italiana, che
spesso nelle loro simbologie si rifanno a queste organizzazioni. La croce della
democrazia Cristiana, ad esempio, probabilmente non è altro che la Croce
templare; mentre la rosa presente nel simbolo di molti partiti è probabilmente
nient’altro che la rosa dei RosaCroce. Quando dico queste cose mi viene risposto
spesso che la rosa della “Rosa nel pugno” è in realtà il simbolo dei radicali
francesi. E io rispondo: appunto, il simbolo dei RosaCroce, che non è
un’organizzazione italiana, ma internazionale. E che non ricorre solo per i
radicali ma anche per i socialisti e per altri partiti di destra. Questo
consentirebbe di capire, ad esempio, il significato del cacofonico nome “Cosa
Rossa” che si voleva dare alla Sinistra Arcobaleno; un nome così brutto
probabilmente non è un caso. Secondo un mio amico inquirente potrebbe derivare
da Cristian Rosenkreuz, il mitico fondatore dei RosaCroce. Mentre la Rosa Bianca
potrebbe fare riferimento alla guerra delle due rose, in Inghilterra; guerra che
terminò con un matrimonio tra Rosa bianca e Rosa Rossa. Al lettore appassionato
di esoterismo il compito di capire il significato delle varie morti che qui
abbiamo solo accennato. Non ho ancora capito, ad esempio, il perché dei
cosiddetti “suicidi in ginocchio”. Secondo un mio amico le gambe piegate trovano
un parallelismo con l’impiccato del mazzo dei tarocchi, che è sempre raffigurato
con una gamba piegata. Era la punizione riservata un tempo al debitore, che
veniva appeso in quel modo affinchè tutti potessero vedere la sua punizione e
potessero deriderlo. E infatti, tutti quelli che vedono un suicidio in ginocchio
capiscono che si trattava di un testimone scomodo e che si tratta di un
omicidio. Tutti, tranne gli inquirenti. (Io speriamo che non mi suicido).
L’omicidio massonico - Il caso Pantani e il caso
Fois, scrive ancora Paolo Franceschetti.
Premessa. In questo articolo approfondiamo alcuni
degli argomenti trattati nel precedente articolo sull’omicidio massonico e
chiariamo alcuni dubbi che l’articolo aveva suscitato specialmente in merito al
caso Pantani. In primo luogo l’articolo precedente terminava con una domanda. Mi
chiedevo cioè il motivo dell’immenso numero di persone “suicidate” (come si dice
in gergo) mediante impiccagione, e facendo toccare alla maggioranza di essere le
ginocchia per terra. Voglio poi rispondere alle molte domande che mi vengono
spesso rivolte: come si distingue l’omicidio massonico? E perché dico che
Pantani fu quasi sicuramente ucciso?
Impiccagioni e avvelenamenti, overdose. In primo
luogo un lettore mi ha inviato la sua spiegazione. il "suicidio in ginocchio"
rappresenta "l'omicidio consacrato" cioè la morte per "volere divino"... cosi
come si viene investiti degli onori alla vita, cosi si viene investiti degli
onori alla morte. Mi è pervenuto inoltre uno scritto, tratto dal libro di un
esoterista che ha, appunto, trattato questo argomento che riportiamo. Il libro è
di Lino Lista e si intitola: “Raimondo di Sangro. Il principe dei veli di
pietra”. In forma romanzata vengono rivelati alcuni aspetti del ritualismo
massonico che hanno quindi dato una risposta alla mia domanda sul motivo dei
tanti impiccati. La corda e l’impiccagione sono i simboli di Giuda e del
tradimento di Cristo. Ma il lavoro di Lino Lista svela anche un altro mistero.
Un’altra modalità frequente di uccisione, tanto frequente da gettare più di un
sospetto, ad esempio, è quella dell’avvelenamento da overdose, in cui sono
incappati, per fare qualche nome, il ciclista Pantani, poi di recente un altro
componente della sua squadra, il ciclista Valentino Fois, e a Viterbo il medico
Manca, ovvero il medico che pare abbia curato il boss mafioso Bernardo
Provenzano. Muoiono poi avvelenati anche molti testimoni di processi importanti.
Morì avvelenato in carcere Sindona. E poi molti “malori” improvvisi, talvolta
nell’anticamera di un giudice, in un tribunale, o nella buovette di Montecitorio
come capitò al generale Giorgio Manes. Voglio citare integralmente il passo del
libro di Lino Lista: La corda...(omissis)...è il segno dominante, che mai deve
mancare, di una vendetta massonica. Con riferimento alla leggenda di Hiram,
volendo spandere un maggior numero d’indizi, convenientemente si potrebbero
lasciare accanto al cadavere del giustiziato, seppur di veleno: dell’acqua, in
ricordo della fontana alla quale il Vendicatore smorzò la sete; un osso spezzato
di cane, in onore dell’Incognito che si mutò in tal bestia; un abito nero, in
memoria del lutto per Padre Hiram. Volendo eccedere, ma mai una società segreta
dovrebbe eccedere perchè troppi indizi talvolta sono considerati alla stregua di
una prova, si potrebbe collocare sulla salma del traditore un mattone, simbolo
muratorio. Queste morti da overdose, quindi, non sono un caso. Anche
l’avvelenamento è una modalità “massonica” perché simboleggia la morte per mano
del serpente, simbolo dell’infedeltà e dell’inganno. Ecco quindi perché Pantani
morirà dopo aver ingerito diverse dosi di coca. Perché sostengo che sia un
omicidio? Perché ogni qualvolta l’incidente, o il malore, o il suicidio, sono
provocati, e sono quindi un omicidio, immancabilmente partono, a seguito del
fatto, i depistaggi e gli occultamenti che solo un potere come quello massonico
è in grado di fornire: sparizione dei fascicoli dai tribunali, morte dei
testimoni, la pervicace volontà degli inquirenti nell’ignorare determinate prove
(per collusione, paura, o per la mancata conoscenza del problema), le
irregolarità procedurali, ecc…
Il caso Pantani. Esaminiamo il caso Pantani, così
come ce lo descrive un giornalista, Philippe Brunel, in un recente libro “Gli
ultimi giorni di Marco Pantani” su cui ci basiamo per la nostra ricostruzione.
E’ noto che Pantani morirà all’hotel Le rose di Rimini per una presunta overdose
da cocaina. Anche qui troviamo tutti gli elementi di un omicidio massonico,
ovverosia le firme, nonchè tutte le modalità procedurali investigative che gli
inquirenti seguono quando il delitto è massonico.
Ad esempio troveremo:
- testimoni che cambieranno versione;
- gli inquirenti che ignorano particolari
fondamentali nell’indagine: ad esempio nel cestino dei rifiuti della stanza
dell’hotel verranno rivenuti resti di una cena presa da un ristorante cinese. Ma
Pantani non mangiava cibo cinese. Allora chi c’era con lui quell’ultima notte?
- Sul corpo compaiono segni di colluttazione ma
nessuno accerterà mai se, ad esempio, sotto le unghie compaiano o meno dei resti
di DNA altrui per verificare se Pantani fu forzato a ingerire cocaina (v. pag.
278).
- Errori e omissioni varie nelle autopsie.
- Una volante della polizia, con due agenti,
interverrà sul luogo dell’incidente, ma non redigerà mai il verbale relativo.
Perché questa irregolarità nelle procedure?
- Le varie perizie medico legali fanno una gran
confusione sull’ora della morte che collocano tra le 11,30 (la perizia del
dottor Fortuni) e le 19 (il medico Toni).
Dire esattamente quanti siano i massoni a Bologna
è difficile, per quanto si parli di circa 450 affiliati. Vicino alla massoneria
viene indicato il medico legale Giuseppe Fortuni, che si occupò di alcune
perizie sulla morte del ciclista Marco Pantani, stroncato da un’overdose di
cocaina il 14 febbraio 2001 in un residence di Rimini, scrive Antonella Beccaria
su “Il Fatto Quotidiano”. E lo stesso accade per l’imprenditore Vittorio Casale,
uomo di Massimo D’Alema e che, tra le molte opere di cui si è occupato, ha
partecipato a progetti di ristrutturazione del patrimonio di Propaganda Fides e
di enti religiosi.
- Il medico legale che dopo l’autopsia si accorge
di essere seguito.
- La camera fu trovata in disordine come se ci
fosse stato un corpo a corpo.
Poi ci sono le domande irrisolte.
- Perché Pantani, volendosi suicidare, prende una
stanza in un albergo a pochi chilometri dalla casa dove abitava?
- Perché prima di suicidarsi ci resta qualche
giorno? Cosa lo fa rimanere in una stanza di albergo quando aveva la sua
abitazione lì vicino?
- Uno degli inquirenti dichiara al giornalista di
avere avuto pressioni dal Ministero dall’interno per concludere in fretta
l’indagine. Ma il ministero non dovrebbe avere fretta di concludere; casomai
dovrebbe avere la volontà di accertare la verità senza lasciare dubbi. Curioso
poi che il Ministero si disinteressi del fatto che dopo decenni non sia mai
venuta fuori la verità per stragi come Ustica, o per il sequestro Moro, e
improvvisamente abbia fretta di concludere per un personaggio come Pantani.
Difficile pensare che sotto ci sia una voglia di arrivare velocemente alla
verità, dato che l’occultamento della verità è sistematico nella storia
giudiziaria italiana. Mai abbiamo sentito un politico affermare che nel
programma elettorale c’era la volontà di scoprire la verità sulle tante stragi
impunite per dare giustizia alle migliaia di morti e alle decine di migliaia di
famiglie delle vittime delle stragi. Mai. Anzi, in compenso alcuni degli autori
di crimini assurdi, come l’ex terrorista D’Elia, hanno addirittura avuto
incarichi istituzionali (sottosegretario alla camera nel governo Prodi).
Personaggi che hanno avuto pesanti responsabilità in vicende come il sequestro
Moro verranno addirittura fatti presidenti della Repubblica (Cossiga). Nessuna
fretta di scoprire chi ha abbattuto l’aereo di Ustica, nessuna fretta di
arrivare alla verità sul Moby Prince, nessuna fretta di scoprire chi c’è dietro
ai delitti del Mostro di Firenze, dietro ai Georgofili, dietro a Piazza Fontana,
dietro alla strage di Bologna. Ma una gran fretta di chiudere il caso Pantani.
Curioso no? Tutte queste contraddizioni, depistaggi, ecc., sono sempre l’indizio
sicuro della presenza della massoneria. In alternativa può ipotizzarsi che si
tratti di incuria o superficialità nell’indagine. Ma si tratta di incuria e
superficialità troppo ricorrenti per essere casuali. Poi ci sono le firme.
Quelle firme che chi non si è mai occupato di massoneria non riesce a vedere. Ma
immediatamente visibili per chi vive in mezzo a queste vicende. Anzitutto
Pantani muore all’hotel Le Rose, il cui nome potrebbe non essere casuale ma
essere la firma della Rosa Rossa. D’altronde anche i suoi amici diranno che la
morte di Pantani in quell’hotel non deve essere un caso, ma forse voleva
lasciare un messaggio a qualcuno perché lui era un uomo che non faceva nulla a
caso (pag. 52). Forse, aggiungo io, non era lui che voleva lasciare un
messaggio, ma chi l’ha ucciso. E poi viene trovato accanto al corpo un biglietto
con una frase apparentemente senza senso: Colori, uno su tutti rosa arancio come
contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la più contata. Non sono in grado
di capire il senso di questo biglietto; ci vorrebbe un esperto e pochi in Italia
sono in grado di capire questi messaggi. Ma indubbiamente sembra un messaggio in
codice. Probabilmente c’è un significato anche nel fatto che sia morto a San
Valentino, giorno in cui tradizionalmente si regalano rose alla fidanzata.
Qualcuno ipotizza che abbia un senso anche la data della sua morte: 14/02/2004,
data la cui somma fa 13, che nelle carte dei tarocchi non a caso è la carta
della morte. Nonostante non sia in grado di decodificare tutti i particolari è
evidente però che Pantani fu in qualche modo costretto ad andare in quel preciso
albergo affinchè poi il delitto fosse firmato. Ovviamente dire che dietro un
delitto c’è la Rosa Rossa significa poco. Essendo la Rosa Rossa
un’organizzazione internazionale, e contando centinaia di affiliati in Italia, è
come dire che si tratta di un delitto di mafia o di camorra. Cioè significa
affermare una cosa talmente generica da essere pressocchè inutile a fini
investigativi, e tuttavia dovrebbe essere un buon indizio perlomeno per non
archiviare la cosa come suicidio. D’altronde che gli attacchi a Pantani
provenissero da ambienti massonici risulta evidente dal fatto che qualche anno
prima ebbe un incidente anomalo nella discesa di Superga. Un auto entrò nella
zona vietata al traffico e investì Pantani e altre due persone. Un incidente
casuale? Difficile, da pensarsi, perché sulla collina di Superga sorge quella
cattedrale omonima, che venne costruita nel 1717, anno in cui venne
ufficialmente fondata la massoneria. Una basilica e una collina, insomma, che
hanno un particolare significato per la massoneria. Per chi sa anche solo poche
cose sulla massoneria si tratta di una firma manifesta, specie alla luce delle
stranezze di quell’incidente (inspiegabile ad esempio è come avesse fatto la
macchina a inserirsi nella zona vietata, tanto che Pantani fece causa alla città
di Torino per questo fatto).
La parola ai testimoni. Per chi conosce le vicende
delle stragi italiane gli incidenti stradali per rottura dei freni o dello
sterzo, non sono una novità, I testimoni di queste stragi, i personaggi scomodi,
muoiono sempre così: non solo impiccati e avvelenati, ma anche in incidenti
banali in cui l’auto (o la moto) escono di strada all’improvviso per un
malfunzionamento. Qualcuno ogni tanto si salva. Ricordo a memoria – tra gli
scampati - il carabiniere Placanica (implicato nei fatti del G8), il giudice
Forleo (ma non così fu per i genitori, che morirono in un incidente analogo
senza ovviamente che gli inquirenti volessero indagare). Persino il famoso
Enrico Berlinguer disse di aver avuto un incidente da cui si era salvato per
miracolo, durante un suo viaggio in Bulgaria nel 1973, in cui morirono però
altre due persone; disse che l’incidente era voluto, ma nessuno gli credette. Di
recente Fabio Piselli, scampato al rogo della sua auto, più volte nominato nei
miei articoli. Ma in tanti hanno avuto “incidenti anomali” e non si sono
salvati. Ne abbiamo parlato in precedenti articoli e non voglio ripetermi.
Voglio invece ricordare alcuni morti del mondo dello sport e dello spettacolo.
Ayrton Senna, cui fu montato male lo sterzo della sua formula 1. Per non parlare
del Torino Calcio; l’aereo ebbe un guasto imprecisato e si schiantò contro –
guarda tu che caso - la collina di Superga. Il cantante Rino Gaetano che ebbe
due incidenti identici, con la stessa auto; nel primo incidente si salvò; nel
secondo morì, anche perché 5 ospedali si rifiutarono (misteriosamente) di
prenderlo in cura. Il cantante morì il 2 giugno 1981 nello stesso identico modo
in cui muore il protagonista di una sua canzone, La ballata di Renzo.
Statisticamente le probabilità che un cantante descriva la morte di qualcuno
perché viene rifiutato da 5 ospedali, e che poi muoia nello stesso identico modo
sono…. nulle. E statisticamente, le probabilità che qualcuno svolga veramente
delle indagini sono le stesse di questi incidenti: nulle.
Mass Media e delitti. Molta strana è anche la
morte del ciclista Valentino Fois, della squadra di Pantani. Anche lui muore per
cause da accertare, ma alcuni giornali parlano di overdose. E già questo fa
venire qualche sospetto, in quanto probabilmente muore nello stesso modo del suo
ex amico. Occorre a questo punto fare una considerazione di ordine generale sui
mass media in Italia. In Italia muoiono per omicidio circa 2500 persone
all'anno. E altrettante ne muoiono suicide. Giornali e Tv si disinteressano di
questi fatti, selezionando accuratamente solo le notizie che piacciono e sono
funzionali al sistema. Quando però su un fatto scatta l’attenzione dei media, in
genere questo è un segnale che sotto c’è dell’altro. Quindi viene spontanea la
domanda. Perché i giornali si interessano alla morte di un ciclista poco
conosciuto come Fois? E perché poi, nei pochi secondi che i TG dedicano alla
notizia, occorre precisare che era implicato in un furto di portatili?
Quand’anche si voglia dar risalto alla morte di un uomo, non c’è alcuna
necessità di informare il pubblico che costui – forse – aveva rubato dei PC. In
primo luogo perché la notizia è generica e posta in forma dubitativa. In secondo
luogo perché non si capisce quale collegamento possa sussistere tra un furto di
PC e una morte per overdose. Il sospetto che sia un omicidio, e che la
televisione abbia volutamente voluto riportare l’immagine di una persona drogata
e dedita al furto, è molto forte. Il messaggio che si vuole trasmettere è
questo: è morto un ladro e per giunta drogato e depresso. Ma chi invece ha
capito come funziona l’informazione in Italia capisce chiaramente un altro
messaggio: probabilmente si tratta di un omicidio e c’è sotto qualcosa. E allora
il pensiero corre al fatto che qualche prima avesse rilasciato un intervista
alle jene. Aggiungiamo poi una cosa. Chi frequenta a livello professionistico il
mondo dello sport sa che il doping è un fenomeno assolutamente diffuso, nel
senso che probabilmente non è possibile partecipare a qualsiasi tipo di sport
senza doparsi. Nella mia esperienza del passato, per anni ho praticato Body
Building e ho seguito corsi per diventare istruttore di questa disciplina. E il
doping era una materia di studio assolutamente ufficiale, nel senso che nella
preparazione atletica di uno sportivo professionista non si poteva prescindere
dal doping. Il problema era solo come eludere i controlli, stare attenti ai
tempi di eliminazione della sostanza ecc... C’è quindi il forte sospetto che
Fois sia morto in questo modo per aver “tradito”, come Pantani, e che i due
abbiano pagato con la vita la loro maggiore pulizia e onestà intellettuale
rispetto al resto dell’ambiente in cui vivevano.
Considerazioni finali. C’è anche (non il sospetto
ma) la certezza, che la verità non verrà mai a galla. Anzi, a dire queste cose,
purtroppo, si rischia di passare per matti o visionari. La cosa che mi dà
tristezza, in tutta questa vicenda, non è la gravità delle collusioni
istituzionali a tutti i livelli, né la scarsa preparazione di molti inquirenti
in materia che si traduce in una mancata tutela del cittadino. Questo ho
imparato ad accettarlo, perché viviamo in una democrazia troppo giovane perché
sia veramente una democrazia. Le mentalità e i costumi di secoli non possono
cambiare in pochi anni. L’oligarchia mascherata in cui viviamo, in fondo, un
giorno dovrà finire per dare spazio ad una nuova era. Ciò che mi dà tristezza è
pensare che la maggior parte delle famiglie di queste vittime non saprà mai la
verità. La maggior parte muore senza che i familiari sospettino un omicidio. Io
stesso dopo il primo incidente che mi capitò pensai ad un caso. E dopo il
secondo pensavo che ce l’avessero con la mia collega e che avessero manomesso
contemporaneamente sia la mia moto che la sua per maggior sicurezza di fare
danni a lei. In altre parole; potevo morire senza sapere neanche perché e pochi
avrebbero sospettato qualcosa. Solo dopo qualche tempo mi spiegarono chi ce
l’aveva come me e perché. Ora, perlomeno, so che mi potrebbe succedere qualcosa
e so anche il perché. Ogni volta che prendo l’auto sono consapevole che lo
sterzo potrà non funzionare, che un auto che viene in senso inverso
all’improvviso potrà sbandare e venire verso di me, o magari che potrò avere un
malore nell’anticamera di una procura come è successo al capo dei vigili
testimone della Tyssen Krupp. Ma all’epoca dei primi incidenti, non avevo
neanche il sospetto di essere stato “condannato a morte”. Perché non ero
consapevole di quale colpa avessi commesso e di quale peccato mi fossi
macchiato.
Mi domando se Senna sapeva il destino che lo aspettava, se i familiari avranno
capito. I familiari del Torino Calcio cosa penseranno di quell’incidente
terribile? E i genitori di Fois? E la Forleo, cui scrissi “una lettera aperta”
dalle pagine di questo blog… avrà capito esattamente cosa le è successo oppure
penserà che il suo incidente d’auto sia stato casuale? I familiari delle vittime
di via dei Goergofili, di Ustica, del Moby Prince, hanno capito. Lì sono troppo
grosse le collusioni, troppo evidenti gli omicidi e i depistaggi perché qualcuno
non capisca. Ma gli altri? I familiari dei testimoni di processi apparentemente
normali, come quelli della Tyssen Krupp, o del Mostro di Firenze, che
apparentemente sembra un normale caso di un serial Killer? E i familiari di
tutte quelle persone che parevano condurre una vita normale, perché il delitto è
maturato in un luogo ove nessuno sospetterebbe l’ingerenza così pesante dei
cosiddetti poteri occulti, come il mondo sportivo? Ho telefonato ai genitori di
Pantani prima di scrivere questo articolo. Dal loro silenzio successivo al mio
fax presumo che abbiano pensato che io sia un folle, magari un mitomane in cerca
di pubblicità. E’ normale che lo pensino, come è normale che la maggior parte
delle persone che leggeranno queste righe le prendano per un delirio. Allora
voglio ricordare le parole dell’onorevole Falco Accame, a proposito degli
incidenti anomali (come quello capitato ai genitori del giudice Forleo) o dei
suicidi dei vari testimoni di processi importanti. Parlavamo dell’incidente
capitato al giudice Forleo, e mi disse “inizialmente, quando mi occupai di
queste cose, credevo al caso. Non volevo credere che fosse una cosa voluta
perché mi pareva fantascienza. Poi, quando mi accorsi che i testimoni morivano
tutti, sistematicamente, ho capito… E’ una cosa che è difficile da accettare.”
Questo articolo, come il precedente, è scritto per tutti i familiari di persone
suicidate, impiccate, morte in incidenti inspiegabili che hanno sempre capito
che la versione ufficiale data dagli inquirenti non quadrava, affinchè perlomeno
loro sappiano la verità. Oramai sono troppe le vittime sparse per la penisola,
perché non si cominci a sospettare. E sono troppi i sopravvissuti perché
qualcosa prima o poi non venga fuori. Oramai parlo con tante persone esperte e
mi confronto. Molti, tanti, hanno capito. Un mio amico medico legale, a cui ho
raccontato le mie “scoperte” mi ha lasciato di stucco quando mi ha detto “si
Paolo, lo sapevo. Lo sapevo perché da medico legale mi rendo conto quando ci
prendono in giro in TV e sui giornali. Tutti quei suicidi in carcere per
soffocamento con buste di plastica sono impossibili dal punto di vista di medico
legale. Analizzando alcuni dei più importanti casi dal punto di vista medico
legale mi sono accorto che ci prendono in giro. E poi sono un appassionato di
esoterismo, e quindi i loro simboli e messaggi io li vedo. Vedi? L’esoterismo è
un linguaggio. Se non lo conosci è come camminare per strade di una nazione
straniera; vedi la gente, vedi le scritte, ma non ti dicono nulla; in certi casi
potrebbero sembrarti innocui disegnini. Ma se invece lo conosci allora riesci a
leggere oltre la superficie e capire i messaggi profondi che vengono lanciati e
gli innocui disegnino diventano frasi precise. Capisci tutto, ma con la maggior
parte delle persone non puoi parlare perché ti prendono per matto. E il problema
principale, quando capisci il sistema, è continuare a fare la vita di sempre
senza impazzire”. Questo, signori, è il sistema in cui viviamo ma con un po’ di
studio e di intuito si può imparare a capirlo. Il paradosso è che non sono mai
stato un appassionato né di gialli, né di spionaggio, né di esoterismo; ma credo
che neanche la più fervida fantasia di qualsiasi scrittore abbia mai immaginato
un sistema del genere. La realtà, per chi la vuole vedere, supera sempre di gran
lunga la fantasia. Anche quella di Stephen king, che forse non a caso ha scritto
una serie di telefilm che si intitola The Red Rose, e che forse per i suoi libri
non si è ispirato alla sua sola fantasia (ad es. nei “Lupi del Calla”, occorre
proteggere una sola rosa rossa che sta in una Torre nera; e se la Rosa venisse
distrutta per qualche motivo la Torre cadrebbe insieme alla Rosa). Ps finale.
Quando facevo il quarto ginnasio rubai tre biscotti (erano dei Ringo per la
precisione) al mio miglior amico, Daniele. Voglio precisare, in caso di suicidio
da parte mia, che i due fatti non sono collegati, al fine di evitare che i media
mi facciano lo scherzo di Fois e che riportino la notizia facendomi passare per
un ladro di biscotti. Peraltro confessai il mio crimine a Daniele, il quale dopo
25 anni non manca mai di ricordarmelo.
Pantani, un altro giallo. Un fax cambia
l’ora della morte. Il medico legale refertò il decesso
alle 11-12.30 Ma lo stesso perito indicò al pm anche le 17, scrive Marco
Bonarrigo su “Il Corriere della Sera”. Un fax dimenticato tra carte
investigative vecchie di dieci anni colora ancora più di giallo la morte di
Marco Pantani, sulla quale la Procura di Rimini, lo scorso agosto, ha riaperto
un’indagine con l’ipotesi di omicidio. È un fax partito alle 20.50 del 16
febbraio 2004, 48 ore dopo la scoperta del cadavere del corridore. Mittente il
medico legale Giuseppe Fortuni, destinatario il magistrato di Rimini Paolo
Gengarelli, che aveva incaricato Fortuni dell’autopsia. Il medico, con la
dicitura «riservato e urgente», scrisse: «Al termine dell’esame autoptico sulla
salma, la informo che il decesso può datare attorno alle ore 17 del 14 febbraio
2004... Allo stato attuale delle indagini medico-legali, la causa può essere
indicata in un collasso cardiocircolatorio terminale». Ma nelle 240 pagine del
rapporto definitivo, depositato un mese dopo, la collocazione del decesso cambiò
radicalmente: secondo Fortuni, Pantani muore tra le 11.30 e le 12.30, come
dimostrato dai dati raccolti da chi per primo ispezionò il cadavere al Residence
Le Rose di Rimini (il dottor Francesco Toni) e dalle evidenze dell’autopsia.
Orario confermato dalla recente perizia del professor Francesco Maria Avato,
consulente della famiglia Pantani, che si limita a posticipare la morte di 15
minuti. Giuseppe Fortuni è un’autorità del settore: sul suo tavolo autoptico
sono passati i corpi di Ayrton Senna e Meredith Kercher. Per quale motivo
formalizzare un orario di morte incompatibile con le evidenze scientifiche? Ma
su quell’orario c’è un altro aspetto inquietante. Quando la polizia scopre il
cadavere, al polso di Pantani, ben visibile nel filmato della scientifica che il
Corriere della Sera ha visionato per intero, c’è il Rolex Daytona cui Marco era
legatissimo. L’orologio è fermo. Segna cinque meno cinque. Un dettaglio che
(come le impronte digitali o la cocaina presente su un bicchiere e su una
bottiglia a fianco del corpo) viene trascurato. Il Daytona fu restituito alla
famiglia che l’ha conservato come un cimelio. Secondo i tecnici (ma adesso il
cronografo, mai più utilizzato, è stato avviato a una perizia accurata) un
modello così sofisticato, a carica automatica, si ferma solo quando resta
immobile per almeno cinquanta ore o subisce un forte colpo. Il colpo l’orologio
di Pantani l’ha subito alle 5 meno 5 del 14 febbraio. Alle cinque del mattino
Pantani era certamente vivo. Alle 17 era morto da cinque ore secondo la perizia
medica legale ufficiale oppure stava morendo secondo il primo rapporto inviato
da Fortuni. E qui il giallo vira verso il nero, perché se Pantani è morto
attorno alle 12 (come confermano dati oggettivi e incontestabili) bisogna
spiegare perché l’orologio si ferma alle 17, la medesima ora indicata nel primo
rapporto di Fortuni. Davanti al procuratore capo di Rimini, Paolo Giovagnoli, in
questi giorni sfilano vecchi e nuovi testimoni dell’inchiesta. Tra loro almeno
due, indicati da Antonio De Rensis, il legale dei Pantani, in grado di smontare
uno degli assunti incrollabili degli investigatori: quello che nella stanza B5
del Residence Le Rose di Rimini non sia entrato nessuno da tre giorni prima
della morte del Pirata al momento della scoperta del cadavere. In quella stanza
entrò sicuramente qualcuno prima della morte e, probabilmente, anche qualcuno
dopo. Qualcuno la cui azione potrebbe aver causato il blocco dell’orologio e
provocato l’ormai palese messa in scena di una camera «messa a completamente
soqquadro in un delirio da cocaina» dove però non venne trovato un solo oggetto
danneggiato, compresi specchi e ceramiche, delicatamente appoggiati sul
pavimento. Caos organizzato in una morte che di organizzato ormai comincia ad
avere un po’ troppo.
Pantani: un video conferma l'inquinamento
delle prove, scrive Mirko Nicolino su “Outdoorblog”.
Su Marco Pantani, la verità sembra ancora molto lontana. La famiglia dell’ex
ciclista non si è mai rassegnata, convinta com’è che loro figlio non si sia
suicidato, bensì sia stato ucciso da qualcuno, che poi ha architettato una scena
di follia all’interno della camera d’albergo presso la quale il ‘Pirata’ è stato
trovato senza vita. Dopo il giallo sull’orario del decesso, con il fax del
perito che indica un’ora diversa rispetto a quella assodata inizialmente, ora
spunta anche un video inedito che confermerebbe la tesi della famiglia Pantani e
del suo legale, secondo cui la scena del crimine sia stata contaminata e non
tutte le prove siano state raccolte dagli esperti che sono stati chiamati a fare
luce sull’accaduto. Oggi 14 ottobre 2014, l’edizione delle 13 di Sportmediaset
ha mandato in onda uno spezzone di un video inedito: in tutto, il filmato consta
di 51 minuti, su un totale di tre ore di sopralluogo nella stanza del Residence
Le Rose in cui si trovava Pantani al momento del decesso. Già qui c’è qualcosa
che non quadra e la Procura di Rimini, che ha aperto un fascicolo per fare luce
sulla morte del Pirata, vuole vederci chiaro: se il sopralluogo è realmente
stato di tre ore, il video dovrebbe avere la stessa durata, altrimenti si
potrebbe pensare che sia stato "tagliato". Perché? Dallo spezzone del video
mostrato dal biscione e commentato in studio da Davide De Zan e in collegamento
dal generale Garofalo, capo dei Ris di Parma dal 1995 al 2009, emergono dettagli
per certi versi inquietanti. Sono passati oltre 10 anni e chiaramente le
tecniche per raccogliere le prove sulla scena di un crimine oggi sono più
all’avanguardia, ma dal filmato emerge una sostanziale incuria da parte delle
persone, dovrebbero essere quattro, che hanno effettuato il primo sopralluogo.
Si vedono chiaramente persone che vagano per la stanza senza protezione e
toccano un po’ di tutto. Addirittura, qualcuno fa cadere delle posate per terra,
che poi non vengono raccolte, ma filmate esattamente così come sono, quasi a
voler far sembrare che fossero parte del caos trovato in albergo. L’elemento che
desta più scalpore, però, è una bottiglia d’acqua che potrebbe essere stata
usata per far ingerire la cocaina a Pantani: il medico legale chiede di poterla
toccare, ma gli dicono di lasciarla così dov’è. Fin qui tutto bene, meglio non
contaminare anche quella. Peccato, però, che quella bottiglia non sia stata mai
presa in esame per individuare oltre alle evidenti tracce di cocaina, eventuali
impronte digitali. Incuria e approssimazione, in definitiva, che gettano nuove
nubi sulle indagini effettuate a suo tempo.
Pantani e quei tagli nel video della
polizia che mostra le ferite del Pirata. Girato dalla
scientifica nel residence dove fu trovato il corpo. Il filmato dura 51 minuti,
ma ci sono salti temporali. Da alcune immagini pare che il cadavere sia stato
trascinato, scrive Marco Bonarrigo su “Il Corriere della Sera”. Sarà che siamo
abituati alla gelida efficienza delle serie tv forensi americane, mentre queste
immagini sono tremolanti e disordinate. Sarà che quel corpo martoriato riverso
sul pavimento non è un attore o un manichino. Ma Marco Pantani. Sarà per questo
che si esce sconvolti dalla visione del video girato dalla polizia scientifica
nella stanza D5 del Residence Le Rose a Rimini, la sera del 14 febbraio 2004. 51
minuti registrati nell’arco di tre ore, con salti temporali e d’inquadratura che
sorprendono il professor Francesco Donato, docente di Tecniche investigative
applicate all’Università di Bologna: «Per avere valore - spiega Donato - un
video girato sulla scena di un crimine deve essere un continuo d’inquadratura.
Il video è stato tagliato? E perché?». Se lo chiede anche la parte civile che ha
chiesto una perizia. Il filmato mostra, oltre al sangue e alle ferite sul corpo
di Pantani, inspiegabilmente minimizzate dal perito del tribunale, anche le
debolezze della tesi che ha orientato l’inchiesta fin da subito: morte da
overdose. Il corpo di Pantani è costretto in uno spazio microscopio tra letto e
parete, dove è quasi impossibile sia precipitato in seguito a un malore. Le
striature allungate di sangue attorno al volto mostrano segni di trascinamento.
La cintura dei jeans disegna un’ampia, innaturale asola sul lato destro del
corpo, suggerendo in maniera immediata che questa sia servita per trascinarlo.
Poi l’obbiettivo si sofferma sul Rolex bloccato sulle 5 meno 5, sul medico
legale che indica della polvere bianca sul collo di una bottiglia, mai
periziata. Nella stanza, al contrario di medico e operatore, girano senza
indumenti di protezione cinque investigatori. E si sentono almeno due volte in
sottofondo rumori di posate che cadono sul pavimento. E ci sono, ripresi in
maniera incoerente, i dettagli di quel «caos ordinato» su cui punta forte
Antonio De Rensis, l’avvocato della famiglia Pantani: si possono divellere uno
specchio da un muro o un lavandino da terra, rovesciandoli sul pavimento, senza
minimamente danneggiarli e, stando ai vicini di stanza, senza il minimo rumore?
«Quando un investigatore entra in una scena del crimine - spiega il professor
Donato - dovrebbe osservare e filmare con curiosità ed obiettività, sgombrando
la mente da idee preconcette per individuare il maggior numero di elementi utili
sia alla ricostruzione dell’evento, sia all’identificazione del suo autore.
Altrimenti si rischiano errori enormi». Frammentario e incoerente, il filmato
oggi resta prezioso: tra i testimoni che stanno sfilando questi giorni in
Procura a Rimini c’è chi - mai ascoltato prima - forse è in grado di dare una
motivazione a quel caos fornendo una chiave decisiva alla nuova inchiesta.
Pantani, via agli interrogatori, perizia
su video Polizia, scrive Francesco Ceniti su “La
Gazzetta dello Sport”. I dubbi sulla versione di Mengozzi, l'amico del Pirata.
Adesso tocca alla manager Ronchi. Le immagini sono state tagliate? Entra nel
vivo l'inchiesta Pantani. La Procura di Rimini ha iniziato gli interrogatori
delle persone informate sui fatti: già sentito Michael Mengozzi, l'amico del
Pirata che avrebbe dovuto tenerlo lontano dagli spacciatori, ma che nel dicembre
2003 gli presentò l'escort russa Elena Korovina diventata l'ultima "compagna"
del Pirata in una relazione che poco aveva a che fare con l'amore. Ascoltato
pure il dottore Giovanni Greco, entrato in scena nella vita di Pantani in modo
prepotente nell'ultimo anno e spesso in contatto con Mengozzi. Tra oggi e domani
toccherà a Manuela Ronchi, manager del ciclista dal 1999 al febbraio 2004,
giorno della tragica scomparsa. Che cosa è emerso da questi primi interrogatori
condotti dalla polizia giudiziaria delegata dal procuratore capo Paolo
Giovagnoli? Dentro il residence — La presenza di Mengozzi a Rimini nella notte
del mistero non era passata inosservata. L'amico (poi non tanto amico, secondo
mamma Tonina) piomba al Residence le Rose intorno alle 22.15. Di certo la
polizia lo fa passare, facendolo entrare nei luoghi delle indagini, mentre tiene
lontano la sorella e la zia di Pantani. Mengozzi avrebbe confermato una certa
confidenza con l'ispettore Laghi: è lui a sentirlo la mattina del 15.
L'imprenditore di Predappio (gestore di una discoteca) avrebbe detto di essere
andato a Rimini una volta appresa la notizia della morte da una amica (informata
dalla tv), ma sugli orari forse è necessario un approfondimento. Mengozzi
racconta di trovarsi a cena a Milano Marittima: "Ho corso più veloce che
potevo", avrebbe riferito. Fatto sta che alle 22.15 è già a colloquio con la
polizia, ma le prime agenzie (e quindi i primi rimbalzi in tv) arrivano 15
minuti dopo. Non solo, per raggiungere Rimini da Milano Marittima ci vuole
almeno mezz'ora. Domanda: chi a quell'ora era già a conoscenza della morte di
Pantani? I 3 giubbini da sci — Il dottor Greco, invece, avrebbe riconfermato
quello messo a verbale 10 anni fa: "Pantani aveva un atteggiamento compulsivo
nei confronti della cocaina: si isolava per giorni assumendone quantitativi
impressionanti, fumandola e inalandola". Nulla di nuovo in sostanza, neppure sul
fronte medicinali che lui stesso aveva prescritto al Pirata per evitargli crisi
pericolose. Medicinali presi dal romagnolo con puntualità anche la mattina del
14 e che, secondo la perizia del professor Avato, sono incompatibili con i 20
grammi segnalati dall'autopsia. Attesa anche per la deposizione della Ronchi:
dovrà spiegare i vari intrecci legati a Mengozzi e Greco, ma soprattutto
ricordare a chi consegnò i tre giubbini da sci lasciati da Pantani nel suo
appartamento di Milano e trovati misteriosamente dentro la stanza della
tragedia. Altra novità: finisce sotto perizia il video girato dalla Polizia
nell'hotel la notte del 14 febbraio. Le immagini durano 51', ma il lasso di
tempo coperto è di circa 3 ore. Anomalia bella grossa: di solito non sono
possibili black out. I periti nominati dall'avvocato Antonio De Rensis, legale
della famiglia Pantani, cercheranno di stabilire se il video ha subito dei tagli
oppure se la telecamera è stata spenta più volte.
Caso Pantani, il mistero del lavandino
spostato, scrive Francesco Ceniti su “La Gazzetta
dello Sport”. È una testimonianza raccolta all’inizio della settimana a
raccontare lo stato dell’appartamento del Pirata. Ma negli atti giudiziari il
lavandino è al suo posto. "La scena non potrò mai dimenticarla: appena entrato
nell’appartamento occupato da Pantani c’era il lavandino al centro della
stanza... Una cosa incredibile, poi ho visto tutto il resto e il povero
Marco...". Tenete bene a mente questo verbale: rischia seriamente di portare ai
primi indagati della nuova inchiesta sulla morte del Pirata. La scena raccontata
non lascia molti margini di manovra. La testimonianza chiave è stata resa a
inizio settimana da una persona informata sui fatti. Una delle prime a entrare
nell’appartamento D5 del residence Le Rose a Rimini. Siamo intorno alle 20.30,
molti minuti prima dell’arrivo di medici e polizia. La presenza del lavandino
smontato dal bagno e posizionato in mezzo alla stanza potrebbe essere inquadrato
come un’alterazione dei luoghi. Perché il lavandino in tutti gli atti ufficiali
è al suo posto. Stessa cosa nel video girato dalla polizia scientifica a partire
dalle 23 del 14 febbraio. Insomma, chi ha spostato il lavandino e soprattutto
perché? le ipotesi — Certo, qualcuno potrebbe sostenere che il testimone
racconti il falso o ricordi male. La prima ipotesi è alquanto poco credibile:
quale motivo avrebbe avuto una persona che aveva un alibi di ferro e non è mai
stato indagato a esporsi in questo modo? Quanto alla memoria, c’è da raccontare
un particolare: nel 2004 questo stesso testimone era stato ascoltato, ma non
aveva fatto menzione al lavandino. Come mai? E’ la stessa domanda posta
nell’interrogatorio di lunedì (durato 30 minuti) dalla polizia giudiziaria
delegata dal procuratore Giovagnoli. La risposta è stata disarmante: "Nessuno me
lo aveva chiesto". A chiederlo per primo è stato l’avvocato Antonio De Rensis,
legale della famiglia Pantani, nel corso delle indagini difensive svolte nei
mesi scorsi. Lì il lavandino è uscito per la prima volta. Uno dei punti forti
dell’esposto era proprio questa testimonianza. La Procura ha fatto il resto:
chiedendo conferma. E la conferma è arrivata, senza esitazioni: "Il lavandino
era al centro della stanza, come si fa a dimenticarlo". Già, come si fa? La
stanza di Pantani è stata trovata a soqquadro, con molte cose messe fuori posto.
"Un disordine ordinato" lo ha definito il professor Avato nella perizia
contenuta nell’esposto. Come a dire: una messinscena per coprire quello che era
realmente accaduto nella stanza. Per l’inchiesta del 2004 le cose andarono
diversamente: quel caos era stato provocato da Pantani nel delirio da overdose
di cocaina che lo avrebbe condotto alla morte. E quindi in preda a questo
delirio se la sarebbe presa con qualunque cosa, fino a smontare un lavandino a
mani nude senza farsi neppure un graffio! Perché per la versione ufficiale
nessuno entra nella stanza del Pirata. E quindi alle 20.30, quando il testimone
vede il lavandino, può essere stato solo Pantani a metterlo lì. Poi torna al suo
posto, misteriosamente. Come mai? Forse chi è arrivato dopo si è reso conto che
non poteva reggere la tesi di un lavandino smontato a mani nude? E allora si
rimette in fretta al suo posto prima d’iniziare il sopralluogo ufficiale? La
Procura dovrà interrogare varie persone e capire cosa è accaduto. E magari
toccherà anche al nuovo perito, il professor Tagliaro, visionare foto e video
per verificare il lavandino. Non solo, il testimone afferma un altro fatto: "È
stata la polizia a tranciare i materassi". Anche questo negli atti ufficiali del
2004 non risulta. Il registro degli indagati forse è stato già aperto...
Pantani, l’omicidio svelato dall’orologio
fermo? Continua Francesco Ceniti. Nuove rivelazioni:
era al polso del Pirata e segnava le 17.05: un guasto possibile solo se battuto.
Spostavano forse il corpo? E c’è quel fax del perito Fortuni che riporta la
stessa ora... L’orologio. Quello al polso di Marco Pantani. Ha scandito le
ultime ore del Pirata, come una cronometro. E adesso dopo oltre 10 anni potrebbe
segnare una svolta nella nuova inchiesta riaperta a luglio dalla Procura di
Rimini con ipotesi omicidio volontario. Tra le tante anomalie delle indagini di
10 anni fa, ne spunta un’altra clamorosa. Antonio De Rensis, legale della
famiglia Pantani, presenterà un nuovo documento per evidenziare una serie di
fatti inquietanti: il Rolex Daytona del Pirata potrebbe aver registrato l’ora
nella quale qualcuno ha spostato il cadavere, entrando nella stanza e forse
mettendola a soqquadro per la messinscena finale. E il mistero diventa sempre
più fitto: c’è un documento ufficiale mandato dal professor Fortuni al pm di
allora Gengarelli che collima alla perfezione con l’orario sospetto: 17.05.
Quando la polizia consegna alla famiglia gli effetti personali di Pantani
considerati non importanti per l’indagine, c’è pure il Rolex. E’ al polso di
Marco ormai cadavere, ma nessuno prende le impronte o ordina una perizia (cosa
che potrebbe accadere ora se il professor Tagliaro, incaricato da Rimini per una
nuova consulenza, chiederà di esaminarlo). L’orologio è fermo alle 17.05 del 14
febbraio. Non è un problema di carica: si è rotto un meccanismo come scopre
mamma Tonina quando lo porta in un negozio di Rimini. Può il Rolex aver
continuato a camminare per ore, bloccandosi poi per fine carica? Non può, perché
quel modello una volta indossato e mosso anche solo per pochi minuti va avanti
per almeno 12 ore. Può essersi rotto parzialmente nella caduta del Pirata per
poi fermarsi alle 17 e 5? Non può, perché qualunque guasto meccanico blocca le
lancette quasi istantaneamente. E allora qual è l’ipotesi? Presto detta:
qualcuno può aver fatto sbattere il polso di Pantani (contro il pavimento, un
mobile o la scala) mentre spostava il cadavere. Tesi confortata da altri due
aspetti. Il primo: il professor Avato dopo aver esaminato le foto dell’autopsia
segnala una ferita al polso compatibile con una forte botta o una compressione.
Il secondo: sempre Avato evidenzia tracce di trascinamento del cadavere
osservando il sangue intorno al Pirata, tracce lasciate tra le 15 e le 18 del 14
febbraio. Dopo non sarebbe stato possibile: il liquido ematico era diventato
cemento. E arriviamo al fax di Fortuni. Il 16 febbraio 2004 il professore dopo
l’autopsia manda un fax urgente al pm Gengarelli: «La informo che il decesso di
Pantani può datarsi intorno alle 17». Guarda caso proprio l’ora indicata
dall’orologio. Magari è una coincidenza, ma resta l’errore (singolare, a quei
livelli) di un professore universitario che sbaglia di parecchio l’ora della
morte che lo stesso Fortuni correggerà nei giorni successivi, portandola tra le
11.30 e le 12.30. Nel frattempo l’orologio è già sparito dall’inchiesta. Anzi,
non c’è mai entrato...
MARCO PANTANI. ASPETTANDO GIUSTIZIA.
La solitudine, il residence e la coca.
Quegli ultimi giorni del Pirata, scrive Alessandra
Nanni su “Quotidiano Nazionale”. La morte di Marco Pantani comincia il 9
febbraio del 2004, quando arriva a Rimini a bordo di un taxi. Sta scappando da
Milano, dopo una lite furibonda con i genitori. Sarà l’ultima volta che vedranno
quel figlio in fuga da se stesso, dal campione che era stato e di cui lui per
primo non vede più che l’ombra. È l’inchiesta che ha portato al processo, a
ricostruire i suoi ultimi giorni di vita. Il Pirata è sprofondato nella cocaina,
e mentre il suo corpo tiene ancora il colpo di 15 grammi al giorno, il suo cuore
batte di una rabbia smisurata. Come quando correva è di nuovo irraggiungibile,
ma la sua ‘vetta’ ora è solo la coca, e in riviera c’è il suo fidato fornitore,
Fabio Miradossa. Al processo riminese, testimoni, investigatori e imputati hanno
messo insieme i pezzi di quei cinque giorni. Pantani si fa scaricare
dall’autista lungo il viale, e va dritto a casa degli amici che ospitano lo
spacciatore. Ma Miradossa non c’è, mamma Tonina ha minacciato di farlo arrestare
se avesse continuato a vendere droga al figlio. Si è spaventato ed è tornato di
corsa a Napoli. Per lui, per tutti, il campione è diventato un cliente che
scotta. Ma Pantani non accetta un rifiuto, pianta una grana: devono trovare il
napoletano. Capiscono che non mollerà, e fanno pressione su Miradossa: liberaci
di Pantani. Lo spacciatore cede e incarica il suo galoppino di accontentare il
campione. È Ciro Veneruso, quella stessa sera, a consegnare a Pantani i 30
grammi di cocaina che lo uccideranno il 14 febbraio. Appartamento
5D, al quinto piano del residence Le Rose. Il Pirata ci arriva a mezzogiorno di
quel lunedì, e da allora lo vedranno di rado. Racconteranno di un uomo rinchiuso
in un mondo immaginario, frasi sconnesse, insofferenza. Scende solo a fare
colazione, qualche incursione al bar per una pizzetta. Non mangia altro e
tollera a malapena la donna delle pulizie. Come un animale braccato che si lecca
le ferite dell’ingiustizia, sceglie il buio. Le tapparelle della stanza sono
abbassate come in una grotta, sta macinando migliaia di chilometri solo con se
stesso. «Si lamentava del rumore — racconteranno i clienti — bastava un passo
per fargli spalancare la porta». «Chiamate i carabinieri» urla in un delirio che
riempie di pena chi è testimone di tutto quel dolore. Alle 11,30 di sabato,
Pantani chiama la portineria e chiede di non essere disturbato più, non gli
interessa che la camera venga rifatta. Sono le 19, quando il portiere suona alla
porta del 5D. Nessuna risposta, scende in cortile per cercare una luce al quinto
piano, ma non riesce a vedere e il telefono della stanza dà sempre occupato. È
preoccupato, decide di entrare con una pila di asciugamani. Usa il passepartout,
ma la porta si apre solo di uno spiraglio, il mobile della tv e del telefono
sono rovesciati. Dentro l’appartamento il caos, come un uragano. «Poi sono
salito nel soppalco, era a terra adagiato su un fianco, non respirava più». Fine
della corsa.
CHI HA UCCISO PANTANI ? A DIECI ANNI DALLA SUA
MORTE, IL CASO RIAPRE E SI INDAGA...........
PANTANI, CASO RIAPERTO DOPO 10 ANNI: “FU UCCISO? DOBBIAMO
APPROFONDIRE”, scrive Guglielmo Buccheri per “la Stampa”.
Cinquemila pagine fotocopiate, decine di testimonianze e immagini. L’esposto
voluto dalla famiglia di Marco Pantani è finito sul tavolo del procuratore di
Rimini Paolo Giovagnoli ed ora l’indagine è aperta come riporta la Gazzetta
dello Sport. «Non fu suicidio volontario, ma Pantani fu ucciso...», sostengono i
familiari del campione romagnolo e, da ieri, è l’ipotesi a cui lavoreranno gli
inquirenti. «Nessun commento, dobbiamo approfondire. Bisognerà fare delle
valutazioni anche alla luce del risultato del processo che ci fu a suo tempo.
Quando - precisa il procuratore Giovagnoli - arriva un esposto-denuncia per
omicidio volontario è sempre un atto dovuto aprire un’indagine...». La svolta,
clamorosa, è sul tavolo. E, in un attimo, i fatti della notte del 14 febbraio di
dieci anni fa tornano sotto i riflettori. La procura di Rimini si metterà al
lavoro, lo farà dopo l’estate e l’indagine appena aperta durerà almeno un anno
prima di arrivare alle sue conclusioni. La famiglia del Pirata, da sempre, ha
sostenuto come non fossi possibile che il loro Marco avesse deciso di chiudersi
nella stanza della pensione sul lungomare per dire basta. Ora, dopo un decennio
di dubbi e perplessità, ecco il primo passo: l’esposto presentato in procura
dall’avvocato Antonio De Rensis, e accompagnato da una perizia accurata, è stato
giudicato fondato, ma dire oggi quale potrebbe essere il punto di arrivo è fin
troppo prematuro. «Non fu suicidio, ma Pantani fu ucciso...», sostengono nella
loro dettagliata ricostruzione i familiari del Pirata. «Ora esca la verità...»,
così gli ex colleghi, ma, soprattutto, amici del romagnolo, Claudio Chiappucci e
Davide Cassani. «Non capisco perchè ci sia stato tutto questo ritardo, è giusto
che si vada a fondo sulla tragica morte di Marco...», sottolinea Chiappucci.
«Forse - così Cassani - si sono date per scontate troppe cose che non lo erano.
Chi ha voluto bene a Marco vuole capire cosa realmente sia accaduto quella
notte...». Il lavoro della procura di Rimini non sarà facile. Come detto dal
procuratore Giovagnoli occorrerà ripartire nell’inchiesta tenendo conto degli
sviluppi che hanno portato alle conclusioni del processo già celebrato. Da tempo
la famiglia Pantani non perdeva occasione per chiedere la riapertura del caso
che, adesso, riaccendere l’attenzione sugli attimi di vita del campione delle
due ruote. Per presentare l’esposto c’è voluto un faticoso impegno, fra
difficoltà nel reperire il materiale e riuscire nella visione di documenti e
faldoni datati quasi dieci anni. Dopo l’estate, i pm si metteranno in azione.
AVEVA CHIESTO AIUTO E FORSE NON
ERA SOLO NELLA STANZA MALEDETTA, scrive Giorgio Viberti per “la Stampa”.
Domande
e risposte sui misteri di quella notte.
Perché Marco
Pantani è uno dei campioni più amati e insieme discussi nella storia dello sport
e non solo nel ciclismo?
«Perché si
dimostrò pressoché imbattibile sulle montagne, dove fece entusiasmare i tifosi
quasi come ai tempi di Bartali e Coppi, ma subì poi una sospensione dalle corse
molto discussa e morì ancora giovane, a 34 anni, in circostanze quasi
misteriose».
Per molti
Pantani non fu soprattutto il simbolo di un ciclismo diventato ostaggio del
doping?
«In quegli anni
tanti corridori usarono farmaci vietati e alcuni in seguito lo confessarono,
eppure Pantani in 12 anni di professionismo non risultò mai positivo
all’antidoping».
Ma non morì per
un eccesso di cocaina?
«È quanto
asserì l’inchiesta dopo la sua morte, avvenuta il 14 febbraio 2004. E
paradossalmente fu quella l’unica volta in cui Pantani risultò positivo a una
sostanza dopante».
Pantani
assumeva cocaina anche quando correva?
«Non venne mai
rilevata nei tanti test ai quali si sottopose da corridore, ma è probabile che
Pantani abbia cominciato ad assumere cocaina dopo lo choc per l’esclusione dal
Giro d’Italia 1999, che aveva ormai quasi vinto, a due tappe dalla fine per
ematocrito alto, cioè perché aveva il sangue troppo denso».
Perché si torna
a indagare sulla morte del Pirata dopo dieci anni dalla sua morte?
«La mamma
Tonina e il papà Paolo non hanno mai accettato la tesi del suicidio involontario
per overdose di cocaina. Insieme con i loro legali hanno raccolto una serie di
dati e testimonianze che hanno convinto i giudici a riaprire l’inchiesta».
Ma è lecito
pensare che la prima inchiesta non sia riuscita a fare piena luce sulle cause
della morte?
«Secondo molti
ci sarebbero tante incongruenze e contraddizioni che quantomeno lascerebbero
molti dubbi sulle conclusioni delle indagini di dieci anni fa. Di sicuro, se è
stata riaperta l’inchiesta, devono essere emersi elementi nuovi e importanti di
valutazione».
Per esempio?
«C’è l’ipotesi
che Pantani non fosse solo nella stanza del residence in cui fu trovato senza
vita. Lo farebbero pensare alcuni abiti che non dovevano essere lì, del cibo che
il Pirata non amava e non avrebbe mai mangiato, il disordine troppo «ordinato»
della stanza, una doppia ma vana richiesta di aiuto che il Pirata fece alla
reception, l’enorme quantità di cocaina trovata nel suo organismo come se fosse
stato costretto a ingerirla, le escoriazioni sul suo corpo, i segni sul
pavimento come se il cadavere fosse stato trascinato... Incredibile poi che
l’hotel nel quale morì Pantani sia stato ristrutturato pochissimo tempo dopo,
come se fosse urgente cancellare ogni prova residua».
Chi è riuscito,
dopo tanto tempo, a trovare tanti nuovi indizi?
«L’avvocato
Antonio De Rensis, per conto dei signori Pantani, ha studiato i faldoni sia
delle indagini di allora, sia quelli relativi al successivo processo. Ma non
basta, perché sono stati sentiti di nuovo alcuni testimoni chiave di quella
vicenda. È stata poi molto preziosa una perizia medico-legale eseguita dal
professor Francesco Maria Avato, che ha aggiunto tantissimi elementi nuovi».
Ma perché
queste cose non emersero subito?
«È quanto
eventualmente stabilirà questa seconda inchiesta. Di sicuro la prima autopsia
sul corpo di Pantani sbagliò a indicare l’ora presunta della morte e si rivelò
molto superficiale anche nel valutare alcuni dati di medicina legale che
avrebbero potuto aiutare a fare chiarezza sul caso».
Chi avrebbe
avuto interesse a falsificare l’esito dell’inchiesta?
«Difficile
dirlo, di sicuro Pantani era finito in un giro di droga che magari coinvolgeva
anche persone molto importanti. Avrebbe potuto parlare e fare dei nomi».
Per questo
potrebbe essere stato ucciso?
«È questa la
tesi sostenuta dai legali dei genitori di Marco. Ed è quanto dovrà appurare
questa seconda inchiesta. L’ipotesi di reato è addirittura di omicidio
volontario a carico di ignoti e alterazione del cadavere e dei luoghi. Il
procuratore capo di Rimini, Paolo Giovagnoli, ha affidato il fascicolo a Elisa
Milocco, giovane sostituto procuratore. Toccherà a lei far luce su quanto
avvenne quel giorno».
«LO SCRISSI GIÀ ALLORA: TROPPI PUNTI OSCURI», scrive ancora Giorgio Vibereti per “la
Stampa”. Philippe Brunel, giornalista francese e
inviato speciale del quotidiano parigino L’Équipe, l’aveva già scritto nel suo
libro «Gli ultimi giorni di Marco Pantani»: la morte del Pirata ha molti lati
oscuri.
Brunel, che ne
pensa di questa nuova inchiesta?
«L’avevo già detto dieci anni fa. Nella morte di
Pantani ci sono troppe incongruenze, troppi episodi inspiegabili per poter
accreditare la tesi del suicidio involontario».
È quanto però
emerse dalla prima inchiesta...
«Mi interesso da molti anni di ciclismo,
soprattutto italiano, e fui incaricato da L’Équipe di indagare, cercare di
capire, raccogliere testimonianze e prove sulla morte di Pantani. E le cose non
quadravano».
Che cosa
soprattutto la lasciò perplesso?
«Tante cose. Marco era una persona precisa,
quadrata e amabile. Impossibile che si sia messo a urlare e spaccare tutto nella
sua stanza d’albergo, come dissero invece gli inquirenti della prima inchiesta».
Tutto qui?
«No, certo. Nella camera del residence Le Rose era
stato portato del cibo che Marco odiava e non avrebbe mai mangiato, e poi le
escoriazioni sul suo corpo, la bottiglia d’acqua mai analizzata, certi indumenti
che non avrebbero dovuto essere lì, quel disordine troppo ordinato, il mancato
rilevamento delle impronte...».
Per lei Pantani
non era solo in quella stanza, vero?
«Ne sono sicuro. In quel residence si poteva
entrare anche dal parcheggio sul retro, di sicuro Marco è stato raggiunto dal
suo pusher ma credo anche da altre persone. Incredibile poi che quell’albergo,
cioè la scena della morte di Pantani, sia stato completamente ristrutturato dopo
pochissimo tempo, cancellando di fatto anche le eventuali possibili prove
rimaste».
Ma chi e perché
avrebbe voluto la morte di Pantani?
«Temo ci fossero sotto interessi molto grossi, che
magari coinvolgevano anche persone importanti. Una storia di droga e
prostituzione. Pantani era diventato un tossicodipendente, che frequentava gente
senza scrupoli. A un certo punto non ha più saputo controllare la situazione, e
ci ha rimesso la vita. Una morte oscura e irrisolta, però, come quelle di Tenco
o Pasolini».
Brunel, che
cosa si augura ora dalla nuova inchiesta?
«Marco era una persona sensibile e generosa che
spesso si spingeva fino agli estremi, come faceva in bici. Per lui il ciclismo
era finito e si sentiva smarrito, perduto. Ma era un uomo sincero e molto
intelligente, che diceva sempre ciò che pensava e che sarebbe potuto diventare
scomodo. Non può essere morto come un disperato, per un’overdose, da solo in una
stanza d’albergo. Non è andata così. Marco merita giustizia».
«Verità lontana dagli atti ufficiali».
Da una parte gli atti di un processo che non ha
mai convinto fino in fondo. Dall’altra le indagini fatte dall’avvocato Antonio
De Rensis. Sono questi i tasselli utilizzati dal professor Francesco..., scrive
“Il Tempo”. Da una parte gli atti di un
processo che non ha mai convinto fino in fondo. Dall’altra le indagini fatte
dall’avvocato Antonio De Rensis. Sono questi i tasselli utilizzati dal professor
Francesco Maria Avato per la sua perizia, il cuore dell’esposto che ha fatto
riaprire il caso Pantani con l’ipotesi di reato, per ora a carico di ignoti, di
omicidio volontario. Il medico legale - perito, tra l’altro, del caso Bergamini
- per definirsi usa lessico da ciclista: «Ho solo aggiunto un tassello da umile
gregario al lavoro del legale», commenta. «La mia esperienza mi ha portato a
conclusioni diverse sulla morte di Marco Pantani. Si è trattato di rivedere gli
atti di causa e non solo, ma anche informazioni recuperate dalle indagini
difensive mettendo insieme i frammenti come in un puzzle. È stato un lavoro di
equipe con De Rensis». Il lavoro del professor Avato si è basato sull’autopsia
del campione morto a Rimini il 14 febbraio 2004 e sull’analisi di foto e video
delle indagini, giungendo a conclusioni differenti rispetto alla prima perizia e
all’esame autoptico effettuato quasi 48 ore dopo il ritrovamento del cadavere di
Marco Pantani. «Sono questioni di pertinenza dell’autorità giudiziaria -
aggiunge il medico legale - non posso esprimermi al di là del fatto che il
quantitativo di cocaina rinvenuta suggeriva modalità di assunzione diverse da
quelle classiche. Sono indagini molto delicate e complesse. Non vogliamo creare
confusione o disagio». La parola adesso è ai magistrati. «Il mio lavoro finito?
- risponde Avato - Dipende dalle informazioni ulteriori che possono giungere,
tutto è perfettibile nella vita».
«Pantani non è stato ucciso».
Parla Fortuni, il medico della prima perizia
sulla morte del campione. «Overdose al termine di un delirio da cocaina. Lo
provano i suoi scritti», scrive Davide Di Santo su “Il
Tempo”. «Non ci sono veri nuovi elementi oggettivi» che facciano pensare a «una
overdose "omicidiaria"». A parlare è Giuseppe Fortuni, il medico legale nominato
dalla Procura di Rimini per eseguire la perizia sul corpo di Marco Pantani ai
tempi del processo ai suoi pusher. È l’uomo «famoso» per essersi portato il
cuore del Pirata a casa, dopo l’autopsia terminata nella notte del 16 febbraio
2004. Pensava di essere seguito da auto sospette - più tardi si apprese che si
trattava di giornalisti - mentre tornava al laboratorio per depositare i
tessuti. Le sue conclusioni di allora sono messe oggi in discussione
dall’esposto presentato dal nuovo legale della famiglia Pantani, Antonio De
Rensis, secondo il quale il campione cesenate, quel giorno di San Valentino di
dieci anni fa, nel residence Le Rose di Rimini nel quale si era barricato, in
realtà sarebbe stato ucciso. La ricostruzione si basa sulle indagini del legale
e sulla nuova perizia di parte del professor Francesco Maria Avato. Pantani
avrebbe ricevuto la visita di uno o più uomini che dopo un diverbio lo avrebbero
aggredito e immobilizzato, costringendolo a bere un cocktail letale di acqua e
cocaina. Per Fortuni, però, il Pirata è morto da solo e in preda ad
allucinazioni. «Nessuno parla degli scritti deliranti di Pantani che furono
ritrovati nel residence - le sue parole - prova certa del suo delirio e in alcun
modo causabili da un overdose "omicidiaria" ma solo da un uso continuo e
crescente della cocaina». Il riferimento è a quanto scritto dal campione nelle
sue ultime ore. Pensieri affidati a fogli e quaderni, ma anche scritti sul muri
del bagno del bilocale riminese. Si va da accuse inquietanti, cariche di astio
(«Hanno voluto colpire solo me», forse un riferimento alla vicenda del doping)
alle composizioni nonsense («Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le
rose sono rosa e la rosa rossa è la più contata». E ancora: «Con tutti Marte e
Venere segnano per sentire»). Prove certe di un «delirio da cocaina», per il
perito della Procura. Eppure molti amici di Marco sostengono che anche quando
era lucido il campione scrivera poesiole e pensieri dello stesso tipo. La madre,
la signora Tonina, conserva ancora fogli e quaderni con quelle strane poesie.
L’altro elemento sottolineato nella prima perizia è la morte sopraggiunta dopo
l’assunzione prolungata di droga, circostanza che si scontra con l’ingestione
coatta, in un solo atto. Nell’organismo c’era una quantità sei volte superiore a
quella considerata la dose letale minima, ma nel sangue «periferico» la
concentrazione era addirittura tredici volte più alta, mentre l’esame del
midollo ha mostrato una compatibilità con un uso cronico della sostanza. Il
tutto in un quadro in cui omissioni e incongruenze sono superiori alle certezze.
Morte Pantani, professor Avato:
“Provinciale l’approccio alle indagini”.
"Ogni ricostruzione di un delitto dovrebbe partire dalla
medicina legale" afferma il professor Francesco Maria Avato sul caso Pantani. La
sua perizia ha contribuito all'indagine sulla morte del Pirata. "Un cold case è
sempre il segno di una primitiva sconfitta", scrive Alessandro Mastroluca su “Fan
Page”. Pantani è stato costretto ad assumere un enorme quantitativo di
droga. È questa la conclusione principale della nuova perizia medica completata
dal professor Francesco Maria Avato, incaricato dalla famiglia del Pirata e
dall’avvocato De Rensis. Il suo esame, insieme ai risultati delle prime indagini
di De Rensis, ha convinto Paolo Giovagnoli a riaprire il caso per omicidio.
Avato, coordinatore della sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni
dell’Università di Ferrara, ha eseguito la prima autopsia sul corpo di Denis
Bergamini, il “calciatore suicidato”. È il perito incaricato dalla difesa di
Alberto Stasi, accusato di aver ucciso la fidanzata, Chiara Poggi, a Garlasco.
Nel febbraio 2011, poi, insieme a Giuseppe Micieli della Neurologia
dell’Università di Pavia e a Francesco Montorsi dell’Urologia del San Raffaele
di Milano, incontra Bernardo Provenzano, per valutarne i problemi di salute che
lo avevano indotto a chiedere il permesso di poter uscire dal supercarcere di
Novara. Il suo esame sul corpo di Pantani si è basato sull’autopsia del
professor Fortuni e sull’analisi di quasi 200 foto a colori e del video della
Scientifica, ed è giunto a conclusioni diverse dal primo esame autoptico
effettuato quasi 2 giorni dopo il ritrovamento del cadavere. Avato accerta la
presenza nel corpo di un quantitativo di cocaina sei volte superiore alla dose
letale. La droga, ci spiega il professor Avato che abbiamo raggiunto
telefonicamente, “era in quantità tale da lasciar intuire un’assunzione in
forme diverse da quella classica. Il conteggio però è complicato, eviterei le
semplificazioni”, aggiunge. “Se poi l’abbia bevuta disciolta nell’acqua
o l’abbia mangiata, attiene alla ricostruzione di competenza dell’autorità
giudiziaria”. Fatto sta che nella stanza D5 del residence Le Rose c’erano
molliche di pane rigurgitate, con presenza di polvere bianca, e una bottiglietta
d’acqua mai esaminata dalla scientifica. Avato sposta
l’ora della morte tra le 10.45 e le 11.45 della mattina di San Valentino del
2004 e conclude che il cadavere sia stato spostato, probabilmente nel
pomeriggio, perché anche nel video della polizia si notano segni di
trascinamento spiegabili solo se il sangue fuoruscito non si era ancora
rappreso. “Il corpo era poggiato sul fianco sinistro” sottolinea Avato,
“con la parte destra più alta. Rimanendo così per molte ore, a causa
dell’emorragia il sangue sarebbe defluito maggiormente nel polmone sinistro”.
Invece è il destro a pesare di più, circa 200 grammi. Come nel caso della
morte di Denis Bergamini, anche la gestione
delle prime ore dopo il ritrovamento del cadavere “aprirebbe un discorso
davvero molto ampio sulle indagini investigative, sulle modalità di approccio al
delitto che definirei un po’ ‘provinciale‘” spiega Avato. “La medicina
legale dovrebbe essere la genitrice prima di ogni ricostruzione. Noi avevamo un
sistema di indagine che è stato un modello per tutto il mondo, ma l’abbiamo
trascurato e abbiamo sviluppato un approccio inglese, alla Scotland Yard, che è
antico”. Ogni vicenda delittuosa, prosegue Avato, “ogni episodio che
richieda competenze medico-legali è sempre diverso”. Nelle inchieste sulla
morte di Bergamini e di Pantani, tuttavia, c’è uno schema ricorrente:
un’indagine frettolosa, una tesi accettata dal primo momento come vera,
sopralluoghi tutt’altro che da manuale sulla scena. “Qui si tratterebbe di
considerare dall’inizio tutti i passaggi, le decisioni che hanno portato alla
formulazione iniziale. Il punto sostanziale è che le competenze richieste in
situazioni del genere devono sempre essere intese come competenze di altissimo
livello”. Ma così non è stato, come dimostra lo stesso video della
Scientifica in cui si vedono addetti che perlustrano la stanza senza protezioni,
senza guanti e non prendono le impronte digitali. Per questo, conclude Avato, “il
cold case non va inteso come un’occasione per mettere in rilievo le capacità
tecniche. Possiamo discutere se l’insufficienza originaria dipenda da
un’impostazione organizzativa o da altre cause. Ma la riapertura di un cold case
è sempre il marchio di una primitiva sconfitta”.
Marco Pantani non aveva più controllo sul
proprio patrimonio economico e immobiliare, scrive “Il
Tempo”. È quanto filtra da ambienti investigativi di polizia, secondo cui il
Pirata di fatto aveva un vitalizio che gestiva con la carta di credito
trovatagli nel portafoglio messo sotto sequestro l'altro ieri, come tutta la
stanza del residence Le Rose dove ha trovato la morte nel giorno di San
Valentino. Questo spiegherebbe anche i rapporti tesi con la famiglia, di cui si
è parlato nelle ultime ore, e l' allontanamento del campione da Cesenatico, dove
non si faceva vedere da parecchio tempo. Non ci sarebbero però accuse ai parenti
fra i biglietti trovati nella stanza del residence, affermano fonti
investigative. Le stesse fonti smentiscono categoricamente le indiscrezioni sul
contenuto dei foglietti riportate da alcuni giornali, in realtà una sorta di
testamento di una persona molto provata psicologicamente che si è sfogata
devastando la camera dell'albergo dove aveva preso alloggio e affidando i propri
pensieri a parole e frasi sconnesse, non riconducibili una all'altra, di
interpretazione impossibile. L'unico riferimento al mondo del ciclismo che
Pantani avrebbe fatto su un pezzo di carta dell'albergo è quello alla sua
bicicletta, una sconclusionata dichiarazione d'amore. Il ciclista nella sua
carriera aveva accumulato una fortuna: si parla di sei milioni di euro che erano
stati investiti in varie società, soprattutto immobiliari a Cesenatico e in
Romagna. Di queste società il campionissimo risultava essere l'amministratore
unico. Amministratore unico insieme al padre Ferdinando. Questo già nel 2003, e
forse da prima. Dopo il ciclone Marco continuava a seguire le vicende delle sue
aziende partecipando alle assemblee ordinarie. Lo testimonierebbe, ad esempio,
il verbale dell'assemblea della società immobiliare «Sotero» del 30 maggio 2003
che aveva come ordine del giorno la presentazione del bilancio 2002.
All'incontro erano presenti Marco Pantani e Ferdinando Pantani in qualità di
amministratore unico. La precaria situazione psicofisica del figlio aveva spinto
il genitore a subentrargli nelle vicende finanziarie. Marco avrebbe reagito
male. In un momento delicato della sua vita, segnata dalla fine della carriera
sportiva, dallo scandalo mal digerito e dall'accentuarsi dei problemi
psicologici, forse l'ingerenza del padre è suonata come una prova ulteriore del
suo fallimento. È anche vero che negli ultimi tempi la deresponsabilizzazione di
Marco era diventata un fardello pesante.
Vita notturna sfrenata, serate in discoteca che si prolungavano fino all'alba,
amicizie discutibili. Quelle vecchie che appartenevano a un mondo passato,
cancellate. «Non mi cercate più» aveva detto a tutti quelli che avevano cercato
di ributtarlo nel mondo delle due ruote. Poi quel lungo viaggio a Cuba in
novembre. Una fuga, la precisa volontà di allontanarsi dalla famiglia, da casa.
La rottura coi genitori, nella quale ha un peso determinante anche la molla
economica, sembrerebbe pure il motivo per cui Pantani a un certo punto era
andato a vivere nella casa di un amico a Predappio. Michel, l'amico che lo ha
ospitato e che non ha nulla a che fare con il mondo del ciclismo, in questo
momento è chiuso nel suo dolore e non vuole parlare. Sembra però che durante un
colloquio informale si sia lasciato andare affermando che nella scelta di Marco
di allontanarsi dalla famiglia c'era pure il suo zampino.
La morte di Pantani è iniziata a
Campiglio, scrive Xavier Jacobelli su “La Provincia di
Varese”. Marco era un ragazzo generoso, trasparente. Gli hanno teso un tranello
perché dava fastidio. La gente era tutta per lui e per il ciclismo; il calcio e
la Formula Uno perdevano seguito e milioni di euro: per questo lo hanno fatto
fuori». Col du Galibier, 2.301 metri di altitudine, Alta Savoia, Francia, 19
giugno 2011. Paolo Pantani ha gli occhi lucidi. Come Tonina, sua moglie. Lui e
lei hanno appena assistito all’inaugurazione del monumento dedicato a Marco,
voluto con tutte le proprie forze da Sergio Piumetto, piemontese di Cherasco
trapiantato a Les Deux Alpes dove il 27 luglio 1998 il Pirata firmò una delle
imprese più memorabili della sua straordinaria carriera. Quella che lo lanciò al
trionfo nel Tour, due mesi dopo avere vinto il Giro. Quel giorno di giugno sono
sul Galibier, accanto a Paolo e a Tonina. Dirigo quotidiano.net, l’edizione on
line dei giornali della Poligrafici Editoriale (Il Resto del Carlino, La
Nazione, il Giorno, Quotidiano Nazionale). Piumetto era venuto a trovarmi un
anno prima, a Bologna, per raccontarmi il suo sogno. Erigere un monumento al
Pirata lassù, sulle montagne francesi. E siccome chi sogna non si arrende mai,
sino a quando la vita che s’immagina diventa realtà, noi di quotidiano.net
avevano deciso di accompagnare passo dopo passo la costruzione di quel sogno. Le
parole di Paolo Pantani mi sono tornate alla memoria in queste ore in cui ha
fatto il giro del mondo la notizia della riapertura delle indagini sulla fine di
Marco, trovato morto nel bilocale D5 del residence Le Rose di Rimini. L’ipotesi
di reato è: «omicidio e alterazione di cadavere e dei luoghi». La magistratura
si è mossa dopo avere ricevuto l’esposto dall’avvocato Antonio De Rensis, legale
dei Pantani. Né Paolo né Tonina hanno mai accettato la tesi che Marco fosse
morto per overdose lui spontaneamente assunta. Mai. Ecco perché, adesso, Tonina
ripete le parole che aveva pronunciato quel giorno sul Galibier, che i due
genitori hanno pronunciato sempre da quando Marco se n’è andato: «Da una parte
sono contenta, finalmente non sto più urlando al vento. Ma dentro di me c’è
anche rabbia, rabbia e ancora rabbia: perché tutto questo tempo? Perché nel 2004
diverse cose non erano al loro posto e nessuno ha fatto nulla per darmi delle
risposte?». Tonina e Paolo hanno sempre difeso strenuamente la memoria di Marco.
E lo avevano sempre difeso anche prima della notte di San Valentino in cui se ne
andò. Lo avevano difeso dalle accuse di doping, lui che non era mai stato
positivo a un controllo; avevano chiesto invano di sapere che cosa fosse
esattamente successo a Campiglio, quando il 5 giugno del ’99, mentre stava
vincendo il Giro, venne squalificato per un valore dell’ematocrito alterato di
un punto. Ai cialtroni e ai mentecatti che da quel giorno hanno sputato solo
veleno addosso a Marco, spingendolo nel tunnel senza ritorno della depressione,
bisogna ricordare le parole del campione: «Ero già stato controllato due volte,
avevo già la maglia rosa e il mio ematocrito era del 46 per cento. Ora invece mi
sveglio con questa sorpresa: c’è qualcosa di strano». Pantani lascia Madonna di
Campiglio alle 13.05. A Imola, nel pomeriggio, si sottopone a un esame del
sangue in un laboratorio accreditato dall’Uci: nei due test il suo ematocrito
risulta pari a 47,8 e 48,1. Regolare. Ma dal Giro l’hanno fatto fuori per
sempre. La mattina di Campiglio un giornale aveva titolato: Marco pedala nella
leggenda. Il giorno dopo l’ha scaricato come un pacco postale. Paolo e Tonina
non hanno mai dimenticato. Ora hanno il diritto di sapere la verità anche su
Campiglio. Mentre le jene sono andate a nascondersi.
Pantani, un uomo sempre solo quando
vinceva e quando sbandava. Non era un angelo né un
diavolo: arrivava da un ciclismo antico, parlava una lingua diversa, sulla canna
della sua bici c’era l’Italia. Dieci anni fa la morte misteriosa, scrive Gianni
Mura su “La Repubblica”. Dieci anni, di già. Ma siete ancora qui a
esaltare un drogato? Oppure: ma non avete ancora capito che era l’agnello
sacrificale? Dieci anni dopo la morte, Marco Pantani continua a dividere, come
dieci giorni dopo. Solo quando correva e vinceva tutti lo sentivano loro. Io non
mi riconosco in nessuna delle due fazioni, quella del diavolo e quella
dell’angelo. Troppo estreme, in un certo senso troppo comode. Sarebbe meglio
conciliare: anche i diavoli hanno slanci positivi, anche gli angeli non
resistono alle tentazioni. E, comunque, Pantani era un uomo. Un uomo solo al
comando quando staccava tutti in salita. Un uomo solo allo sbando dopo Madonna
di Campiglio. La lunga, sofferta discesa in fondo alla quale non sapeva più
distinguere gli amici veri dai finti, quelli che si preoccupano della tua
infelicità e quelli che la rivestono di polveri bianche e donne a pagamento. Mi
riconosco pure in un libro appena uscito: «Pantani era un dio». L’ha scritto
Marco Pastonesi, collega della Gazzetta che ha per primo amore il rugby ma che
nel ciclismo tiene bene la ruota dei grandi suiveurs sui fogli rosa. È uno che
sa osservare e sa ascoltare, Pastonesi. E anche onesto. Prime righe della
prefazione: «Pantani non era uno dei miei. Nessun campione, nessun capitano,
nessun vincitore né vincente né vittorioso è uno dei miei. I miei sono i
corridori che, da professionisti, non ne hanno vinta neanche una». Dunque non
Pantani. In questi dieci anni sono usciti molti libri sulla vita e la morte di
Pantani, scritti da giornalisti italiani e stranieri, dalla manager, dalla madre
Tonina. Più un film per la tv e un lungo, doloroso e umanissimo spettacolo del
Teatro delle Albe di Ravenna (romagnoli come lui) e una decina di canzoni, dai
Nomadi ai Litfiba, da Lolli agli Stadio. Più le processioni: sui blog, al
cimitero di Cesenatico, sulle salite di Pantani. Quelle domestiche, l’amato
Carpegna, il Centoforche, il Fumaiolo. Quelle più famose. Mortirolo, Alpe
d’Huez, Galibier, Ventoux. Per come correva, posso dire che tutte le salite
erano di Pantani. Erano il suo pascolo naturale, il suo mare verticale, erano
croce e delizia. La croce era quella che chiamava agonia, la fatica più dura. La
delizia era quel suo attaccarle stando in coda al gruppo e poi un po’ alla volta
sorpassare tutti gli altri guardandoli in faccia. Lo faceva apposta, non era un
caso. Non era un caso l’alleggerirsi in vista dell’attacco, era un segnale per
gli avversari, un avvertimento, come il drin di un campanello: tra un po’
comincio a darci dentro, mi venga dietro chi può. Non a caso, ancora, Pastonesi
dilata il quadro, dà voce a tutti i gregari di Pantani, a chi s’è allenato con
lui e ha corso con lui, anzi per lui, perché la Mercatone Uno prevedeva un solo
capitano, Pantani, e tutti gli altri al servizio della causa, Se vinceva lui,
vincevano tutti. E se perdeva, tutti perdevano. Nella dilatazione del quadro ci
sono i grandi ciclisti romagnoli del passato, e i grandi scalatori come Gaul,
Bahamontes, Massignan. Come il primo dei grandi scalatori, René Pottier,
vincitore del Tour 1906, che s’impiccò a una trave delle officine Peugeot il 25
gennaio del 1907. Delusione d’amore, dissero ai tempi. Nessun biglietto
lasciato, un’altra morte misteriosa. Come quella di Pantani. Che ha due grandi
punti interrogativi su due stanze d’albergo. Una è quella di Madonna di
Campiglio, 5 giugno 1999, l’inizio della fine. Come mai, trattandosi di una
visita annunciata, non a sorpresa, il sangue di Pantani presentava un ematocrito
a 52? E cosa accadde veramente nella stanza D5 del residence Le Rose, a Rimini,
la fine della fine? Un libro di Philippe Brunel dell’Equipe ha documentato
quante smagliature e lacune ci fossero nell’inchiesta. I dubbi restano e quel
residence non c’è più, è stato demolito in tempi brevi, sorprendenti per la
burocrazia nostrana. I dubbi non restano in chi parla di Pantani solo come di un
drogato, in bici e giù dalla bici, o solo come di un angelo innocente tirato giù
dal cielo. Rivivere quegli anni, tra la fine degli ’80 e poco oltre il 2000, è
come seguire le piste dell’Epo. Pantani ne ha fatto uso? Sì, come tutti. In che
misura? Pastonesi cita livelli alquanto alti. Avrebbe vinto ugualmente? Sì, a
parità di carburante. Ma, a Pantani morto, è saltato fuori che su qualcuno
(Armstrong) l’Uci teneva aperto un larghissimo ombrello. Per onestà, come
Pastonesi ha scritto che Pantani non era uno dei suoi, devo scrivere che Pantani
è stato uno dei miei. Perché, come i vecchi ciclisti, in corsa faceva di testa
sua, non usava il cardiofrequenzimetro e quando s’allenava dalle sue parti
beveva alle fontane e mangiava pane e pecorino. Perché, più ancora delle
vittorie, ricordo l’attesa delle vittorie, o comunque dell’attacco in salita. E
l’entusiasmo della gente, come un ascensore sonoro fra tornante e tornante. E
l’Italia sulla canna di quella bicicletta, e i francesi che s’incazzavano, ma
neanche tanto. Perché gli piaceva ascoltare Charlie Parker. Perché dipingeva.
Perché era piccolino. Perché parlava una lingua diversa. Pontani (Aligi, quasi
un omonimo) mi chiamò dalla redazione quel 14 febbraio 2004. Ero in ferie, stavo
cenando a Firenze. È morto Pantani. Non si sa di preciso, in un residence. Serve
un coccodrillo, di corsa. Taxi, albergo, speciale Tg, dettare. Trovo ancora
lettori che mi dicono che quel pezzo a caldo, in morte di Pantani, è tra i più
belli che ho scritto. Non avrei mai voluto scriverlo e non l’ho scritto, è
venuto fuori così. Come aprire un rubinetto, o una vena.
Pantani, dopo quella morte speculazione infinita,
scrive Eugenio Capodacqua su “La Repubblica”. Avevo fatto un patto con me
stesso, in nome dell’amicizia che mi ha legato per breve tempo a Marco Pantani,
e cioè che non avrei più scritto un rigo su di lui e sulle sue tragiche vicende.
Pur conoscendo la sua storia nei minimi particolari non ritenevo di dover
puntualizzare fatti e situazioni; proprio per rispetto di un uomo che ha
comunque pagato il prezzo più alto. Ma evidentemente non c ‘è pace sotto gli
ulivi. E, con la riapertura d’ufficio dell’inchiesta sulla morte, riecco Pantani
pronto ad essere di nuovo immolato sull’altare della cronaca. Quella più bieca
e nera che allunga un triste velo di grigio sull’ immagine dell’uomo e
dell’atleta, comunque rimasto profondamente nel cuore di molti appassionati e
tifosi. Un atto dovuto da parte dei magistrati dopo l’esposto dei genitori e
l’accurata perizia dell’avvocato di parte che ipotizza l’omicidio. Diciamo
subito che se ci sono dubbi (e ce ne sono) sulle circostanze di questa tragedia
è doveroso andare fino in fondo. Anche se il cammino delle indagini, a dieci
anni di distanza dai fatti, risulta piuttosto difficile. Ma, più in generale,
sembra arrivato il momento di fare un minimo di chiarezza. Per lunghissimi dieci
anni l’informazione (specie la tv di stato) ha contribuito a mistificare un
dramma che è e resta umano prima ancora che sportivo. Pantani trasformato in un
eroe. Pantani campione, esempio da seguire e imitare. Pantani vittima di chissà
quale complotto. Pantani “capro espiatorio” di una realtà che invece tutti
conosciamo, purtroppo. E cioè la realtà di un ciclismo all’epoca stradopato che
ha tradito la passione degli spettatori propinando uno “spettacolo” al di fuori
e al di sopra di ogni umana credibilità. Pantani faceva sognare e del sogno in
questa dannata società c’è fame come dell’aria, dell’acqua, del pane. Lui
incarnava l’attacco, il successo, la botta vincente. Quello che tanti “travet”
covano nell’intimo. Il “come” poco importava. Quanti erano in grado di capire, o
volevano capire il “come”? E forse poco importa, adesso. Da questo punto di
vista Pantani è stato un grande. Ha toccato nel più profondo l’animo degli
appassionati. Ancorché alle prese con un problema esistenziale che tormenta
spesso, troppo spesso, la vita di tanti protagonisti. Un problema che Madonna di
Campiglio ha acuito e fatto esplodere. Mettendo in risalto tutta la fragilità
dell’uomo, ma anche l’insensibilità, l’egoismo e l’ignoranza di qualcuno che gli
è stato accanto. Vediamo di ragionare con un minimo di freddezza. Pantani è
stato un eccellente ciclista. Un eccellente scalatore che, doping o meno,
probabilmente avrebbe inebriato ugualmente le folle con le sue gesta in salita,
con il suo carattere e la sua personalità. Perché comunque il ciclismo si fa e
si esalta in salita. Ma che facesse come tutti gli altri lo ammette anche la
stessa madre che – è comprensibile: è la mamma – continua una sua battaglia
infinita. La capisco: la mia, di mamma, è andata fuori di testa alla morte del
figlio 25enne in un incidente aereo di cui non si è mai data ragione. E comunque
si vuole restituire dignità. Ma quale dignità? Quella del “così fan (hanno
fatto) tutti”? Ben magra consolazione… Perché che facesse come tutti i ciclisti
della sua epoca è ormai chiarissimo. E adesso, dopo l’indagine del Senato
francese sul Tour 1998, è addirittura comprovato al di là di ogni sospetto.
Niente da aggiungere. Niente da chiedere al mondo ipocrita del ciclismo. La
dignità a Pantani la si restituisce non arzigogolando attorno a presunti
complotti, ma spiegando come la vita possa mettere trappole mortali anche sulla
strada degli uomini di più grande successo. Insegnando a diffidare della
notorietà, della gloria effimera (un giorno sugli altari, il giorno dopo nella
polvere); ad essere guardinghi e mai esagerati. La breve vita del Pirata è un
paradigma dove c’è tutto: dall’esaltazione nel momento della gloria, alla più
profonda depressione quando un mondo costruito con cura crolla davanti al test
di Campiglio. Pantani come gli altri. Tanti altri. L’osservatore un minimo
distaccato tocca con mano la profondità del baratro quando si finisce nei
meandri della droga. Vede come sia facile scivolare, cadere definitivamente.
Eppure cosa era è successo, in fondo, a Madonna di Campiglio? Nient’altro che
quello che è successo a decine di altri corridori. Uno stop (di soli 15 giorni,
neppure una squalifica…) per essere fuori dalle regole stabilite in quel
momento. Scontata quella pena che all’epoca non aveva neppure il marchio del
doping (“sospensione a tutela della salute”) tutto era finito. Ma
paradossalmente è stata proprio la sensibilità particolarissima dell’uomo, la
coscienza e il sentimento di vergogna per essere stato scoperto e messo a nudo,
a perderlo. Non ha retto, dicono, e si è rifugiato nella droga, trascinato in un
mondo che gli turbinava attorno da tempo. In un mondo di cinici si è comportato
come l’ultimo dei romantici. Ciò che lo rende umano, umanissimo. Tutt’altro che
un dio: umanissimo uomo. Per questo ancora più apprezzabile. Per questo, a me
non danno fastidio le celebrazioni e i ricordi. Men che meno che si scavi per
chiarire i dubbi sulla morte. Mi da fastidio il sentimento peloso che trasuda
interesse economico attorno a tutta la vicenda. Mi da fastidio chi su quella
morte ci ha guadagnato e continua a guadagnarci, speculando sull’emozione.
Pantani è stato un business milionario da vivo e ancora di più da morto. I libri
basati sulla sua tragica epopea sono andati a ruba. Al ritmo di 25-27 mila copie
vendute. Fra il 2003 e il 2005, raggranellando cifre di gadget, dvd, bandane,
donazioni, libri, poster, foto e tutto il merchandising connesso sono arrivato a
calcolare quasi un milione di euro. Una cifra che si può tranquillamente
moltiplicare per 3, per 5 arrivando ai nostri giorni. Chiaro che a questo
mercato serva l’eroe. Anche se eroe non è. Pace all’anima sua. Il sistema che in
qualche modo lo ha messo in un angolo, continua a succhiarne la linfa. Come?
Raccontando la favola dell’eroe tragico. Della vittima predestinata. Del
campione che suscita invidia e viene eliminato. Emozione, sentimento,
partecipazione. Sul piano umano è tutto più che comprensibile, dopo la grande
tragedia. Ma se vogliamo dare un esempio ai giovani non possiamo continuare a
proporre tesi senza fondamento. Complotto? E chi mai avrebbe avuto interesse a
complottare contro il Pirata? La Fiat perché lui aveva scelto la Citroen come
sponsor? Ma, andiamo! Chi lo voleva in squadra ottenendo il rifiuto? E come si
sarebbe realizzato il complotto? Corrompendo i medici prelevatori? Quello che si
è letto negli anni e di recente appare chiaramente strumentale. E a mio avviso
infondato. Oggi c’è di mezzo la giustizia ordinaria e un’indagine ufficiale, ma
se ne sono viste e lette in passato… Soprattutto per assecondare la tesi della
trappola. Qualcuno ha tirato fuori perfino la provetta di quel tragico prelievo
ematico a Campiglio che sarebbe stata scaldata per alzare l’ematocrito. Ma – è
addirittura banale – scaldando il sangue si scalda e aumenta di volume anche la
parte liquida non solo quella corpuscolare e il rapporto in percentuale
dell’ematocrito resta inalterato. Insostenibile scientificamente, eppure c’è chi
ne ha fatto un elemento saliente della tesi complottistica. E poi: chi l’avrebbe
scaldata? Il medico prelevatore? I medici dell’ospedale di Parma che nella
serata di quel 5 giugno 1999 hanno ripetuto i test su ordine del pm di Trento
Giardina trovando gli stessi valori dei medici Uci? Si può sostenere un’accusa
così grave, che sfiora la calunnia, in modo così generico? Chi fa riferimento al
complotto deve anche spiegare chi, come e dove può aver complottato. Per questo
dico che sono solo speculazioni per suscitare emotività e vendere copie (o
altro) al tifoso. Pantani era la gallina dalle uova d’oro per il ciclismo di
quel tempo. E non solo. L’atleta che era riuscito a riportare milioni di tifosi
sulle strade del Giro e con loro gli sponsor, cioè il potere economico. Cioè il
dio denaro. Tanto e disponibile per tanti. Su Campiglio ha indagato la Procura
di Trento. Il verdetto è stato univoco: nessuna truffa, nessuna sostituzione di
provette (il sangue era di Pantani, come hanno provato i test del DNA), nessun
complotto, nessuna manomissione. Resta solo l’ombra delle scommesse. Ma le
indagini fin qui fatte non hanno portato a nulla. E ad anni di distanza il nome
di quell’ “amico” di Vallanzasca che gli avrebbe consigliato di non scommettere
su Pantani perché non sarebbe arrivato a Milano nonostante la maglia rosa sulle
spalle e la classifica ormai blindata dai risultati, ancora non viene fuori. Su
Pantani si specula. Come definire altrimenti il sottolineare l’irregolarità
della procedura punto centrale in una delle ultime pubblicazioni? La provetta
sarebbe stata scelta da uno dei medici prelevatori e non dall’atleta come vuole
il regolamento. Un vizio di forma ininfluente ai fini del test. A meno di non
chiamare in causa la stessa ditta produttrice delle provette, che sono sigillate
e sottovuoto. Tutte. E anche qui senza prove si sfiora la calunnia. Ma a cosa
può servire tirare fuori un vizio di forma di fronte al quale oggi non si può
fare nulla se non instillare senza motivo il dubbio generico che qualcosa di
irregolare sia accaduto? Facile rispondere: è una mossa furba per accalappiare
ancora di più il tifoso. Ma dire, 14 anni dopo, che si sarebbe potuto fare
ricorso contro le modalità di quel test, non toglie nulla alla realtà storica:
l’ematocrito fuori norma per le regole del tempo. Controllato otto volte sul
sangue del Pirata. Valori fiori norma. Non per la prima volta, come del resto
provano i dati emersi nel processo Conconi alle cui cure Pantani si era affidato
già dal ‘94. E baggianate come “il prelevatore ha messo la provetta in tasca
alzando la temperatura, ecc. ecc.” dicono sopratutto dell’ignoranza se non della
malafede di chi sostiene tale ridicola tesi. Basta pensare alla temperatura
corporea: 38 gradi circa. Ci sono 38 gradi in una tasca? Difficile. Dunque caso
mai la provetta si sarà raffreddata non riscaldata. Ma tant’è. Lo dico chiaro:
queste “spiegazioni postume” non mi convincono. Come quella che la macchina da
analisi (Coulter Act) avrebbe “visto” un ematocrito alto per via del raggrumarsi
delle piastrine. Ma gli esperti sono chiarissimi: “E’ impossibile – sostiene
Benedetto Ronci ematologo di fama dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma,
consulente dei pm nella inchieste doping più clamorose – anche se le piastrine
hanno tendenza ad aggregarsi non incidono sul volume corpuscolare; non possono
modificare in alcun modo l’ematocrito”. Piuttosto al medico che avrebbe fatto
l’ematocrito a tutta la squadra in quei giorni andrebbe posta una semplice
domanda. Perché? Si sa che con lo sforzo prolungato per settimane l’ematocrito
cala. Che bisogno c’era di controllare? Altro discorso è la morte nel residence.
Ma qui la scelta è ancora più netta. O si sposa la tesi dell’esagerata
ingestione di cocaina (sette volte la dose mortale), overdose accidentale, come
dice il referto di morte e dunque si spiega così il delirio la gran baraonda
trovata in quella tristissima camera n.5 del Residence Le Rose, che è poi la
tesi ufficiale di chi ha indagato. Oppure si allineano una serie di elementi di
dubbio. Particolari incerti che dall’ora della morte, al cibo cinese (odiato dal
Pirata), trovato in camera, alle ferite sul corpo, ai boxer che farebbero
sospettare un trascinamento, al particolare del cuore portato via dal medico che
eseguì l’autopsia timoroso che venisse rubato (da chi?); alimentano dubbi
concreti. Cui dovrà rispondere l’indagine. Si continua a confondere il piano
umano che merita il massimo della comprensione per una morte assurda con quello
sportivo sfruttando la mozione degli affetti. Cosa dobbiamo fare? Giustificare
tutto in nome della tragedia? E cosa raccontiamo ai nostri figli? Segui
quell’esempio e sarai felice?
Protagonisti e comparse. Ecco il
dizionario del mistero Pantani. Chi poteva volere
morto il campione? L'inchiesta della Procura di Rimini parte da nomi e ruoli dei
personaggi dell'affaire, scrive Pier Augusto Stagi su “Il Giornale”. «Pantani è
stato ucciso». Questo è il titolo del «romanzo noir» di questa estate italiana
poco assolata e calda. A gridarlo da anni mamma Tonina. A raccogliere il suo
grido di dolore e le prove per presentare un fascicolo presso la Procura di
Rimini che ha competenza sull'accaduto è l'avvocato De Rensis. La richiesta:
riaprire il caso sulla base dei molti fatti nuovi contenuti nelle pagine (120)
dell'istanza. Un romanzo che ha una storia buia, molti protagonisti e qualche
comparsa. Ecco un dizionario per orientarsi, mentre la Procura rinvia a
settembre la decisione su chi assegnare la delega a indagare, carabinieri o
polizia.
A come avvocato.
Antonio De Rensis è l'avvocato della famiglia Pantani, che in
nove mesi di lavoro ha raccolto una serie impressionante di contraddizioni e
anomalie. È a lui che si deve l'esposto per la riapertura del caso.
D come dubbi.
Il lavoro del professor Avato si discosta di molto dalle conclusioni prospettate
all'epoca dal collega Giuseppe Fortuni, che aveva eseguito l'autopsia su
incarico della Procura. Quali sono i rilievi di Avato? Molti. A partire dall'ora
della morte: posizionata tra le 10.45 e le 11.45. La quantità di droga trovata
su Pantani equivarrebbe a diverse decine di grammi, tale da essere paragonabile
ai pacchetti ingeriti dai corrieri per eludere i controlli. Impossibile per
qualunque persona mangiare o inalare una dose simile. L'unico modo per farlo è
diluirla nell'acqua e farla bere a forza (la bottiglia trovata nella stanza, non
viene nemmeno analizzata). Le numerose ferite sul corpo di Pantani sono
compatibili con opera di terzi, con evidenti segni di trascinamento del
cadavere. Il corpo di Pantani è poggiato sul fianco sinistro ma per Avato è il
polmone destro a pesare 200 grammi di più: quindi, il corpo di Marco è stato
spostato dalla posizione originaria della morte. E poi c'è la stanza, con il suo
«disordine ordinato». L'ipotesi è fin troppo chiara: far passare Pantani in
preda al delirio per celare altro. Nessuna impronta fu presa e non sarà più
possibile farlo neppure 10 anni dopo.
E come esperto.
Francesco Maria Avato è il perito di parte, il medico-legale (lo
stesso che ha contribuito a far riaprire dopo 23 anni il caso Bergamini, il
calciatore «suicidato») che ha fornito un contributo fondamentale per completare
e avvalorare l'esposto preparato da De Rensis.
I come imputati.
Dieci anni fa l'indagine sulla morte di Pantani viene svolta dal sostituto
procuratore romagnolo Paolo Gengarelli, con la Squadra mobile di Rimini e la
Polizia di Napoli. Tre mesi dopo la morte del Pirata, il 14 maggio 2004 vengono
arrestati Fabio Miradossa (il fornitore napoletano di cocaina del romagnolo già
dal dicembre 2003), Elena Korovina (la cubista russa che ebbe una relazione con
il corridore), Fabio Carlino (leccese, titolare di un'agenzia di immagine) e
Ciro Veneruso (il corriere napoletano che portò la dose letale a Pantani). Viene
rinviato a giudizio anche il barista peruviano Alfonso Ramirez Cueva. Il
processo di primo grado inizia il 12 aprile 2005 davanti al Gup di Rimini.
Vengono in seguito accettati i patteggiamenti di Miradossa (4 anni e 10 mesi) e
di Veneruso (3 anni e 10 mesi) e Cueva (1 anno e 11 mesi). Gli altri accettano
di affrontare il dibattimento. La russa viene assolta. Fabio Carlino viene
condannato in primo grado e in appello, ma poi prosciolto in Cassazione.
M come manager.
Manuela Ronchi è la manager del campione romagnolo. La sua è una
figura non marginale in tutta questa vicenda, anche perché è una delle ultime a
vedere Marco vivo. Doveva andare a sciare con suo marito, per questo Marco passa
il 26 gennaio da Cesenatico per prendere tre giacconi che porta su a Milano. Il
31 gennaio Marco ha una lite con la manager davanti agli occhi di mamma Tonina e
papà Paolo, chiamati per l'occasione dalla Ronchi. Il 9 febbrario Marco decide
di andare a Rimini. La Ronchi gli fa recapitare una «sportina» di effetti
personali (non ha valige) ad un hotel in piazza della Repubblica. Marco qualche
giorno dopo parte per Rimini. Uno dei grandi misteri di questa vicenda è: come
ci sono arrivati i tre giubbotti al residence Le Rose?
P come procuratore.
Paolo Giovagnoli è il procuratore capo di Rimini al quale è stato
consegnato il fascicolo, il quale a sua volta l'ha assegnato ad Elisa Milocco,
giovane sostituto procuratore, arrivato a Rimini da pochi mesi. Toccherà a lei
far sul luce su quella sera del 14 febbraio 2004.
Pantani, il legale accusa: "Inchiesta
piena di buchi". Nove mesi di indagini private e una
perizia medica hanno messo in forse la tesi del suicidio. L'avvocato di famiglia
contro il pm che archiviò: "Troppi silenzi", scrive Pier Augusto Stagi su “Il
Giornale”. Quando facciamo suonare il suo cellulare l'avvocato Antonio De Rensis
è alla buca 18. Cerca, dopo mesi duri e difficili, di rilassarsi un po', di
liberare la mente dalle tossine accumulate durante la preparazione di
un'indagine difensiva molto delicata. «In verità forse mi conveniva restare a
casa, perché sono riuscito a giocare pochissimo». Per dirla con un linguaggio
molto caro al nostro presidente del Consiglio, l'avvocato De Rensis per certi
versi assomiglia a un «rottamatore»: non vuole mandare a casa nessuno ma
smontare teorie e ricostruzioni fatte dieci anni fa, quello sì. E grazie ai suoi
nove mesi di lavoro, di indagini e alla perizia di parte effettuata dal
medico-legale, il professor Francesco Maria Avato, la ricostruzione originaria
sulla fine tragica di Marco Pantani è stata smontata pezzo per pezzo. Ci
vorranno mesi, per arrivare ad una nuova fase di questa storia che in dieci anni
non ha finora trovato la vera parola fine. E una verità. Al momento il bandolo
della matassa è nelle mani del procuratore Capo di Rimini Paolo Giovagnoli e in
quelle della pm Elisa Milocco. «È esattamente così - spiega l'avvocato De Rensis
-, ci vorranno mesi di lavoro, anche perché ovviamente sono tantissime le cose
che la dottoressa Milocco dovrà esaminare. Bisognerà solo avere pazienza». Si
parte dalle accuse di mamma Tonina, che non ha mai creduto al suicidio del
figlio, ai nove mesi di indagini condotte dall'avvocato Rensis, trascorsi a
recuperare carte e materiale di ogni tipo e studiandole successivamente con
assoluta minuzia e passione. «Il tutto è concentrato in centodieci pagine, dense
di dati e osservazioni», puntualizza il legale. Lui, però, non se la sente di
stilare una graduatoria tra le tante incongruenze che nella sua inchiesta ha
portato alla luce. «Mi creda, non voglio apparire per quello che vuole eludere
ad una legittima curiosità o a una domanda, ma si fa fatica a dire quali di
queste incongruenze possa essere più decisiva rispetto ad altre. Vedrà, sono e
saranno tutte decisive perché concatenate l'una all'altra». Paolo Gengarelli, il
pubblico ministero della prima inchiesta, non si è soffermato molto su questo
nuovo capitolo della storia tragica di Marco Pantani, limitandosi a dire
stizzito che «non sono abituato a commentare le notizie, come del resto
dovrebbero fare in tanti». L'avvocato De Rensis, non esita a rispondergli:
«Anche noi cerchiamo di parlare con i fatti. Anche noi cerchiamo di rispettare
le indagini. Ma soprattutto noi vogliamo raccontare che all'epoca dei fatti non
sono state prese le impronte digitali; che il video dei carabinieri dura 51
minuti mentre il girato è di due ore e cinquantasei minuti e via elencando. Non
mi sembra di parlare di atti dell'indagine. Mi sembra solo di evidenziare cosa è
stato fatto o meglio, non è stato fatto all'epoca. Anche noi staremo zitti nel
momento in cui si tratterà di affrontare le cose da fare, ma queste sono fatti
accaduti in passato ed è giusto portarli alla luce. Se il silenzio è luminoso ha
un senso, i silenzi con le ombre a me non piacciono neanche un po'». L'avvocato
De Rensis è capace di attaccare, ma si dimostra abile anche in fase difensiva.
Quando gli chi chiede se ha un'idea di chi abbia ucciso Marco, si chiude a
riccio. «Se sia stata una persona o più persone che fanno sempre parte del giro
dei pusher? Se si tratta di persone fuori da questi giri? La prego, non mi
chieda nulla. Sui nomi non mi esprimo. Non posso e non voglio». Più morbido
all'ultima domanda: ma se la pm Milocco, alla fine dovesse decidere di chiudere
il tutto con un nulla di fatto, quale sarebbe la sua reazione. Si griderebbe al
complotto? «È una eventualità che non voglio nemmeno prendere in considerazione.
Ho grande fiducia nel procuratore Capo Paolo Giovagnoli e nella dottoressa Elisa
Milocco. Il procuratore capo è un galantuomo e la dottoressa Milocco - che ho
conosciuto da poco - mi ha dato l'idea di essere una persona molto rigorosa.
Quindi...».
Pantani, l’avvocato di famiglia:
«Leggendo le carte la strada s’illuminerà da sola»,
scrive “Giornalettismo”. Antonio De Renzis, legale della famiglia del Pirata,
parla della perizia che potrebbe far emergere una nuova verità sulla morte del
ciclista romagnolo. Intanto, il ristoratore che consegnò l'ultima cena ricorda:
«Non aveva la faccia di uno che volesse suicidarsi». Ufficialmente per la
giustizia italiana Marco Pantani,
trovato morto in una stanza d’albergo il 14 febbraio del 2004, è deceduto «come
conseguenza accidentale di overdose». Per la
famiglia del campione
romagnolo, invece, la verità è un altra. Il Pirata sarebbe stato ucciso da una o
più persone che lo avrebbero raggiunto quella sera al
Residence Le Rose di Rimini,
forse dopo essere stato costretto a bere
cocaina disciolta nell’acqua. A
parlare dopo la riapertura del caso è innnanzitutto la mamma di Pantani,
Tonina Belletti, che ha
provveduto a presentare un
esposto-denuncia per
omicidio volontario in Procura.
Ma ad esporsi è anche l’avvocato della famiglia del ciclista,
Antonio De Renzis, che alle
telecamere di Sky racconta oggi di «mancanze», «lacune»,
«incongruenze», «anomalie», «accertamenti non fatti», che avrebbero condizionato
la prima inchiesta sulla morte del Pirata che risale a 10 anni fa e che fu
chiusa a tempo di record, in soli 55 giorni. Il legale, descrivendo la
segnalazione alla Procura, parla di «rilettura» di quegli «atti d’indagine e
processuali» che avrebbero determinato una verità giudiziaria a suo parere
lontana dalla realtà, di una rilettura che contiene «elementi che convergono e
vanno in una direzione precisa» e opposta rispetto a quanto emerso finora.
Secondo De Renzis, in sostanza, la tesi seguita poche ore dopo la scoperta del
corpo di Pantani, e «mai più abbandonata», andrebbe dunque «assolutamente
rivisitata», ed è possibile che fancendo luce sulle «mancanze» della prima
inchiesta emergerà un’altra verità. «Le carte e il video parlano molto», ha
detto l’avvocato parlando della «corposa e approfondita consulenza» (perizia
medico-legale) realizzata da professor Francesco Maria Avato. E ha aggiunto:
«Credo che leggendo bene le carte sia possibile colmare queste lacune», «la
strada si illuminerà da sola». Molto chiara è stata la signora Tonina, la prima
ad annunciare, su Facebook,
la riapertura del caso
Pantani. «Me l’hanno ammazzato. La mia sensazione, sin da subito, è che avesse
scoperto qualcosa e gli abbiano tappato la bocca», ha dichiarato nei giorni
scorsi la madre del Pirata. «Non vedo altre ragioni – ha spiegato a TgCom24 -.
Non mi sono mai sbagliata su Marco. Così come non credo siano stati gli
spacciatori». «Sono dieci anni – ha aggiunto – che lotto e non mollerò, fino
alla fine. Voglio la verità, voglio sapere cosa è successo a mio figlio. Da
subito ho detto che me l’hanno ammazzato e, infatti, me l’hanno ammazzato». La
signora Tonina ha poi parlato anche di una richiesta di aiuto del Pirata nelle
ultime ore di vita: «Ha chiamato i carabinieri, parlando di ‘persone che gli
davano fastidio’». E infine: «Marco aveva pestato i piedi a qualcuno, perché lui
quello che pensava diceva: parlava di doping, diceva che il doping esiste».
Morte di Marco Pantani, legale: “Realtà è
molto diversa da quella ufficiale”. Per l'avvocato
Antonio De Rensis le indagini che vennero condotte dieci anni fa "presentano
lacune e contraddizioni". Il legale ha ottenuto la riapertura delle indagini da
parte della procura di Rimini che indaga per "omicidio volontario a carico di
ignoti". La tesi della famiglia e della difesa è che il campione non morì di
overdose ma venne ucciso, scrive “Il Fatto Quotidiano”. La realtà che emerse
dieci anni fa sulla morte di Marco
Pantani è “molto diversa” da quello che è accaduto realmente la
mattina del 14 febbraio 2004, nel bilocale del residence Le Rose di
Rimini. Ne è convinto
l’avvocato dei familiari del Pirata,
Antonio De Rensis, che spinto dalla tenacia della madre del
campione, Tonina, ha riletto e analizzato migliaia di pagine che compongono le
indagini e il processo. Per il legale le conclusioni a cui gli inquirenti
giunsero dieci anni fa sono piene di “lacune e contraddizioni”. Pantani non morì
per un’overdose, ma venne ucciso da una o più persone che il campione romagnolo
conosceva e a cui lui stesso aprì la porta. Nella stanza scoppiò una lite. Il
Pirata ebbe la peggio. L’aggressore (o gli aggressori) fecero bere al ciclista
una dose letale di cocaina diluita in acqua. In sostanza, gli investigatori
condussero le indagini su una messa in
scena. Quelle certezze sono state messe nero su bianco
dall’avvocato De Rensis che ha presentato un esposto alla procura di Rimini.
“Accolto”. Il fascicolo accantonato per dieci anni è stato riaperto per “omicidio
volontario a carico di ignoti”. “Mi limito a dire – ha
dichiarato all’Ansa il legale – che è già importante comprendere tutti
che la realtà fattuale è molto diversa. E già questo è tanto, perché porta poi
in direzioni molto precise. Intanto facciamo emergere le enormi lacune e
contraddizioni, facciamo emergere ciò che si poteva comprendere facilmente
all’epoca e poi partiamo tutti insieme da qui per arrivare a ristabilire una
verità. È un’indagine nuova che si apre con una ipotesi di reato grave. Sarà
un’indagine che durerà molto, perché comunque è complessa. Gli elementi
che dovrà valutare la procura sono tantissimi, però il nostro intendimento è di
evidenziare in modo chiaro che la verità ufficiale è piuttosto lontano da quella
fattuale”. De Rensis, avvocato del foro di Bologna, è un legale abituato alle
battaglie che legano lo sport alla giustizia: ha assistito
Antonio Conte nella vicenda del
calcio scommesse. Il lavoro dell’avvocato su carte e riscontri investigativi è
suffragato dalla perizia medico scientifica del prof. Francesco Maria Avato, che
con un suo lavoro aveva portato alla riapertura del caso di
Denis Bergamini, il calciatore
del Cosenza morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico (Cosenza). Un caso
che per anni è stato considerato un suicidio poi è stato riaperto per omicidio.
“Un lavoro faticoso e impegnativo – dice De Rensis – anche di rilettura. Gli
atti non è stato nemmeno semplice acquisirli. Questi faldoni sono negli archivi,
sono migliaia e migliaia di pagine che sono state analizzate, sezionate,
studiate, confrontate. Poi il lavoro scientifico del prof. Avato, che si è
andato a confrontare e intrecciare continuativamente con le analisi degli atti
di indagine e processuali, a confronto reciproco e intreccio reciproco. Quindi
le indagini difensive che sicuramente, seppure assolutamente riservate, hanno
evidenziato elementi importantissimi”. “Io nutro un grande rispetto per la
magistratura – precisa De Rensis – Noi abbiamo lavorato pensando che dovevamo
aprire una pagina nuova sulla base di enormi lacune e
enormi contraddizioni“. “Queste
lacune e incongruenze per noi possono essere colmate – conclude – possono essere
riviste e credo che questo sia un dovere morale, oltre che giudiziario, da parte
di tutti. Dobbiamo lavorare insieme per riscrivere la pagina di quella
dolorosissima vicenda il più possibile vicino alla realtà”. Un
ricordo di Pantani lo offre in queste ore anche
Oliver Laghi, il
ristoratore di Rimini che in
albergo consegnò al campione romagnolo la sua ultima cena, un’omelette di
prosciutto e formaggio. Il Piarata appariva stanco , ma sereno. «Ricordo – ha
detto Laghi al Corriere della Sera – come ieri il volto di Marco: stanco, le
occhiaie profonde, la barba un po’ lunga, ma ho pensato che fosse colpa del
viaggio e che una bella dormita avrebbe rimesso tutto a posto, tanto che prima
di andarmene gli chiesi se potevo tornare il giorno dopo con mio figlio piccolo
per un autografo e lui mi rispose con un sorriso timido e una pacca sulla
spalla: ‘Va bene, a domani’». E ancora: «Il Marco con cui ho parlato quella sera
non aveva la faccia di uno che volesse suicidarsi». Ora gli occhi sono tutti
puntati sulla procura di Rimini
che dovrà esprimersi sulla perizia del dottor Aveta (secondo la quale le ferite
presenti sul corpo di Pantani «non sono autoprocurate, ma opera di terzi») e che
dovrà esprimersi relativamente alla nuova ipotesi«omicidio con alterazione del
cadavere e dei luoghi». Il lavoro spetta innanzitutto al pm
Elisa Milocco, cui è stato
affidato il fascicolo dell’indagine bis,
e comincia senza che alcuna persona risulti indagata. Va ricordato che tre anni
fa la corte di Cassazione
aveva assolto il presunto pusher
di Pantani, accusato di aver provocato la morte del campione vendendogli cocaina
purissima, «perché il fatto non costituisce reato».
Il timer fissa la durata del girato in
due ore e 56 minuti, ma ne restano solo 51. Caso
Pantani, un buco di 125 minuti nel video della polizia scientifica. Per i pm
cinque nuovi testimoni che potrebbero raccontare una verità diversa sulla morte
del Pirata. Tutti i punti oscuri del caso, scrive Fiorenza Sarzanini su “Il
Corriere della Sera”. Un «buco» di 125 minuti nel video della Polizia
scientifica e almeno cinque nuovi testimoni che potrebbero raccontare una
diversa verità sulla morte di Marco Pantani. Riparte da qui la nuova indagine
avviata dalla procura di Rimini e si concentra su almeno sei anomalie denunciate
dalla famiglia del «Pirata» con l’esposto presentato dall’avvocato Antonio De
Rensis. Ricomincia da un’imputazione di omicidio volontario che non sarà facile
dimostrare a oltre dieci anni di distanza da quel San Valentino che il ciclista
trascorse nell’appartamento D5 del Residence «Le Rose». Anche perché la
struttura alberghiera è stata completamente modificata, ma soprattutto perché
l’ipotesi più probabile è che se davvero qualcuno è entrato in quel bilocale e
ha picchiato Pantani, è possibile che lo abbia fatto per fargli pagare uno
«sgarro», non per ucciderlo. E che la situazione gli sia poi sfuggita di mano.
Il campione era un uomo disperato, preda dei suoi demoni e della sua totale
dipendenza dalla droga. Ma - questo dicono alcune nuove testimonianze - non
sembrava affatto «fuori di testa» come qualcuno ha voluto far credere. «L’ho
trovato stanco ma lucido - ha raccontato Oliver Laghi, il ristoratore che la
sera del 13 febbraio 2004 gli portò un’omelette al prosciutto e formaggio -, mi
disse di tornare il giorno dopo con mio figlio che voleva l’autografo». Secondo
l’inchiesta svolta dieci anni fa e chiusa avvalorando la tesi del suicidio,
Laghi è stato l’ultimo a vedere Pantani vivo. Il procuratore Paolo Giovagnoli e
il sostituto Elisa Milocco dovranno stabilire se è davvero così. Ma la
convinzione è che qualcuno sia comunque entrato in quella stanza prima delle
20,30 del 14 febbraio, quando i soccorritori accertarono che per Pantani non
c’era ormai più nulla da fare. Agli atti del processo contro i due spacciatori
Fabio Miradossa e Ciro Veneruso - hanno patteggiato condanne rispettivamente a 4
anni e 10 mesi e 3 anni e 10 mesi - c’è un video girato dai poliziotti della
Scientifica che comincia alle 22,45 del 14 febbraio e termina all’1.01 del 15
febbraio. Il timer fissa dunque la durata in due ore e 56 minuti ma il «girato»
è di soli 51 minuti e termina prima dalla fine dell’ispezione. Chi ha effettuato
i «tagli»? Perché ci sono dei «salti» tra una scena e l’altra? Eppure è proprio
il filmato a fornire le tracce più evidenti di una ricostruzione diversa da
quella ufficiale mostrando indizi evidenti per accreditare l’ipotesi che, almeno
in un certo lasso di tempo di quel giorno, Pantani non sia stato da solo. Ma
anche per dimostrare quelle che appaiono alcune «lacune» nelle indagini.
L’avvocato della famiglia ha infatti denunciato come nel fascicolo processuale
non risulta la rilevazione di alcuna impronta digitale durante il lungo
sopralluogo. E questo nonostante ci fossero molti mobili spostati, alcuni rotti,
un filo dell’antenna tv legato come un cappio e pendente dal soppalco, una
confusione pressoché totale. Lo stesso filmato mostra svariate dosi di cocaina.
Secondo quanto accertato al processo, Pantani aveva acquistato 20 grammi di
droga. La nuova relazione medico-legale, firmata dal professor Francesco Maria
Avato e basata sulla rilettura delle analisi effettuate dieci anni fa, assicura
invece che Pantani aveva assunto cocaina in quantità sei volte maggiore di
quanto una persona possa sopportare e altra sia rimasta inutilizzata. Proprio
questo accredita l’ipotesi che qualcuno l’abbia portata durante la giornata.
Nella denuncia si parla di «costrizione a bere cocaina sciolta nell’acqua», una
circostanza difficile da dimostrare e che probabilmente costituirà uno dei punti
più controversi della nuova inchiesta. Strano anche quanto accertato riguardo ai
pasti consumati da Pantani. Secondo la versione ufficiale l’ultimo cibo ingerito
è l’omelette portata da Laghi. Per l’autopsia Pantani ha invece fatto colazione,
i resti vengono rinvenuti nello stomaco. I dipendenti del residence hanno sempre
dichiarato che il Pirata non ha mai lasciato l’appartamento e che nessuno è
entrato. E allora come ha fatto a procurarsela? In realtà rileggendo quanto
verbalizzato all’epoca, il legale ha scoperto il racconto di un custode che ha
spiegato come fino alle 21 fosse «possibile entrare passando dal garage». E
dunque potrebbe essere proprio questa la strada percorsa da chi voleva
incontrare il campione senza essere visto. E che potrebbe aver lasciato almeno
due indizi: nel bilocale non c’era il frigobar, ma è stata trovata la carta di
un cornetto Algida; Pantani era arrivato con un piccolissimo bagaglio, «una
sporta», ma lì c’erano tre giubbotti pesanti. Un quadro indiziario nuovo, lo
definiscono gli stessi inquirenti che prima di riaprire il fascicolo, sia pur
come «atto dovuto», hanno avuto un lungo incontro con il legale della famiglia.
E adesso dovranno concentrarsi sulla visione del filmato incrociata con la
relazione medico-legale che evidenzia due punti: il corpo trascinato sulle
tracce di sangue e dunque spostato dopo il decesso; lesioni ed ecchimosi
incompatibili con l’autolesionismo, sia pure in una persona completamente
stravolta dalla cocaina.
Caso Pantani, depistaggi e buchi
nell'indagine. "Quando lo trovammo non c'era sangue".
I racconti dei primi soccorritori contraddicono la perizia fatta all'epoca dal
medico legale. E le testimonianze di chi lo vide nelle sue ultime ore si
smentiscono a vicenda, scrivono Marco Mensurati e Matteo Pinci su “La
Repubblica”. Testimonianze stridenti, perizie divergenti e protagonisti
dimenticati s'intrecciano intorno alle ultime ore di vita di Marco Pantani. E
con il passare dei giorni i dettagli inquietanti sembrano quasi sommarsi,
alimentarsi uno con l'altro, accentuando i depistaggi, le lacune nella versione
ufficiale, ma anche nei racconti di chi per primo intervenne sul corpo
dell'atleta, fino a quelli dei testimoni della primissima ora. "Non c'erano
tracce di sangue". Così lo raccontano i medici del 118, i primi a intervenire
dopo la segnalazione del portiere del residence Le Rose. Eppure, i filmati della
polizia dimostrano come Pantani sia stato trovato riverso a terra in una pozza
di sangue, il viso una maschera rossa. La lettura dell'esame autoptico rivela
poi anche una serie di ferite sul corpo, sulla fronte, sul naso, intorno al
capo. Eppure, chi arriva per primo nella stanza D5 di viale Regina Elena, a
Rimini, proprio non riesce a ricordarle: "Marco non aveva alcuna ferita sul
viso". Incongruenze curiose, come le divergenze sulle macchie di sangue presenti
nella stanza. Quegli schizzi secondo la perizia del professor Avato allegata
alle indagini condotte dal legale della famiglia, Antonio De Rensis, non possono
essere frutto della caduta. Non la pensava così però il dottor Fortuni, il
medico legale che condusse l'autopsia, seppur 48 ore dopo il ritrovamento del
corpo: volevano lui, anche a costo di doverlo aspettare due giorni. E pensare
che Fortuni e Avato hanno sostenuto tesi opposte anche sul caso Aldrovandi,
controverso almeno quanto la morte del Pirata: il primo consulente della difesa
dei poliziotti sotto accusa, l'altro per la famiglia del giovane. Ma incollato
come un'ombra al nome di Fortuni è rimasto soprattutto il dettaglio macabro del
cuore del Pirata portato via dal laboratorio e custodito in casa per una notte,
per evitare furti. Un pezzo del cuore del campione di Cesenatico che
rappresentava "un corpo di reato, sotto la mia custodia in qualità di perito,
che ovviamente non poteva andare né perso né distrutto". Procedura non
inconsueta, eppure oggetto di attenzioni quasi morbose. Il cuore di un uomo
farneticante: così almeno lo raccontavano le indagini dell'epoca. Un ritratto
che nasce dalle dichiarazioni notturne di tre ragazzi, giovani, 27 anni appena:
si presentano spontaneamente alle 23.30 della notte di San Valentino per
consegnare la loro verità sul campione scomparso a un ispettore mentre nella
stanza D5 del residence Le Rose si muovono ancora inquirenti al lavoro e civili,
filmati impietosamente dall'occhio delle telecamere della polizia. Avevano
incontrato Pantani, dicono, la sera prima, sul pianerottolo, intorno alle 22.15.
Avevano impiegato un po' a riconoscerlo, poco curato, una barba sciatta. Lo
avevano sentito dire cose surreali, lo avevano salutato con un generico "a
domani", salvo sorprendersi nel sentirlo rispondere in dialetto "non so se ci
sarà un domani per me". Visibilmente turbato, poco lucido e tragicamente
inquieto, quasi consapevole del proprio destino irreversibile. Testimonianza
ritenuta credibile al punto da essere inserita nella consulenza medico legale.
Quella testimonianza diventa l'elemento per dare coerenza alla tesi di un
Pantani in preda al delirio, quello che avrebbe potuto demolire la stanza del
residence o barricarsi in camera e drogarsi fino a morire. Apparentemente
affermazioni utili a raccontare lo sviluppo delle ultime ore del campione
caduto. Eppure, nessuno sentirà la necessità di ascoltarli ancora: né durante le
indagini, né durante il procedimento giudiziario. Curioso, almeno. Viene da
chiedersi perché, al contrario, durante la pur fugace indagine non sia venuto in
mente a nessuno di ascoltare se avesse qualcosa dire l'ultima persona che, con
certezza, ebbe occasione di incontrare Pantani vivo. Eppure era proprio lì, a
pochi metri dalle stanze ormai demolite e rivoluzionate del Le Rose. Oliver
Laghi è il ristoratore a cui viene ordinata l'ultima cena del Pirata,
un'omelette prosciutto e formaggio, qualche succo di frutta che prende dal
concierge dove scopre che il cliente da servire, stavolta, è il suo idolo. Tra
le 21 e le 21.30, Pantani gli apre la porta: se qualcuno lo avesse sentito
all'epoca, Laghi avrebbe detto quello che dice soltanto ora. "Non aveva la
faccia di chi voleva suicidarsi", dice. Racconta che emozionato per
quell'incontro inatteso gli chiese di poter tornare con il figlio, che sarebbe
impazzito per un suo autografo. Marco gli diede una pacca sulla spalla e rispose
"va bene, ci vediamo domani". L'esatto opposto di quello che solo un'ora dopo,
un Pantani sconvolto e delirante avrebbe detto ai tre ragazzi. Almeno stridente,
se non inquietante. In un'ora scarsa, Pantani avrebbe dovuto mangiare la cena
ricevuta per poi imbottirsi di cocaina e uscire dalla stanza per apparire
instabile, in preda a manie persecutorie, perso in discorsi surreali ai giovani
che lo incontrano sul pianerottolo. Rimini parla, racconta, aspetta. La pm Elisa
Milocco dalle vacanze genovesi inizia a cercare risposte.
Pantani, il giallo dei pusher. Contatti
frenetici al telefono mentre Marco era già morto.
L'indagine per omicidio: cellulari impazziti tra le 13 e le 20. Il gelo del
magistrato che archiviò: per me parlano gli atti. Si riparte da zero: il
fascicolo affidato a una giovane pm, l'ultima arrivata nella procura. Dall'esame
dei tabulati l'ultimo mistero sulla fine del Pirata nel motel Le Rose di
Rimini.Il legale della famiglia: "Possibile colmare le lacune", scrivono Marco
Mensurati e Matteo Pinci su “La Repubblica”. La nuova indagine sulla
morte del Pirata ripartirà da una serie di tabulati telefonici. Numeri che si
incrociano in maniera convulsa nelle ore immediatamente successive all'omicidio
di Marco Pantani, in quel tragico pomeriggio del 14 febbraio 2004, e che
disegnano una strana, fittissima triangolazione tra Fabio Miradossa, Ciro
Veneruso - vale a dire il fornitore e lo spacciatore del ciclista
(successivamente per questo condannati) - e altri numeri per il momento non
meglio identificati. Cosa c'era all'origine di quel febbrile giro di chiamate
rimbalzato nell'etere tra le 13 e le 20 di quel giorno? Chi sapeva cosa? Per
quale motivo, di punto in bianco, due "pesci piccoli" dello spaccio in Riviera
cominciano ad agitarsi in maniera scomposta? Ci vorranno mesi per saperlo. Le
indagini penali, si sa, hanno tempi lunghi, specialmente quando diventano
tecniche. Ma ormai la macchina si è messa in moto, e comunque vada, alla fine,
una risposta definitiva sulla morte di uno dei campioni più amati di sempre
dovrà pur venire fuori. Almeno questo è l'intento del procuratore di Rimini
Paolo Giovagnoli. "Abbiamo appena ricevuto le carte presentate dai familiari e
aperto un'indagine. È un atto dovuto quando arriva un esposto-denuncia per
omicidio volontario. Leggeremo le carte, se ci sarà l'esigenza di indagini
chiederemo al giudice". Le carte, in realtà, Giovagnoli le aveva già lette la
scorsa settimana facendo in tempo ad aprire il fascicolo "contro ignoti" e ad
affidare l'inchiesta a una giovane fidata collega, il pm Elisa Milocco. In
procura - dove tutti si nascondono dietro il più assoluto segreto istruttorio -
nessuno sottovaluta la difficoltà di un cold case del genere, con una vittima
tanto famosa e amata, uno scenario alternativo così suggestivo, e con dieci anni
di distanza a rendere tutto, se possibile, ancor più complicato. Basti pensare
che il luogo del delitto, semplicemente, non c'è più: il residence Le Rose,
nella cui stanza D5 venne ritrovato, il 14 febbraio 2004, il cadavere di Marco
Pantani, è stato demolito. E non è un dettaglio da poco. Molto, nella
ricostruzione originaria, quella fatta a pezzi dalle indagini difensive condotte
dall'avvocato Antonio De Rensis, ruotava attorno al fatto che nessuno fosse
entrato o uscito in quei giorni dalla stanza di Pantani, visto che nessuno era
passato per la portineria chiedendo di lui. In realtà, si è scoperto, quella
stanza, così come tutte le altre in quel residence, poteva essere raggiunta
comodamente e con la massima discrezione dal garage (non c'era nemmeno una
telecamera di controllo). Insomma, in quei giorni chiunque potrebbe essere
entrato e uscito dalla stanza di Pantani, spacciatori, vecchi amici del posto,
gente venuta da Milano. Chiunque, insomma, oltre allo stesso Pantani e ai suoi
eventuali assassini. Purtroppo però non sarà possibile effettuare alcun
sopralluogo. Ciononostante la voglia di fare luce su un caso che da anni
avvelena le acque di questa piccola procura è tanta. Ancora ieri Paolo
Gengarelli, il pm della prima inchiesta, quella oggi sotto tiro ha rilasciato
una dichiarazione non proprio amichevole: "Io non commento la notizia, sono un
magistrato con l'abitudine di non parlare come dovrebbero fare in tanti, lascio
che siano gli atti a farlo". La scelta di affidare l'incartamento a un
magistrato "nuovo" dell'ambiente, lontano per definizione da ogni possibile
pressione locale non appare casuale. La strada dell'indagine a questo punto è
abbastanza scontata. La dottoressa Milocco al ritorno dalle vacanze (ha chiuso
ieri l'ufficio portando con sé il fascicolo) avvierà i primi accertamenti,
delegando la polizia giudiziaria. Poi disporrà una nuova perizia. Il cuore delle
accurate indagini effettuate da De Rensis e il suo staff è infatti la perizia
medico legale del professor Francesco Maria Avato che ha parlato di "ferite non
autoprodotte, ma inferte da terzi" sul corpo di Pantani, di "evidenti segni di
trascinamento del cadavere", e della "probabile ingestione della cocaina da una
bottiglia di acqua" ritrovata sulla scena e "mai repertata". Elementi che, se
confermati, non lascerebbero più dubbi sull'omicidio di Pantani. Resterebbe a
quel punto da rispondere alle altre domande: chi e perché ha ucciso Pantani, e
chi e perché ha coperto l'assassino? Nell'istanza presentata da Rensis ci sono
numerosi altri elementi che potrebbero aiutare a rispondere anche a queste
domande. E i tabulati telefonici sono uno di questi. "Quando i genitori di Marco
mi hanno contattato, mi sono riservato prima di capire perchè non volevo creare
false illusioni ma non c'è voluto molto per comprendere che c'era molto lavoro
da fare - racconta l'avvocato De Rensis ai microfoni di Sky -. La stessa
consulenza scientifica è stata inizialmente un percorso esplorativo ma abbiamo
capito subito che dovevamo buttarci a capofitto con una rilettura della vicenda.
Sono stati mesi molto faticosi, dolorosi, pieni di tensione e speranza. Adesso
sappiamo che abbiamo molto lavoro da fare insieme e mi concentro sul fatto che
inizia un nuovo percorso faticoso, lungo, ma che affronteremo con determinazione
massima. La prima indagine? Penso al passato soltanto in proiezione futura, sono
molto concentrato su quello che dobbiamo fare". L'esposto presentato, spiega De
Rensis, "è una rilettura, un esame degli atti di indagine e processuali, c'è una
corposa e approfondita consulenza scientifica, tutti elementi che convergono
verso una direzione molto precisa. Ci sono state molte mancanze, molte lacune,
accertamenti non fatti e una tesi seguita poche ore dopo la scoperta del corpo
di Marco mai più abbandonata e che credo vada invece assolutamente rivisitata".
Ancora nessuna pronuncia su possibili sospetti: "Iniziando a fare luce sulle
mancanze, sulle lacune, sulle incongruenze, sulle anomalie, credo che la strada
si illuminerà da sola, il percorso sarà molto chiaro e preciso. Il perchè certe
cose sono venute meno non lo devo dire io, chi fa le indagini avrà molti punti
da chiarificare e credo che questo sia assolutamente possibile. Colmare le
lacune credo sia possibile, le carte parlano molto, il video parla molto,
leggendo le carte nel modo giusto, leggendo il video e altri dati credo che sia
possibile colmare queste lacune". "Credo che adesso inizierà un'indagine molto
faticosa - conclude De Rensis - ma il procuratore capo di Rimini è un
galantuomo, la dottoressa Milocco mi ha dato l'impressione di una persona molto
rigorosa. C'è grandissima fiducia nell'opera della magistratura e daremo il
nostro piccolo supporto perchè i fatti vengano chiarificati e la verità fattuale
prevalga su quella ufficiale che penso sia molto lontana dalla verità dei
fatti".
PRESUNTE COLPEVOLI. SABRINA MISSERI E COSIMA
SERRANO.
SABRINA MISSERI, NESSUN PERMESSO PREMIO.
"Non riconosciuti i 45 giorni ogni 6 mesi". Omicidio
Sarah Scazzi, Sabrina Misseri e il ricorso alla Corte europea dei diritti
dell'uomo. L'avvocato Franco Coppi: “Ha superato la prima fase, siamo
fiduciosi”, scrive Silvana Palazzolo il 9 ottobre 2018 su "Il Sussidiario". Al
centro dell'intervista all'avvocato Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri,
all'ergastolo insieme alla madre Cosima Serrano per il delitto della piccola
Sarah Scazzi, anche i presunti permessi premio di cui potrebbe usufruire la sua
assistita. Evenienza smentita dal legale che proprio nel corso del suo
intervento alla trasmissione di Rai1 ha spiegato come la giovane non abbia
ancora maturato gli anni sufficienti per poter usufruire sia di un possibile
sconto di pena che di un permesso premio. "I permessi premio non arriveranno.
Non sono maturati ancora i dieci anni", ha dichiarato l'avvocato Coppi che ha
quindi spiegato come funziona tecnicamente questo aspetto importante. "Alla
Misseri non sono stati ancora riconosciuti quei famosi sconti di 45 giorni ogni
6 mesi e quindi, allo stato, non è nelle condizioni di poter usufruire di alcun
permesso", ha chiarito. Nel frattempo la Corte Europea dei Diritti Umani ha
giudicato ammissibile il ricorso presentato dalla cugina della giovane vittima
uccisa ad Avetrana nell'agosto 2010. Coppi ha chiarito ancora che nel caso in
cui Strasburgo dovesse riconoscere eventuali violazioni dei diritti della
difesa, potrebbe accadere la riapertura di un procedimento, al quale chiaramente
la stessa difesa punta. (Aggiornamento di Emanuela Longo)
L'AVVOCATO: “PUNTIAMO A RIAPERTURA PROCESSO”. Chi
ha ucciso Sarah Scazzi? In tre gradi di giudizio la responsabilità dell’omicidio
è stata attribuita a Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e
zia della ragazzina di Avetrana. Ma loro sostengono che sia stato Michele
Misseri, il quale dal canto suo ha cambiato spesso versione. «Non prova
risentimento per il padre, ma pietà e compassione. Potete capire lo stato
d'animo di fronte ad un padre che l'ha accusata ingiustamente», ha dichiarato il
legale di Sabrina Misseri, l’avvocato Fausto Coppi, a Storie Italiane. Non ha
dubbi invece il legale di Concetta Serrano, la madre della vittima: «C’è stata
la condanna all'ergastolo per tre gradi di giudizio. Questo processo resterà
nella storia della giurisprudenza perché abbiamo 2800 pagine di motivazioni».
Anche la criminologa Roberta Bruzzone è intervenuta per commentare le
dichiarazioni di Coppi: «Definire questo un processo ingiusto è ingeneroso nei
confronti di quello è successo». Ma il legale di Sabrina Misseri tira dritto:
«Se la Corte di Strasburgo dovesse riconoscere che sono state consumate
violazioni dei diritti della difesa, si porrà in Italia il problema della
riapertura del processo, e noi puntiamo a questo». (agg. di Silvana Palazzo).
“SUO PADRE MICHELE È L'ASSASSINO DI SARAH SCAZZI”.
Nel corso del suo intervento a Storie Italiane, l'avvocato di Sabrina Misseri ha
riversato su Michele Misseri la responsabilità dell'omicidio di Sarah Scazzi.
«Ha dichiarato di essere l'assassino. Se Sabrina fosse stata coinvolta avrebbe
fatto sparire il telefonino, invece lei ha chiamato i carabinieri», ha
dichiarato l'avvocato Fausto Coppi. E poi ha contestato il fatto che lo zio
della vittima non sia stato ritenuto credibile perché ha cambiato continuamente
versione: «Ma i cambiamenti non sono gratuiti e non credibili. Vera o falsa che
sia la motivazione, ha sempre cercato di spiegare i suoi cambiamenti. Ad esempio
ha dichiarato di essere stato indirizzato dall'avvocato Galloppa». Quest'ultimo,
primo difensore di Michele Misseri, ha spiegato nello studio di Eleonora
Daniele: «Mi accusò di avergli suggerito la versione che ha dato nel primo
incidente probatorio. Dichiarò di aver subito pressioni da me e Roberta
Bruzzone». E per questo Michele Misseri è accusato di calunnia. A tal proposito
è intervenuta telefonicamente la criminologa Roberta Bruzzone, arrabbiata perché
in studio si è detto che lei e Galloppa sono stati “cacciati” come team
difensivo: «Ci tengo a precisare che io e Galoppa non siamo stati cacciati. Non
mi ha cacciato nessuno. Michele Misseri è accusato di calunnia nei nostri
confronti. Definire questo un processo ingiusto è ingeneroso nei confronti di
quello è successo». (agg. di Silvana Palazzo).
OMICIDIO AVETRANA, SABRINA MISSERI E IL RICORSO A
STRASBURGO. Sabrina Misseri fuori dal carcere grazie a permessi premio? Ve ne
abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma ora interviene l'avvocato Franco
Coppi per smentire le voci che sono circolate in merito alla cugina di Sarah
Scazzi, che il 26 agosto 2010 scomparve da Avetrana per poi essere ritrovata
morta. «Non ci sarà alcun permesso premio, perché non sono ancora maturati i
dieci anni visto che non sono stati riconosciuti sconti», ha chiarito il legale
di Sabrina Misseri a Storie Italiane. Ma ha anche confermato di aver registrato
segnali positivi in merito al ricorso presentato alla Corte europea dei diritti
dell'uomo: «Abbiamo presentato ricorso a Strasburgo perché riteniamo che abbia
subito un processo ingiusto. Ha superato il primo esame di ammissibilità, ma non
è decisivo. Ci sono altri esami da affrontare, ma è confortante constatare che
si sia concluso positivamente». L'avvocato Coppi ha aggiunto che ora resta in
attesa, del resto anche i tempi della giustizia di Strasburgo sono molto lunghi.
“RICORSO MOLTO MOTIVATO”. Nella vicenda del
ricorso presentato dalla difesa di Sabrina Misseri alla Corte europea dei
diritti dell'uomo si inserisce quella di un fioraio, Giovanni Buccolieri, che
dichiarò di aver visto Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri trascinare il
corpo di Sarah Scazzi in auto il pomeriggio della sua scomparsa. Una
dichiarazione che poi ritrattò, finendo per essere accusato di falsa
testimonianza. Questa vicenda non è arrivata nel processo che ha portato alla
condanna delle due donne, e proprio questa vicenda è finita all'interno del
ricorso. Lo ha spiegato l'avvocato Franco Coppi a Storie Italiane: «Abbiamo
presentato un ricorso molto motivato. Sabrina è stata condannata sulla base di
prove non riscontrate, come le dichiarazioni di un fioraio che non è stato
esaminato nel processo. Ci sono violazioni di diritti che riguardano la difesa.
Non abbiamo esaminato la vicenda del fioraio, quindi ci sono state sottratte
delle prove, il problema è questo».
INTERVISTA A FRANCO COPPI.
Franco Coppi: «I tribunali? Gabbie di
matti. Ho difeso la Juve con la cravatta romanista».
L’avvocato: parlo con il mio cane, me l’ha regalato Ghedini. Da ragazzo credevo
di poter contribuire alle sorti dell’arte. Poi non ho più preso in mano un
pennello, non potevo permettermi la tentazione di distrarmi, scrive Giusi Fasano
il 3 dicembre 2017 su "Il Corriere della Sera". Franco Coppi, 79 anni, con il
golden retriever Rocky avuto in regalo dall’avvocato Niccolò Ghedini.
«Buongiorno professore». «Ossequi». «Carissimo
prof, permette un saluto?». «I miei omaggi, avvocato». Più che un’intervista è
uno slalom fra ammiratori. Franco Coppi, fra i più stimati e autorevoli avvocati
italiani, è a casa sua, in Cassazione, e qui non c’è collega, giudice,
cancelliere, usciere che non lo conosca. Anche perché dei suoi 79 anni ha
passato più tempo in questo palazzo che in qualsiasi altro posto. E oggi è il re
dei cassazionisti. Un’istituzione.
Prof, non le danno tregua con le riverenze. Come
fa a dar retta a tutti?
«Io sono un noto chiacchierone e poi sarebbe
disonesto dire che non fa piacere sentirsi apprezzati o vedere che i colleghi ti
dimostrano considerazione e simpatia. Anche se, le confesso, avrei una voglia di
smettere...»
Non dica così o farà venire un infarto ai suoi
assistiti.
«Ma sì, invece. In questi ultimi anni ho sentito
sulla mia pelle l’ingiustizia di alcune decisioni che sono diventate un peso
insopportabile».
Neanche glielo chiedo. So che sta parlando di
Sabrina Misseri e del suo ergastolo per l’omicidio di Avetrana.
«Esatto, non mi stancherò mai di ripetere che la
sua è una pena ingiusta, mostruosa. Sapere di non essere riuscito a dimostrare
la sua innocenza non mi fa dormire la notte».
Sta criticando una sentenza definitiva.
«E perché no? Chi lo dice che non si debba fare?
Se la ritengo non giusta posso criticarla eccome! Quella condanna mi ha segnato
così profondamente che ho pensato davvero di abbandonare la professione».
Cosa le ha fatto cambiare idea?
«Il senso di responsabilità verso i colleghi dello
studio e le cause che sto seguendo. E poi una persona che stimo molto mi ha
detto: in futuro quella ragazza potrebbe avere ancora bisogno di te, se te ne
vai non la potrai più aiutare. È vero, e io spero ancora di esserle utile. Nel
frattempo ci scriviamo. Lei sa del mio amore per gli animali e assieme alle
lettere mi manda disegni di animali bellissimi che fa con le sue mani».
Ha detto animali ma lo sanno tutti: il suo amore
più grande è per i cani.
«È vero ma ho avuto anche gatti e perfino una
gazza ladra».
Era arrivata da lei come imputata?
Ride. «No. Era venuta perché le piaceva il mio
terrazzo, forse. Le abbiamo costruito una gabbia il più grande possibile ma
spesso era libera, veniva a mangiare nel piatto e faceva il bagno nel lavello
della cucina. È morta di vecchiaia. Ma nella mia vita ho sempre avuto accanto un
cane, fin da piccolissimo».
Ne ha uno anche adesso?
«Sì. Dopo la morte del nostro Bruce io e mia
moglie eravamo molto indecisi. Siamo anziani, sa com’è...E invece a Natale di
due anni fa si presentò a casa mia con un cucciolo irresistibile di golden
retriever l’avvocato Ghedini (con Coppi si occupò del caso Ruby in cui
Berlusconi fu assolto, ndr)».
Un regalo post-assoluzione del Cavaliere?
«Era un regalo di Ghedini, graditissimo. Aveva già
un nome, Rocco, che io ho cambiato in Rocky e poi gli ho dato anche un cognome».
Che sarebbe?
«Ghedini».
Chissà come sarà contento l’avvocato...
«È una persona intelligente, sono certo che capirà
che non è un’offesa. Anzi, per me è un onore. Io e Rocky Ghedini ci facciamo
passeggiate lunghissime, ci capiamo al volo con un’occhiata. Ogni tanto gli
parlo, un giorno o l’altro mi risponderà».
Ancora passeggiate chilometriche anche dopo la
caduta e la frattura alla spalla?
«Ora confesso una cosa: lì non stavo passeggiando.
Correvo. Ho visto tutti quei ragazzi correre al parco e mi sono detto: ci provo
anch’io. Ricordo che quando sono tornato in aula il presidente mi chiese
“avvocato, cosa le è successo”? Gli ho risposto: se le dico com’è andata mi
caccia per manifesta stupidità».
Torniamo alla sua professione. C’è il nome di
Coppi nel caso Andreotti, nello scandalo Lockheed, nel Golpe Borghese, nelle
difese di grandi gruppi industriali e in quelle di Niccolò Pollari, Antonio
Fazio, Gianni De Gennaro, Berlusconi... Però lei ha sempre detto che la sua
Corte preferita è quella d’Assise. Cosa ci trova di così appassionante in un
omicidio?
«Ma scherza? I cosiddetti casi “di cronaca”
consentono di vedere le sfaccettature della vita, capisci molto della natura
umana, entri nei moventi dell’agire degli individui, scopri i meccanismi di
giustificazione che le persone cercano per i propri comportamenti. È
affascinante, ogni volta è quasi una lezione di psicologia».
Non starà esagerando?
«Beh, lo dico con il dovuto rispetto: i luoghi
della giustizia spesso sono gabbie di matti. Lei sa, vero, che Eduardo De
Filippo in molte delle sue commedie ha preso spunto dalla realtà nelle aule dei
tribunali? Nella vita ho assistito a difese diciamo bizzarre, per usare un
eufemismo».
Per esempio?
«Per esempio ricordo tanti anni fa l’arringa
straordinaria di un collega che cercò di convincere tutti con un discorso
aulico: “La vita di questo povero ragazzo è stata già messa duramente alla
prova” disse indicando il suo assistito. E poi cose tipo: “Vivrà il resto dei
suoi giorni senza avere più accanto i suoi genitori”. Erano parole accorate».
E cosa c’era di bizzarro in quella difesa?
«C’era che il presidente a un certo punto disse:
ma avvocato, i genitori di ha ammazzati lui! E la risposta fu: “E che c’entra?
Rimane pur sempre orfano”. Indimenticabile».
Rientra nel capitolo bizzarrie anche la sua
cravatta giallorossa durante il processo in difesa della Juventus?
«Lì ho agito per chiarezza. Per evitare l’accusa
di tradimento io, romanista, ho messo in chiaro le cose con la cravatta più
adeguata».
A proposito, è vero che di cravatte ne ha un
numero imbarazzante?
«Temo di sì»
Quante? Cento, duecento, di più?
«Non le ho mai contate ma credo di più...».
Tempo fa parlò di un segreto per il figlio di
Borsellino. Gliel’ha poi svelato?
«Non l’ho mai incontrato. Più che un segreto era
un ricordo di parole che mi disse suo padre. Eravamo a Roma, io camminavo
accanto a lui e più avanti c’era Falcone. Borsellino indicò Falcone e mi disse:
“Vede quell’uomo? Gli devo tutto, mi ha ridato la fiducia e il coraggio che
stavo perdendo e ogni volta che sono accanto a mio figlio sento che gli posso
trasmettere tutto il bene che Falcone mi ha passato”. Mi sono commosso, non ho
mai dimenticato quelle parole».
Lei è nato in Libia per puro caso, giusto?
«Giusto. Mio padre Filippo, che ho perso quand’ero
ragazzino, era un dirigente Fiat che andò lì a lavorare e mia madre, che era una
casalinga, lo seguì. Così io e mia sorella Cecilia siamo nati laggiù. Avevo
quattro anni quando scappammo da Tripoli con i magazzini in fiamme e i tedeschi
che davano ordini alle auto in coda. Ricordo tutto come fosse qui, adesso. Non
ci sono mai tornato».
Come ha conosciuto sua moglie?
«Fu mentre ero in vacanza a Capri, dove Anna Maria
lavorava. Mi è piaciuta subito».
Corteggiamento?
«Una cosa semplice. Abbiamo cominciato a
frequentarci e a un certo punto le ho detto: che ne diresti se ci sposassimo?»
Tutto qui?
«Beh, proprio tutto no».
Avete avuto tre figlie.
«Sì. Francesca fa l’avvocato nel mio studio,
Alessandra è ingegnere e Giuliana è consigliere parlamentare. Ho avuto e ho una
vita familiare felice. Sono fortunato».
E la vita da docente universitario?
«Ho cominciato nel ‘68 a Teramo e ho finito sei
anni fa alla Sapienza. Insegnavo Diritto penale, un’esperienza bellissima di cui
conservo molti ricordi».
C’è qualcosa nei suoi 79 anni che avrebbe voluto
fare e non ha fatto?
«Adesso, da anziano, penso ai libri non letti, ai
musei non visti, ai viaggi non fatti, assorbito com’ero dalla mia professione.
Ma non sono rimpianti, solo malinconie postume».
E quel vecchio amore per la pittura? Nessun
rimpianto neanche per quello?
«Da ragazzetto, a forza di girare per chiese e
musei romani con mio padre, mi ero innamorato del bello e credevo di poter
contribuire alle sorti dell’arte. Avevo frequentato corsi, l’avevo presa sul
serio. Quando ho deciso di smettere non ho più guardato un pennello, non potevo
permettermi tentazioni. Dalle tentazioni bisogna avere il coraggio di
allontanarsi sennò chissà quanti motivi d’appello avrei lasciato scadere per
dipingere i miei paesaggi...».
A fine intervista ce lo può svelare: erano
eleganti le cene a casa Berlusconi?
«Anche. Non mi faccia aggiungere altro».
PRESUNTI COLPEVOLI. OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI.
LA STRAGE DI
ERBA. Strage di
Erba, Olindo Romano "Siamo innocenti".
Video intervista Le Iene: “scambiati per ciò che non eravamo”. Strage di Erba,
video intervista Iene a Olindo Romano. Famiglia Castagna attacca: “Vendete
menzogne”. Antonino Monteleone in carcere per incontrare l'autore con Rosa Bazzi
del pluriomicidio, scrive il 29 ottobre 2018 Silvana Palazzolo su "Il
Sussidiario". Strage di Erba, intervista Le Iene a Olindo Romano. Dopo 12 anni,
Olindo Romano, condannato all'ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi nei tre
gradi di giudizio in quanto ritenuti i soli responsabili della strage di Erba,
ha deciso di rompere il silenzio concedendo una intervista in esclusiva alla
trasmissione Le Iene. Olindo ha raccontato la sua "verità", giurando sulla cosa
che ha di più caro, "mia moglie". Per tutta Italia è lui lo spietato assassino
che avrebbe sterminato un'intera famiglia, madre, figlia e nipotino di appena 2
anni, nonché una vicina di casa. Alla domanda di Antonino Monteleone sul perchè
sia in carcere, Romano ha replicato: "Non lo so nemmeno io. Forse ci hanno
scambiati per quello che non eravamo, ci han scambiati sicuramente". "I fatti
non coincidono con quanto accaduto e con quelle mezze confessioni", ha poi
aggiunto Olindo. "Non sono stato io ad uccidere quelle persone", ha proseguito,
sostenendo ancora una volta la sua innocenza. Poi, ritenendo di essere stato
accusato ingiustamente, ha evidenziato i suoi dubbi: "Pensavo fosse stato il
marito", ha spiegato, riferendosi ad Azouz Marzouk, padre del bimbo di due anni
e marito di una delle donne uccise nella strage. (Aggiornamento di Emanuela
Longo)
Olindo Romano rompe il silenzio e lo fa
con un'intervista a “Le Iene”. È veramente lui il
mostro di Erba? Se lo chiede Antonino Monteleone, che ha firmato il ciclo di
servizi sulla strage. «Io non faccio mai interviste, per la tv è la prima
volta», dichiara l'ex netturbino prima di rispondere alle domande del
giornalista. «Il tempo è passato alla svelta, dodici anni sono tanto tempo»,
prosegue prima di entrare nel merito del pluriomicidio. E lo fa giurando su sua
moglie Rosa Bazzi. «Non so nemmeno io perché sono in carcere, qualcuno ci ha
scambiati sicuramente. I fatti non coincidono con tutto quello che è successo.
No, non sono stato io ad ucciderli». All'epoca Olindo si fece un'idea su chi
poteva essere il responsabile: «Quando vieni accusato ingiustamente, ti guardi
bene dal puntare il dito contro qualcuno se non sei più che certo, è questo il
discorso». Poi ammette: «Noi pensavamo che era stato il marito (Azouz Marzouk,
ndr). Loro litigavano, una volta siamo andati su a dividerli, un'altra sono
arrivati i carabinieri. Sicuramente erano professionisti». Il marito di
Raffaella Castagna ora sostiene che Olindo e Rosa possano essere innocenti: «So
che lo ha sempre pensato, ma i primi tempi non lo ha detto perché doveva trovare
il modo di uscire dal carcere, poi avrebbe detto quello che ha sempre pensato».
Nell'intervista Antonino Monteleone affronta il tema relativo al movente, quindi
alle continue liti della coppia con le vittime. «Lei sul tardi faceva delle
feste e non ci lasciava dormire. Siamo arrivati anche ad insultarci. Come si
faceva a sopportarli? Eravamo sempre a litigare, ma mica ammazzi uno perché non
lo sopporti». La domanda delle domande però è un'altra: perché hanno confessato?
«Ci siamo ritrovati in un contesto che portava a quello. Ci ritrovammo da casa
nostra al carcere nel giro di poco tempo. Quando ci siamo rivisti non sapevamo
neppure perché eravamo lì. Dopo due giorni due carabinieri ci hanno detto che
eravamo messi male. Ci dissero che confessare sarebbe stato “il minore dei
mali”». Qualcuno gli ha suggerito di confessare? «Abbiamo cercato di resistere,
ma quando mi hanno detto che non avrei rivisto mia moglie... Anche quello ha
influito. Se volevo vedere mia moglie dovevo dirgli qualcosa, e io li ho
seguiti». Per Olindo Romano i magistrati hanno fatto leva sui loro sentimenti
per spingerli a confessare. «Noi inizialmente abbiamo detto che non c'entravamo
nulla». Eppure hanno cominciato a rivelare dettagli che solo gli assassini
potevano sapere: «Ce li hanno mostrati loro. Alcuni dettagli gli abbiamo visti
su un mucchio di fotografie che ci hanno messo sul tavolo». Olindo Romano spiega
che la premeditazione è stata confessata a causa di una strategia concordata con
l'avvocato di ufficio. «Ci aveva detto di essere convincenti». E questo legale
avrebbe consigliato a Rosa Bazzi di denunciare di aver subito una violenza
sessuale da Azouz Marzouk: «Mi sa che non è vera...». Olindo Romano vorrebbe che
la vicenda giudiziaria venisse riaperta: «Vorrei la revisione del processo, un
giudice onesto valuti le cose per quello che sono, ma dopo questo chi si prende
la patata bollente? Ma non siamo arrivati alla fine». (agg. di Silvana Palazzo)
Il programma “Le Iene” continua ad occuparsi
della strage di Erba, dove l'11 dicembre 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna,
il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria
Cherubini, mentre il marito di quest'ultima - Mario Frigerio - fu gravemente
ferito. Per il pluriomicidio sono stati condannati all'ergastolo i vicini di
casa delle vittime, i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Sono poche le
anticipazioni fornite dalla trasmissione sull'intervista che andrà in onda
stasera. «Ci diamo del tu?», chiede Antonino Monteleone a Olindo Romano quando
lo incontra in carcere. «Diamoci del tu poi se ci scappa qualche lei ci sta»,
risponde Olindo, come mostra il video di anticipazione del servizio. Dopo 12
anni di silenzi, l'assassino ha deciso di parlare con un giornalista. Sono
tanti, secondo “Le Iene”, i dubbi sul caso che - è bene precisarlo - è stato
chiuso dopo i tre gradi di giudizio. Il programma ha quindi espresso il
desiderio di intervistare entrambi i condannati, e il ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede ha precisato che non ci sono ostacoli, quindi “Le Iene” ha
ottenuto l'intervista con Olindo Romano in carcere. L'inchiesta de “Le Iene” è
partita dai dubbi di Azouz Marzouk, che nella strage di Erba ha perso moglie e
figlio, e di molti esperti e giornalisti. Poi è stata analizzata la
testimonianza dell'unico superstite, Mario Frigerio, quindi Antonino Monteleone
si è concentrato su una prova, la macchio di sangue trovata sull'auto dei due.
Il dubbio della Iena è che ci sia stato un inquinamento delle prove. Nel quarto
servizio è stata trattata la morte di Valeria Cherubini con una ricostruzione
alternativa a quella stabilita dalle sentenze. Nell'ultimo servizio andato in
onda, invece, “Le Iene” si interroga sul motivo che ha spinto Olindo e Rosa a
confessare. L'inchiesta de “Le Iene” sulla strage di Erba ha diviso l'opinione
pubblica e provocato la dura reazione di Pietro e Beppe Castagna, fratelli di
Raffaella, secondo cui il programma vende «menzogne spacciandole per verità». In
un post su Facebook nei giorni scorsi hanno criticato quanti stanno mettendo in
dubbio la verità emersa dai processi. «Non sta a noi né difendere la procura né
gli inquirenti né il loro operato, consentiteci di difendere però la verità, che
per noi è solo una, consentiteci di essere indignati e increduli nel sentire
gente che definisce i colpevoli come innocenti vittime di una giustizia sommaria
e faziosa, definiti addirittura come "un gigante buono e una gracile signora"».
Ma Olindo Romano e Rosa Mazzi «hanno ucciso brutalmente nostra madre, nostra
sorella, nostro nipotino, la signora Valeria, hanno tentato di uccidere il
signor Mario, spezzando pochi anni dopo la sua vita e pochi mesi fa la vita di
nostro padre, facendo vivere a me e a Beppe, a Elena e Andrea Frigerio un incubo
continuo».
Strage di Erba, Olindo Romano: "Siamo
innocenti", scrivono il 29 ottobre 2018 Le Iene.
Olindo Romano, condannato con la moglie Rosa Bazzi all’ergastolo per la strage
di Erba, parla per la prima volta in tv. Lo fa dal carcere con il nostro
Antonino Monteleone, nel sesto appuntamento dell’inchiesta di Marco Occhipinti e
Monteleone sui quattro omicidi del 2006. “Non siamo stati noi”, “non sono stato
io a uccidere quelle persone”. Olindo Romano, condannato all’ergastolo assieme
alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba (Como), continua a professare
l’innocenza sua e della moglie. Lo fa in carcere nella sua prima intervista
rilasciata in tv, dopo 12 anni di silenzi, al nostro Antonino Monteleone. Nella
strage dell’11 dicembre 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio
Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.
Rosa e Olindo, secondo la sentenza ormai definitiva, li hanno uccisi per le
continue liti condominiali. Per Le Iene questa intervista esclusiva è il sesto
appuntamento dell’inchiesta di Marco Occhipinti e Antonino Monteleone, che hanno
messo in dubbio molti elementi delle indagini. "Forse ci hanno scambiati per
quello che non eravamo, i fatti non coincidono con tutto quello che è successo,
comprese quelle mezze confessioni, non sono stato io a uccidere quelle persone”,
dice Olindo. “Quando vieni accusato ingiustamente, poi ti guardi bene dal
puntare il dito a qualcuno se non sei più che certo”, è per questo che dice di
non volere fare nomi su chi possa avere commesso la strage. “Litigavamo con loro
per le solite liti condominiali. Il motivo della prima era su una festa. Avevo
la camera da letto sotto il soggiorno, andavano avanti fino alle quattro del
mattino. E io mi dovevo svegliare alle cinque”, continua Olindo. “Non ho mai
visto spacciare, però il vai e vieni c'era. Ci arrivava di tutto. Si capiva che
c'era qualcos'altro, oltre alle feste. Ammazzi uno perché non lo sopporti?
Litigare sì”. “Gli assassini erano dei professionisti, non hanno lasciato in
giro niente”, sostiene. Olindo entra in molti particolari dell’inchiesta. Una
delle tante domande che viene spontanea è per tutti: perché allora hanno
confessato (e poi ritrattato) una strage mai commessa? “Ci siamo ritrovati in un
contesto che ci portava a quello. Ci siamo trovati da casa nostra al carcere,
nel giro di un'ora e mezza. In carcere non sapevamo neanche perché eravamo lì.
Aspettavo qualcuno che venisse a dirmi qualcosa. Dopo due giorni sono arrivati
due carabinieri. Ci hanno detto che eravamo messi male, e in poche parole ci
hanno prospettato una via d'uscita. Era il minore dei mali confessare, una cosa
così. Il mio primo pensiero era riuscire a vedere mia moglie, perché da quando
eravamo entrati in carcere non l'avevo più vista. Noi abbiamo cercato di
resistere. Però ti dicono: se non confessi non vedi più tua moglie... Anche
quello ha influito. E quando sono arrivati i magistrati io mia moglie l'ho
vista. Io il mio scopo l'avevo raggiunto, ma loro il loro no. Hanno fatto leva
sui nostri sentimenti. All'inizio ai magistrati che volevano farci confessare
l'avevamo detto che non c'entravamo niente. Ma loro hanno continuato a
insistere. E non so neanch'io come sia successo, ma è saltata fuori tutta questa
storia”. E i dettagli che solo chi era stato sul luogo della strage poteva
sapere? “Ce li hanno fatti vedere loro! I magistrati, ci coinvolgevano loro! E
alcuni dettagli li abbiamo visti su un mucchio di fotografie degli omicidi che
ci hanno messo sul tavolo. Avevamo ammesso la premeditazione per avvalorare la
strategia difensiva decisa con l'avvocato precedente. Se tornassi al 2006
sicuramente non rifarei la confessione”. “Oggi mi sono iscritto a Biologia, va
benino, riesco a cavarmela. Mezza giornata la passo in cucina, il tempo che
rimane faccio un po' di pulizie...”, dice Olindo. “Vedo Rosa una volta al mese
per un'ora e ci parlo al telefono una volta a settimana”. La revisione del
processo? “Siamo passati da 26 giudici: vorrei trovare un giudice onesto. Ma
dopo tutto questo chi è che si prende la patata bollente? Penso che la vicenda
giudiziaria non sia conclusa perché se non siamo stati noi, è stato qualcun
altro. Male che vada, quando arriviamo a Strasburgo qualcosa cambia. Sul piano
giudiziario ci daranno ragione per forza. Ci vorrà un po' di tempo ma arriverà”.
La nostra inchiesta è partita nel primo servizio dai dubbi di Azouz Marzouk, che
nella strage ha perso la moglie Raffaella e il figlio Youssef, e di molti
esperti e giornalisti. Abbiamo analizzato poi la testimonianza dell’unico
superstite, Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini, che ha riconosciuto
Olindo come colpevole. In realtà, nelle sue prime parole al risveglio avrebbe
parlato di un’altra persona, di carnagione olivastra, che non aveva mai visto
prima e non del posto. Ci siamo soffermati successivamente su un’altra prova: la
macchia di sangue trovata sull’auto dei due. I dubbi aumentano, sia sul modo del
reperimento della prova sia sul suo possibile inquinamento. Nel quarto servizio
abbiamo parlato della morte di Valeria Cherubini. Una ricostruzione alternativa
a quella stabilita dalle sentenze sul suo decesso potrebbe scagionare Rosa e
Olindo. Anche il generale Luciano Garofalo, ex comandante del Ris dei
Carabinieri, proprio sulla base di questa e altre ricostruzioni, sostiene che “è
lecito avere dei dubbi sulla strage di Erba”. Nel quinto servizio, andato in
onda martedì 23 ottobre, ci chiediamo perché Olindo e Rosa hanno
confessato? Dalle intercettazioni emerge come Olindo decide di confessare
sperando di ottenere benefici di pena e non l’ergastolo e di lasciare la moglie
in libertà. Rosa però non ci sta: confessa per prima. Olindo prova allora a
scagionare lei, sostenendo di aver fatto lui tutto da solo. Hanno confessato
potendo vedere le foto della strage e conoscendo man mano le dichiarazioni
dell’altro. In tutto Olindo colleziona 243 errori nella sua ricostruzione, uno
ogni 30 secondi. Gli errori di Rosa sono incalcolabili.
Olindo: "Le nostre confessioni? Parte
della strategia difensiva". Romano, condannato
all'ergastolo insieme alla moglie: "Siamo innocenti, speriamo che ci sia un
giudice onesto", scrive Felice Manti, Lunedì 29/10/2018, su "Il Giornale". «Le
nostre confessioni facevano parte di una strategia difensiva che non ha
funzionato. Ma io e mia moglie siamo innocenti. Speriamo che in Italia ci sia un
giudice onesto». È un Olindo Romano sorridente e impacciato a parlare alla Iena
Antonino Monteleone ieri sera durante la sesta puntata della trasmissione di
Italia Uno che ha rilanciato i dubbi sull'inchiesta e sul processo che ha
portato alla condanna all'ergastolo per Olindo e la moglie Rosa Bazzi, colpevoli
secondo 26 giudici di aver ucciso Raffaella Castagna e suo figlio di due anni
Youssef Marzouk, Paola Galli la nonna del bambino, e Valeria Cherubini, la
vicina del piano di sopra, e di aver ferito mortalmente il marito della
Cherubini, Mario Frigerio, che a processo riconoscerà la coppia come autori
della mattanza che l'11 dicembre 2006 in via Diaz sconvolse per sempre la
tranquillità e la fama di Erba. Per la legge e l'opinione pubblica sono stati
riconosciuti da un testimone («Ma io con Frigerio non ce l'ho mai avuta, lo
hanno manipolato e girato come una patata», dice Olindo), incastrati da una
traccia di sangue trovata sull'auto e inchiodati da una confessione. Prove che
la trasmissione ha smontato, una a una, basandosi su riscontri di periti,
documenti in parte già usciti come sul Giornale nei mesi precedenti e successivi
alle fasi del processo e da testimonianze inedite. Ieri il colpo di scena
finale: chi si aspettava un Olindo pentito, rancoroso, cinico, è rimasto deluso.
Ma le sue accuse contro l'ex legale, i pm e i carabinieri sono pesanti. Si parte
dalle confessioni, arrivate, dice Monteleone, «dopo due giorni di isolamento,
l'ergastolo prospettato come una certezza, la promessa di benefici di pena in
caso di confessione e l'ingenua speranza di Olindo di poter ottenere una cella
matrimoniale». «I carabinieri ci hanno detto che eravamo messi male, se non
confessi non vedi più tua moglie... anche quello ha influito racconta Olindo
Romano - Hanno fatto leva sui nostri sentimenti, e lì è saltato tutto». E i
dettagli che solo gli assassini potevano conoscere? «Quando abbiamo confessato i
pm ci hanno mostrato delle foto, ce li hanno fatti vedere loro...», ammette
candidamente «dove non riuscivamo ad arrivare ci correggevano un po' loro... e
alcuni dettagli noi li abbiamo praticamente visti su un mucchio di fotografie
sul tavolo». Poi si passa al racconto sui rapporti con le vittime e sull'odio
come movente. Olindo racconta le feste a casa Castagna-Marzouk fino «alle due,
le tre di mattina... io mi dovevo svegliare alle cinque...» e delle liti
continue «ma dalla Raffaella siamo saliti anche a prendere il caffè!», racconta.
Senza dirsi stupito che Azouz Marzouk, il tunisino espulso per spaccio di droga
che nella strage ha perso moglie e figlio, lo consideri innocente: «Io penso che
lo abbia sempre pensato. Non l'ha mai detto prima perché era nei casini». Chi
sono i veri assassini? Gli chiede Monteleone. «Sicuramente professionisti, se
non han lasciato in giro niente. Sto pagando al posto loro. Ma quando vieni
accusato ingiustamente ti guardi bene da puntare il dito contro qualcuno se non
sei più che certo». Un po' di freddezza la riserva solo nei confronti di Carlo
Castagna («Come ha fatto a perdonarci? Non saprei...»). E sul video in cui Rosa
Bazzi racconta la mattanza in maniera delirante e poi denuncia di essere stata
stuprata da Azouz rivela: «Da quello che so io, questa denuncia qui, è stata
suggerita dall'avvocato (Pietro Troiano, nominato d'ufficio, ndr) che avevamo,
perché aveva quella sua strategia lì. Ci aveva detto di esser convincenti». Ma
secondo Olindo chi ascoltava la confessione (il perito della difesa Massimo
Picozzi, ndr) avrebbe dovuto capire che erano tutte balle («Essendo un
professore riuscirà a capire che c'è qualcosa che non va. Invece no...»). Una
strategia difensiva che, se fosse vera, si è dimostrata catastrofica. Ma Romano
non ce l'ha con il suo ex legale: «Ha sbagliato, però è stato travolto anche lui
eh. Noi non eravamo all'altezza della situazione per dire, no? Ma lui era messo
come noi».
Strage di Erba, Olindo Romano alle Iene:
“Ho confessato per proteggere Rosa e lei me”, scrive
Blitz Quotidiano il 29 ottobre 2018. “Ho confessato per proteggere Rosa e lei ha
confessato per proteggere me”. Risponde così Olindo Romano alle domande di
Antonino Monteleone. Il sesto appuntamento dell’inchiesta delle Iene dedicata
alla strage di Erba si svolge nel carcere milanese di Opera, dove Olindo è
rinchiuso da 12 anni. La moglie Rosa Bazzi, condannata insieme a lui
all’ergastolo, è invece reclusa nel carcere di Bollate. Era l’11 dicembre del
2006 quando Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli
e la vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane furono uccisi a colpi di
coltello e spranga in una palazzina a Erba, provincia di Como. “Ho di fronte il
mostro che ha preso a sprangate e sgozzato 4 persone o un povero cristo finito
in carcere per un orrendo delitto che non ha mai commesso?”, si domanda
Monteleone mentre microfoni e telecamere vengono sistemati nella stanza. E’ la
prima volta di Olindo in tv, dopo 12 anni di silenzi. L’inchiesta delle Iene era
partita dai dubbi di Azouz Marzouk, che nella strage ha perso la moglie
Raffaella e il figlioletto di appena 2 anni Youssef. Poi la testimonianza
dell’unico superstite, Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini, risparmiato
dagli assalitori perché creduto morto e che ha riconosciuto Olindo come
colpevole. In realtà, nelle sue prime parole al risveglio avrebbe parlato di
un’altra persona, di carnagione olivastra, che non aveva mai visto prima e non
del posto. Alle Iene Olindo Romano continua a professare la sua innocenza.
“Forse ci hanno scambiati per quello che non eravamo, i fatti non coincidono con
tutto quello che è successo, comprese quelle mezze confessioni, non sono stato
io a uccidere quelle persone”, dice. Ma non vuole fare nomi su chi possa aver
compiuto la strage. “Quando vieni accusato ingiustamente – spiega – poi ti
guardi bene dal puntare il dito a qualcuno se non sei più che certo”. Secondo la
sentenza, passata in giudicato, Olindo e Rosa ammazzarono i vicini di casa per
le continue liti condominiali. “Litigavamo con loro per le solite liti
condominiali – spiega alle Iene Olindo – Il motivo della prima era su una festa.
Avevo la camera da letto sotto il soggiorno, andavano avanti fino alle quattro
del mattino. E io mi dovevo svegliare alle cinque”. “Non ho mai visto spacciare,
però il vai e vieni c’era – prosegue – Ci arrivava di tutto. Si capiva che c’era
qualcos’altro, oltre alle feste. Ammazzi uno perché non lo sopporti? Litigare
sì”. “Gli assassini erano dei professionisti, non hanno lasciato in giro
niente”, aggiunge. E a quel punto la domanda sorge spontanea: “Perché ha
confessato?” “Ci siamo ritrovati in un contesto che ci portava a quello. Ci
siamo trovati da casa nostra al carcere, nel giro di un’ora e mezza. In carcere
non sapevamo neanche perché eravamo lì. Aspettavo qualcuno che venisse a dirmi
qualcosa. Dopo due giorni sono arrivati due carabinieri. Ci hanno detto che
eravamo messi male, e in poche parole ci hanno prospettato una via d’uscita. Era
il minore dei mali confessare, una cosa così. Il mio primo pensiero era riuscire
a vedere mia moglie, perché da quando eravamo entrati in carcere non l’avevo più
vista. Noi abbiamo cercato di resistere. Però ti dicono: se non confessi non
vedi più tua moglie… Anche quello ha influito. E quando sono arrivati i
magistrati io mia moglie l’ho vista. Io il mio scopo l’avevo raggiunto, ma loro
il loro no. Hanno fatto leva sui nostri sentimenti. All’inizio ai magistrati che
volevano farci confessare l’avevamo detto che non c’entravamo niente. Ma loro
hanno continuato a insistere. E non so neanch’io come sia successo, ma è saltata
fuori tutta questa storia”. Già nel quinto episodio dell’inchiesta le Iene si
erano soffermate sulle confessioni. Dalle intercettazioni emergerebbe che Olindo
decise di confessare sperando di evitare l’ergastolo e di lasciare libera la
moglie. Rosa Bazzi però non ci sta e confessa per prima. Olindo poi prova a
scagionarla, sostenendo di aver fatto tutto da solo. Monteleone gli domanda come
facesse allora a conoscere dettagli che solo chi era stato sul luogo della
strage poteva sapere? “Ce li hanno fatti vedere loro! I magistrati, ci
coinvolgevano loro! E alcuni dettagli li abbiamo visti su un mucchio di
fotografie degli omicidi che ci hanno messo sul tavolo. Avevamo ammesso la
premeditazione per avvalorare la strategia difensiva decisa con l’avvocato
precedente. Se tornassi al 2006 sicuramente non rifarei la confessione”.
L’intervista vira poi sulla vita di Olindo in carcere: “Oggi mi sono iscritto a
Biologia, va benino, riesco a cavarmela. Mezza giornata la passo in cucina, il
tempo che rimane faccio un po’ di pulizie…”, racconta. “Vedo Rosa una volta al
mese per un’ora e ci parlo al telefono una volta a settimana”. Sulla revisione
del processo Olindo Romano afferma: “Siamo passati da 26 giudici: vorrei trovare
un giudice onesto. Ma dopo tutto questo chi è che si prende la patata bollente?
Penso che la vicenda giudiziaria non sia conclusa perché se non siamo stati noi,
è stato qualcun altro. Male che vada, quando arriviamo a Strasburgo qualcosa
cambia. Sul piano giudiziario ci daranno ragione per forza. Ci vorrà un po’ di
tempo ma arriverà”.
Strage di Erba: Le Iene intervistano Olindo
Romano. Domenica 28 ottobre, in prima serata, su Italia 1, scrive Antonio
Galluzzo su Spettacolo news. Oggi, domenica 28 ottobre, in prima serata su
Italia 1, a “Le Iene Show”, Antonino Monteleone torna a occuparsi del processo
per la Strage di Erba con un’intervista esclusiva a Olindo Romano, uno dei
due condannati all’ergastolo per ilpluriomicidio avvenuto l’11 dicembre 2006.
Quella sera, nella cittadina in provincia di Como, vennero uccisi Raffaella
Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli, la vicina di casa
Valeria Cherubini e fu gravemente ferito il marito di quest’ultima Mario
Frigerio. Assieme a Romano, è stata condannata in via definitiva al carcere a
vita anche sua moglie Rosa Bazzi: i due erano vicini di casa delle vittime. Si
tratta della prima intervista rilasciata da Romano dopo la condanna. È stata
realizzata all’interno del carcere di Opera (Milano).
Iena: Buongiorno, Antonino Monteleone.
Olindo: Sì, la conosco tramite la tv.
Iena: Come va?
Olindo: Eh insomma, andiamo avanti.
Iena: È più nervoso l’avvocato…
Olindo: Sì mi sa di sì, mi sa di sì. Anche se io
di interviste non ne faccio mai però…
Iena: La prima volta?
Olindo: Eh penso di sì.
Iena: Per la tv è la prima volta.
Olindo: Sì penso proprio di sì, per la tv è la
prima volta, per la tv.
Iena: Ci diamo del tu o del lei?
Olindo: Ci diamo del tu, poi se ci scappa qualche
lei vabbè ci sta.
Iena: Intanto grazie per aver accettato.
Olindo: Sono io che ringrazio voi...
Iena: Quando ci hai scritto hai detto le Iene di
Canale 5…
Olindo: Ah beh, mi sono sbagliato, allora mi sono
sbagliato.
Iena: Li hai visti i nostri servizi?
Olindo: Sì sì sì, li ho visti.
Iena: Ma quando ti rivedi 12 anni fa e pensi a
tutto il tempo che è passato, che pensi?
Olindo: Che è passato alla svelta, che quasi 12
anni sono passati alla svelta, tanto tempo…
Iena: Noi possiamo chiederti qualsiasi cosa?
Olindo: Sì…
Iena: Va bene. Olindo, questa per te è
un’occasione unica quindi tutta la verità, nient’altro che la verità…
Olindo: Come sono andate le cose.
Iena: Lo giuri?
Olindo: Sì sì.
Iena: Qual è la cosa più cara che ha Olindo
Romano, su cui tu puoi giurare?
Olindo: Eh, mia moglie…
Iena: Tua moglie, cioè tu giuri su tua moglie
Rosa?
Olindo: Sì sì… sì sì lo giuro.
Iena: Per 26 giudici, 3 sentenze, quindi 3
tribunali, tu sei un assassino.
Olindo: Sì.
Iena: Hai ammazzato un bambino di due anni, la
madre, la nonna. Hai ferito a morte un vicino e ne hai ucciso la moglie, Valeria
Cherubini. Youssef Marzouk, Raffaella Castagna, Paola Galli.
Olindo: Sì… me li ricordo.
Iena: Per tutta Italia tu sei l’assassino spietato
che li ha fatti fuori. Perché sei in carcere?
Olindo: Eh, non lo so nemmeno io, forse… perché ci
han scambiati per… per quello che non eravamo. Ci han scambiati, sicuramente.
Iena: Gli italiani che ti guardano in questo
momento, perché dovrebbero crederti?
Olindo: Ehhhh, perché, come dire, i fatti non
coincidono.
Iena: Non coincidono con cosa?
Olindo: Con tutto quello che è successo, con
quelle mezze confessioni comprese.
Iena: È la prima volta che entro in un carcere ed
è la prima volta che intervisto un detenuto. Capisci se mi vedi un po’ nervoso…
io però vedo anche te che sei un po’ teso…
Olindo: Eh, eh… un po’ agitato sì, per forza…
Iena: Ci guardiamo negli occhi adesso, solo la
verità rende liberi, sei stato tu ad uccidere 4 persone la sera dell’11 dicembre
2006?
Olindo: No.
Iena: Nonostante tutti i dubbi di questa indagine,
io un pochino devo sperare che tu sia veramente il colpevole. Sai perché?
Olindo: No.
Iena: Perché se tu non fossi il colpevole, avremmo
un grossissimo problema in Italia, che riguarda la giustizia. Ma soprattutto
avremmo gli assassini di quattro persone a piede libero oggi in Italia.
Olindo: Eh, beh… sì. Per forza.
Iena: Questa cosa mi angoscia.
Olindo: Questo per forza.
Iena: È più comodo per me pensare che tu sia il
colpevole, quindi un pochino io ti guardo e dico “Ma possiamo permetterci che
non sia stato Olindo?” Al mio posto ti faresti questa domanda?
Olindo: Eh penso di sì, penso di sì.
Iena: Tu a un certo punto prima di finire in
galera, si sospetta di questi famosi vicini di casa…
Olindo: Sì, però non pensavamo di essere noi.
Quello è il discorso.
Iena: E chi pensavate che fosse?
Olindo: Beh sinceramente non pensavamo di essere
noi, potevamo pensare di qualcun altro per dire, però non… va beh lasciamo stare
che non è il caso, non è il caso di…
Iena: In questo momento, è il caso di dire tutto
quello che ti passa per la testa.
Olindo: Sì sì, però non… non lo so, di sicuro non
pensavamo di essere noi… quello di sicuro, dopo poi di cose se ne possono dire,
però a livello come dire, di pettegolezzi…
Iena: Io per primo mi preoccuperei se nel mio
condominio sgozzassero quattro persone.
Olindo: Eh lo so, però ehh, cosa devi fare, sei
lì…
Iena: Tu prima mi hai detto “Si possono dire tante
cose ma preferisco di no…”. Qual era questa cosa che preferisci non dire?
Olindo: Eh…
Iena: Tanto qua puoi dire tutto quello che vuoi,
perché più dell’ergastolo non ti possono dare.
Olindo: No, lo so…
Iena: Al massimo ti vengo a fare compagnia io
dopo, perché portano anche me con te quindi…
Olindo: No però non nella mia cella, io ci sto da
solo eh… Come dire, nel senso che: quando vieni accusato ingiustamente e finisci
in carcere eccetera eccetera, poi ti guardi bene dal puntare il dito contro
qualcuno se non sei più che certo. Allora è meglio lasciar perdere… è quello il
discorso.
Iena: Dovevi fare il giudice popolare allora.
Olindo: No no lasciamo stare.
Iena: Non puntare il dito, ma svelami
questo segreto.
Olindo: No, ma non è neanche un segreto, però sai,
che so io: se mi metto a parlare male di te e lo sente lui, può farsi un’idea
sbagliata…
Iena: Dai Olindo!
Olindo: No no lasciamo stare… non è giusto! No non
è giusto, non è neanche bello.
Iena: Sei all’ergastolo Olindo…
Olindo: Eh lo so, però non è…
Iena: E’ giusto che sei all’ergastolo?
Olindo: No, però vabbè non è neanche giusto che
vado a sparlare che so io, di qualcuno.
Iena: Ma non voglio che sparli, voglio solo che mi
dici il tuo pensiero, dell’epoca, non ti sto chiedendo di dirmi una cattiveria
gratuita.
Olindo: Eh lo so, però…
Iena: Quello che ti è venuto in mente.
Olindo: Pensavo che era stato il marito. Ho
pensato, però…
Iena: L’ha pensato tutta Italia!
Olindo: Eh lo so.
Iena: Che effetto ti fa sapere che Azouz Marzouk
pensa che tu e Rosa siate innocenti?
Olindo: È una cosa buona, ma io penso che lo abbia
sempre pensato. Solo che i primi tempi non l’ha mai detto, perché era nei casini
anche lui, si trovava in carcere anche lui no? Quindi doveva trovare il modo
prima di uscire dal carcere e poi dopo magari avrebbe detto quello che magari ha
sempre pensato…
Iena: Ma quando tu dici “Effettivamente noi
pensavamo che era stato il marito”, lo pensavi perché ti risultava che
litigassero?
Olindo: Sì! Che litigavano sì, vabbè… una volta
siamo andati su anche noi a, come dire, a dividerli…
Iena: Su a casa di Raffaella?
Olindo: Sì sì… una volta… una volta o due sono
arrivati anche i carabinieri… sì…
Iena: Per dividerli.
Olindo: Sì.
Iena: Ma tu hai mai visto Azouz spacciare nella
corte di via Diaz?
Olindo: Eh qualcuno, beh sì, di gente ne arrivava,
però io non è che… come dire, io non ho mai visto spacciare diciamo, però con il
vai e vieni, diciamo ci arrivava di tutto… sì poi, si capiva che c’era anche
qualcos’altro oltre alle feste che faceva, però non è che vai a ficcarci il
naso.
Iena: Cosa pensi degli assassini che hanno fatto
quella strage?
Olindo: Beh… sicuramente erano professionisti, se
non han lasciato in giro niente.
Iena: Se io fossi innocente per prima cosa
penserei che sto pagando al posto loro.
Olindo: Sì però… è vero sto pagando al posto loro
però…
Iena: Perché litigavate spesso con Azouz Marzouk e
Raffaella?
Olindo: Le solite liti condominiali…
Iena: E quand’è che litigate la prima volta?
Olindo: Beh la prima volta, penso dopo un paio di
anni…
Iena: Un paio d’anni.
Olindo: Più o meno.
Iena: Però ti ricordi il motivo della prima
litigata?
Olindo: Sì, in pratica lei la sera, sul tardi,
faceva come delle feste in casa sua. Dove invitava un sacco di gente e
praticamente non ti lasciava dormire.
Iena: Perché tu avevi la camera da letto sotto
al…
Olindo: Sotto al soggiorno.
Iena: Che ore erano?
Olindo: Eh andavano avanti fino alle due, le tre e
anche le quattro di mattina… io dovevo alzarmi alle cinque. Le prime volte
litigavamo, glielo andavo a dire il giorno dopo… poi dopo si arrivava anche a
battere con la scopa sul soffitto. E poi siamo arrivati anche a insultarci…
Iena: Con Rosa qualche volta se le sono proprio
date, si sono date due schiaffi.
Olindo: No, beh… proprio date date no.
Iena: Qualche spintone?
Olindo: No, eh no, lo spintone se non sbaglio si
riferisce allo stendibiancheria…
Iena: Cioè?
Olindo: Mia moglie aveva messo lo stendibiancheria
fuori di casa, poi non so se aveva litigato con la Raffaella, una cosa del
genere. Lei è arrivata giù e ha buttato per aria tutto.
Iena: Lei Raffaella?
Olindo: Raffaella… solo che nell’andarsene o nel
fare questo movimento è scivolata da sola e lì mi pare che c’aveva fatto la
denuncia, che era stata spinta, ma in realtà aveva fatto tutto da sola.
Iena: Che tutti si convincono, sono stati Olindo e
Rosa perché? Perché litigavano da tanti anni, ci sarebbe stata da lì a pochi
giorni un’udienza in tribunale e…
Olindo: Sì, sì sì sì…
Iena: Olindo e Rosa sarebbero probabilmente stati
condannati…
Olindo: No...
Iena: Il movente diciamo che erano queste
liti, che voi non li sopportavate più.
Olindo: Eh beh come fai a sopportarli? Logicamente
dopo non li sopporti più. Dopo, come dire, sei sempre dietro a litigare, sei
sempre dietro… però l’avvocato che avevamo per quella causa lì, ci aveva detto
che non c’era niente da preoccuparsi perché avevamo tutte le ragioni, ci aveva
detto… quindi non…
Iena: A un certo punto però, posso dirti che
secondo me l’avete fatta grossa sai quando? Il giorno in cui voi seguite in
macchina Raffaella Castagna che è a bordo del treno. Lei se ne accorge, chiama
la polizia e vengono i vigili urbani a fermarvi.
Olindo: Ah la polizia locale, sì sì…
Iena: Cioè perché avete fatto questa cosa? L’avete
fatta proprio grossa, dice lei che vi vede dal finestrino del treno.
Olindo: Sì, ma l’abbiamo vista anche noi.
Iena: Eh ma perché…
Olindo: Anche io l’avevo vista.
Iena: La stavate seguendo?
Olindo: Nooo, allora… lì così, stavamo facendo
quella strada lì perché mia moglie aveva trovato un lavoro… ehh… in una zona lì
a Canzo e ci sarebbe dovuta andare a lavorare a breve diciamo. Praticamente
eravamo andati a vedere che strada… siccome lei non aveva la patente della
macchina no, se era meglio prendere il treno, cioè prendere a Erba e andare su
con il treno e poi farsi l’ultimo pezzettino a piedi… in poche parole siamo
andati a vedere la strada che avrebbe dovuto fare per andare a lavorare lì.
Iena: Coincidenza c’era…
Olindo: Coincidenza eh… e l’abbiamo fatta,
l’abbiamo ripetuta due o tre volte quella strada lì, la Castagna ci ha
visto, avrà pensato male e ha chiamato i vigili, ha chiamato…
Iena: Eh però se lei non guida, non fai la strada
in macchina. Prendete la corriera.
Olindo: Sì però bisogna vedere anche gli orari del
treno, perché c’era il treno, o gli orari del pullman.
Iena: E alla fine che cosa conveniva fare, il
pullman o il treno?
Olindo: Alla fine si è messa d’accordo ed è andata
a lavorare di pomeriggio e ce la portavo io, alla fine.
Iena: Un fatto che insospettirebbe chiunque, dice
questi ce l’avevano talmente in odio che la seguono, la pedinano…
Olindo: No, era per questo motivo, non era per…
non era per quello… poi dopo…
Iena: Però che non vi sopportavate me l’hai detto
pure tu.
Olindo: Sì sì… quello ci stava…
Iena: E li avete ammazzati!
Olindo: No eh, e che vai ad ammazzare uno perché
non lo sopporti? Non penso proprio, litigare sì. Litigare ci stava…
Carlo Verdelli per ''la Repubblica'' del 9
settembre 2014. “Meglio l’erba dei vicini dei vicini di Erba”. Cioè, Rosa e
Olindo, basta il nome. Oltre al doppio ergastolo, cementato da tre gradi di
giudizio; oltre all’iscrizione perpetua tra i mostri della porta accanto; oltre
ad essere diventati una specie di marchio d’infamia per etichettare coppie
odiabili, Rosa e Olindo sono stati anche lapidati dal sarcasmo popolare. Niente
conta che abbiano più volte ritrattato le loro confessioni, attribuendole alle
pressioni ricevute in quei giorni funesti. Otto anni dopo la mattanza, resta la
scia malata di un ricordo inumano, e una foto incompatibile: Olindo che a un
processo, dietro le sbarre, dice qualcosa teneramente a Rosa e lei ride come una
bambina felice. Sulla pietra tombale calata su questi sventurati, si è da poco
aperta una breccia. Fine dell’isolamento diurno, che tra una cosa e l’altra
(pena accessoria, più la necessità di proteggerli dagli altri detenuti, vista
l’infamità del crimine) durava da quando la coppia più schifata d’Italia è
entrata in un carcere, 8 gennaio 2007, per non uscirne più. Oggi stanno in due
prigioni del milanese, lei a Bollate, lui a Opera, si vedono tre venerdì al mese
per due ore, che passano tenendosi la mano. Olindo Romano, 52 anni, nome
ereditato da uno zio alpino scomparso in Russia nel 1943, è più che ingrassato
(ha toccato i 119 chili per un metro e 66), cura un orto da caserma ingentilito
da una pianta di rose, si tormenta perché gli sta scadendo la patente, come se
davvero un giorno potesse tornare a guidare il suo Eurocargo della spazzatura.
Dicono che “non è più in sagoma”, che si fissa sulle cose, che è convinto che
prima o poi il signor Frigerio, cioè il testimone che l’ha inchiodato, si
ricorderà meglio e lo scagionerà. E poi pensa incessantemente a Rosa, la sua
metà, e non è un modo di dire: non ci fosse ancora lei, argine al suicidio, non
ci sarebbe più lui. Una simbiosi quasi patologica che include loro e esclude il
resto. Rosa Bazzi, 51 anni, mancina (particolare non secondario, visto che
alcune delle vittime riportano ferite inferte da una mano sinistra), petulante,
bisbetica, con una ossessione per l’ordine tanto apprezzata dalle signore erbesi
che serviva a ore, si è adattata al carcere meglio del marito. Non legge niente
e non risponde alle lettere, come invece fa lui, perché non sa leggere né
scrivere, nonostante una remota licenza elementare. In compenso frequenta la
sartoria, dove ha cucito un paio di tendine per la cella di Olindo, che resta la
sua preoccupazione centrale. Lei, leader della coppia? Di sicuro è Rosa che con
le sfuriate e gli insulti (per altro ricambiati) a Raffaella Castagna e al
marito Azouz Marzouk ha cominciato a scavare l’abisso dove sono poi precipitate
tante vite, compresa la sua. L’abisso si spalanca lunedì 11 dicembre 2006. Verso
le otto di sera, Rosa e Olindo lasciano la loro casetta a pianoterra, scala B,
di una ex cascina ristrutturata, venti famiglie affacciate su un cortile chiuso.
Hanno un progetto, che poi Olindo spiegherà così: “Non volevamo ammazzarli, solo
riempirli di botte”. Fanno una quindicina di metri a sinistra verso il portone
accanto, salgono a viso scoperto un piano di scale e in una ventina di minuti
sterminano con una sbarra di ferro e due coltelli quattro persone, quasi cinque.
Nell’ordine di esecuzione: Raffaella Castagna, 31 anni, figlia inquieta di una
delle famiglie bene della città; Paola Galli, 57 anni, madre di Raffaella e
nonna di Youssef, 2 anni e tre mesi, trafitto sul divano della sala con due
colpi alla gola. Dopo aver appiccato un incendio nelle due camere da letto, i
killer trovano sul pianerottolo i coniugi Frigerio, richiamati dal fumo. Li
fanno fuori entrambi, solo che lui si salva grazie a una malformazione alla
carotide, lei invece, Valeria Cherubini, 55 anni, finisce straziata, con il suo
cagnolino Martina asfissiato ai suoi piedi. In tutto, una sessantina di colpi,
tra coltellate e sprangate, con schizzi di sangue che arrivano fino al metro e
sessanta. Completata la spedizione punitiva, siamo intorno alle 20 e 25, mentre
la corte di via Diaz 25 si riempie di pompieri, ambulanze, curiosi, Rosa e
Olindo tornano nella loro tana (per raggiungerla devono percorrere a ritroso
quei 15 metri allo scoperto, ma nessuno li vede), stipano armi e vestiti
insanguinati in tre sacchi neri della pattumiera, li infilano (sempre non visti)
sulla loro Seat Arosa grigia, scaricano i sacchi in tre diversi cassonetti e poi
vanno a mangiare gamberi e bacon a un McDonald’s di Como. Otto euro e 25 il
conto. Timbro dello scontrino: 21.37, un’ora e qualcosa dopo l’ultimo omicidio.
Anche se parecchio stretti (mezz’ora di auto, 10 minuti per attraversare la zona
pedonale di Como, più il tempo minimo per la cena), gli orari potrebbero forse
tornare. O forse no. Nell’incertezza, inquirenti e giurie passano oltre, come su
altre incongruenze, dalla sparizione delle armi usate per i delitti al fatto che
i Ris di Parma non trovano tracce di Rosa e Olindo né nell’appartamento della
strage né sui corpi o tra le unghie delle vittime (qualcuna di loro, Raffaella
per esempio, che era una donna piuttosto imponente, deve aver sicuramente
lottato prima di soccombere) e nemmeno nella casa degli assassini; in compenso,
dalla Castagna, rilevano impronte non appartenenti ad alcuna delle persone
presenti sulla scena del crimine, impronte che però non vengono esaminate e
quindi restano “non attribuibili”. Persino il luogotenente Luciano Gallorini,
capo di lungo corso dei carabinieri di Erba, ha un momento di incertezza. Il
primo giorno in carcere, Rosa nega tutto davanti a tutti. Poi chiede di lui, gli
si butta tra le braccia e singhiozzando implora: mi aiuti, mi aiuti! “Me lo
chiese con così tanta passione”, dirà Gallorini, “che per un attimo ho pensato:
magari stiamo sbagliando”. Un attimo fuggente. “La più atroce impresa criminale
della storia della Repubblica”, secondo il pubblico ministero Massimo Astori. A
commetterla, sempre secondo Astori, oltre a tre Corti della Repubblica, un
netturbino corpulento e una minuscola domestica. Sintesi ancora di Astori: “Quei
due sono molto più di una coppia. Sono un quadrupede”. Movente dello scatenarsi
del quadrupede: sei anni di liti da ballatoio, con i Romano sempre più
intolleranti verso la famiglia di sopra, composta da Raffaella, Azouz, il figlio
Youssef, più gli amici, stranieri e no, spacciatori di droga e no, che andavano
e venivano a tutte le ore. Troppo chiasso, troppo disordine, troppo.
Esasperati, Rosa e Olindo hanno fatto pulizia, che è in fondo il mestiere di
entrambi, sperando poi di farla franca con la storia del McDonald’s. Ma il
signor Frigerio, quando si è ripreso dal trauma, li ha riconosciuti, prima lui
poi anche lei, loro hanno confessato e in 28 giorni il caso si è chiuso. Il 10
gennaio 2007, dalla ricca e devota Erba, gioiello della Brianza alta tra Milano
e Como, 7 parrocchie per 17 mila abitanti e 23 sportelli bancari (il doppio
della media nazionale), si leva un sospiro di sollievo che si estende come
un’eco all’intero Paese. Poi, rapidamente, si fa largo un altro sentimento,
almeno tra gli erbesi: il disgusto per la vicenda che ha sporcato la reputazione
della città. Quando pochi mesi dopo la tragedia, Pino Corrias va lì a presentare
il suo documentato e dolente libro-inchiesta “Vicini da morire” (Mondadori,
ottobre 2007), a differenza che in molte altre piazze, trova ad accoglierlo una
sala vuota. “Io vengo da Reggio Calabria e là c’è omertà perché la gente ha
paura. Qui lo stesso, ma perché non vuole fastidi”. Fabio Schembri, 47 anni,
avvocato (senza cravatta, capellone, gran fumatore), è una mosca bianca e forse
avventata. Si aggira tra via Diaz e la vicina piazza Mercato, da dove secondo
lui potrebbero essere passati i veri killer, con una frustrazione che il tempo
non attenua. Insieme alla collega Luisa Bordeaux, è tra i pochissimi ad essere
convinti che Rosa e Olindo siano innocenti. “Erano i tonti del villaggio, non
avrebbero avuto né la testa né la forza per combinare quel disastro. Il problema
è che le altre piste possibili sono state archiviate in fretta, neanche battute
in verità, una voragine investigativa. Ma un colpevole bisognava trovarlo. E
quei poveri cristi, senza parenti né amici, indifesi e indifendibili, erano
perfetti. Pensi che il giorno dell’arresto è Olindo che telefona ai carabinieri
perché la corte è piena di giornalisti e lui teme che possano danneggiargli il
camper parcheggiato davanti alla lavanderia, e Rosa chiama la signora dove
doveva andare a servizio profondendosi in scuse perché era costretta a saltare
l’impegno. I carabinieri, che già li stavano andando a prelevare, li scaricano
davanti al Bassone di Como. Olindo li guarda stupito: in carcere? Io e la Rosa?
Ma perché? Risposta: buona fortuna”. Schembri è il secondo avvocato di Rosa e
Olindo, quello che li ha accompagnati in tutti i processi, perdendoli. Gratis,
comunque, visto che il poco che i due avevano, compresa la casa valutata 70 mila
euro, è stato venduto per risarcire le parti civili. Quanto al primo avvocato
(assegnato d’ufficio), Pietro Troiano, dura sei mesi, punta sulla perizia
psichiatrica e sul rito abbreviato “data la sovrabbondanza di prove”. La prima
non la otterrà, né lui né il suo successore, ed è abbastanza sconcertante, visto
il caso. Il secondo nemmeno, perché nel frattempo i suoi assistiti cominciano a
maturare il sospetto di essere stati incastrati e cambiano strategia. Ma
incastrati da chi? Anche se è un calcolo senza senso, le persone che
nell’inferno brianzolo hanno perso di più sono Carlo Castagna (figlia, moglie,
nipotino) e Azouz (moglie e figlio). Due uomini agli antipodi. Il primo, 70
anni, è un mobiliere superlativo in tutto: soldi, fede, filantropia. Vox populi:
a Erba non si muove foglia che il signor Carlo non voglia. Sposato dal 1968 con
Paola, donna altrettanto perfetta e pia, hanno tre figli, due maschi (Pietro e
Giuseppe) di 44 e 40 anni, impegnati a seguire le orme di tanto padre, e la più
piccola, Raffaella, “una che vuole salvare il mondo”, frequenta centri sociali e
immigrati, diventa amica di “quelli che vendono le zebre al mercato”. A 23 anni
esce di casa, papà gli compra la casa di via Diaz, poi le cose si complicano
quando non solo si innamora di Azouz, un tunisino che vive ai margini della
legalità e oltre, ma lo sposa pure e ci fa un figlio, nato il 6 settembre 2004.
E’ Youssef, così descritto dallo zio Pietro nel libro di Corrias: “Era una
specie di cartone animato, bellissimo, allegro”. Un piccolo ponte fragile,
destinato magari nel tempo a sanare la rottura tra l’erede ribelle e la parte
maschile dei Castagna, rottura che invece di rimarginarsi si dilata: Azouz
spesso picchia e maltratta Raffaella, finisce anche in carcere per spaccio di
droga (sconta solo 16 mesi grazie a un indulto) ma lei annuncia lo stesso alla
famiglia che vuole trasferirsi presto in Tunisia, e con la parte di patrimonio
che le spetta. Nel periodo della strage, il ponte prova comunque a farlo nonna
Paola, che prende il nipotino quando la figlia è al lavoro (un part time
pomeridiano in una casa per anziani disabili a Magreglio), gli prepara la cena,
poi lo riporta a sera dalla figlia. Così anche “quella” sera, solo che
stranamente Paola lascia a casa borsetta e telefonino, guida in ciabatte e
dimentica la porta della Lancia K aperta nel cortile di via Diaz. Dove sta
correndo? Il marito di Raffaella ne ha combinata un’altra? Azouz Marzouk ha 26
anni all’epoca. Viene da una buona famiglia tunisina di Zaghouan, 30 chilometri
dal mare di Hammamet. Emigra sognando la Germania, finisce in Brianza dove già
sta il fratello Salem, che gli somiglia come un gemello. Incontra i giri della
droga e Raffaella, non separandoli. Visto il tipo, i precedenti penali, la
risaputa violenza di lui verso la moglie, il procuratore capo di Como Alessandro
Mario Lodolini, a botta calda, annuncia: “Sospettiamo che l’autore dei delitti
sia il marito”. Peccato che “il marito” sia da una settimana in Tunisia dai
genitori. Una partenza disastrosa delle indagini che metterà ansia e fretta a
chi investiga. Si ipotizzano tre piste: rapina, vendetta trasversale nel mondo
dello spaccio, faida familiare. Muoiono tutte sul nascere quando Carlo Castagna,
dopo aver commosso l’Italia ai funerali (“Perdono chi ha ucciso, lo devo a Dio e
ai miei morti”), butta lì al luogotenente Gallorini il nome di Olindo: “La sera
del fatto ebbi modo di vederlo tra la gente e da allora ho un cruccio che mi fa
pensare a lui”. Il cruccio diventa molto più pesante quando Mario Frigerio, oggi
settantenne, ripete quel nome: Olindo. In realtà non ci arriva subito. Appena si
riprende in ospedale, il 15 dicembre, dice di non conoscere chi l’ha colpito e
fornisce un identikit che porta altrove: tanti capelli corti neri, occhi scuri,
carnagione olivastra (Olindo ha pochi capelli radi, occhi verdi, pelle bianco
latte). Dieci giorni dopo, però, la memoria cambia: “E’ stato un vicino,
l’Olindo. Non volevo crederci ma adesso mi è chiaro”. Fatalità vuole che
proprio lo stesso giorno, il 26 dicembre, venga rinvenuta una macchiolina sul
predellino della Seat dei Romano: il dna è di Valeria Cherubini. Con tutto il
sangue colato in cortile dopo i getti d’acqua dei pompieri, e con tutto il
sangue che gli assassini, per quanto “ripuliti”, devono essersi portati in auto,
sembra persino poco che sia resistita solo quella traccia. Comunque, solo
quella. A chiusura del cerchio, nel febbraio 2008, quando si sta istruendo a
Como il processo di primo grado, sempre Frigerio aggiungerà di aver visto,
quella sera, “una seconda persona, una donna, quasi sicuramente Rosa Bazzi”. Nel
maggio 2011, pur confermando gli ergastoli, la Cassazione alza un sopracciglio
su queste parole, definendole “oggettivamente vischiose”, e più in generale
sull’intera inchiesta: “Numerosi sono i dubbi e le aporie che si addensano sul
caso”. A spazzarli via tutti, dovrebbe bastare, ed è bastata in giudizio, la
doppia confessione del “quadrupede” Romano, datata 10 gennaio, 2 giorni dopo
l’arresto, un mese dalla strage. Ma anche lì qualcosa stona. Il prima,
innanzitutto. Olindo ha appena avanzato alle autorità che l’attorniano richieste
insensate: una cella matrimoniale, poi la scarcerazione di Rosa, quindi il suo
breve trasferimento in un ospedale psichiatrico, quindi tutti a casa. Il tragico
è che deve aver ricevuto qualche tipo di rassicurazione.
Olindo: Ciccia, ho parlato col magistrato. Mi ha
detto che se vogliamo fare finire questa storia qui… Di dire la verità.
Rosa: Ma non c’è niente da dire, niente. Olli,
hanno fatto tutto loro.
Olindo: Loro mi hanno spiegato un po’ la
situazione in termini pratici...
Rosa: Olli, non siamo stati noi.
Olindo: Lo so, aspetta, è per tagliare le gambe al
toro. Io becco le attenuanti e finisce tutta la storia.
E così Olli taglia il toro. A modo suo, con una
ricostruzione che contiene 243 buchi, tra “non ricordo”, errori nel
posizionamento delle vittime, nel numero dei colpi, assenze sui punti più
insopportabili (“Perché il bambino? Non lo so”). A rileggerla per intero, o
siamo davanti a un attore formidabile, e quindi l’ergastolo è ancora poco,
oppure un po’ di aporia postuma è giustificabile. Ne è venuta anche ad Azouz,
che intanto si è risposato con una ragazza di Lecco, con cui ha avuto una
bambina, e vive da espulso in Tunisia: “Prima pensavo diverso ma mi sono
convinto che Rosa e Olindo stanno solo pagando per la loro ingenuità. Prego il
signor Frigerio di dire la verità”. Quale altra verità, per esempio? Il
sostituto procuratore di Como Massimo Astori, che all’epoca condusse indagini e
accusa, è serenissimo: “Mai avuto un’incertezza. Una tribù ha invaso lo spazio
di un’altra, che ha reagito con una vendetta primordiale, conclusa col fuoco.
L’unico rammarico è di non aver fatto filmare la Bazzi mentre raccontava come ha
sgozzato il bambino, il gesto che ha fatto. Mi creda, da brividi”.
Comprensibilmente, l’avvocato Schembri immagina una scena diversa, che però non
è andata in aula. Qualcuno toglie la luce alla casa di Raffaella verso le 18.
Una coppia di siriani che abita sotto di lei, sente dei passi leggeri dalle
18.30 alle 20. Se così fosse, essendo la serratura intatta, vuol dire che chi è
entrato dalla signora Castagna aveva le chiavi, ha frugato per cercare qualcosa
e poi nel buio ha aspettato il suo rientro. Intorno alle 20, i siriani avvertono
un altro sonoro: mobili spostati, urla, lamenti. Sei-sette minuti e di nuovo
tace tutto. Poi il fumo dell’incendio, il chiasso sul pianerottolo, che coincide
con l’assalto ai Frigerio. Intanto, dall’esterno, l’abitante di un palazzo di
via Diaz affacciato alla finestra e un algerino che sta in Piazza Mercato notano
la stessa cosa: due extracomunitari fermi tra la via e la piazza, raggiunti a
incendio in corso da un uomo con il cappotto lungo fino alle ginocchia e una
berretta scura. All’algerino sembra di riconoscerlo, forse è italiano, certo non
l’Olindo, ma al momento del processo non si presenta a dirlo. Era in carcere per
droga a Modena, ma nessuno l’ha cercato e quindi è risultato irreperibile. E
poi, francamente, la credibilità di uno spacciatore non è altissima. Su tutta la
vicenda pende da due anni un ricorso alla Corte di Strasburgo e, a breve, una
richiesta di revisione a Brescia. Intanto Olindo Romano, nella sua cella di
Opera, ha studiato una dama rivoluzionaria dove si gioca in tre o anche in
quattro. Improbabile, anzi impossibile, come il sì di Strasburgo o di Brescia.
Ma per la metà di un “quadrupede”, abituato a pensare sempre e solo per due, un
indiscutibile passo avanti.
“C’è gente che ha visto gli assassini di mia
moglie e di mio figlio. E non si trattava di Olindo e Rosa. Nel commando della
strage di Erba erano tutti italiani”. Uomini bene addestrati che massacrarono
quattro persone e ne ferirono una quinta nel giro di appena 20 minuti.
Appiccando, nello stesso lasso di tempo, un incendio per fare sparire le tracce.
Torna a parlare della strage di Erba, Azouz, ma stavolta aggiunge nuovi dettagli
a Nicoletta Appignani su “La Notizia”: i suoi contatti
con alcuni testimoni oculari, le sue indagini, perfino di conoscere la
descrizione precisa di uno dei presunti assassini. Ora si trova in Tunisia, il
marito e padre di due delle vittime, espulso dall’Italia per reati legati alla
droga ed estradato nel suo paese. Sostiene l’innocenza dei Romano, al punto da
essersi rivolto all’avvocato Luca D’Auria per depositare un ricorso a
Strasburgo. Raggiunto telefonicamente, ora Marzouk spiega finalmente a La
Notizia quali siano le ragioni che l’hanno spinto a dubitare dei risultati dei
processi. “È tutto nelle carte – racconta – l’insieme di elementi che potrebbero
condurre ai veri killer. Comprese le impronte mai analizzate. Ci sono troppi
dettagli che non tornano: gli assassini sono entrati in casa nostra senza
rompere nulla, i vicini hanno iniziato a sentire rumori nel nostro appartamento
già dalle 18.30 del pomeriggio. Ed è tutto nei verbali. Basterebbe leggerli
senza pregiudizi. Invece si sono sempre basati su prove dubbie: una microtraccia
di sangue nella macchina di Olindo e Rosa, che potrebbe essere finita lì in
mille modi e che non è neanche stata fotografata al momento del rilievo”.
Però c’è un testimone. Mario Frigerio,
l’unico sopravvissuto. Perché il suo appello a “dire la verità”?
“Per le contraddizioni. Una persona riconosce
subito l’aggressore nel suo vicino di casa. Invece Frigerio prima ha dichiarato
di non conoscerlo, che non era neanche della zona. Ha dato una descrizione che
non corrispondeva minimamente a Olindo. Poi invece ha detto che si trattava di
lui”.
Sua madre ha ricevuto una strana visita in
Tunisia. Cosa le disse?
“Mi avvertì che qualcuno si era presentato a casa
dicendo che i Romano con la strage di Erba non c’entravano. E poco prima che la
Corte di Assise di Como si riunisse in camera di consiglio, chiesi di
testimoniare. Volevo dire di svolgere altre indagini. Poi però mi sono tirato
indietro su consiglio del mio legale. Diceva che non sarei stato preso sul
serio. Solo in seguito ho deciso di prendere una posizione, ho cambiato avvocato
e con il mio attuale legale, Luca D’Auria, ho depositato il ricorso a
Strasburgo. Sono davvero convinto che Olindo e Rosa siano innocenti”.
Ha sospetti su chi possa essere stato a
commettere la strage?
Appena ho potuto sono andato a cercare le persone
che avevano parlato con mia madre, per saperne di più. E loro mi hanno riferito
che la sera della strage videro alcune persone allontanarsi dal cortile e
dirigersi verso piazza del Mercato. Erano italiani e uno l’hanno visto bene.
Allora ho cercato di convincerli a testimoniare, ma non hanno voluto, dicono che
hanno paura della giustizia italiana, soprattutto perché sono extracomunitari.
Lei non ha mai provato a cercare le
persone di cui le hanno parlato?
“Sì ma poi sono stato espulso. E comunque non era
compito mio. Sarebbe bastato visionare i nastri delle telecamere che si
trovavano nella piazza. C’erano. Eppure nessuno li ha mai guardati, come per i
video del Mc Donald’s di Como, dove si trovavano Olindo e Rosa quella sera”.
Ha mai pensato che gli omicidi potessero
essere una ritorsione nei suoi confronti?
“Questa è un’accusa che mi hanno mosso molte
persone. Ma io non ho mai avuto problemi o denunce. Né ho mai fatto finire
qualcuno nei guai. Le persone dovrebbero credere in quello che dico: non ho
nulla da nascondere. Non ho mai spacciato, anche se sono stato arrestato. C’è
anche chi crede che a causa di problemi in carcere possano avermi preso di mira,
ma in prigione esiste un codice: donne e bambini non si toccano. Quindi
sarebbero venuti a cercare direttamente me, non la mia famiglia. E non cerco di
passare da santo, a differenza di molte altre persone che in questa storia ci
hanno provato. Io sono una vittima: ho perso mia moglie e mio figlio, un bambino
di due anni, tre mesi e due giorni. A questo punto io cerco solo la verità”.
Non si arrendono i sostenitori dell’innocenza di
Olindo Romano e della moglie Rosa Bazzi, definitivamente condannati
all’ergastolo come autori della strage di Erba, l’11 dicembre del 2006. La
notizia, rimbalzata via internet, riguarda la costituzione di un "Comitato Rosa
- Olindo:”giustizia giusta", fondato dall'avvocato Diego Soddu e dai giornalisti
Paola Pagliari e Cristiana Cimmino, quest'ultima già autrice di una
pubblicazione, "Finché morte non ci separi", che raccoglie le lettere di Rosa e
Olindo dal carcere. Secondo i sostenitori dell'innocenza della coppia, «il
Comitato ha come scopo principale quello di promuovere le iniziative e le
attività che ritiene idonee al fine di dimostrare l'ingiusta condanna di Rosa
Angela Bazzi e Olindo Romano, attualmente condannati all'ergastolo. Sono campi
di intervento del Comitato tutti quelli in cui si può impegnare in una lotta
civile contro le forme di ignoranza, intolleranza, preconcetti, emarginazione e
discriminazione nei confronti di Rosa Angela Bazzi e Olindo Romano». Tra i
propositi ci sono quelli di organizzare convegni, dibattiti, riunioni, di
lanciare petizioni, raccolte pubbliche di adesioni, fondi e firme. I due coniugi
erbesi, lo ricordiamo, furono riconosciuti, dopo tre gradi di giudizio,
colpevoli di una delle più orrende stragi dell'Italia del Dopoguerra. Persero la
vita una giovane mamma, Raffaella Castagna, all'epoca 30 anni, disoccupata,
volontaria in una comunità di assistenza a persone disabili, colpita con una
spranga e da dodici coltellate; Paola Galli, 60 anni, casalinga, madre di
Raffaella, lei pure uccisa a colpi di coltello, e la vicina di casa Valeria
Cherubini, 55 anni, commessa, accorsa per prestare aiuto. Con un unico colpa
alla gola, Rosa Bazzi assassinò il piccolo Youssef Marzouk, un bambino di due
anni e tre mesi, figlio di Raffaella. Il marito della Cherubini, Mario Frigerio,
63 anni, si salvò per un miracolo. La sua testimonianza si rivelò fondamentale
per la condanna degli assassini.
Sono ormai passati più di sei
anni da uno dei delitti più efferati, la strage di Erba, ma nonostante la
confessione dei due colpevoli, i coniugi Olindo e Rosa Romano che abitavano
nello stesso palazzo in cui sono avvenuti i fatti, c'è chi li difende e ha
deciso di fondare anche un comitato a loro sostegno. E' sempre difficile
riuscire a dimenticare un caso di cronaca particolarmente grave nonostante il
passare degli anni e il delitto di Erba è certamente uno di questi proprio
perchè a causa di alcune liti di condominio due coniugi, Olindo e Rosa Romano,
che sono ora stati condannati all'ergastolo, hanno deciso di agire con grande
crudeltà attraverso coltellate e spranghe uccidendo quattro persone, tra cui
anche il piccolo Youssef, che al tempo aveva solo due anni e mezzo e senza
mostrare alcun tipo di pentimento. A distanza di qualche anno Carlo Castagna,
che con questo delitto ha perso moglie, figlia e nipotino, ha trovato la forza
di perdonare comunque gli assassini, anche se ben diversa è la reazione di Azouz
Marzouk, il suo ex genero, che non solo si è ricostruito una famiglia, ma
clamorosamente è arrivato addirittura a ipotizzare che i colpevoli non siano
Rosa e Olindo. Il parere de tunisino, pur essendo sorprendente, non è però
l'unico e lo dimostra anche la nascita di un comitato nato in loro dfesa
chiamato appunto "Comitato Rosa - Olindo:
giustizia giusta", che si pone proprio l'obiettivo quello di
promuovere una serie di iniziative e attività volte a dimostrare l'ingiusta
condanna della coppia. Si tratta comunque di un progetto apolitico e apartitico
nato dall'iniziativa dell'avvocato Diego Soddu e delle giornaliste Paola
Pagliari e Cristiana Cimmino, autrice del libro "Finchè morte non ci separi",
che raccoglie proprio le lettere che i due si son scambiati da quando sono
rinchiusi in carcere a dimostrazione che il loro legame, per quanto li abbia
portati a compiere un atto tanto grave, non ha scalfito minimamente il loro
amore. Da qui in avanti si proverà quindi a lottare contro ogni forma di
ignoranza, intolleranza, preconcetti, emarginazione e discriminazione nei
confronti di Rosa Angela Bazzi e Olindo Romano. Chi lo vorrà potrà quindi
aderire a questa iniziativa attraverso la partecipazione a dibattiti, convegni,
riunioni o raccolte fondi che saranno organizzati nei prossimi mesi.
Azouz Marzouk scagiona Olindo
e Rosa: "Non hanno ucciso loro Youssef e Raffaella". Una rivelazione che può
riaprire il processo. Il marocchino pensa che i due assassini della moglie e del
figlio non sono i vicini di casa.
Parole che fanno discutere. I
colpevoli non sono più colpevoli. Una rivelazione che può ribaltare una
sentenza. Azouz Marzouk torna a parlare sulla strage di Erba. La sua
dichiarazione lascia molte ombre su quello che è successo in quelle sera quando
morirono il figlio Youssef, di 2 anni e la moglie Raffaella Castagna, e la
suocera. Per l'omicidio sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi, che
per discussioni condominiali avevano deciso di fare fuori un'intera famiglia.
Ora Marzouk parla e mette in dubbio la colpevolezza di Olindo e Rosa: "Loro non
sono i colpevoli, sono solo dei poveretti che stanno pagando la loro ingenuità.
Credo che giustizia non sia stata fatta – spiega al quotidiano “Il Giorno” a
firma di Gabriele Moroni -. Ogni volta che ci penso, mi vengono in mente
particolari che mi convincono che a ucciderli non siano stati i Romano”. Azouz
vorrebbe la riapertura del procedimento per dimostrare che i due vicini non
hanno compiuto la strage. “Ci sono dei colpevoli in giro e degli innocenti in
galera. Prima o poi farò uscire la verità”. Su Erba il sipario non cala mai. «Olindo
e Rosa sono innocenti. Mi batterò perché la loro innocenza venga a galla».
Azouz Marzouk sei anni dopo. A sei anni
dalla strage di Erba, quell’11 dicembre di orrore infinito, nella casa di
ringhiera, grande come un falansterio, in via Diaz 25/C. Il
giovane tunisino, marito, padre e genero di tre delle
quattro vittime, parla da Zaghouan, la cittadina dove vive. E va oltre.
La Cassazione si preparava a confermare l’ergastolo ai coniugi Romano, i vicini
di casa che si erano autoproclamati giustizieri, e già Azouz auspicava una
rilettura dell’inchiesta. Oggi Marzouk compie un passo in più. «Credo - dice
scandendo le parole nell’italiano corretto di sempre - che giustizia non sia
stata fatta. Ogni volta che ci penso, mi vengono in
mente in mente particolari sia del processo sia della vita passata di mia moglie
e di mio figlio che mi convincono che a ucciderli non sono stati loro, i Romano.
Vedremo per un nuovo processo». Lancia quella che suona come una sfida. «Non ho
mollato il processo. Chi pensa che mi sia fatto da parte si sbaglia. Prima o poi
farò uscire la verità». L’ex netturbino di Erba e la moglie, la colf maniaca di
ordine e pulizia, sono allora due innocenti murati nel carcere a vita? Azouz
denuncia il suo parere assolutorio: «Sono dei
poveretti che stanno pagando la loro ingenuità. Ci sono dei colpevoli in giro e
degli innocenti in galera. Lo so perché ho passato anch’io il carcere da
innocente, sottolineo da innocente». Una nuova moglie conosciuta a Lecco, una
bambina, la proprietà di un minimarket nella sua città. Quanto pesa il passato
sulla vita che ha ricominciato? «Porto nel cuore la breve vita che abbiamo
passato insieme, io, Raffa, nostro figlio. La ripercorro almeno una volta la
settimana per non dire tutti i giorni. L’amore per loro non lo può cancellare
nessuno. L’uomo non è un computer a cui è possibile cancellare la memoria».
Quella sera acqua mista e sangue lungo le scale, ristagnava nell’ampio cortile.
Nell’appartamento al primo piano i corpi massacrati di Raffaella Castagna, della
madre Paola Galli, del piccolo Youssef, due anni, sgozzato, riverso su un
divano. Valeria Cherubini, la premurosa vicina, era vissuta giusto il tempo di
risalire le scale, nove gradini, un pianerottolo, un’altra rampa e altri nove
gradini, inseguita dal coltello assassino, per andare morire nella sua mansarda.
Un uomo contemplava il massacro della sua famiglia: Carlo Castagna, il marito di
Paola, il padre di Raffaella, il nonno di Youssef. Uomo di lavoro e di fede. Lì
affonda la sua serenità, la stessa che usa per commentare le affermazioni di
Azouz: «Non ho parole. Rispetto la sua posizione, anche se non riesco a capire
cosa lo abbia indotto a prenderla. Mi pare incredibile, dopo tre gradi di
giudizio. Come mi pare incredibile il ricorso della difesa a Strasburgo, come se
non si avesse fiducia nella magistratura italiana. Vado avanti. Vivo nel ricordo
di quelli che ho perduto, nella speranza e nell’attesa di raggiungerli. Nella
vita ho messo il fieno in cascina con mia moglie Paola. Tanto fieno. Mi ha
aiutato a passare questi inverni gelidi». Il coltello che gli trapassa la gola e
recide una corda vocale. Nelle orecchie le invocazioni di aiuto della moglie.
Mario Frigerio, il marito di Valeria Cherubini, è l’unico sopravvissuto. Ha
lasciato Erba, vive in una paese vicino (ancora in via Diaz), a pochi passi
dalla casa di Elena, la figlia dolce e forte. «Il nostro dolore - dice Elena -
lo teniamo tutto dentro. La sofferenza è ancora tanta, tanto grande che è
difficile esprimerla a parole». La truce saga di Erba forse non è ancora
conclusa. Il difensori di Olindo e Rosa tenteranno di ottenere un nuovo
processo. «Stiamo lavorando - dice l’avvocato Fabio Schembri - per la revisione.
Abbiamo raccolto elementi interessanti, nuove dichiarazioni».
Azouz Marzouk: "Rosa e Olindo innocenti,
il vero assassino è libero", scrive di Francesco
Borgonovo il 21 luglio 2016 su “Libero Quotidiano”. In quel teatro degli orrori
conosciuto alle cronache come la «Strage di Erba», Azouz Marzouk è uno dei
personaggi più disturbanti. Ambiguo, opaco, dotato di una carica negativa e
ammantato di una luce nera. Una vittima, certo. Ma non solo. Senz' altro un
protagonista, anche perché ha voluto a tutti i costi stare sotto i riflettori, a
un certo punto ha provato anche a trarre profitto dalla sua condizione, e questo
non ha giovato alla sua immagine. L'11 dicembre del 2006 - il giorno del sangue
- era in Tunisia, dove è nato nel 1980, per far visita alla sua famiglia.
Dunque, non è colpevole. Ma forse sa più di quel che dice, o forse millanta di
sapere quello che non sa: decifrarlo non è semplice. Resta che le sue
affermazioni aprono sempre voragini, spalancano interrogativi senza risposta.
Nel maledetto giorno di dicembre di dieci anni fa Azouz non era in Italia.
Intanto, nella corte di via Diaz a Erba, si manifestava uno scampolo di inferno.
Quella sera, Azouz perse la sua compagna Raffaella Castagna e suo figlio, il
piccolo Youssef, di appena due anni. Furono ammazzati a sprangate e coltellate,
con furia bestiale. Assieme a loro, morirono anche Paola Galli, madre di
Raffaella e suocera di Azouz, e Valeria Cherubini, una vicina di casa. Il tempo
passa, i mesi si sommano ai mesi, e su quella carneficina gravano ancora tanti
dubbi, in primis quello riguardante l'identità dei veri colpevoli. Già, perché i
tribunali hanno indicato in Rosa Bazzi e Olindo Romano gli autori del massacro,
eppure le sentenze non hanno illuminato tutti i luoghi oscuri. Ad Azouz, nel
frattempo, ne sono successe di tutti i colori. Sono emersi i particolari torbidi
del suo passato. Storie di droga e criminalità, l'espulsione dall'Italia, i
tentativi raccapriccianti di procacciarsi un po' di celebrità sfruttando la
mattanza dei suoi cari. Infine il matrimonio, nel 2009, con l'italiana Michela
Lovo. Ora Azouz vive in Tunisia, per sbarcare il lunario, dice, fa il fotografo
ai matrimoni. Sorte beffarda, per lui che voleva vedere stampate le sue, di
foto, sui giornali di gossip. Non potendo mettere piede qui, si fa raggiungere
dalla moglie appena possibile. Sono una famigliola felice, pare. Hanno due
figlie, una terza in arrivo. Ma qualcosa turba Azouz: i mostri del passato. Le
macchie che non riesce a lavare via tornano a perseguitarlo, e gli fanno temere
per la sua sorte e per quella dei suoi cari. Il tunisino, dopo mesi di silenzio,
ha deciso di parlare con i cronisti di Telelombardia. Lo ha fatto via Skype, e
la sua intervista integrale andrà in onda questa sera nel corso della
trasmissione Iceberg Lombardia condotta da Marco Oliva. Libero è in grado di
anticipare i dettagli della conversazione, per molti versi inquietanti. Marzouk,
infatti, da tempo si dice convinto che sulla strage di Erba non sia emersa la
verità. Secondo lui, insomma, i colpevoli non sono Rosa e Olindo. Non solo non
lo convince il romanzo horror dei vicini di casa assassini del profondo Nord.
«Non sono convinto di tutto il processo», spiega. «Ancora ho dei dubbi, secondo
me gli assassini sono ancora fuori». Poi sospira: «La mia vita è iniziata in
salita ed è rimasta in salita». I mostri sono ancora lì, incubi che non se ne
vogliono andare. Dal suo Paese Natale, Azouz esibisce il suo italiano non
proprio perfetto, e parla di indagini e processi. «Ci sono dei punti che non
sono chiari, quindi a uno gli viene il dubbio. Io vorrei togliermi questi
dubbi», dichiara. Già, i dubbi. Per esempio quelli sulla confessione di Olindo e
Rosa. Per Marzouk, non regge alla prova dei fatti, contiene troppi «non lo so o
boh o non ricordo». Poi c' è la questione della vicina di casa. I soccorritori
hanno detto di aver udito i suoi lamenti, quell' 11 dicembre. Ma forse qualcosa
non torna. Secondo Azouz, il punto da chiarire riguarda «la testimonianza dei
Vigili del fuoco». «Sentivano Valeria Cherubini che gridava "aiuto! aiuto!"»,
ricostruisce, «e il medico legale dice che il taglio che ha sulla gola non le
permette nemmeno di parlare. Quindi c' è qualcosa che non va anche lì». Ma,
soprattutto, al tunisino non va giù che non siano «stati analizzati gli
indumenti di Youssef». Quella è stata «una sciocchezza», dice. Sui vestitini del
suo bimbo che non c' è più potrebbe esserci la chiave di volta di tutta la
vicenda, almeno di questo è convinto Azouz. «Sento che c' è qualcuno che ci sta
ostacolando», racconta ai microfoni di Telelombardia. E aggiunge parole
sibilline: «Se uno veramente si sente onesto, di aver fatto il suo lavoro bene,
non gli cambia niente nel fare gli esami sui vestiti di Youssef, su quel famoso
pelo che è stato trovato. Potrebbe essere dell'assassino». Ma chi è questo
assassino che ancora si muove «la fuori»? Da dove viene? Marzouk non lo dice. Fa
capire, però, di essere terrorizzato. «Temo sicuramente per la mia nuova
famiglia», spiega. Racconta di provare terrore ogni volta che non è assieme alla
moglie e alle sue bambine. «Ho paura», ripete. Forse non vorrebbe aggiungere
altro, ma il cronista lo incalza, e lui si lascia sfuggire un'altra
dichiarazione strana. «Ho paura che magari succede ancora quello che era
successo nel 2006». Ha paura che accada di nuovo, Azouz. Teme che qualcuno possa
accanirsi sulla sua compagna e le sue piccole. «Piuttosto di fargli del male
prima devono eliminare me», ruggisce. Prima di chiudere il collegamento via
Skype, Azouz afferma di essere disposto «a depositare la mia testimonianza».
Altro non aggiunge. Ma i suoi timori parlano per lui. La luce ancora non
illumina i luoghi oscuri di Erba.
Strage di Erba, Rosa e Olindo sono
innocenti? Verso la revisione del processo scrive il
23 aprile 2017 Roberto Ragone su osservatoreitalia.eu. E’ la sera dell’11
dicembre 2006, all’incirca 20 minuti dopo le 20, al numero 25 di via Diaz, a
Erba, in provincia di Como. La vecchia corte ristrutturata è composta da alcune
palazzine, ed è nota come Condominio del Ghiaccio. All’improvviso da una delle
finestre si alza una densa colonna di fumo. Due vicini di casa, uno dei quali
pompiere volontario, intervengono, ed entrano nella palazzina. L’incendio è al
primo piano. A ridosso del primo piano trovano un uomo ferito, Mario Frigerio.
Ha la testa nell’appartamento, e il corpo fuori, è prono, e lo trascinano al di
fuori dell’appartamento in fiamme.
Subito all’interno dell’appartamento brucia il
corpo di una donna: è Raffaella Castagna. I soccorritori trascinano anche lei
lontano dall’incendio, sul pianerottolo, spegnendo le fiamme che lo avvolgono.
Dal piano superiore odono la voce di una donna che ripetutamente e
disperatamente chiede aiuto. È Valeria Cherubini, la moglie di Mario Frigerio,
il quale, senza poter parlare perché ferito alla gola, indica ai due che
un’altra persona si trova di sopra. Le fiamme sono alte, il fumo sempre più
denso, e i due devono abbandonare l’impresa. Solo all’arrivo dei Vigili del
Fuoco vengono scoperti in totale quattro cadaveri e un ferito grave, Mario
Frigerio, che viene trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como. Sottoposto a
diversi interventi, si risveglia dall’anestesia dopo due giorni. Raffaella
Castagna, la donna il cui corpo era in fiamme, 30 anni, moglie di Azouz Marzouk,
è stata colpita al capo con una spranga di ferro, accoltellata dodici volte e
poi sgozzata. È morta per la frattura del cranio.
La madre di Raffaella, Paola Galli, 60 anni, viene
trovata all’interno dell’appartamento, anche lei colpita a sprangate e
accoltellata. Il decesso è avvenuto per frattura del cranio. Il piccolo Youssef
Marzouk, figlio di Raffaella Castagna e di Azouz Marzouk, due anni e tre mesi è
morto dissanguato sul divano, dopo aver ricevuto un’unica coltellata che gli ha
reciso la carotide. Al piano di sopra, nel sottotetto, giace il corpo di Valeria
Cherubini, 55 anni, moglie di Mario Frigerio. Nonostante la violenta
colluttazione con il suo aggressore, ha subito 8 colpi di spranga e 34
coltellate, una delle quali le ha reciso la lingua. All’arrivo dei soccorsi, la
donna aveva gridato più volte chiedendo aiuto, e si era trascinata lungo le
scale lasciando una impressionante scia di sangue, è morta per asfissia da
ossido di carbonio, prima che la morte intervenisse per la gravissime ferite
riportate. Morto per asfissia da monossido di carbonio anche il cane di casa.
Mario Frigerio, colpito più volte con una spranga
e accoltellato, è sopravvissuto grazie ad una malformazione congenita della
carotide, che ne ha impedito il dissanguamento.
I rilievi evidenziarono che l’aggressione era
stata opera di due persone, una delle quali mancina, armate di spranga e di
coltelli a lama lunga e corta. Date le modalità islamiche delle esecuzioni, la
prima persona sospettata è il marito di Raffaelle Castagna, Azouz Marzouk, 26
anni, tunisino, pregiudicato per spaccio di droga, da poco uscito dal carcere
per indulto.
Le successive indagini dimostrano che Marzouk era
all’estero, in Tunisia da alcuni giorni, in visita ai genitori, per un viaggio
programmato da tempo. Gli investigatori incominciano a pensare ad una vendetta
nei suoi confronti. Nell’appartamento situato sotto a quello della strage
abitano due coniugi senza figli, di mezz’età. Lei, Rosa Bazzi, ha 42 anni e lui,
Olindo Romano, 44. Rosa lavora come donna delle pulizie, lui è dipendente di una
ditta di raccolta e smaltimento rifiuti. È una coppia particolare, che vive in
simbiosi. Hanno un camper, con il quale ogni tanto fanno dei piccoli viaggi. Non
hanno amici, non hanno parenti, non hanno figli.
Il loro regno è la loro casa, insieme, sempre
insieme. Il Pubblico Ministero Massimo Astori, li definirà “Un quadrupede”. Una
coppia tranquilla, che da sempre soffre la presenza di una famiglia ‘rumorosa’
come quella che abita al piano di sopra, e con cui più volte ha avuto delle
liti. Per il 13 dicembre, due giorni dopo l’eccidio, è fissata l’udienza per la
causa civile con Raffaella Castagna, che ha denunciato la coppia per ingiurie e
lesioni in seguito ad una lite avvenuta il giorno di Capodanno 2005. Il loro
comportamento, per alcune piccole cose, appare sospetto agli inquirenti, come ad
esempio il fatto che Rosa, la sera del fatto omicidiario, abbia azionato la
lavatrice più tardi del solito, lei che era abituata a farlo sempre non più
tardi delle 18, come dimostrano i controlli eseguiti presso l'azienda elettrica.
Un'abitudine che aveva da tre anni, costantemente.
Perchè proprio quella sera Rosa ha cambiato
orario? E' una domanda legittima, ma il motivo può anche essere irrilevante.
Rosa e Olindo hanno un alibi: la sera dell’incendio sono stati al Mc Donald’s a
Como, e hanno ancora lo scontrino. Il quale dimostra però che sono stati al fast
food due ore dopo la strage, e quindi in tempo per compierla. Il loro torto è
quello di averlo mostrato senza che fosse loro richiesto, quasi a voler
presentare un alibi non necessario. L’attenzione delle indagini si concentra su
di loro, e ogni ragione è buona per sospettare del loro comportamento, anche
quando Rosa, intercettata, dice al marito: “Adesso sì che possiamo dormire.”
Successivamente vengono trovate piccole tracce di sangue femminile sugli
indumenti dei Romano e una macchiolina di sangue del signor Frigerio sul
tappetino della loro auto. Ciò che non viene trovato non viene considerato, cioè
indumenti insanguinati, armi del delitto, e grandi quantità di sangue di cinque
vittime. Si sa che gli accoltellamenti, e soprattutto gli sgozzamenti ne
producono in quantità incontrollabile, soprattutto sulle scarpe degli assassini,
nè vengono considerate le dichiarazioni di due testimoni oculari che riferiscono
di aver visto fuggire due persone di colore, forse tre, dal terrazzino del primo
piano dopo l'incendio. Nè si considera che Olindo non può aver ucciso la
Cherubini, che ancora gridava aiuto all'accorrere dei primi soccorritori, e che
è stata trovata con la lingua recisa da una coltellata, quindi uccisa da
qualcuno che era al piano di sopra mentre sotto si apprestavano le prime cure
alle vittime e si cercava di spegnere l'incendio. Nè si considera che nessuno ha
visto Rosa e Olindo nella corte, in quella circostanza. I coniugi vengono messi
sotto torchio.
La loro unica paura è quella di non poter più
vivere l'uno per l'altra, come sempre; il loro rapporto viene definito di
“succubanza reciproca”. Basta che un investigatore prospetti a Olindo la
possibilità d'essere divisi per sempre per farlo crollare, e decidere di
addossarsi la responsabilità della strage, con la promessa di pochi anni di
carcere e la possibilità di tener fuori Rosa. Ma Rosa non è d'accordo a rimanere
fuori, e il 10 gennaio 2007 Rosa e Olindo confessano. All’inizio lui cerca di
scagionarla, dicendo di ‘aver fatto tutto da solo’, ma Rosa confessa anche lei.
“Il bambino l’ho fatto io” dice al PM “La mamma l’ho fatta io e glie ne ho date
tantissime, anche alla Raffaella.” Il PM le chiede: “Di coltellate?” “Sì, di
coltellate.” Il 29 gennaio 2008 inizia il processo. Rosa Bazzi e Olindo Romano
vengono condannati all’ergastolo, con isolamento diurno per tre anni. La loro
unica mira è che non li si separi, e chiedono una cella matrimoniale.
L’appello presso il Tribunale di Brescia conferma
la sentenza, come la Cassazione. Mario Frigerio, il supertestimone, colui che
aveva sempre accusato Olindo di essere lui quello che lo aveva colpito la sera
dell’11 dicembre 2006, è morto il 16 settembre del 2014, otto anni dopo la
strage. Il camper e la casa dei Romano sono stati venduti all’asta, per
risarcire le vittime. La casa, dopo che le prime due sedute erano andate
deserte, è stata venduta per 69mila euro. Attualmente sono detenuti in due
carceri diverse, lui a Opera, lei a Bollate, e si vedono tre volte al mese per
due ore. Sono passati dieci anni, e Olindo spera in un permesso premio.
«Continuo a vedere Rosa tre volte al mese e questa è la cosa più importante.
Spero che prima o poi io e Rosa possiamo avere i permessi premio così potremmo
vederci tranquillamente e in santa pace come facevamo prima. Sarebbe bello avere
un permesso premio da soli con Rosa per farci un giro in camper e fermarci a
mangiare una pizza lungo il lago. Il problema è che il camper ce l’hanno
venduto. Chissà se il magistrato di sorveglianza ci darà l’ok. Mi ricordo il
giorno della strage e fino a sera è stato un giorno normale: lavoro, casa, Rosa,
McDonald’s… È da dieci anni che dura questo incubo, ma aspettiamo fiduciosi la
revisione del processo. Sono innocente». In fondo alla lettera l’ennesima
dichiarazione d’amore per la moglie: «Quello tra me e Rosa è un amore che
nessuno può dividere».
Olindo e Rosa, quasi si svegliassero da un brutto
sogno, una volta in carcere hanno provato a ritrattare, ma non sono stati
creduti. Ora si apre uno spiraglio, nell’interminabilità della loro detenzione,
la possibilità di una revisione del processo. Gli avvocati di Olindo e Rosa,
Nico D’Ascola, Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, intervenuti nella loro difesa
sei mesi dopo l’arresto, dopo il difensore d’ufficio, hanno presentato
un’istanza per riesaminare alcuni reperti la cui amplificazione era stata negata
ai tempi del processo, e che consistono in: alcune ciocche di di capelli, un
accendino, un mazzo di chiavi, due giubbetti, alcuni margini ungueali, un
cellulare, una tenda, una macchia di sangue mai analizzata ed altri reperti. In
merito a questa istanza, rimbalzata più volte da Como a Brescia, abbiamo parlato
con uno degli avvocati della difesa, l’avvocato Fabio Schembri.
Cristiana Lodi per “Libero Quotidiano” il 31
gennaio 2018. Non resta che ricorrere alla corte Suprema. Nell' attesa, Rosa e
Olindo della strage di Erba del 2006, dovranno restare all' ergastolo che già
scontano da undici anni. I giudici d' Appello di Brescia hanno infatti respinto
al mittente (la difesa) la richiesta di analizzare e cristallizzare con un
«incidente probatorio», alcuni reperti raccolti nella palazzina dove ci furono i
morti (quattro), un ferito e il fuoco. Reperti che all' epoca non erano stati
analizzati, perché gli indagati avevano confessato la strage. Salvo ritrattare
subito dopo. «Le nuove analisi richieste dai difensori dei condannati»
sostengono i magistrati bresciani, «non sarebbero in grado di ribaltare la
sentenza e tantomeno il giudizio di colpevolezza». Una marcia indietro
improvvisa, dato che a pronunciarsi in questo senso sono gli stessi identici
giudici d' Appello che, a novembre scorso, avevano al contrario acconsentito
all' analisi dei reperti in questione. Aprendo uno spiraglio alla revisione del
processo e una speranza per i coniugi Romani. Olindo e Rosa avevano cominciato a
crederci, anche perché erano già state celebrate due udienze per decidere le
modalità con cui procedere agli accertamenti sui fatidici reperti. Ora il cambio
di orientamento, con la dichiarazione di «inammissibilità» da parte degli stessi
giudici. Nel freddo linguaggio giurisprudenziale, i magistrati dei due pareri
opposti, spiegano che le richieste avanzate dalla difesa sono «generiche», e
quindi «meramente esplorative e inidonee a superare il vaglio di ammissibilità
richiesto dal codice», secondo il quale gli elementi indispensabili per chiedere
la revisione devono «essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato
deve essere prosciolto». La revisione è (sempre stando ai giudici) un fatto
«eccezionale» e non «un quarto grado di giudizio»; la richiesta dei legali dei
Romano non è invece in grado di «scardinare le prove già acquisite». A
cominciare dalle confessioni (poi ritrattate) di Olindo Romano e di sua moglie
Rosa Bazzi. La richiesta della difesa, dunque, «non presenta nemmeno un'astratta
potenzialità distruttiva del giudicato con il quale si deve in qualche modo
confrontare». Insomma, qualsiasi esito una eventuale analisi sui reperti potesse
dare, esso non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare che Olindo e Rosa sono
innocenti. Dunque niente test. Per i giudici i condannati sono colpevoli
comunque e a prescindere da qualsiasi perizia o altro esame. Non entreranno
dunque in laboratorio per essere analizzati «alla luce dei progressi della
scienza», come chiedevano gli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D'
Ascola, una serie di oggetti e sostanze biologiche. Per esempio «alcune
formazioni pilifere» trovate sulla felpa del piccolo Youssef, figlio di
Raffaella Castagna e nipote di Paola Galli, ucciso con una coltellata alla gola
(secondo la Corte da Rosa). Aveva due anni, Youssef. Poi i cosiddetti «i margini
ungueali delle vittime», e ancora «un accendino trovato sul pianerottolo della
famiglia Castagna», e «una traccia di sangue rinvenuta sul terrazzino della
casa, tre giacconi appartenuti a Raffaella Castagna, Valeria Cherubini e Paola
Galli, un mazzo di chiavi, la tenda dell'appartamento di Valeria Cherubini alla
quale la donna si aggrappò, dopo essere stata aggredita al piano di sotto».
Nulla di tutto questo sarà analizzato. Per Manuel Gabrielli, difensore della
famiglia Frigerio (i vicini dei Castagna morti nella strage), la decisione dei
giudici bresciani «risparmia ulteriore dolore ai famigliari delle persone che
sono morte». Secondo Fabio Schembri, avvocato dei Romano, invece «il
provvedimento smentisce una precedente decisione dei giudici stessi», e perfino
la «Cassazione che aveva annullato una precedente pronuncia contraria dei
giudici bresciani». Lo stesso avvocato annuncia ricorso alla Suprema Corte. E
cita (testuali) le parole del presidente dei giudici d' Appello, Enrico
Fischetti, pronunciate nella prima udienza: «lo dico chiaro» disse il
magistrato, «noi faremo un'ordinanza di ammissione, sentiremo le parti, vi diamo
poi la data, la data di conferimento dell'incarico sarà, credo, a metà
gennaio...». Invece il 30 gennaio si fa macchina indietro.
Strage di Erba: Olindo e Rosa sono
innocenti? Tutti i dubbi sulla condanna. Un
documentario su Nove mette in luce elementi finora sconosciuti al grande
pubblico. Ecco perché potrebbero non essere i due coniugi gli autori della
strage, scrive l'1 Ottobre 2018 TPI. L’11 dicembre 2006, in un piccolo paese in
provincia di Como, 4 persone vengono barbaramente uccise a coltellate e
sprangate. Gli assassini, subito dopo, danno fuoco all’appartamento. È la strage
di Erba, uno dei delitti più efferati della storia italiana, un caso di cronaca
che avrà immediatamente un enorme risalto mediatico e a cui seguirà un processo
che si concluderà nel 2011. Le vittime della strage sono Raffaella Castagna,
30enne disoccupata e volontaria in una comunità di assistenza ai disabili, suo
figlio Youssef Marzouk, la madre della donna, Paola Galli, e Valeria Cherubini,
una vicina di casa che era intervenuta per prestare soccorso. Il marito di
Valeria Cherubini, Mario Frigerio, viene aggredito ma riesce a sopravvivere. Per
il delitto vengono condannati in via definitiva due vicini di casa di Raffaella
Castagna, i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Si tratta di una vicenda su cui
il giudizio di colpevolezza, dei giudici come dell’opinione pubblica, è stato
pressoché unanime per anni. Di recente, però alcune presunte certezze sono state
rimesse in discussione.
Martedì 10 aprile 2018, sul canale Nove, è andato
in onda un reportage intitolato “Tutta la verità”: una ricostruzione minuziosa
della strage, in cui vengono presentati elementi finora sconosciuti al grande
pubblico, e che ha fatto sorgere non pochi dubbi sulla reale colpevolezza dei
coniugi Romano. Proprio negli ultimi mesi, inoltre, la difesa dei Romano ha
presentato una richiesta di incidente probatorio su nuovi reperti. L’obiettivo
finale dei legali di Olindo e Rosa è quello di arrivare alla revisione del
processo. La richiesta è stata rigettata dalla Corte di Appello di Brescia, ma
gli avvocati dei Romano hanno presentato ricorso in Cassazione. Se l’incidente
probatorio fosse ammesso, potrebbero aprirsi scenari impensabili fino a qualche
mese fa.
La strage di Erba: i fatti. Intorno alle 20
dell’11 dicembre 2006, un incendio divampa in un appartamento situato in via
Diaz, a Erba. Ad appiccarlo sono le stesse persone che poco prima avevano ucciso
a coltellate e sprangate Raffaella Castagna, Paola Galli e il piccolo Youssef
Marzouk. La vicina di casa Valeria Cherubini muore invece all’interno della
propria abitazione. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni fatte dagli
inquirenti, sarebbe andata in soccorso della famiglia Castagna, attirata dal
fumo che usciva dal loro appartamento, ma sarebbe stata aggredita sulle scale
dagli assassini, per poi morire dissanguata. Assieme a lei c’era il marito Mario
Frigerio: anche lui accoltellato alla gola, riesce a sopravvivere grazie a una
malformazione alla carotide, che gli permette di non morire dissanguato.
I primi sospetti sul marito di Raffaella Castagna.
Inizialmente gli inquirenti concentrano le loro attenzioni su Azouz Marzouk,
marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef. Azouz, tunisino, aveva
dei precedenti penali per spaccio di droga ed era già stato in carcere.
Tuttavia, come si apprenderà pochi giorni dopo il delitto, Azouz in quel periodo
si trovava in Tunisia, in visita ai parenti. Il suo alibi è di ferro, e le
accuse contro di lui cadono immediatamente. Resta in piedi una pista che
riconduce indirettamente al marito di Raffaella Castagna: quando era in cella,
aveva avuto pesanti screzi con degli esponenti della ‘ndrangheta. Per evitare
che la situazione potesse degenerare, era stato addirittura trasferito in un
altro penitenziario. La strage di Erba è quindi una vendetta trasversale contro
il tunisino?
La svolta: vengono indagati Rosa Bazzi e Olindo
Romano. L’ipotesi della vendetta contro Azouz non trova seguito. Questo anche
perché i sospetti degli inquirenti si orientano molto presto verso due vicini di
casa di Raffaella Castagna, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il 26 dicembre vengono
disposti degli accertamenti sulla loro macchina. Viene rinvenuta, sul battiporta
dello sportello del guidatore, una traccia di sangue di Valeria Cherubini, una
delle vittime. I due coniugi vengono arrestati, e dopo alcuni interrogatori in
cui negano di essere gli autori della strage, l’11 gennaio 2017 confessano
davanti ai pubblici ministeri. La confessione avviene separatamente: ciascuno
dei due coniugi rivela ai magistrati come si sarebbero svolti i fatti. Tuttavia,
il 10 ottobre 2007, davanti al Giudice per l’udienza preliminare che deve
decidere se rinviare i coniugi a giudizio, Olindo e Rosa ritrattano, affermando
che la confessione gli è stata estorta dietro la promessa di ricevere sconti di
pena e di poter condividere la cella. Il Gup li rinvia a giudizio. Durante il
processo di primo grado, all’impianto accusatorio si aggiunge un altro elemento
che peserà come un macigno sulla successiva condanna. Mario Frigerio, l’unico
sopravvissuto alla strage, riconosce come suo aggressore in aula Olindo Romano,
confermando così quanto già aveva detto ai pubblici ministeri in fase di
interrogatorio. Sulla base di queste tre, pesantissime prove (la macchia di
sangue nell’auto, la prima confessione e il riconoscimento del testimone
oculare), il 26 novembre 2008 i coniugi Romani vengono condannati all’ergastolo,
sentenza confermata in appello e resa definitiva, il 3 maggio 2011, dalla Corte
di Cassazione.
Perché Rosa e Olindo potrebbero in realtà essere
innocenti. Proprio per la consistenza delle prove portate dall’accusa, i media
si sono sostanzialmente uniformati nel fornire una ricostruzione che individua
nei Romano i colpevoli certi della strage. In pochi hanno avuto dubbi sulle
effettive responsabilità di Rosa e Olindo. Del resto, con una traccia ematica,
una confessione e un testimone oculare, la loro colpevolezza sembra poter essere
provata, come vorrebbe la legge, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma è
proprio così? Il documentario trasmesso su Nove martedì 10 aprile evidenzia una
serie di elementi finora poco noti, per non dire del tutto sconosciuti,
all’opinione pubblica. Elementi che non solo intaccano in maniera significativa
le prove a carico dei Romano, ma che suggeriscono anche delle piste alternative
scartate forse troppo frettolosamente da inquirenti e magistrati.
La macchia di sangue sul battiporta dell’auto. Va
innanzitutto sottolineato come le numerose perquisizioni nell’abitazione dei
Romano e sul luogo del delitto non abbiano portato al rilevamento del benché
minimo elemento riconducibile a Rosa e Olindo. In altre parole, ad eccezione di
quella macchiolina di sangue sul battiporta della macchina, della presenza dei
Romano sulla scena del delitto non c’è traccia. Possibile che i due coniugi
siano riusciti a ripulire in maniera così certosina auto, abitazione e
appartamento della strage, nonostante quest’ultimo fosse già in fiamme pochi
minuti dopo l’aggressione (e dunque ben difficilmente accessibile e
“ripulibile”)? È quantomeno ipotizzabile che quell’unica traccia di sangue
trovata nella macchina fosse il risultato di una contaminazione (ovviamente non
volontaria). Nel documentario su Nove, viene evidenziato come già la sera della
strage, quando Olindo e Rosa vennero convocati in caserma in quanto vicini di
casa, la loro auto fu perquisita, anche con lo scopo di inserirvi delle cimici.
Uno dei carabinieri che effettuarono l’ispezione, come risulta dal verbale,
nell’immediatezza dei fatti era andato sulla scena del crimine. La perquisizione
della macchina avvenne solo poche ore dopo. Potrebbe quindi essere stato proprio
quel carabiniere a trasportare involontariamente una traccia ematica
dall’abitazione all’auto. Inoltre, viene rilevato come la presenza della macchia
di sangue sia attestata dagli inquirenti sulla base di una semplice fotografia
effettuata senza il luminol, un composto chimico utilizzato dalla polizia
scientifica per evidenziare macchie di sangue. “In quale versione della scienza
si accetterebbe un principio scientifico invisibile, quello di una macchia che
nessuno ha visto?”, si chiede nel documentario Luca D’Auria, avvocato di Azouz
Marzouk, il marito di Raffaella Castagna.
La confessione di Rosa e Olindo. Durante un primo
interrogatorio, che si svolge l’8 gennaio 2007, Olindo Romano e Rosa Bazzi,
interrogati separatamente, negano entrambi di aver commesso il delitto. In una
telefonata intercettata tra i due coniugi subito dopo gli interrogatori, emerge
chiaramente la loro preoccupazione di poter restare separati per il resto della
vita, reclusi in due diverse celle. In un successivo interrogatorio uno dei
procuratori, sapendo di poter far leva sul fortissimo legame tra i due coniugi,
dice a Romano: “Sua moglie ora la trasferiamo di carcere, e lei non la vede
più”. Lo stesso giorno, nell’interrogatorio di Rosa Bazzi, quest’ultima dice
agli inquirenti: “Lo so che mio marito non ce la fa a stare qua dentro, e io
così lo perdo per sempre”. I due coniugi parlano nuovamente tra loro dopo questa
sessione di interrogatori, e Romano prospetta alla moglie la possibilità di
prendersi tutta la colpa “per far finire questa storia”. La moglie protesta
contestandogli che non hanno nulla da confessare perché nulla hanno fatto. Ma il
10 gennaio, temendo che il marito possa auto-incriminarsi, Rosa Bazzi va dai
magistrati e confessa di essere lei l’unica autrice del delitto, scagionando il
marito. Poco dopo, Olindo Romano fa la stessa cosa, invertendo i ruoli: sarebbe
stato lui a salire, da solo, in casa di Raffaella Castagna, e a commettere la
strage senza che la moglie fosse minimamente coinvolta. In una telefonata
intercettata poco prima che i due coniugi decidano di confessare, Olindo dice a
Rosa che, così facendo, sarebbero potuti tornare entrambi a casa in tempi brevi,
mettendo fine a quella insopportabile separazione, e che avrebbero inoltre
goduto di notevoli benefici. Ci sono quindi seri dubbi sul fatto che la
confessione sia arrivata sulla base della falsa convinzione, verosimilmente
indotta dall’esterno, di ricevere un trattamento di favore, una pena mite nonché
di poter condividere la cella. Diversamente, Olindo e Rosa erano convinti che
non si sarebbero mai più rivisti. Oltre a questo, va rimarcato come la
ricostruzione fatta dai due coniugi sulle modalità con cui sarebbe stato
commesso il delitto risulti del tutto incompatibile con molte circostanze poi
accertate dagli inquirenti. Tra i tanti esempi che si possono fare: Olindo e
Rosa non sapevano che gli assassini avevano staccato la luce in casa Castagna
attorno alle 18.30 (per poi verosimilmente commettere il delitto, che si
consumerà alle 20, dopo aver aspettato le vittime all’interno
dell’appartamento). Inizialmente non menzionano la circostanza. Quando gli viene
segnalato che la luce era stata staccata, affermano di averlo fatto alle 20,
cosa assolutamente impossibile secondo quanto rilevato dagli inquirenti.
E ancora: viene accertato che gli assassini, per
dare fuoco alla casa, hanno usato del liquido infiammabile. Olindo e Rosa
invece, nelle loro confessioni, affermano di aver fatto tutto con un semplice
accendino. Sono solo alcune delle numerosissime contraddizioni rilevabili in
quegli interrogatori. Persino la sentenza di secondo grado stabilirà come la
ricostruzione fatta da Olindo e Rosa durante le loro prime confessioni non fosse
sovrapponibile con il reale svolgimento dei fatti, affermando però che si
sarebbe trattato di una strategia deliberata dei due coniugi volta a lasciarsi
aperto uno spiraglio per una futura ritrattazione.
Il testimone oculare: Mario Frigerio. L’ultima
decisiva prova è quella relativa alla testimonianza di Mario Frigerio, l’unico
sopravvissuto alla strage. Frigerio, durante il processo, riconosce in aula
Olindo Romano come suo aggressore. Tuttavia, nell’immediatezza della strage,
quando aveva ripreso conoscenza in ospedale, Frigerio aveva dichiarato (in
conversazioni registrate) di non essere minimamente in grado di identificare il
suo aggressore. Poco dopo affermerà di avere qualche vago ricordo di una persona
“di carnagione olivastra, comunque non del posto”. Ripetutamente imbeccato in
questo senso dai pm, dopo numerosi colloqui, Frigerio arriverà
all’identificazione di Olindo Romano. Come viene mostrato nel documentario su
Nove, inoltre, nelle settimane successive al delitto, a causa del trauma subito,
le capacità cognitive di Frigerio erano sensibilmente compromesse. Visitato da
un neuropsichiatra, Frigerio mostrerà di non riuscire a svolgere nemmeno calcoli
estremamente banali come 100-7.
Le piste alternative. Come visto, quindi, tutti
gli indizi che hanno portato alla sentenza di colpevolezza per Olindo Romano e
Rosa Bazzi sono molto meno solidi di quello che si potrebbe pensare sulla base
di una conoscenza superficiale della vicenda. Ma se non fossero stati loro a
commettere la strage, chi potrebbero essere i veri colpevoli? La pista sulla
‘ndrangheta e sui compagni di cella di Azouz Marzouk, il marito di Raffaella
Castagna, viene vagliata dagli inquirenti almeno in una prima fase, ma non porta
a nulla di concreto. Il documentario di Nove fa invece luce su un’altra pista,
forse troppo frettolosamente scartata in fase di indagini. Secondo quanto
riferisce Azouz Marzouk, Raffaella Castagna, due mesi prima del delitto, aveva
chiesto ai genitori un anticipo di eredità. I fratelli di Raffaella, Pietro e
Beppe, avevano visto dietro questa richiesta una manovra di Azouz, accusandolo
così la sorella di volergli sottrarre il patrimonio per darlo al marito
tunisino. Da quel momento, sempre secondo Azouz, i rapporti tra Raffaella e i
suoi fratelli si erano interrotti del tutto. In una telefonata tra Pietro
Castagna e un suo amico, effettuata pochi giorni dopo il delitto e intercettata,
si sente il fratello di Raffaella ridere di gusto sulla strage, facendo ironia
sugli sforzi degli inquirenti di trovare i colpevoli a abbandonandosi a frasi
come “sarà stata la Franzoni”. Carlo Castagna, il padre di Raffaella, afferma
che la sera della strage era preoccupato perché non aveva visto rientrare la
moglie, la quale generalmente effettuava i suoi spostamenti con un Fiat Panda,
che invece non veniva utilizzata dal marito. Carlo Castagna dirà poi che sempre
la sera della strage, aveva visto proprio quella Fiat Panda rientrare nel suo
garage attorno alle 22.30, con a bordo una persona diversa da sua moglie. La
circostanza inquietante, e mai del tutto chiarita dagli inquirenti, è che i
Castagna, nell’immediatezza del delitto, hanno provato (riuscendoci) a liberarsi
di questa Fiat Panda. Nello specifico, l’auto viene donata a un convento di
suore, come verrà confermato dalle stesse religiose. Come viene fatto vedere nel
documentario, le suore rivelano addirittura come i Castagna (padre e due
fratelli) si fossero recati in convento due o tre giorni dopo il delitto per
lasciare in dono la macchina. Questa circostanza verrà però scoperta solo alcuni
anni dopo il delitto grazie a delle intercettazioni telefoniche. Nonostante
questo, gli inquirenti non riterranno di dover fare alcun tipo di accertamento
sulla Panda “per rispetto del dolore dei familiari”, come dice nel documentario
Luciano Gallorini, comandante dei carabinieri di Erba. “Io mi domando, ma stiamo
scherzando? Se si fossero voluti accertare davvero i fatti, la prima cosa da
fare era sequestrare quella Panda per fare le opportune analisi”, sono le parole
di Azouz Marzouk. Come rivela lo stesso Azouz, inoltre, pochi giorni dopo la
strage un suo amico tunisino, anche lui residente a Erba, gli racconta che
quella sera si trovava nel cortile del condominio di via Diaz, e che aveva visto
tre persone confabulare indicando l’ingresso di casa Castagna. Anche un altro
testimone, Fabrizio Manzeni, sosterrà di aver visto quella sera alcune persone
nella corte del condominio, riconoscendo poi una di queste persone in Beppe
Castagna, uno dei fratelli di Raffaella Castagna. Infine, la porta
dell’appartamento non presentava segni di effrazione, lasciando presumere, o
quantomeno ipotizzare, che gli esecutori del delitto fossero in possesso delle
chiavi.
Conclusioni. Al di là di quello che deciderà la
Corte di Cassazione sulla richiesta di incidente probatorio presentata dai
legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, il documentario trasmesso su Nove solleva
non pochi dubbi sulla colpevolezza dei due coniugi. Viene evidenziato come
inquirenti e pubblici ministeri, nei giorni successivi alla strage, si siano
forse troppo frettolosamente convinti della colpevolezza dei due vicini di
Raffaella Castagna, non indagando abbastanza a fondo sulle altre possibili
piste. Lo stesso Azouz Marzouk, marito e padre di due delle vittime,
inizialmente convinto della colpevolezza dei Romano, ha poi cambiato idea:
“Olindo e Rosa sono innocenti. Mi batterò perché la loro innocenza venga a
galla. Credo che giustizia non sia stata fatta. Ogni volta che ci penso, mi
vengono in mente particolari sia del processo sia della vita passata di mia
moglie e di mio figlio che mi convincono che a ucciderli non sono stati loro, i
Romano. Sono dei poveretti che stanno pagando la loro ingenuità”.
N.B.: Per completezza d’informazione,
pubblichiamo a questo link la lettera scritta da Beppe Castagna – “fratello, zio
e figlio” di tre delle quattro vittime del delitto di Erba – e indirizzata alla
redazione del programma di Nove “Tutta la verità”.
La lettera scritta da Beppe Castagna "fratello,
zio e figlio" di tre delle quattro vittime del delitto di Erba, pubblicata su
TPI il 20 Aprile. 2018. Giovedì 19 aprile 2018 abbiamo pubblicato un
articolo che ricostruiva le tesi presentate nel documentario del programma
“Tutta la verità” andato in onda su Nove, di Discovery Italia, sulla strage di
Erba.
Per completezza d’informazione, pubblichiamo la
lettera scritta da Beppe Castagna – “fratello, zio e figlio” di tre delle
quattro vittime del delitto di Erba – e indirizzata alla redazione del programma
“Tutta la verità”.
“Buongiorno, ci avete fatto passare un paio di
giorni d’inferno, mio fratello non si è ancora del tutto ripreso, ma abbiamo la
pelle dura e supereremo anche questo. Ma veramente credete di aver fatto un buon
lavoro? Avete spacciato per verità delle tesi innocentiste che non hanno mai
avuto valore in nessuno dei gradi di giudizio. Non contenti avete buttato fango
su di noi… ma avete un’idea di quello che abbiamo vissuto e sopportato? di
quanto è stato difficile andare avanti? Ci avete messi alla gogna, insinuando
dubbi e sospetti su di noi, utilizzando addirittura il nostro diniego ad una
vostra intervista come rafforzativo. Avete fatto ascoltare un’intercettazione di
mio fratello, ulteriore rafforzativo per creare un mostro, ma guardate che anche
dopo aver subito un lutto plurimo la vita continua, fra le lacrime si continua a
mangiare, a sentire amici e magari a fare battute ciniche… P.S.: la risata era
dell’amico. Ma, non avete fatto ascoltare le intercettazioni di Azouz, tipo: “è
il periodo più bello della mia vita” o: “mi pagano anche per fare sesso” o
addirittura: “cosa me ne frega a me delle bare” …Avete riportato solo e soltanto
il materiale che vi è stato suggerito da Panza, Montolli e Schembri,
tralasciando le montagne di materiale che certifica la colpevolezza dei coniugi
Romano. Avete montato in modo strumentale le interviste a Gabrielli e Gallorini.
Avete permesso a Montolli di dire una serie di inesattezze strumentali, come ad
esempio il verbale che ci riguarda: Verso le ore 22.00, non riuscendo ancora a
contattare mia moglie, ho informato mio figlio Giuseppe che la mamma non era
ancora rientrata. Mio figlio mi informava che aveva sentito una macchina e
quindi mi diceva di controllare in quanto la mamma poteva essere in cortile o in
giro per casa. Io facevo un controllo ed accertavo che la macchina arrivata era
sì quella di mia moglie, ma con un’altra persona sopra, tralasciando quello che
c’era dopo la virgola: in quanto come detto, mia moglie aveva preso la mia
LANCIA K e non la sua. L’utilizzo della mia infatti avveniva da una settimana,
in quanto la sua la utilizzava mio figlio che a sua volta aveva la sua in auto
officina. Vorrei tralasciare tutto il discorso della Panda perché è veramente
ridicolo… quel fenomeno di Candian l’ha “trovata” non grazie al suo fiuto, ma
perché lo dissi al direttore Brindani, durante uno scambio di messaggi e poco
dopo l’investigatore arrivò dalle suore. Perché l’abbiamo regalata così
frettolosamente? Perché mio padre stava male nel vederla parcheggiata in
cortile, solo per questo…Non avete detto che Chencoum, il tunisino, egiziano o
marocchino che ha detto di aver visto mio fratello con un cappello mentre
parlava in arabo con due tunisini, solo questo dovrebbe far capire tanto, era un
tossico cliente fisso della famiglia Marzouk, bastava andare a leggere i
giornali di quel periodo per capire l’odio che i Marzouk nutrivano nei nostri
confronti, bastava ascoltare le loro intercettazioni agli atti per capire che
loro vivevano la strage come un ostacolo ai loro traffici e si sentivano il
fiato sul collo, quindi avevano bisogno di qualcuno che indicasse altri, inoltre
nel secondo grado a Milano venne letta una lettera di un compagno di cella del
Chencoum che raccontava le ammissioni di falsa testimonianza…Non avete riportato
le intercettazioni dei due assassini che raccontano un’altra storia rispetto
alla vostra: “guarda che non sono cattivi .. No, no no … no veramente io ho
trovato delle brave persone … Infatti anche io non sapevo come comportarmi
perché non sapeva come finiva, Poi quello che c’era lì mi ha spiegato tutto e
allora … Forse stiamo meglio adesso … DOPO AVER FATTO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO.”
– Non avete parlato del colloquio di Olindo con Picozzi, il video è ben
custodito dalla difesa ma il testo è questo: «Mi ricordo che abbiamo anche
pensato: avremo rimorsi. E invece non ne ho neanche uno. Ecco tutto. E siccome
l’abbiamo fatto insieme io dico che ci devono mettere insieme. Dividerci no. Non
è giusto». «Così, appena entrato nella casa gli ho dato una stangata secca.
Madre, idem. Mia moglie è andata di là e ha sgozzato il bambino. Poi abbiamo
dato fuoco e poi abbiamo chiuso la porta per non danneggiare il resto della
casa. A quel punto ho visto la signora Valeria con il cagnolino. Siamo rientrati
nel soggiorno ma non si poteva più respirare. Abbiamo aspettato qualche minuto.
Quando siamo usciti ce li siamo ritrovati davanti. Io l’unica cosa che mi
ricordo è che sono saltato addosso a lui. Poi basta, siamo scesi in lavanderia e
ci siamo cambiati. Io non avevo tutto il sangue che dicono, un po’ in faccia, un
po’ sui pantaloni. E poi belli tranquilli a Como. Dove ci siamo guardati le
nostre vetrine. Ci siamo mangiati uno spuntino e siamo tornati. Tranquilli che
erano morti tutti. Invece appena arrivati sentiamo che il Frigerio non è morto.
Allora ci siamo detti: speriamo che muoia anche questo. Non che dobbiamo per
forza pregare, però insomma speriamo che muore anche lui. Invece non è morto. Io
dico che se lui moriva noi la facevamo franca, perché non c’erano tante cose
contro di noi. Sapevamo che dovevamo stare tranquilli e soprattutto che dovevamo
stare attenti con Gallorini. Siamo stati interrogati una sola volta, poi basta.
Per un mese si stava bene, andavamo a dormire alle nove, eravamo tornati a fare
una vita normale». Non avete parlato dei “pizzini” di Olindo sulla sua Bibbia,
ulteriore confessione scritta: “Oggi a colloquio con Rosa mi ha raccontato che
sono alcune notti che vede Raffaella davanti alla branda come quella sera col
sangue che le scende sul volto ed i colpi che gli ho inferto quando la
uccidemmo” – “accogli nel tuo regno il piccolo Youssef, la sua mamma Raffaella,
sua nonna Paola e Cherubini Valeria a cui noi abbiamo tolto la vita...” – “i
Frigerio dovevano farsi i cazzi suoi” …Fino a quando conoscono i nuovi difensori
e sulla Bibbia di Olindo qualcosa cambia (26/7/2007): “mi hanno chiesto di dare
una logica alle coltellate che nella confessione ho detto di avere dato alla
Valeria in testa …” – “SEMINARE DUBBI, INCERTEZZE, CAOS nella stampa che ci è
contro ed agli imbecilli colpevolisti” dopo l ‘udienza preliminare dell’ ottobre
2007:“i nostri legali hanno presentato le loro istanze di annullamento per le
nostre confessioni precedenti. Il giudice ha preso nota e si è ritirato per
deliberare. DOPO TRE ORE HA ACCOLTO L’ ANNULLAMENTO DELLE NOSTRE CONFESSIONI PER
VIZIO DI FORMA…ABBIAMO PRESO TUTTI IN CONTROPIEDE, NON SI ASPETTAVANO UNA
STRATEGIA COSI’ SEMPLICE”
Non avete parlato del movente, anzi dei moventi
che i due coniugi avevano, non ultimo la comparsa davanti al giudice 2 giorni
dopo per una denuncia di lesioni che mia sorella aveva loro fatto. Non avete
parlato di un sacco di cose, ma solo di quello che vi hanno dettato…Avrei delle
domande da porvi, visto che dovreste esservi documentati: secondo le tesi
difensive gli assassini si trovavano già all’ interno dell’appartamento
all’arrivo delle loro vittime. Come mai le vittime hanno comunque il tempo per:
mia mamma maneggiare un accendino, cercando di fare luce, prendere un cartone
del latte dal frigorifero e appoggiarlo sul piano della cucina, togliere
berretto e piumino al piccolo, mia sorella togliersi berretto, appoggiarlo sul
cassettone dietro al divano vicino a quello di Jouseff togliersi le scarpe e
infilare le ciabatte, prima di riuscire per riaccendere il contatore? secondo le
tesi difensive la signora Valeria ricevette il colpo di grazia all’ interno del
suo appartamento.
-Come mai la signora Valeria dopo essere stata
assalita sul pianerottolo insieme a suo marito, non scappa nel suo appartamento
ma lo raggiunge lentamente, come se ne deduce dalla forma dalle macchie di
sangue sui gradini e dalle impronte delle sue mani sul muro?
-come mai gli assalitori le danno anche il tempo
di togliersi il giubbotto?
-come mai viene trovata inginocchiata sotto all’
abbaino, davanti la sua finestra con il volto rivolto al pavimento appoggiato
alle sue mani, come se cercasse di respirare l’aria più pulita, che come tutti
sanno, durante un incendio si trova proprio in basso?
secondo le tesi difensive gli assassini scapparono
dal terrazzo di Raffaella.
-Come mai non vengono trovate tracce sul parapetto
e sul canale pluviale dello stesso?
-Gli inquirenti dicono di aver cercato tracce
ematiche anche lì, se così non fosse, come mai gli avvocati difensori, con
l’aiuto dei loro consulenti, Candian e Bruzzone, non le hanno cercate anche
loro, vista l’importanza per loro di dimostrare quella via di fuga?
-Come mai la grossa pianta di Olia Fragrans nel
vaso montato su ruote che occupava tutto lo spazio davanti al parapetto non
risulta essere stata spostata o danneggiata?
-Come mai la maniglia interna del portoncino di
ingresso della palazzina viene trovata imbrattata di sangue con impronte
lasciate da guanti del tutto simili a quelli che Olindo ha detto di aver
utilizzato?
secondo le tesi difensive vengono trovate all’
interno dell’ appartamento di Raffaella delle impronte digitali e palmari su un
muro e all’ interno dell’ appartamento Frigerio un’ impronta di scarpa che non
appartengono nè ai Romano nè a nessuno dei soccorritori.
-come fanno a dire che non appartengono a nessuno
dei soccorritori se le uniche impronte prese dagli inquirenti furono quelle dei
Romano e del primo soccorritore Bartesaghi, tralasciando le decine di altre
persone che andarono e venirono dalla scena del crimine quella sera e i giorni
successivi, fra pompieri, medici legali, carabinieri, Ris e personale del 118?
come fa Olindo a confessare di aver dato delle
pugnalate con il suo coltellino a scatto sulla testa di Valeria, ferite di cui
il medico legale non si era accorto e che quindi non erano a conoscenza degli
inquirenti, ma confermate, autogol, dal perito di parte durante il processo ?
Potrei continuare elencando quello che non avete
detto, ma in fondo la cosa più grave è che non avete fatto il vostro lavoro,
anzi, l’avete fatto, a mio parere, in modo disonesto. Beppe Castagna, figlio,
fratello e zio.”
STRAGE DI ERBA, PIETRO CASTAGNA:
“ASSALTO” DE LE IENE. Azouz Marzouk difende Rosa e
Olindo. Pietro Castagna, parente di tre vittime della strage di Erba:
intervista-assalto de Le Iene. “Rosa e Olindo innocenti”: la tesi del programma
di Italia 1, scrive il 30 settembre 2018 Emanuela Longo su "Il Sussidiario".
Antonino Monteleone torna a parlare della strage di Erba alle Iene, con un
servizio che vuole approfondire il caso, aprendo a nuovi scenari sconvolgenti.
"Nell'immaginario collettivo Rosa e Olindo sono colpevoli, anche a causa delle
sentenze, eppure Azouz Marzouk, marito della vittima Raffaella Castagna e padre
del piccolo Youssef, sembra dubitare della sentenza su Rosa e Olindo". Azouz
infatti non crede siano loro i veri colpevoli, nonostante le confessioni, forte
delle teorie di alcuni giornalisti investigativi che chiedono la riapertura del
caso. Durante il servizio, la iena ha intervistato diversi esperti e contattato
una psicologa, la quale, a sorpresa, sembra sostenere l'innocenza di Rosa Bazzi
e Olindo Romano. Il giornalista investigativo Montolli va nella stessa
direzione: "Non risulta alcuna traccia di Olindo e Rosa nel palazzo della
strage". E Azouz, parente delle vittime, continua a non essere convinto delle
sentenze dei giudici: "Prima o poi verranno fuori i veri colpevoli".
(Aggiornamento Jacopo D'Antuono)
LA STRAGE DI ERBA 12 ANNI DOPO. Sono passati quasi
12 anni dalla terribile strage di Erba dell'11 dicembre 2006, nella quale
rimasero uccise 4 persone tra cui un bambino di appena due anni. A perdere la
vita furono Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef Marzouk, la madre Paola
Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Tra le vittime anche il cane di
quest'ultima. Per l'assurdo duplice omicidio furono accusati e condannati in via
definitiva alla pena dell'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Di
recente, nei loro confronti la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai
legali della coppia contro la decisione dell'Appello di Brescia di negare
l'incidente probatorio su presunti nuovi reperti, confermando così a loro carico
l'ergastolo definitivo. Sono in tanti, però, negli anni, ad aver messo in dubbio
la colpevolezza dei coniugi Romano, a partire da Azouz Marzouk, marito di
Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, il quale aveva commentato ai
microfoni della produzione Tutta la verità sul Nove, asserendo: "Hanno
confessato perché non avevano nessuno, vivevano uno per l'altra, punto e basta".
Voci di presunti complotti hanno messo in dubbio la vera colpevolezza di Rosa e
Olindo e proprio su questo aspetto punterà la trasmissione Le Iene, in un
servizio che andrà in onda questa sera, nel corso dell'esordio della nuova
stagione.
LE IENE, INTERVISTA-ASSALTO A PIETRO
CASTAGNA. Stando a quanto reso noto da La Provincia di
Como, le telecamere della trasmissione di Italia 1 hanno raggiunto Pietro
Castagna, che nella strage di 11 anni fa ha perso la madre, la sorella e il
nipotino ed ora protagonista di quella che è stata definita una vera e propria
intervista-assalto. Contro di lui, come spiega il quotidiano, domande
provocatorie del calibro di "Sa che ci sono due innocenti in carcere?" ed ancora
"Come mai avete fatto sparire subito la Panda di sua madre?", "Perché ha
cambiato versione su dov’era quella sera?". Il tono, dunque, è stato quello
inquisitorio con il quale si è quasi voluto mettere sul banco degli imputati
l'uomo, parente delle vittime, additato negli anni come possibile “pista
alternativa” rispetto a quella dei coniugi all'ergastolo in via definitiva.
Stando alle domande fatte a Castagna, dunque, pare che Le Iene abbiano sposato
la tesi innocentista e che vedrebbe in prima fila anche lo stesso Azouz Marzouk.
Quest'ultimo da convinto colpevolista aveva poi cambiato rotta alla vigilia
della Cassazione. Decisione che ha fece molto discutere.
Strage di Erba: un caso veramente chiuso?
Scrivono "Le Iene" il 30 settembre 2018. Azouz
Marzouk, che nella strage ha perso moglie e figlio, parlando con Antonino
Monteleone, dice di non credere alla verità processuale. Come lui, alcuni
esperti nutrono forti dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi.
“Voglio far riaprire il caso, Rosa e Olindo non c’entrano niente”. A parlare
è Azouz Marzouk, che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef,
uccisi assieme alla suocera e a una vicina di casa, nella strage di Erba (Como)
dell’11 dicembre 2006, per la quale sono stati condannati in via definitiva
all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Si tratta dei vicini di casa che
avrebbero compiuti il massacro per continue liti condominiali. Marzouk, parlando
con il nostro Antonino Monteleone, dice di non essere convinto di questa
ricostruzione. Ritorniamo quindi a parlare delle prime piste su cui si è
indagato: le liti precedenti di Marzouk in carcere con un uomo legato alla
‘Ndrangheta, quella dei contrasti per il traffico di droga. Un’altra pista è
quella familiare: Marzouk conferma “freddezza” con i Castagna, i familiari della
moglie. Rosa Bazzi e Olindo Romano, dopo l’arresto, hanno confessato, seppure
con versioni differenti e con punti da chiarire. Poi hanno ritrattato e si sono
detti innocenti. Fondamentale è anche la testimonianza di Mario Frigerio,
sopravvissuto alla strage nonostante le ferite. Non solo Marzouk non è convinto.
Anche alcuni giornalisti non lo sono. E come lui, anche la psicologa del carcere
di Como. Ad aumentare i dubbi ci sono le indagini del Ris di Parma: non ci sono
tracce biologiche delle vittime nella casa di Rosa e Olindo (dove dopo la strage
sarebbero tornati a cambiarsi) né dei due nella “casa del massacro”. Ci
sarebbero poi elementi non analizzati, tra cui un accendino, un telefono, un
mazzo di chiavi e tracce di persone, finiti poi quasi tutti stranamente
distrutti. E non è finita qui: dopo questa prima tappa, continueremo nella
nostra inchiesta sul caso.
Secondo appuntamento domenicale con Le
Iene Show del 7 ottobre 2018. Condotto da Nadia Toffa,
Filippo Roma e Matteo Viviani, scrive Irene Verrocchio Domenica, 7 Ottobre 2018
su maridacaterini.it. E’ andata in onda in prima serata, alle 21.15
su Italia1, la seconda puntata domenicale de Le iene Show. Condotto da Nadia
Toffa, Filippo Roma e Matteo Viviani. Al rientro della pubblicità tornano sul
caso di Olindo e Rosa (la Strage di Erba), i quali avrebbero sterminato una
famiglia nel 2006. Mandano in onda un’intercettazione ambientale del 2 gennaio
2007 di Mario Frigerio (superstite) e le iene ascoltano i pareri di alcuni
giornalisti. C’è chi è colpevolista e chi pensa invece che i coniugi siano
innocenti. Solo l’unico superstite potrebbe dire la verità, Mario Frigerio.
Inizialmente accusa come aggressore un uomo dalla pelle olivastra poi la colpa
la fa ricadere su Olindo. Cambia quindi versione. Nell’intercettazione del 2007,
invece, Frigerio confessava che l’aggressore era un uomo straniero dalla pelle
scura. I dubbi, quindi, sono sempre di più. Il nome di Olindo viene fatto per la
prima volta dal maresciallo Gallorini, il quale durante un interrogatorio
avrebbe fatto il nome di Olindo per ben 9 volte. Si tratterebbe di manipolazione
della memoria e dei ricordi. Le intercettazioni poi sarebbero sparite e mai
messe agli atti. Mario Frigerio purtroppo è deceduto nel 2014. Ci sarebbero
anche degli audio modificati al fine di incolpare Olindo.
Strage di Erba: due innocenti
all'ergastolo? Scrivono "Le Iene" il 7 ottobre 2018.
Seconda puntata dell'inchiesta di Marco Occhipinti e Antonino Monteleone sul
massacro di 4 persone del 2006. Che mostra come le prime parole al risveglio del
testimone chiave, l'unico sopravvissuto, vanno in senso opposto alle condanne.
Seconda puntata dell’inchiesta di Marco Occhipinti e Antonino Monteleone sulla
“Strage di Erba” (Como) dell’11 dicembre 2006, per la quale sono stati
condannati in via definitiva all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, i vicini
di casa che avrebbero compiuti il massacro per le continue liti condominiali. Il
primo a dubitare della colpevolezza della coppia, come vi abbiamo raccontato una
settimana fa, è Azouz Marzouk, che ha perso nella strage la moglie Raffaella
Castagna e il figlio Youssef, uccisi assieme alla suocera e a una vicina di
casa. Ci sono poi quelli di giornalisti, psicologi e la mancanza di prove
secondo le analisi del Ris di Parma e la distruzione di alcuni elementi
eventualmente utili. L’unico superstite, Mario Frigerio ha riconosciuto Olindo
come colpevole. Frigerio però, nelle sue prime parole al risveglio avrebbe
parlato di una persona di carnagione olivastra e più grosso di lui (tutto il
contrario di Olindo Romano). Il nostro Antonino Monteleone ci fa sentire
anche le registrazioni del primo colloquio con i magistrati di Frigerio, che
vanno in questo senso. L'inchiesta ovviamente continua.
Strage di Erba: la macchia di sangue
incastra veramente Olindo? Scrivono Le Iene il 14
ottobre 2018. Antonino Monteleone continua a indagare sulla strage di Erba, per
cui sono finiti all'ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano. Il ministro della
Giustizia Bonafede promette: "Verificherò perché sono sparite le
intercettazioni". Sul giallo delle intercettazioni sparite della strage di Erba,
che ha portato all’ergastolo i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano, il ministro
della Giustizia promette a Le Iene: “Verificherò perché sono sparite le
intercettazioni. Voglio che la giustizia sia credibile agli occhi dei
cittadini”. Antonino Monteleone racconta di come non si ritrovino più alcune
delle intercettazioni dell’unico sopravvissuto e super testimone Mario Frigerio,
che nella sua prima versione dei fatti disse di ricordare che l’uomo che aveva
ucciso Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la
vicina di casa Valeria Cherubini era di carnagione scura e non era della zona.
Sei giorni dopo cambia la sua versione, e dice di ricordarsi chiaramente che si
trattava di Olindo Romano. Mancano all’appello, inoltre, le intercettazioni
ambientali registrate nella casa dei coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano tra il
12 dicembre e il 16 dicembre. E i giudici hanno valutato che il fatto che i due
non avessero parlato della strage come un elemento in più che ha portato poi a
dichiarare la colpevolezza dei due. La Iena è riuscita a ottenere una clamorosa
rivelazione sulla macchia di sangue di Valeria Cherubini trovata sulla macchina
di Olindo Romano, l’unica prova scientifica che inchioda i coniugi alle loro
responsabilità. Carlo Fadda, il brigadiere oggi in pensione che fece la
fotografia alla macchia di sangue, ammette che il sangue potrebbe essere stato
frutto della contaminazione dai carabinieri che erano stati sul luogo della
strage.
Strage di Erba: Olindo e Rosa, innocenti
all'ergastolo? Video Iene: “Una traccia potrebbe
essere stata inquinata”. Video Iene: il caso delle intercettazioni sparite,
Antonino Monteleone chiede al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di
trovarle, scrive il 14 ottobre 2018 Silvana Palazzolo su "Il Sussidiario".
Strage di Erba: Olindo e Rosa, innocenti all'ergastolo? Il nuovo servizio de Le
Iene sulla strage di Erba non si è concentrata solo sul giallo delle
intercettazioni, ma soprattutto sulla macchia di sangue che ha inchiodato Olindo
Romano, quella sul battitacco dell’auto dell’uomo. Antonino Monteleone si è
allora recato dal brigadiere Carlo Fadda, del nucleo operativo di Como, che
trovò la macchina di sangue nei rilievi che fece. Si parte dalla presenza di un
uomo nella foto che fece all’auto: «Quell’uomo era lì ma non faceva i rilievi».
Non è stata neppure evidenziata la luminescenza: «Ci voleva la macchina
fotografica più adeguata per fare quella foto». Quando Monteleone gli chiede se
si può trattare di inquinamento, cominciano le rivelazioni: «Non posso sapere
chi è entrato in macchina, se la macchina è stata lasciata da un collega». E
quando pensa di non essere ripreso si sbilancia: «Gli avvocati potevano puntare
sull’inquinamento di quella traccia. Perché non hanno combattuto su quello?
Quella macchia non li avrebbe mai mandati all’ergastolo. L’auto comunque non è
mai stata oggetto di analisi accurata». (agg. di Silvana Palazzo)
Strage di Erba: dov'è morta veramente la
vicina Valeria Cherubini? Scrivono "Le Iene" il 17
ottobre 2018. Nuovo appuntamento con l'inchiesta sul massacro di 4 persone del
2006 per cui sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi. Dopo i dubbi
sulla testimonianza dell'unico superstite e sull'unica prova scientifica. Quarto
appuntamento dell’inchiesta di Marco Occhipinti e della Iena Antonino
Monteleone sulla strage di Erba. Siamo partiti dai dubbi di Azouz Marzouk (e di
molti esperti e giornalisti) che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il
figlio Youssef, uccisi assieme alla suocera, Paola Galli, e a una vicina di
casa, Valeria Cherubini, nella sua casa l’11 dicembre 2006. Per gli omicidi sono
stati condannati in via definitiva all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, i
vicini di casa che avrebbero compiuto il massacro per le continue liti
condominiali. Abbiamo analizzato poi la testimonianza dell’unico
superstite, Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini, che ha riconosciuto
Olindo come colpevole e che, in realtà, nelle sue prime parole al
risveglio avrebbe parlato di un’altra persona, di carnagione olivastra, più
grosso di lui e non del posto. Ci siamo soffermati poi su un’altra prova contro
i condannati: la macchia di sangue trovata sull’auto dei due. I dubbi aumentano,
sia sul modo del reperimento della prova sia sul suo possibile inquinamento.
Oggi ci concentriamo sulla morte di Valeria Cherubini. Quando arrivano i
soccorsi, l’11 dicembre 2006, la vicina chiedeva ancora “aiuto” dal secondo
piano della palazzina del massacro. Secondo tre gradi di giudizio sarebbe salita
al secondo piano in condizioni già devastate dalle coltellate. L’altra ipotesi è
che sia stata uccisa con l’ultimo colpo al secondo piano, dopo aver chiesto
aiuto ai soccorritori. Gli aggressori sarebbero poi scappati da casa casa
Castagna, con un salto che non sarebbe alla portata dei due condannati. In
quella zona sarebbero state viste scappare invece tre altre persone. I dubbi
sono alimentati anche dalla testimonianza del generale Luciano Garofalo, ex
comandante del Ris dei Carabinieri che, proprio sulla base di questa e altre
ricostruzioni, sostiene: “È lecito avere dei dubbi sulla strage di Erba”.
Strage di Erba, dov’è morta veramente
Valeria Cherubini? Il servizio de Le Iene, scrive la
Redazione di"Blitz Quotidiano" il 18 ottobre 2018. Continua l’inchiesta de Le
Iene con l’inviato Monteleone che, dopo il primo servizio, si interroga su dove
è stata aggredita e poi colpita a morte Valeria Cherubini, la moglie del super
testimone del processo della strage di Erba Mario Frigerio. Scoprire come è
morta la Cherubini infatti può svelare come si sono mossi gli assassini, ovvero
se hanno lasciato la palazzina scendendo le scale o attraverso una via
alternativa come affermato dalla difesa. Il giornalista Edoardo Montolli ha
commentato: “Viene trovata morta sotto la tenda della mansarda, con le mani a
protezione del capo: sia Frigerio che i soccorritori la sentono chiedere aiuto.
Loro provano a salire ma non ci riescono e tornando indietro”. E il primo
soccorritore Glauco Bartesaghi ha confermato che la Cherubini urlava “aiuto”. Il
volontario, che si trovava al pianerottolo del primo piano e sentì gridare la
Cherubini, è sicuro che lei si trovasse all’interno della sua abitazione al
secondo piano: quello che sarebbe fondamentale scoprire è se la Cherubini era da
sola ferita a morte con gli assassini in fuga oppure se insieme a lei c’era
ancora il suo assassino pronto a infliggerle il colpo di grazia. “Il problema
nasce dal fatto che se lei è stata uccisa lì, gli assassini non potevano
scendere le scale facendo quel percorso, per la presenza dei soccorritori: a
quel punto Olindo e Rosa sarebbero innocenti”, sottolinea Montolli, anche se
secondo i giudici, la Cherubini avrebbe risalito le scale e chiesto aiuto ai
soccorritori dopo essere già stata aggredita dai killer, con la gola squarciata
e la lingua tagliata. Luciano Garofalo, ex comandante del Ris, ha ammesso: “Noi
abbiamo fatto tanti tentativi se ci fossero presenze delle vittime o viceversa,
ma il risultato è stato negativo. Non so il perché, ma è normale che ai
cittadini vengano dei dubbi. Effettivamente per il modo in cui sono state
aggredite le vittime, non potevano non sporcarsi per il sangue versato”.
Strage di Erba, dov’è morta Valeria Cherubini?
Video Le Iene, l'ex comandante dei Ris Luciano Garofalo rivela: "dubbi su Rosa e
Olindo condannati", scrive Carmine Massimo Balsamo il 17 ottobre 2018 su "Il
Sussidiario". Strage di Erba, dov’è morta Valeria Cherubini? Continua
l’inchiesta de Le Iene con l’inviato Monteleone che, dopo il primo servizio, si
interroga su dove è stata aggredita e poi colpita a morte la Cherubini, la
moglie del super testimone Frigerio. Scoprire come è morta lei infatti può
svelare come si sono mossi gli assassini, ovvero se hanno lasciato la palazzina
scendendo le scale o attraverso una via alternativa come affermato dalla difesa.
Il giornalista investigativo Edoardo Montolli ha commentato: “Viene trovata
morta sotto la tenda della mansarda, con le mani a protezione del capo: sia
Frigerio che i soccorritori la sentono chiedere aiuto. Loro provano a salire ma
non ci riescono e tornando indietro”. E il primo soccorritore Glauco Bartesaghi
ha confermato che la Cherubini urlava “aiuto”.
IL COMMENTO DI LUCIANO GAROFALO. Quando il
volontario che si trova al pianerottolo del primo piano sente gridare la
Cherubini, è sicuro che lei si trovasse all’interno della sua abitazione al
secondo piano: quello che sarebbe fondamentale scoprire è se la Cherubini era da
sola ferita a morte con gli assassini in fuga oppure se insieme a lei c’era
ancora il suo assassino pronto a infliggerle il colpo di grazia. “Il problema
nasce dal fatto che se lei è stata uccisa lì, gli assassini non potevano
scendere le scale facendo quel percorso, per la presenza dei soccorritori: a
quel punto Olindo e Rosa sarebbero innocenti”, sottolinea Montolli, anche se
secondo i giudici, la Cherubini avrebbe risalito le scale e chiesto aiuto ai
soccorritori dopo essere già stata aggredita dai killer, con la gola squarciata
e la lingua tagliata. Luciano Garofalo, ex comandante del Ris, ha ammesso: “Noi
abbiamo fatto tanti tentativi se ci fossero presenze delle vittime o viceversa,
ma il risultato è stato negativo. Non so il perché, ma è normale che ai
cittadini vengano dei dubbi. Effettivamente per il modo in cui sono state
aggredite le vittime, non potevano non sporcarsi per il sangue versato”. Clicca
qui per vedere il video de Le Iene.
INTERCETTAZIONI SPARITE: LE IENE DAL MINISTRO
BONAFEDE. Prosegue l’inchiesta de Le Iene sulla strage di Erba, per la quale
Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all’ergastolo. Antonino
Monteleone, convinto che il caso non sia veramente chiuso, ha chiamato in causa
il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, chiedendogli di trovare le
intercettazioni ambientali che sono misteriosamente sparite. Mancano sei giorni
interi, in cui Mario Frigerio ha ricevuto la visita del neurologo che doveva
testare i suoi ricordi della strage. Il giallo delle intercettazioni sparite non
finisce qui: mancano le registrazioni dei colloqui di Olindo e Rosa dopo la
strage. Interpellato da Le Iene, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede:
«Il ministero può fare delle verifiche, nelle valutazioni del magistrato non
posso entrare. Mi riservo di verificare. Non snobbo le segnalazioni. Questo è un
caso molto grave, io voglio che la giustizia sia credibile agli occhi dei
cittadini».
LE IENE E I DUBBI SULLA TESTIMONIANZA DI FRIGERIO.
Rosa e Olindo Romano potrebbero non essere gli autori della terribile strage di
Erba: questo è il dubbio che ha lanciato il programma Le Iene, che per la nuova
stagione ha deciso di occuparsi della strage del 2006. Nel servizio della scorsa
settimana il mirino è stato puntato su Mario Frigerio, colui che indicò il nome
di Olindo Romano come autore della mattanza in cui morirono quattro persone:
Raffaella Castagna, il piccolo Youssef, la madre Paola Galli e la vicina di casa
Valeria Cherubini. Nonostante tre gradi di giudizio abbiano condannato in via
definitiva i due coniugi all’ergastolo, la trasmissione approfondisce un caso
che continua a dividere l’opinione pubblica. La vicenda è stata ripercorsa fino
a mettere in dubbio la testimonianza chiave dell’unico sopravvissuto a quella
strage, Mario Frigerio. A far vacillare le certezze alcuni file audio registrati
durante le indagini, in cui emerge come Mario Frigerio al suo risveglio in
ospedale dopo l’aggressione non ricordi Olindo Romano ma un’altra persona. A
fomentare i dubbi de Le Iene sarebbero infine anche alcune registrazioni audio
“scomparse”, come rilevato dal giornalista investigativo Edoardo Montolli,
autore di alcuni libri sulla strage di Erba. Clicca qui per il video del secondo
servizio.
LA PRIMA TAPPA DELL'INCHIESTA DE LE IENE.
L’inchiesta de Le Iene sulla strage di Erba si è aperta con l’intervista ad
Azouz Marzouk, che perse moglie e figlio. Parlando con Antonino Monteleone
raccontò di non credere alla verità processuale, confessando di avere quindi
dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. «Voglio far riaprire il
caso, Rosa e Olindo non c’entrano niente», confida l’uomo. La ricostruzione di
quella strage dell’11 dicembre 2006 non lo convince. Rosa Bazzi e Olindo Romano
dopo l’arresto hanno confessato, ma con versioni differenti, poi hanno
ritrattato e si sono detti innocenti. Decisiva è stata la testimonianza di Mario
Frigerio, sopravvissuto alla strage nonostante le ferite. Ma Azouz Marzouk non è
convinto, e non è l’unico. Le indagini del Ris di Parma non trovano tracce
biologiche delle vittime nella casa dei coniugi, dove sarebbero tornati a
cambiarsi al termine della mattanza, né della coppia nelle abitazioni delle
vittime. Ci sarebbero poi elementi non analizzati, tra cui un accendino, un
telefono, un mazzo di chiavi e tracce di persone, finiti poi quasi tutti
stranamente distrutti. Clicca qui per il video del primo servizio.
Strage di Erba: Le Iene ritornano sul
caso, scrive Luana Geria, Autore della news (Curata
da Valentina) il 10/10/2018 Blasting News. I dubbi sulla confessione di Rosa e
Olindo e le incongruenze sul caso messe in evidenza da Azouz Marzouk, marito e
padre delle vittime. A dieci anni dalla Strage di Erba, Le Iene indagano sui
veri colpevoli. A distanza di 12 anni dalla condanna all'ergastolo attribuita ai
coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano accusati nell'anno 2006 di esser stati i
fautori della strage di Erba, il programma condotto da Nadia Toffa e trasmesso
su rete Mediaset Le Iene indaga sulla veridicità della condanna, ponendo un
quesito che attualmente sembrerebbe essere quasi irrisolto: Rosa e Olindo sono
realmente gli autori della strage in cui morirono brutalmente tre adulti e un
bambino? Domenica 7 ottobre, in prima serata è andata in onda la seconda puntata
del format televisivo Le Iene che con un servizio della durata di circa mezz'ora
ha risollevato le questioni riguardanti uno dei casi più cruenti della cronaca
italiana: la strage di Erba. L’intero servizio è stato dedicato sia alle
dichiarazioni rilasciate dal testimone della strage unico sopravvissuto, Mario
Frigerio, che interrogato direttamente in ospedale e successivamente in aula
indicò Rosa e Olindo come fautori della strage, sia ad alcuni dettagli del caso
non presi in considerazione finora.
Rosa e Olindo sono innocenti?
A decidere di far riaprire il caso secondo quanto
mandato in onda durante la puntata è stato proprio Azouz Marzouk, marito
di Raffaella Castagna e padre di Youssef, vittime della mattanza. L’uomo,
durante un’intervista svolta da Antonino Monteleone, giornalista del format
televisivo, ha spiegato di essere convinto dell’innocenza di Rosa e Olindo, di
non credere alla ricostruzione dell’omicidio fatta dagli inquirenti e alle
testimonianze di Mario Frigerio, incongruenti nelle diverse fasi degli
interrogatori alla quale l’uomo, attualmente deceduto, si è sottoposto.
Ripercorrendo e analizzando i dettagli del caso e
il racconto del testimone chiave, sia la psicologa del carcere di Como dove i
coniugi sono detenuti, sia molti giornalisti che si sono occupati del caso in
maniera dettagliata sembrano non essere convinti né della confessione di Rosa e
Olindo né del racconto del sopravvissuto Mario Frigerio che durante una prima
confessione, parlando dell’assassino aveva dichiarato: "Si tratta di un uomo più
alto di me di almeno di 10 cm, carnagione olivastra e probabilmente di
nazionalità araba”. Secondo quanto mostrato durante il servizio, Frigerio sia in
tribunale durante il processo, sia durante gli interrogatori successivi svolti
durante la sua permanenza in ospedale, aveva ritrattato il profilo
dell’assassino da lui dichiarato e additato il vicino di casa Olindo e la moglie
come unici colpevoli della strage.
Confessioni ritrattate e dettagli mancanti. A
incrementare i dubbi sulla colpevolezza dei coniugi, secondo quanto dichiarato
al termine delle indagini condotte dal Ris di Parma, sarebbe inoltre l’assenza
di tracce biologiche delle vittime all'interno dell’abitazione di Rosa e Olindo.
Secondo quanto dichiarato dalla coppia durante la prima confessione dove si
dichiarano colpevoli, entrambi dopo aver commesso la mattanza sarebbero tornati
a cambiarsi all'interno del proprio appartamento, quindi in base a quanto
sottolineato dai giornalisti, da Marzouk e dalla polizia scientifica sembrerebbe
quasi impossibile non aver rilevato alcuna traccia delle vittime. Durante le
indagini, oltre all'assenza di tracce biologiche sopracitate sembrerebbero
essere emersi alcuni dettagli fondamentali mai presi in considerazione in
maniera approfondita: non sarebbero mai stati analizzati alcuni elementi che
potrebbero essere di fondamentale importanza, come un accendino, un mazzo di
chiavi ed un telefono, finiti in maniera inspiegabile distrutti. Tra le
incongruenze del caso, sottolinea il giornalista, vi sarebbe la confessione di
Rosa e Olindo successivamente ritrattata, le motivazioni dell’omicidio e il
racconto dettagliato di come si sarebbe svolto, incongruente per alcuni versi
con quanto dichiarato dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario
intervenuto sul luogo del delitto.
Strage di Erba, gli audio mai entrati a
processo a Le Iene e l’imbarazzante impreparazione dei giornalisti,
scrive Edoardo Montolli l'8 ottobre 2018 su Fronte del Blog. Sui social si
scatenano le reazioni dei colpevolisti. Tra loro anche la giornalista del
Corriere della Sera che seguì il caso, più Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile.
Il risultato? Imbarazzante. Leggere per credere. Domenica Le Iene mandano in
onda la seconda puntata sulla strage di Erba. Vengono analizzate le
dichiarazioni e le intercettazioni di Mario Frigerio, il superstite della strage
che accuserà Olindo Romano di essere l’aggressore dopo aver detto per dieci
giorni che a colpirlo era stato un olivastro sconosciuto. Tra le prime a reagire
c’è Selvaggia Lucarelli, che sui social ha un brillante seguito. E cosa scrive
su Twitter? Questo: "I giudici hanno già valutato la questione delle primissime
dichiarazioni di Frigerio e spiegano la cosa nelle varie sentenze, basta
leggere. È storia vecchia care #leiene. E pure stracciando la confessione di
Frigerio, rosa e olindo restano colpevoli. Basta fuffa. Basta". Già. Basta
leggere. Come abbiamo visto, Selvaggia Lucarelli invita gli altri a leggere, ma
lei non lo fa. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che sulla vicenda le
notizie le inventi letteralmente, come ha fatto per il testimone della strage
Chencoum. Anche questa volta si ripete. Infatti gli audio mandati in onda da Le
Ienedel 22 dicembre, del 24 dicembre e del 26 dicembre in cui Frigerio parla
rispettivamente con il suo avvocato, con i figli e di nuovo con il suo avvocato,
non sono MAI entrati a processo. MAI riportati nelle sentenze.
Nemmeno MAI trascritti. Come dice Selvaggia, basta leggere. Attività che
evidentemente le riesce davvero male. E che compensa inventando anche questa
volta una notizia. Ma perché sono importanti questi audio? Perché Mario Frigerio
disse in aula che da quando il comandante dei carabinieri Luciano Gallorini gli
fece il nome di Olindo il 20 dicembre, lui fu sicuro su chi fosse il suo
aggressore. Così come confermò il figlio Andrea. Ma gli audio del 22 dicembre,
del 24 dicembre e del 26 dicembre col suo avvocato lo smentiscono, dato che in
quelle circostanze sembrava non ricordare proprio nulla. Per essere molto
chiari, sempre a beneficio della Lucarelli e del suo “basta leggere” nemmeno
l’audio del 20 dicembre tra Gallorini e Frigerio mandato in onda da Le
Iene fu MAI fatto ascoltare in aula a Como, dove invece venne fatto ascoltare un
audio del 15 dicembre in cui Frigerio diceva “è stato Olindo”. E il processo di
primo grado si chiuse lì. Peccato che i giudici avessero fatto ascoltare un
audio involontariamente modificato, come è scritto nella sentenza
d’appello (basta leggere!) con il programma Cool Edit 2000, che cambiò la frase
“stavano uscendo” con “è stato Olindo”. Lasciamo da parte le elucubrazioni e i
problemi di lettura della giudice di ballo per concentrarci ora su chi ha
seguito la strage fin dall’inizio. Perché la Lucarelli ritwitta un messaggio di
Giusi Fasano del Corriere della Sera: "L'avvocato non ha avuto bisogno di dire
granchè. L'«hanno arrestato», ha tagliato corto, Mario Frigerio ha chiuso gli
occhi: «Bene, avvocato. Per me è una conferma». «C'è un'altra cosa, è in carcere
anche lei» ha aggiunto il legale, Manuel Gabrielli. Sapeva che questa
seconda informazione l'avrebbe stupito e così è stato. Ma lo stupore di
Frigerio, il sopravvissuto della strage di Erba, non è durato che un attimo. I
pensieri, ieri, erano tutti per la sua Valeria, la moglie uccisa nella
carneficina dell'11 dicembre assieme a Raffaella Castagna, al suo piccolo
Youssef e a sua madre, Paola Galli. Per il massacro di quella sera sono in
carcere da due giorno Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi vicini di casa di
Frigerio. Lui accusato di omicidio plurimo aggravato, lei di concorso in
omicidio. «I Romano ed i Castagna si odiavano. Ma noi cosa c'entriamo? - si
dispera Frigerio in lacrime - non abbiamo fatto niente...Io ho aiutato la
procura. Adesso chiedo che mi ridiano mia moglie»". La preparatissima cronista
del Corriere della Sera scrive polemicamente rispetto alla trasmissione de Le
Iene: “Così. Per saperne un po’ di più… @stanzaselvaggia #Erba” E allega un suo
articolo del gennaio 2007. Prima ancora, forte della sua preparazione in
materia, twittava: "Un assassino crede sgozzato un uomo che invece rimane vivo
per una malformazione alla carotide. Lui si salva (sua moglie e il cane no) e
diventa il testimone-chiave, ovvio. Ergastolo. Sentenza definitiva Eppure c’è
sempre qualche genio che “io la so meglio” @stanzaselvaggia #Erba". Eh già.
Basta leggerlo l’articolo di Giusi Fasano. La seconda parte. Perché, all’epoca,
Giusi Fasano scriveva questo: "«indicazioni confuse», come ripetono gli
inquirenti. Ha raccontato tutto in dettaglio ai magistrati, precisando ogni
volta di più. E l'ultima volta è stato il 2 gennaio. IL VERBALE - «La porta si è
aperta all'inizio piano piano, poi di colpo. Ho visto lui, il mio vicino Olindo.
Sembrava un indemoniato». Il supertestimone racconta che Olindo non ha detto una
parola, descrive l'espressione rabbiosa del suo volto. «Mi ha sollevato di peso
e mi ha sbattuto a terra - ricorda. Poi si è chinato e lo ha riempito di pugni e
calci. - Sentivo Valeria che gridava, lui continuava a colpirmi». Frigerio si
ritrova in faccia in giù, incassa botte in testa, sulla schiena, sul collo. «Poi
si è messo a cavalcioni sulla schiena, non potevo muovermi». Il superstite,
sottile di statura, rivive in ogni deposizione l'immobilità e il senso di
impotenza di quei momenti. Ricorda che un peso enorme lo teneva schiacciato a
terra. Sente l amano di quell'uomo, che a lui sembra quella di un gigante,
mentre gli afferra la testa e gliela tira indietro. Descrive un gesto simile a
quello visto nei video dei terroristi islamici che sgozzano l'ostaggio. Ecco «Mi
ha sollevato la testa e ho sentito una lama che mi ha tagliato la gola».
Frigerio spiega le sensazioni di quel taglio, il sangue, sua moglie che urla più
forte e che probabilmente lo salva, perchè a quel punto, mentre lui è a faccia a
terra, la furia cieca dell'assassino si sposta sulla moglie Valeria. Lei scappa,
su, per le scale. Lui la rincorre e la uccide. Le ultime parole che Frigerio
sente sono «Mario aiutami». Ma lui non può muoversi. Resta lì, davanti alla
porta di Raffaella Castagna, mentre il «demonio» scappa e il fuoco appiccato
dall'assassino si avvicina sempre più. Frigerio (che ha anche ustioni al viso)
adesso sta meglio. Ci vorrà molto tempo per rimettersi fisicamente. Non basterà
tutto il tempo che..."
Concentriamoci qui: "Frigerio spiega le sensazioni
di quel taglio, il sangue, sua moglie che urla più forte e che probabilmente lo
salva. Perché a quel punto, mentre lui è faccia a terra, la furia cieca
dell’assassino si sposta sulla moglie Valeria. Lei scappa, su, per le scale. Lui
la rincorre e la uccide. Le ultime parole che Frigerio sente sono «Mario
aiutami». Ma lui non può muoversi". Giusi Fasano non si rende conto, o forse non
lo sa pur essendo tutto agli atti, che se questa fosse la versione delle
sentenze, non staremmo qui a scrivere da anni che Olindo e Rosa sono innocenti.
Per spiegarlo anche all’autrice dell’articolo, questa ricostruzione
sull’assassino che insegue Valeria Cherubini e la uccide nel suo appartamento
dopo che la donna ha gridato aiuto, è purtroppo per lei quella che la difesa dei
Romano ha sempre sostenuto. Ma i giudici hanno detto tutt’altro: hanno infatti
scritto che Valeria Cherubini, con il cranio fracassato da otto colpi e una
quarantina di ferite su tutto il corpo, fu colpita SOLTANTO all’altezza del
pianerottolo di Raffaella Castagna. Poi salì in casa, senza deglutire sangue,
senza respirarlo (non c’è sangue nello stomaco né nei polmoni) e senza perdere
che minuscole gocce di sangue sulle scale. Infine arrivò sotto la tenda della
sua mansarda e lì, con la gola già squarciata e la lingua già tagliata al piano
di sotto, gridò “aiuto” prima di morire. Come si può credere che sia possibile
una cosa simile in natura? Com’è possibile gridare aiuto con lingua tagliata,
gola squarciata e cranio fracassato? Eppure, i giudici furono costretti a
sostenere questa tesi per condannare Olindo e Rosa, perché se Valeria Cherubini
fosse stata uccisa in mansarda come logica impone (compresa quella del vecchio
articolo di Giusi Fasano), la coppia sarebbe innocente. Il motivo è semplice:
dopo che Valeria Cherubini gridò “aiuto”, la coppia non poteva più scendere da
lì e andare in casa a cambiarsi, perché di sotto c’erano già i soccorsi. Ma
Giusi Fasano questo evidentemente non lo sa. Tanto che scrive «Sentenza
definitiva Eppure c’è sempre qualche genio che “io la so meglio”» e allega un
suo articolo che per contro scagionava i Romano. Davvero imbarazzante, perché fa
capire quale sia il livello di conoscenza dei fatti di chi scrisse della strage
per il maggiore quotidiano italiano. Ma il top lo raggiunge Salvo Sottile. Il
brillante giornalista e conduttore televisivo twitta: "Ad @a_monteleone ho detto
tante altre cose che spero trasmetterà prima o poi. Capisco che non ero
funzionale a questa sua parte di racconto ma ascoltando i giornalisti
‘investigativi’ non capisco ancora perché avrebbero dovuto incastrare Olindo e
Rosa #erba". E, soprattutto, aggiunge, con l’aria di chi la sa lunga: "La difesa
di Olindo e Rosa poteva controinterrogare Frigerio negli anni e non l’ha fatto,
poteva chiedere un incidente probatorio sulle tracce di sangue trovate dai Ris e
non l’ha fatto. Poteva cercare altre prove, altre testimonianze…che mancano
dov’è il complotto? Cos’è che poteva fare la difesa negli anni?!
“Controinterrogare” Frigerio negli anni successivi?! Ma da dove l’ha dedotta
questa cosa?! La seconda frase è anche migliore: “poteva chiedere un incidente
probatorio sulle tracce di sangue trovate dai Ris e non l’ha fatto”. Ora, non lo
so come segua Salvo Sottile le vicende, ma sono anni che la difesa chiede di
fare gli incidenti probatori sulle tracce di sangue trovate dai Ris e all’epoca
giudicate “scientificamente non interpretabili”: lo hanno scritto pure nei
bollettini parrocchiali. Anche perchè, com’è noto anche a chiunque, i
Ris NON hanno trovato alcuna traccia di Olindo e Rosa nel palazzo della strage
e NEMMENO tracce delle vittime in casa loro. Non voglio neppure ipotizzare che
Salvo Sottile si riferisca, quanto a incidente probatorio, alla macchia di
sangue rinvenuta sull’auto di Olindo. Perchè, in quel caso, anche i muli sanno
che non fu trovata dai Ris, ma dal Rono di Como. Infine Sottile, argutamente,
dice che la difesa poteva cercare altre prove e altre testimonianze. Ma vah?
Però se almeno chi informa sapesse di ciò che parla, potrebbe essere utile a
fare chiarezza. O no? Edoardo Montolli
P.S.: Sui social scrivono che è troppo facile
tirar fuori gli audio di Frigerio mai entrati a processo solo ora che il
testimone è morto. Ma quando la difesa mi mise a disposizione le intercettazioni
non trascritte eravamo nel 2010 e nel 2011. Uscirono gli articoli sul
settimanale Oggi che ne rivelavano il contenuto e vennero fatti i lanci alle
agenzie. Mario Frigerio era ancora vivo. Ma tutti finsero che quegli audio non
esistessero.
La strage di Erba e l’imbarazzante
articolo di Selvaggia Lucarelli: quando le fantasie diventano notizie,
scrive Edoardo Montolli il 30 settembre su Fronte del Blog. Dare giudizi sulle
persone che ballano le riesce benissimo. Ma quando si tratta di cose serie, come
la vita delle persone, Selvaggia Lucarelli che fa? Inventa di sana pianta le
notizie, come se fosse al bar. Così come fa sulla strage di Erba. A distanza di
quasi dodici anni dalla strage di Erba, non pensavo che potessero uscire ancora
articoli completamente disinformati sulla vicenda. Invece, e con grande stupore
su Il Fatto Quotidiano, ci riesce benissimo Selvaggia Lucarelli. Che, rispetto
ad allora, quando tantissimi negavano l’esistenza di alcuni atti, riesce pure ad
inventarsi notizie di sana pianta e a dare, sulla base delle sue invenzioni,
lezioni morali, come se stesse giudicando una gara di ballo o si trovasse al bar
a discutere con le amiche davanti ad un gelato. Il titolo dell’articolo è Strage
di Erba, i fan di Rosa & Olindo contro i sopravvissuti. E all’interno se la
prende con il documentario Tutta la verità, andato in onda sul Nove, spiegando
che «con i social pronti all’indignazione a comando e l’orda di programmi a tema
cronaca nera, riaprire mediaticamente casi archiviati e lavorare sulle
suggestioni è facile». Già, è facile. Non si capacita, Selvaggia Lucarelli, del
perché il documentario focalizzi l’attenzione su Pietro Castagna, fratello di
Raffaella, figlio di Paola Galli e zio del piccolo Youssef Marzouk, tre delle
vittime, domandandosi cosa ci fosse contro di lui. Ma questo dovrebbe chiederlo
ai carabinieri di Erba, che – come confermato in aula dal luogotenente Luciano
Gallorini – lo sospettarono fin da subito. Salvo non far emergere le
macroscopiche contraddizioni tra le dichiarazioni tra padre e figlio e far
sparire dalle indagini da subito l’auto utilizzata da Pietro, la Panda nera
della madre, che infatti non sarà mai messa sotto intercettazione né cercata. La
cosa comica è che Selvaggia Lucarelli, nel riprendere l’articolo sulla propria
pagina Facebook, sostiene di aver letto gli atti dell’inchiesta. Se così fosse,
dovremmo concludere che abbia patologici problemi di comprensione. Perché
nell’articolo su Il Fatto quotidiano si inventa di sana pianta un particolare
piuttosto rilevante su un testimone che vide una persona verbalizzata come “il
fratello della morta” sul luogo della strage: "Quindi si sottolinea che tale
Chencoum, tossicodipendente cliente di Azouz, dichiarò di aver visto un tizio
con la barba rossiccia qualche giorno prima della strage parlare con due arabi
proprio davanti alla corte. Lo stesso testimone poi sparisce nel nulla". Ho
inizialmente pensato ad un, per quanto ingiustificabile, refuso. Invece no.
Perché Selvaggia Lucarelli, che dice di aver letto gli atti, lo ribadisce su
Facebook aggiungendo un altro dettaglio. E cioè che Chencoum addirittura
ritrattò. Nientemeno. Se le cose stessero così, non si capisce in effetti perché
parlare di Chencoum. Ma ovviamente le cose non stanno affatto così ed è di tutta
evidenza che la Lucarelli non sappia di cosa stia parlando. E figuriamoci dunque
se ha letto gli atti. Dunque, Ben Brahim Chencoum era un senza fissa dimora che
si presentò in caserma il 16 dicembre del 2006, a distanza di circa un’ora da
quando andò lì a rilasciare sommarie informazioni Pietro Castagna. Sostenne di
aver visto qualcosa fuori dalla corte esattamente all’ora della strage (non due
giorni prima). La sua versione era piuttosto interessante perché la descrizione
combaciava con quanto narrato da un dirimpettaio, Fabrizio Manzeni. Ma non
basta. Il 25 dicembre Chencoum tornò dai carabinieri, fece stavolta un racconto
molto dettagliato e aggiunse che la persona che aveva visto fuori dalla corte
era la stessa incrociata in caserma il 16, e che fu insolitamente verbalizzata
come “il fratello della morta”, senza cioè alcun nome. Naturalmente Chencoum
poteva essersi sbagliato. Ma qual è l’aspetto inquietante di tutto questo? È che
il 16 e soprattutto il 25 dicembre non c’erano ancora indagati per la strage
(Olindo sarà riconosciuto da Frigerio davanti ai pm solo il 26). Ma il
comandante dei carabinieri di Erba – che pure sospettava di Pietro Castagna –
tenne inspiegabilmente questa testimonianza a Erba, inviandola in Procura
soltanto il 15 gennaio, dopo le confessioni dei coniugi Romano. Perché, non si
sa. Ovviamente Chencoum non ha mai ritrattato, è un’altra invenzione da bar
della Lucarelli. Al processo venne dichiarato irreperibile quando invece era in
prigione e lo si poteva rintracciare benissimo. Ulteriore dettaglio curioso è
che il comandante Gallorini disse in aula di aver svolto dei lavori sulla
testimonianza di Chencoum. Ma agli atti non esiste alcun verbale in proposito.
Le invenzioni dell’articolo su Il Fatto Quotidiano, proseguono. E la Lucarelli
le utilizza ancora per dare giudizi morali. Ad esempio:
"Azouz. Che tra le altre cose, solo dalla
Cassazione in poi, è diventato improvvisamente innocentista". Qui non c’era
nemmeno bisogno di leggere gli atti. Alla Lucarelli sarebbe bastato seguire il
processo di primo grado (anche banalmente guardando i giornali) per sapere che
Azouz aveva fin da subito avuto dubbi sulla colpevolezza dei coniugi. La polizia
penitenziaria di Vigevano inviò una relazione in tribunale con questi dubbi
espressi mentre era detenuto e Azouz, prima che la Corte si ritirasse per la
sentenza, fu ascoltato. Ma stranamente lì il tunisino negò tutto. Alla vigilia
della Cassazione decise infine di smettere di fingere di credere alla
colpevolezza di Olindo e Rosa. Perché lo negò nel 2008, bisogna che Selvaggia
Lucarelli lo chieda a lui. Potrei esercitarmi ancora a lungo sulle ulteriori
sciocchezze messe nero su bianco da Selvaggia Lucarelli nell’articolo, ma dopo
aver scritto due libri sul caso e innumerevoli articoli prima su Il Giornale e
poi, soprattutto su Oggi, già molti anni fa pubblicai sul sito del settimanale
uno speciale con i documenti originali dell’inchiesta. Per quanti volessero
verificare le fesserie allora raccontate dalla gran parte dei media. È tuttora
online. Selvaggia Lucarelli potrebbe così scoprirle da sola – trovando pure i
verbali sulla Panda e su Chencoum – anche se so che non lo farà, essendo più
comodo giocare a fare il giudice e a prendere like. Mi preme tuttavia
sottolineare un suo commento su Facebook, perché denota quale sia stata l’unica
sua fonte per scriverlo. E cioè, con l’aria di chi la sa lunga e conosce i
segreti delle redazioni, sciorina ai suoi fan, ottenendo un gran successo di
like, la seguente frase: Dove fosse finita la Panda, l’ha poi detto Beppe
Castagna al direttore di Oggi Brindani, pensa che gran segreto. Pensa che
incredibile coincidenza. Gli articoli su Oggi li scrivevo io: dove fosse la
Panda era scritto nei brogliacci delle intercettazioni. E lo sapevamo da subito:
è la conversazione tra Carlo Castagna e un’impiegata del 21 dicembre 2006, delle
ore 9,20. Lo dico a beneficio della preparatissima opinionista. Secondo
Selvaggia Lucarelli, che dunque non ha letto gli atti e non ha manco seguito il
processo sui giornali – e neppure ha letto libri e articoli a proposito di ciò
di cui si occupa – c’erano tuttavia così tante prove che i Romano sarebbero
stati condannati anche «con 34 gradi di giudizio». Addirittura. Deve essere per
questo che la Cassazione, nel chiudere la vicenda, scrisse che sul caso si
addensavano numerosi dubbi e aporie. Ossia domande senza risposta. Avrebbero
potuto chiedere a lei. Se ne sarebbe senz’altro inventata una. Edoardo Montolli
I veri numeri della giustizia in Italia:
i dati allarmanti di Strasburgo, scrive Edoardo
Montolli il 31 agosto su Fronte del Blog. Quali sono i veri dati sulla giustizia
in Italia? Davvero la giustizia funziona perfettamente e ha solo la (notevole)
pecca della lentezza processuale? Ho raccontato in questo intervento su Onda
Libera, condotto da Giulio Cainarca su Radio Padania, quali sono i veri dati
sulla giustizia in Italia, che ci inquadrano, quanto a rispetto del diritto dei
cittadini, in un fazzoletto di “patrie” della democrazia come Russia, Turchia,
Ucraina e Romania. Ovvero lontanissimi dagli Stati occidentali dell’Europa. Si
tratta di dati della Corte di Strasburgo, che riporta tutte le condanne dei
paesi europei per la violazione del Trattato dei diritti dell’Uomo dal 1959 al
2017. L’Italia “eccelle” non solo nella lentezza processuale, ma anche, di gran
lunga, nella violazione dei diritti della difesa, nell’intrusione illecita nella
vita famigliare (in cui si contano notevoli sentenze sanzionate a Strasburgo per
sottrazione illecita di minori) e nella proprietà privata.
Strage di Erba: perché Rosa e Olindo
hanno confessato? Scrivono il 23 ottobre 2018 Le Iene.
Quinto appuntamento con l'inchiesta di Marco Occhipinti e Antonino Monteleone
sul massacro di 4 persone del 2006 per cui sono stati condannati Olindo Romano e
Rosa Bazzi: ecco perché la loro confessione potrebbe non essere una prova
decisiva. Eccoci di fronte alla prova ritenuta più importante che ha portato
alla condanna definitiva all’ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano per la
Strage di Erba, ovvero la loro confessione dell’uccisione della vicina di casa
Raffaella Castagna e il figlio Youssef, assieme alla suocera, Paola Galli, e a
un’altra vicina di casa, Valeria Cherubini, l’11 dicembre 2006 a Erba (Como). Il
motivo: le continue liti condominiali. Siamo al quinto appuntamento
dell’inchiesta di Marco Occhipinti e della Iena Antonino Monteleone sulla strage
di Erba. Siamo partiti dai dubbi di Azouz Marzouk, che nella strage ha perso la
moglie Raffaella e il figlio Youssef, e di molti esperti e giornalisti. Abbiamo
analizzato poi la testimonianza dell’unico superstite, Mario Frigerio, marito di
Valeria Cherubini, che ha riconosciuto Olindo come colpevole. In realtà, nelle
sue prime parole al risveglio avrebbe parlato di un’altra persona, di carnagione
olivastra, più grosso di lui e non del posto. Ci siamo soffermati
successivamente su un’altra prova: la macchia di sangue trovata sull’auto dei
due. I dubbi aumentano, sia sul modo del reperimento della prova sia sul suo
possibile inquinamento. Nel quarto servizio abbiamo parlato della morte di
Valeria Cherubini. Una ricostruzione alternativa a quella stabilita dalle
sentenze sul suo decesso potrebbe scagionare Rosa e Olindo. Anche il generale
Luciano Garofalo, ex comandante del Ris dei Carabinieri, proprio sulla base di
questa e altre ricostruzioni, sostiene: “È lecito avere dei dubbi sulla strage
di Erba”. Dalle intercettazioni, in questo nuovo servizio, emerge come Olindo
decide di confessare sperando di ottenere benefici di pena e non l’ergastolo e
di lasciare la moglie in libertà. Rosa però non ci sta: confessa per
prima. Olindo prova allora a scagionare lei, sostenendo di aver fatto lui tutto
da solo. Hanno confessato potendo vedere le foto della strage e conoscendo man
mano le dichiarazioni dell’altro. Le versioni con il tempo “si
aggiustano”. Olindo a un certo punto dice al pm: “Metta quello che vuole”. Rosa
chiede continuamente: “È giusto, così?”. Nonostante tutto questo, gli errori
delle due versioni restano. Quella di Rosa sembra surreale, quella di Olindo
contiene inesattezze clamorose da quando avrebbe staccato la luce al semplice
accendino con cui avrebbe appiccato il fuoco alla casa (cosa impossibile), dai
numeri dei colpi (da 2 a 43 coltellate a Valeria Cherubini) alle armi del
delitto, “una stanghetta e un coltellino svizzero”. In tutto colleziona 243
errori, uno ogni 30 secondi. Gli errori di Rosa sono incalcolabili. “Il fenomeno
delle false confessioni è più che frequente: mediamente una confessione su
quattro è falsa”, dice un esperto di neuroscienze forense, Sartori, che dubita
delle confessioni di Rosa Bazzi e Olindo Romano. I dubbi ormai sono
molti. Vorremmo porre le domande a entrambi i condannati. Il ministro della
Giuistizia, Alfonso Bonafede, dice che non ci sono ostacoli. Abbiamo ottenuto
l’intervista con Olindo Romano in carcere: in conclusione di questo servizio ne
vedete l’esordio, domenica prossima ne manderemo in onda la versione integrale
in esclusiva assoluta.
Strage di Erba, perchè Rosa e Olindo
hanno confessato? Ultime notizie, le due versioni
zeppe di errori: le anomalie sui coniugi Romano, la ricostruzione de Le Iene,
scrive il 23 ottobre 2018 Carmine Massimo Balsamo su "Il Sussiadiario". Strage
di Erba, perchè Rosa e Olindo hanno confessato? Dopo la sparizione delle
intercettazioni e i dubbi sul luogo della morte di Valeria Cherubini, una nuova
puntata dell’inchiesta de Le Iene sulla tragedia di Erba. Il focus è su cosa
hanno spinto i coniugi Romano a confessare la strage: riascoltando le prime
intercettazioni dopo il fermo, i due non sembrano due spietati assassini,
faticano a capire perché sono finiti in carcere, “tant’è che la moglie piange”
come evidenzia l’inviato Monteleone. Interrogato dai pm, Olindo spiega: “Il
fatto di essere stati riconosciuti dal Frigerio e le tracce di sangue delle
vittime trovate sull’auto di Olindo Romano”. Ricordiamo che, sebbene ritrattata
prima del rinvio a giudizio, la confessione ha convinto i giudici della loro
colpevolezza. Ma ancora prima dell’ammissione, dopo il primo incontro con i
magistrati, queste erano le parole dei Romano: “Non è da noi fare quelle cose
lì, abbiamo litigato ma non da arrivare a quel livello lì”.
PERCHE’ OLINDO E ROSA HANNO CONFESSATO? Olindo
Romano ha perseverato: “Io non l’ho mica fatto eh. Frigerio può dire quello che
vuole, che ci posso fare io”. Il 10 gennaio seguente Olindo chiede di incontrare
i magistrati con l’unico scopo di vedere la moglie: “Era l’unico modo per
vederla”, confessa ai pm. I magistrati insistono per cercare di strappare la
confessione e, dopo due giorni in isolamento e la minaccia di non vederla più, i
pm gli permettono un incontro con Rosa. Olindo arriva a capire che con le prove
che hanno in mano rischia l’ergastolo, mentre con il rito abbreviato ci sarebbe
uno sconto: “Ma cosa c’è da confessare, non siamo stati noi”, sottolinea Rosa,
“Non è vero niente Olli, sai che non è vero niente di questa cosa”. Olindo
replica: “Se facciamo così prendiamo anche dei benefici, te ne vai a casa”.
Subito dopo la svolta: dai magistrati entra Rosa prima di Olindo e inizia
racconto delirante, cercando di prendersi le colpe per scagionare il marito. “Ho
preso il coltello e sono partita… Niente, Olindo è entrato e gli ha dato il
colpo. Lei, la mamma è caduta, si è accasciata a terra, lei invece si è alzata
subito: mi ha sputato in faccia, si è messa a ridere e abbiamo lottato insieme.
Più picchiavo, più la accoltellavo e più mi sentivo sollevata”, lo straziante
racconto della donna. Il giornalista investigativo Edoardo Montolli sottolinea
che “le confessioni non tornano quasi mai con i fatti, non erano
dettagliatissime”. E l’avvocato Schembri conferma: circa un errore ogni 30
secondi in testimonianze considerate dettagliate e sovrapponibili nella sentenza
di primo grado.
LA STRAGE DI ERBA, L’AVVOCATO DI OLINDO E
ROSA: “NON CREDO AI COMPLOTTI MA E’ EVIDENTE CHE QUALCUNO HA OSTACOLATO E FORSE
INDIRIZZATO LE INDAGINI.” Scrive la Redazione di
TAG24 il 22 Ottobre 2018. Nuovo clamoroso capitolo della strage di Erba avvenuta
l’11 dicembre del 2006 e per la quale sono stati condannati all’ergastolo Olindo
Romano e Rosa Bazzi, ritenuti responsabili dell’uccisione del piccolo Youssef
Marzouk, di Raffaella Castagna, Paola Galli e Valeria Cherubini. A Radio Cusano
Campus è andato in onda lo sfogo dell’avvocato Fabio Schembri, legali di Olindo
Romano e Rosa Bazzi, intervistato per “La Storia Oscura” da Fabio Camillacci.
C’è stata la distruzione della gran parte dei
reperti utili a far riaprire le indagini. “E’ successo e sta succedendo un po’
di tutto. Verbali sbagliati, intercettazioni ambientali scomparse, altre non
messe agli atti, presunta manipolazione della memoria dell’unico superstite
della strage di Erba, Mario Frigerio, dubbi sulla repertazione che ha portato a
rilevare una piccola traccia di sangue trovata nella macchina di Olindo Romano,
estenuanti rimpalli tra Procure. Ma la cosa più grave e più recente è la
distruzione della gran parte dei reperti utili a far riaprire le indagini.
Questi contenevano le tracce dei veri assassini: reperti distrutti
nell’inceneritore di Como prima che la Cassazione decidesse di dire no alla
revisione del processo.
Nemmeno nella casa dei coniugi Romano sono state
rinvenute tracce di sangue delle vittime. Questo nonostante i provvedimenti
delle Procure di Brescia e di Como che avevano sospeso la distruzione di quei
reperti. Tutto ciò non solo è incredibile ma è inammissibile in uno Stato di
diritto. Credo che una cosa del genere non sia mai accaduta nella storia della
nostra Repubblica. Fortunatamente - ha aggiunto l’avvocato Schembri - ci sono
altri reperti che siamo riusciti a far conservare presso l’università di Pavia e
ora infatti chiederemo un accertamento tecnico su questi reperti rimasti.
Ovviamente, ci auguriamo anche che tramite il Ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede si possa fare chiarezza su questo. E anche su altri strani episodi che
si sono verificati come la scomparsa di importanti intercettazioni ambientali.
Oltre a questo abbiamo a disposizione altri elementi nuovi utili per dimostrare
che Olindo e Rosa sono innocenti. Voglio infatti ricordare - ha concluso il
legale di Olindo e Rosa - che i Ris di Parma hanno accertato che sulla scena del
crimine non ci sono tracce di Olindo e Rosa. Nemmeno nella casa dei coniugi
Romano sono state rinvenute tracce di sangue delle vittime. Si dice, ‘però Rosa
e Olindo hanno confessato’. Ma la loro confessione è stata clamorosamente
smentita dal dato scientifico che acquista maggior rigore soprattutto se c’è
stata una confessione. Non credo ai complotti ma qualcuno ha ostacolato e
indirizzato le indagini”.
Strage di Erba. Ecco Olindo
privatissimo: gli incubi, la cella. E su Bossetti...,
scrive Matteo Pandini su “Libero Quotidiano” del 14 dicembre 2015. «Tra me e
Rosa non è cambiato nulla, ma vorrei passare più tempo insieme a lei. È la cosa
che mi manca». Olindo Romano è ancora innamorato di sua moglie Rosa Bazzi,
nonostante si possano vedere solo tre volte al mese. Sei ore in tutto. Lui,
classe 1962, faceva lo spazzino. Ora è rinchiuso nel carcere di Opera. Lei, di
un anno più giovane, era una donna delle pulizie. È in cella a Bollate. Sono
stati condannati all'ergastolo per aver ucciso quattro persone - ferendone
gravemente un'altra - a Erba, l'11 dicembre 2006. Secondo le sentenze, dopo anni
di liti condominiali hanno stroncato con coltelli e spranga la loro vicina
Raffaella Castagna (30 anni), suo figlio Youssef Marzouk di 2, sua madre Paola
Galli di 60 e un'altra residente del palazzo: Valeria Cherubini, 55. Mario
Frigerio, 65 primavere, è riuscito a sopravvivere per miracolo (poi è morto per
malattia). Ora gli avvocati di Olindo e Rosa (Fabio Schembri, Luisa Bordeaux,
Nico D' Ascola) sperano di poter riaprire il processo. Facendo analizzare del
«materiale pilifero», probabilmente capelli, trovato sul corpo del piccolo
Youssef. Olindo - ciabatte, pantaloni della tuta blu e maglietta azzurra - crede
di poter essere scagionato. Lo confida in una lettera, dove risponde a delle
domande di Libero.
Signor Romano, come sta?
«Come salute sto abbastanza
bene, mentalmente sono provato ma guardo avanti. A tempi migliori».
Ci descriva la sua giornata
tipo.
«Mi sveglio verso le 8, faccio
colazione e terapie per la pressione. Dalle 9 alle 11 lavoro. Tengo pulito fuori
dal fabbricato dove mi trovo: strada, parcheggio e giardino».
Poi?
«Verso le 13 pranzo, con
un'ora per andare nel locale cucina se voglio prepararmi qualcosa. Poi a volte
vado all' ora d' aria con gli altri, mi occupo del giardino, taglio l'erba, se
mi avanza tempo mi occupo dell'orto. Dalle 16 alle 19 faccio doccia e bucato».
E si arriva all' ora di
cena.
«Non mi perdo mai Il segreto!
(Una soap opera spagnola, ndr). Ma nei fine settimana non c' è, quindi vado in
una saletta a giocare a carte, poi ceno. Mi piace preparare piatti veloci:
spaghetti col sugo, carni, cibi surgelati. Alle 23 vado a dormire, magari sbrigo
le faccende domestiche e rispondo alla corrispondenza».
Chiuda gli occhi. Che
profumo c'è in carcere?
«C' è un po' di odore di fumo,
nel bagno di Lysoform con il detersivo che uso per il bucato».
Com' è la sua cella?
«Entrando a destra, c' è un
mobiletto con le ruote dove tengo le scarpe e sul ripiano le cose di cartoleria.
Alle pareti ho tre calendari compreso quello di frate Indovino».
E che se ne fa di tre
calendari?
«Sono indispensabili per non
dimenticarmi cosa ho da fare!».
Diceva della cella.
«C' è un vecchio letto da
ospedale con materasso e cuscino da campeggio che ho acquistato un paio di anni
fa. Lì vicino ho il campanello per le emergenze e una lampadina che mi permette
di scrivere. Ho una finestra, sulla sinistra c' è un piccolo bagno con lavabo,
wc e una vaschetta attaccati insieme in acciaio, con i rubinetti da giardino.
Poi ho un armadietto in metallo e un tavolino dove tengo quello che mi serve per
cucinare. Tutto è tinteggiato di arancione col soffitto bianco».
Ha mai diviso la cella con
qualcuno?
«No».
Può leggere i giornali e
navigare in Internet?
«Leggo un po' di tutto, la tv
la guardo poco, a Internet non si può accedere».
È interessato anche alla
cronaca nera?
«Non la seguo molto».
Si è fatto un'idea di
Massimo Bossetti, il muratore accusato di aver ucciso Yara Gambirasio?
«Anche su Bossetti hanno fatto
un grande pasticcio, non ho idea di come andrà a finire».
Riceve molte lettere?
«Sì, se fossero di più farei
fatica a rispondere perché non ne avrei il tempo. Ho degli amici di penna che
per qualche ora mi aiutano a dimenticare questo brutto luogo».
Lei è considerato un
mostro.
«Mi sento come un pesce di
lago finito in una palude».
E come la trattano gli
altri detenuti?
«C' è chi mi parla e chi no e
io mi comporto di conseguenza, non ho mai avuto grossi problemi».
C' è qualcosa che le ha
dato particolarmente fastidio?
«Il modo, o la maniera, con
cui tanti giornalisti della carta stampata e della tv, estrapolando da atti e
documenti, sono stati colpevolisti a prescindere perché non hanno guardato tutto
il contesto. Evidentemente non faceva notizia. Così hanno rovinato tanta gente,
influenzando chi è chiamato a giudicare».
Qual è il momento più bello
e più brutto che ha avuto in carcere?
«Diciamo che i momenti, belli
o brutti, qui hanno un sapore diverso. Anche perché non mi manca qualcosa in
particolare, qui mi manca sempre tutto!».
E in particolare le manca
sua moglie Rosa...
«Il nostro rapporto non è
cambiato, ma si è ridotto alle poche ore che abbiamo a disposizione».
Ha più sentito qualcuno
della famiglia Castagna, per esempio il signor Carlo che nella strage ha perso
figlia, moglie e nipote?
«Non ho più sentito nessuno,
se poi loro considerano esaurienti i processi e sono convinti di aver ottenuto
nel suo insieme un giusto processo al di là di ogni ragionevole dubbio, be' non
c' è niente da dirgli».
E cosa pensa di Azouz, il
marito di Raffaella Castagna e del piccolo Youssef?
«Azuz ha capito che le cose
non tornavano, ma ormai è andata così. Guardiamo avanti. C' è ancora Strasburgo
(la corte di giustizia europea che dovrà stabilire se i Romano hanno avuto un
giusto processo, ndr) e la revisione del processo».
Ha incubi?
«No, dato che vivo un
incubo. Quando mi sveglio non ricordo cosa ho sognato».
Lei e sua moglie prima vi
siete autoaccusati e poi vi siete professati innocenti. Perché avete confessato,
se non avete commesso la strage?
«È successo il 10 gennaio
(2007, ndr), quando un carabiniere della scientifica di Como è venuto per
prendermi delle impronte. Con lui ce n' era un altro, che non doveva essere lì e
mi chiedo: chi l'ha mandato?».
E cos'è successo?
«Soprattutto lui, con
insistenza, mi ha prospettato la migliore via d' uscita dalla mia situazione, e
a Rosa hanno detto la stessa cosa».
Scusi, signor Romano: lei e
sua moglie Rosa eravate accusati di reati gravissimi. Come potevate credere che
la migliore via d' uscita fosse confessare un crimine mai commesso?
«Sul momento mi è sembrato il
minore dei mali, non avevo capito che ero finito in qualcosa di più grande di
me. Chiamatela come volete: manipolazione, trappola psicologica… L'avvocato d'
ufficio è stato travolto pure lui».
Poi avete cambiato idea.
«Grazie a persone che ci erano
vicine abbiamo capito che stavamo sbagliando e abbiamo ritrattato, ma quando
sono arrivati gli avvocati che abbiamo tuttora il disastro era già stato fatto.
Il giudice non ci ha ascoltati».
Cosa ricorda della sera
della strage, quando siete tornati da Como e avete trovato la vostra palazzina
zeppa di carabinieri, pompieri, giornalisti e curiosi?
«Ricordo quasi tutto, ma sono
ricordi poco piacevoli e sfuocati dal tempo trascorso».
Ma se non siete stati lei e
Rosa, chi ha ammazzato quelle persone?
«Non saprei».
Si sente una vittima?
«Vittima o capro espiatorio,
la differenza è poca».
Cosa pensa della giustizia
italiana?
«Va cambiata, lo sanno e lo
dicono quasi tutti, il problema è che non lo fa mai nessuno. Per il momento».
Nei momenti difficili cosa
l'ha aiutata?
«La speranza. E tante brave
persone che ci hanno sostenuto a partire dai nostri legali e da altri che non
conosco ma che a suo modo ci hanno aiutato».
Va a messa?
«Posso andarci ogni quindici
giorni, Dio è sempre di conforto come lo sono i cappellani che ci sono nelle
carceri».
S' immagini fuori di qui.
«La prima cosa che farei è
abbracciare Rosa!».
Le capita di pensare alla
vostra vecchia casa di Erba?
«Qualche volta, anche se non è
più nostra».
Non si distrae col calcio?
«Non lo seguo».
Ascolta musica?
«Sì ma non ho preferenze: ogni
cantante o gruppo ha dei brani che mi piacciono. Italiani e non».
Segue la politica?
«Non mi pongo il problema: mi
hanno tolto il diritto di voto».
Ultima domanda: crede
davvero di poter tornare libero, dimostrando la sua innocenza?
«Certo che ci credo, e non
sono il solo a crederci».
«Abbiamo
sbagliato a confessare» Olindo e Rosa, l’ultima battaglia.
Carcere di Opera, l’ex netturbino all’ergastolo dopo la sentenza definitiva
della Cassazione punta alla revisione: speriamo di uscirne, scrive Gabriele
Moroni su “Il Giorno” il 28 giugno 2015 - La voce di Olindo Romano dal carcere
di Opera. Appesa alla speranza che il lavoro dei difensori riesca a riannodare
il filo esilissimo che conduce alla revisione e un nuovo processo. Le sentenze
sono state inequivocabili, grevi come macigni. La condanna all’ergastolo è stata
resa definitiva dal pronunciamento della Cassazione: l’ex netturbino e la moglie
Rosa Bazzi sono i carnefici della strage di Erba, la notte degli orrori dell’11
dicembre del 2006, quando, in un condominio di via Diaz grande come un
falansterio, vennero trucidati Raffaella Castagna, il suo bambino Youssef, di
due anni, la madre Paola Galli, la vicina Valeria Cherubini, mentre il marito di
quest’ultima, Mario Frigerio, si salvò solo perché una malformazione della
carotide deviò il coltello dell’assassino che gli trapassava la gola.
Signor
Romano, spera nella revisione?
«La nostra
difesa sta lavorando bene alla revisione del processo. Certamente, dopo tutto
speriamo che si giunga a rimediare all’errore giudiziario fatto nei nostri
confronti».
Tutti si
chiedono perché, dopo avere confessato, avete ritrattato. Perché?
«Ho ritrattato
semplicemente perché non avendo detto la verità, ho deciso di dirla. Cioè che
non eravamo noi gli autori della strage. Inizialmente, sbagliando, ho pensato
che fosse il minore dei mali (confessare - ndr), visto il quadro che ci era
stato prospettato. La stessa cosa ha pensato Rosa e siamo finiti nei guai».
Come vive
oggi? Come trascorre le sue giornate?
«Oggi vivo male,
guardando avanti, in attesa che le cose cambino. Intanto passo tre ore come
giardiniere, un’ora all’aria, due nell’orto, un’altra in saletta a giocare a
carte. Dopo cena qualche lavoretto domestico, la corrispondenza ed è passata la
giornata».
Tempo fa i
giornali hanno pubblicato che ha ideato una particolare scacchiera per il gioco
della dama.
«Dama da una
parte e scacchiera dall’altra, ideata quando non avevo niente da fare. Ci si può
giocare in due, tre e in quattro. Per un po’ ci giocavo da solo, poi l’ho messa
nel cassetto».
Sua moglie.
Vivevate in assoluta simbiosi. Come sono, oggi, i vostri colloqui?
«I nostri
colloqui, tre ogni mese, sempre al venerdì, punto di riferimento in attesa che
ci mettano nello stesso “collegio”, se non altro».
Cosa vorrebbe
dire alla famiglia Castagna? Carlo Castagna, padre, marito e nonno di tre delle
vittime, ha espresso il desiderio di incontrarvi per quello che dovrebbe essere
un momento di raccoglimento.
«Al signor
Castagna non saprei cosa dire, visto che ci ritiene responsabili della perdita
dei suoi familiari. Senza essere polemico, trovo strana questa sua insistenza
nel volere venire a trovarci, come il fatto, diciamo così, di pubblicizzare il
suo perdono. Penso che i momenti di raccoglimento devono essere personali e
privati, come il perdono che si raggiunge non nell’immediatezza, ma con il
tempo».
Azouz
Marzouk, il tunisino marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, si è
schierato in vostra difesa. Questo l’ha stupita? Le ha fatto piacere?
«Azouz non mi ha
stupito, mi ha fatto piacere. Penso che già da molto tempo aveva capito che non
c’entravamo, arrivando poi alla conclusione che conosciamo».
Riesce a
vedere un futuro davanti a sé?
«Un futuro lo
vedo, come sarà non posso saperlo. Questo grazie alle tante persone che ci sono
vicine e ci aiutano. Li ringraziamo tutti di cuore. Concludendo, nella vita ci
sono cose che ti cerchi e altre che purtroppo ti vengono a cercare. Speriamo in
bene».
“Chi la
visto?” su Rai tre ripercorre le tappe di una vicenda tutta da chiarire.
ROSA:
“Ma che cosa c’è da confessare… non siamo stati noi…”
OLINDO: “Lo so aspetta… Per tagliare le gambe al toro… Metti che sono
stato io…” ROSA: “Ma quando sei andato
su?” OLINDO: “Non lo so.”
(Intercettazione ambientale del 10
Gennaio 2007 nel carcere di Bassone, Como).
IL GRANDE ABBAGLIO. Due
innocenti verso l’ergastolo? di Felice Manti e Edoardo Montolli. Aliberti
editore.
La verità è che questa storia
è ancora tutta da raccontare.
Controinchiesta sulla strage di Erba.
Il problema vero è che in questa vicenda non torna niente. Non tornano le
perizie, non torna il riconoscimento che Marco Frigerio ha fatto di Olindo, non
torna la macchia di sangue sull’auto, non torna niente…
“Quando
abbiamo iniziato a occuparci del caso, esattamente come immaginerà il lettore,
abbiamo pensato che si trattasse di un’idea folle. Poi, sfogliando le carte,
scoprimmo che ogni cosa non tornava.
Non tornava
la perizia del Ris,
depositata ben dieci mesi più tardi, che non aveva trovato tracce dei vicini di
Erba sul luogo della strage, né delle vittime in casa loro o in garage. Eppure
le avevano cercate la sera stessa del massacro, non mesi, né settimane, né
giorni dopo.
Non tornavano
le intercettazioni ambientali
in cui i coniugi, ignari di
essere ascoltati, si mettevano d’accordo per confessare il falso perché
spiazzati dalle prove a loro carico.
Non tornavano
le confessioni,
rilasciate, annotava il gup Vittorio Anghileri, con violazione dei diritti della
difesa. E ancora non tornava quell’unica macchia di sangue trovata sul
battitacco dell’auto di Olindo Romano e Rosa Bazzi e il singolare riconoscimento
dell’unico sopravvissuto, Mario Frigerio. Che, dopo aver detto che l’aggressore
era un gigante di colore e dai capelli rasati, nove giorni dopo la strage
accusava un vicino di casa che conosceva bene da tempo.
E soprattutto
non tornavano, questi dettagli, perché nessuno li aveva mai scritti.
Di ogni cosa era stato riportato l’esatto contrario di quanto era nelle carte.
Scavando e indagando, il dubbio ha preso sempre più piede, fino ad accorgerci
che le cose potevano essere andate, dati alla mano, in tutt’altra maniera”.
Felice Manti
ed
Edoardo Montolli hanno così iniziato a
scrivere dalle colonne del “Giornale”. Poi il materiale era così tanto e così da
approfondire, da decidere di farne un libro.
Un libro
sconvolgente
e appassionato, che contiene anche testimonianze inedite e una
lettera inviata da Olindo Romano e Rosa
Bazzi, scritta in carcere, nella solitudine della cella.
STRAGE DI ERBA: "Montagne di
dubbi sulla colpevolezza di Olindo e Rosa" (Edoardo Montolli).
E se la
strage di Erba non fosse stata compiuta da
Rosa Bazzi e
Olindo Romano? Sembrava fantascienza,
un’ipotesi del genere: poi Edoardo Montolli
e Felice Manti si sono letti le carte
del processo, e hanno scoperto che qualcosa non tornava. Ci hanno scritto un
libro, Il grande abbaglio,
inizialmente ignorato. Loro due? Pazzi, figurati: a Erba, sono stati i vicini
diabolici, la questione è chiusa. Ora sembra che le cose stiano cambiando.
Gabriele
Ferraresi ne ha parlato con Edoardo Montolli:
— intervista —
Sembra che
chi dava dei pazzi a te e Felice Manti si stia ricredendo. Una bella rivincita,
no?
«E’ presto per dirlo. Di certo
gli inviati speciali del Tg1 e del Tg2, dopo aver visto le carte, si sono resi
conto che ci sono diversi dubbi. Così come se n’è accorto il direttore di Oggi,
che oggi fa uscire in edicola il mio ultimo libro, “L’enigma di Erba”.»
Che cosa non
vi ha convinto, nelle carte del processo di Erba?
«Niente. C’è un testimone che
racconta che il suo aggressore era olivastro. Arrivano i carabinieri e gli
chiedono se “la figura nera che aveva di fronte” potesse invece essere Olindo.
Glielo chiedono un sacco di volte e lui alla fine dice sì, potrebbe essere
Olindo. Un brigadiere trova una macchia di dna, della moglie del testimone
sull’auto dei Romano. Per passarla in diverse parti prima con il crimescope e
poi con il luminol ci mette sette minuti. Solo che la macchia sull’auto non si
vede: non c’è una foto buia dove si vede il blu del luminol. C’è una foto
normale con sopra un cerchietto in cui il brigadiere sostiene ci fosse la
macchia. Sarà senz’altro così. Però non sa molto di altro il brigadiere di
quella sera: non sa nemmeno che l’orario di inizio del verbale è sballato
rispetto a quando iniziarono gli accertamenti. Non sa nemmeno che non era da
solo, come dichiarò in aula, a fare accertamenti: da una foto scattata da lui,
ho scoperto che, alzando la luminosità, appariva sullo sfondo un uomo con il
volto coperto e lo spruzzino del luminol in mano. Chi, è Olindo? E’ Olindo che
faceva gli accertamenti per mandarsi all’ergastolo? E poi le strabilianti
confessioni che ho provato siano state fatte guardando le foto della strage,
recuperando un vecchio verbale del 6 giugno 2007. E sono pure gli unici
dettagli, quelli visti nelle foto, i dettagli che tornano nelle confessioni.
Infatti Rosa la prima volta disse addirittura di aver ammazzato Raffaella
Castagna da sola. E che dopo 20 minuti arrivarono Paola Galli e il bambino, che
invece arrivarono e furono uccisi insieme. Disse sempre di aver tentato di
accoltellare Frigerio, che mai lo ha ammesso. Non sapeva nemmeno che non ci
fosse la luce in casa di Raffaella Castagna. E sostenne che Frigerio fosse stato
preso a sprangate, quando invece fu trascinato nell’appartamento e sgozzato,
secondo lo stesso Frigerio. Ma in aula a Como, questi dettagli preferirono non
farli sentire. Era più ad effetto il video rilasciato al criminologo Massimo
Picozzi, quello che poi passò in tv. Anche se nessuno, davanti alla tv, poteva
sapere se ciò che diceva la donna corrispondesse al vero. E questo, per essere
chiari, è solo l’inizio della montagna di dubbi che sorgono sulla colpevolezza
dei coniugi.»
Crollano le
certezze: se ci pensi, Alberto Stasi, altra icona della “nera” degli ultimi
anni, è stato un assassino per mesi, poi l’assoluzione, poi una puntata a Matrix
ed è tutto ribaltato, ora è un povero ragazzo cui “qualcuno” ha ucciso la
ragazza, Chiara Poggi. Prevedi che qualcosa del genere possa accadere anche con
Olindo e Rosa? Ma soprattutto: funziona maluccio la giustizia in Italia, se le
cose stanno in questa maniera…
«Il caso Stasi non l’ho
seguito. Quanto a Erba io spero solo che sia consentito di riaprire il
dibattimento, chiarendo a Milano ciò che a Como non fu fatto, visto che alla
difesa furono tagliati 64 testimoni e che il processo con quell’audio mandato in
aula in cui si sentiva “per me è stato Olindo”, una frase che Frigerio non
sapeva di aver detto visto che accusava nello stesso momento un uomo di colore.
Quell’audio, analizzato dalla difesa, risulta trattato con un programma per
l’amplificazione e l’elaborazione del suono, Cool Edit 2000. Per ciò che
riguarda la giustizia, siamo il Paese più condannato per ingiuste detenzioni. Ma
pure quanto a errori giudiziari non scherziamo: negli ultimi due anni sono
usciti dalla galera due innocenti che si sono fatti rispettivamente 15 e 30 anni
di prigione ingiustamente.»
Puoi spiegare
ai nostri lettori perché a compiere la Strage di Erba potrebbero non essere
stati Olindo Romano e Rosa Bazzi?
«Non c’è il sangue delle
vittime, sangue di cui sarebbero dovuti essere lordi, in casa loro. Si parla di
microtracce, eppure non ci sono. E su questo non si trovano precedenti nella
nera. Perché, com’è noto, il sangue anche quando è lavato o su cui addirittura
sia stata passata sopra vernice, si trova. Invece non c’è nulla. Ed è curioso.
Di più. Rosa aveva un cerotto sul dito: e non c’è sopra il dna delle vittime.
Non c’è neppure il sangue degli imputati nel palazzo e nelle case delle vittime,
dove pure ci sono impronte di scarpe mai identificate e perfino un’impronta
palmare che, confrontata con tutti quelli entrati nel palazzo, non si sa di chi
sia. Le confessioni sono quelle che sono. Sul resto mi pare di aver già risposto
prima.»
Strage di Erba. I dubbi di
“Oggi”. Dalle prime udienze del processo
d’appello di Erba si conferma quello che Oggi ha messo in luce. Sulla strage
dell’11 dicembre 2006, sull’omicidio di Raffaella Castagna, di suo figlio
Youssef, di sua madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini
troppi sono i punti oscuri, i vuoti investigativi, i dubbi. E se Rosa e Olindo,
condannati all’ergastolo, fossero innocenti? Sulla loro colpevolezza si è
cristallizzata una convinzione generale. Ma dalle carte emergono circostanze,
interrogatori, indizi che dovrebbero suggerire qualche cautela. Soprattutto se
si rileggono gli atti in cui il 10 gennaio 2007 Olindo Romano e Rosa Bazzi
confessano (e poi ritrattano) nella convinzione di ottenere una cella
matrimoniale; in cui il riconoscimento di Mario Frigerio, unico sopravvissuto,
arriva solo dopo che il nome di Olindo glielo fanno a lungo i carabinieri; in
cui si ammanta di mistero perfino l’unica prova concreta trovata contro la
coppia: la macchia di sangue individuata sull’auto di Olindo.
L’UOMO SENZA VOLTO
Il 26 dicembre 2006 è la
giornata cruciale. Frigerio, sopravvissuto allo sgozzamento per una
malformazione della carotide, è ancora in ospedale. Dopo la strage, per due
volte ha descritto un aggressore sconosciuto e olivastro, ma alle 13.10 del 26
davanti al pm che lo interroga conferma il dubbio avuto coi carabinieri e cioè
che l’aggressore è Olindo. Ma è ancora un po’ confuso: dice che Olindo è
olivastro, quando in realtà è bianco cadaverico. La testimonianza però non trova
riscontri: negli «stracci» sequestrati ai coniugi Romano la notte della strage
il Ris non ha trovato tracce di sangue. Non ne troverà nemmeno in casa loro e
nulla di riconducibile a loro verrà scoperto nell’appartamento della strage.
Dopo il fragile riconoscimento di Frigerio ai pm, la sera stessa la sorte va in
aiuto degli inquirenti e fornisce la prova che inchioda Olindo. Lo spazzino
viene invitato a presentarsi in caserma a Como con la sua Seat Arosa.
«Accertamenti urgenti», dicono i carabinieri. Anche se li verbalizzeranno due
giorni dopo. Se ne occupa il brigadiere Carlo Fadda. Ha i reagenti per il
sangue. Prima passa il mini crimescope, invano. Poi il luminol, che dà l’effetto
di luminescenza sul battitacco lato guida. Il brigadiere passa la carta filtro e
preleva il campione in cui sarà trovato il dna di Valeria Cherubini, moglie di
Frigerio. Verso le 23 Fadda comincia gli accertamenti e scatta 12 foto. Al primo
processo gli avvocati dei Romano, Luisa Bordeaux e Fabio Schembri, gli
chiederanno: «Si è occupato solo lei di questo accertamento?». «Sì», risponderà
il brigadiere, «ho fatto tutto io». E precisa: è lui che ha spruzzato il
luminol, ed è sempre lui che ha scattato le foto. Al presidente, Fadda
aggiungerà che era presente anche Olindo. Dunque c’erano Fadda, Olindo e basta.
Come da verbale. La foto decisiva è la numero 11: è quella del battitacco su cui
c’era il sangue della Cherubini. La prova per l’ergastolo. La prima cosa da
chiarire è che non si vede l’effetto del luminol, che in presenza di una traccia
brilla. No, è una foto normale su cui è disegnato un cerchietto: sul verbale c’è
scritto che la traccia era lì dentro. Bisogna fidarsi del verbale, dunque. E
allora è interessante tornare a leggerlo. C’è una frase curiosa: «Gli operanti
decidevano di repertare…». Perché «operanti» se l’operante è uno, Fadda? Forse è
meglio guardare con più attenzione le foto originali. Guardando bene la foto 3,
presa alle 23.29, si intravede un uomo. Si copre il volto con qualcosa e ha lo
spruzzino del luminol nella mano sinistra. Chi è? Le immagini scattate con una
reflex digitale, una Fujifilm Finepix S7000, vengono registrate nella memoria
con data e ora di scatto. La foto precedente è stata scattata 11 secondi prima,
dal retro della vettura. Non c’è alcuna possibilità che l’uomo senza volto sia
lo stesso che ha fatto la foto. Non c’è nemmeno il tempo fisico per
l’autoscatto, tanto che il cavalletto appare proprio in disparte. E nemmeno ci
sarebbe motivo per fare un autoscatto e mettersi dietro la vettura con uno
straccio sul volto. E allora chi è l’uomo? È forse Olindo? E cosa ci fa Olindo
con lo spruzzino del luminol in mano? Quello che appare nell’immagine sembra
anche molto più snello di Olindo. Allora, l’uomo che si copre il volto è Fadda
ed è Olindo la persona che scatta la foto? Assurdo. Ma se così fosse e si
prendesse in considerazione l’ipotesi più inverosimile del mondo, e cioè che il
colpevole della strage abbia aiutato il brigadiere Fadda a fare gli accertamenti
sulla sua auto per spedire se stesso all’ergastolo, perché Fadda, in aula, non
l’ha detto? Ma se quello non è Olindo, chi è? Perché non lo ha messo a verbale e
non ne ha nemmeno parlato in aula? Oppure c’è un uomo di cui nessuno sa nulla,
né volto, né ruolo, né addirittura se si tratti di un carabiniere, nel momento
in cui viene trovata la prova decisiva per un ergastolo? Ma se davvero c’è lì un
altro uomo di cui Fadda tace se c’è un uomo ignoto nel momento in cui si reperta
la prova per un ergastolo, ma per quale ragione ci si deve allora fidare di una
foto normale con sopra un cerchietto, scattata otto minuti dopo dallo stesso
Fadda, alle 23.37, nella quale il brigadiere, senza altri testimoni se non
l’inattendibile Olindo, sostiene che ci fosse la macchia con il dna della
vittima senza che la macchia si veda? Chi è l’uomo senza volto?
LA PANDA NERA
Nelle ore successive alla
strage gli inquirenti tengono d’occhio tutti. Anche i Castagna, il padre Carlo e
i figli Giuseppe e Pietro. Ascoltati dai carabinieri Carlo e Pietro Castagna
cadono inizialmente in contraddizione. Le versioni agli atti sono almeno tre. La
prima in cui Pietro sostiene di aver dormito tutto il pomeriggio. La seconda in
cui il padre afferma che Pietro è invece uscito e rientrato verso le 22. La
terza, che li accorda in aula, sostiene che Pietro è uscito e rientrato tra le
20 e le 20.20, certamente prima delle 21. Nel memoriale consegnato a Oggi la
settimana scorsa, Giuseppe ha poi fissato l’orario di rientro di Pietro tra le
20.00 e le 20.05. Tre anni fa, però, nessuno degli inquirenti ha approfondito.
Nemmeno quando il 25 dicembre il tunisino Ben Brahim Chemcoum, che poi sparirà,
mette a verbale di aver riconosciuto il «fratello della morta» che aveva già
notato in caserma il giorno 16 nelle vicinanze di via Diaz, in orario
compatibile con quello della strage. E il 16 in caserma c’era Pietro. L’unica
cosa certa sulla sera della strage riguardo ai Castagna è che Pietro va e viene
da casa su una Panda nera. È l’auto di Paola Galli, moglie di Carlo, madre di
Beppe e Pietro, che quel giorno ha usato la Lancia K del marito. I Castagna
vengono sottoposti a intercettazioni telefoniche e ambientali: tranne che sulla
Panda. Il 19 dicembre Carlo spiega a un interlocutore che, così come gli hanno
detto, i telefoni possono essere sotto controllo. Due ore dopo, parla col figlio
Beppe di una macchina. Il giovane propone al padre di regalarla alla Croce
Rossa. «Sei meraviglioso», risponde il padre. Due giorni più tardi, a nove
giorni dal massacro della sua famiglia, Carlo chiama in ditta spiegando che la
Panda della defunta moglie, con un solo anno di vita, verrà regalata alle suore
di Albese. E che si trova in carrozzeria per qualche ritocchino e per una
“pulizia interna”: per i carabinieri, all’epoca, si tratta di conversazioni “non
utili”. Nel novembre 2008 Carlo Castagna dirà all’inviato del Corriere della
Sera d’aver consegnato la macchina a una suora amica di famiglia nel gennaio
2007. Nell’indifferenza degli inquirenti, l’auto sparisce da Erba, anche se
continua a figurare sui registri del Pra, sempre intestata a Paola Galli.
L’auto, in effetti, è là dove doveva essere: sotto un portico, all’istituto
delle suore di Albese, dove l’hanno trovata la settimana scorsa i cronisti di
Oggi. Giuseppe ha spiegato a Oggi i motivi per cui l’auto fu data
alle suore, e ha dichiarato che la Panda fu portata ad Albese «una decina giorni
dopo», non a gennaio. Le monache dicono che Castagna portò loro la Panda il
giorno dopo la strage. «Al massimo», aggiungono, «due o tre giorni dopo».
Probabilmente non c’è nulla di strano, a distanza di tanto tempo i ricordi
possono essere confusi. Ma, visto che Oggi può documentare la presenza
dell’auto, perché gli inquirenti non vanno sul posto a verificare l’esistenza di
un mezzo ripetutamente citato nei verbali ma ignorato dai controlli?
La svolta di Azouz Marzouk
Appare per certi aspetti indecifrabile l’atteggiamento del tunisino Azouz
Marzouk, marito di Raffaella Castagna, padre del piccolo Youssef e genero di
Paola Galli. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta era stato indicato dalla procura
di Como come l’autore della strage. Bufala colossale. Azouz era dai suoi
familiari in Tunisia. È rientrato in Italia nei giorni scorsi per seguire il
processo d’appello in cui è parte civile, contro i Romano. Fuori dall’aula,
prende la parola e reagisce ai proclami di innocenza dei due imputati: «Vogliono
giustizia, no?», dice Azouz. «L’avranno. È già tutto scritto, giustizia è già
stata fatta una volta e sarà fatta anche la seconda con la conferma
dell’ergastolo. Da subito ho riconosciuto lo sguardo di chi ha sterminato la mia
famiglia e non lo dimenticherò mai». Da subito mica tanto. A caldo Azouz si
esprimeva in modo completamente diverso. Fu lui a convincere il connazionale Ben
Brahim Chemcoum a presentarsi dai carabinieri per dire che la sera dell’11
dicembre aveva visto il «fratello della morta» nei pressi di via Diaz. Fu sempre
lui che, detenuto a Vigevano per spaccio, confidò i suoi sospetti sulla famiglia
della moglie, tanto da spingere la direzione del penitenziario a scrivere
un’informativa al presidente della Corte d’assise di Como. E non poteva che
essere stato lui a orientare la madre Souad, che al telefono dalla Tunisia
confidava al figlio il suo terribile sospetto: «Vedrai che con il tempo
troveranno che è stato suo fratello [di Raffaella, ndr] dietro tutto questo… Il
mio cuore non mi mente, te lo dico io, Azouz». Cosa intendesse, non si sa: in
aula lei non verrà. Ma oggi anche Souad è parte civile contro Olindo e Rosa,
accusati di aver ammazzato il nipote Youssef.
PRESUNTO COLPEVOLE. MASSIMO BOSSETTI.
Massimo Bossetti... come ti faccio
credere di aver condannato un assassino, scrivono
Massimo Prati e Gilberto Migliorini sabato 13 ottobre 2018 su Albatros Volando
Controvento. Molto probabilmente non ci sarebbero stati nessun arresto e nessun
processo se Massimo Bossetti fosse vissuto fuori dai confini italici. Purtroppo
per lui è un cittadino italiano che vive in Italia... e in Italia da quando
esistono i processi indiziari, la cultura giudiziaria invece che progredire è
regredita tornando all'epoca di Alessandro Manzoni quando nel Incipit della
“Storia della Colonna Infame” scriveva: “Ai giudici che, in Milano, nel 1630,
condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver propagata la peste
con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cosa
talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in
aggiunta de' supplizi, la demolizione della casa d'uno di quegli sventurati,
decretarono di più, che in quello spazio s'innalzasse una colonna, la quale
dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la
notizia dell'attentato e della pena. E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio
fu veramente memorabile.” Da ieri sera Massimo Bossetti per la giustizia
italiana è colpevole. Non ci strapperemo le vesti. Sappiamo aspettare, siamo
fiduciosi che la verità verrà a galla, magari fra troppi anni come capitato ad
altri condannati innocenti. Ciò che è accaduto è oramai la "normalità
giudiziaria". Per un perverso meccanismo psicologico si è finiti per credere a
qualcosa diventato talmente di dominio pubblico, così lapalissiano e corroborato
mediaticamente, da non aver altra necessità di conferma se non quella della voce
che corre. La voce si presenta come la spiegazione ideale degli indizi che essa
stessa ha immaginato. La voce è un dato ‘oggettivo’: i membri di un gruppo, sia
mediatico che popolare che investigativo che peritale che istituzionale che
giudiziario, ‘parlano e riparlano’ dando origine a un racconto, a un’ipotesi
accusatoria che facilmente può essere convalidata da indizi double face che si
adatterebbero a chiunque venisse arrestato. Perché, in un altro eventuale "caso
Yara", migliaia di persone potrebbero adattarsi a una qualsiasi ricostruzione
accusatoria... ah già, ma nel caso in questione c'è il famoso mezzo dna di
ignoto uno che accusa! Il fatto a dir poco sorprendente è che si asserisca
giudiziariamente che Massimo Bossetti è figlio di Giuseppe Guerinoni senza che
sia mai stato fatto un confronto diretto fra i due Dna originali padre e figlio,
che nello stesso tempo si dichiari che Massimo Bossetti non è figlio di Giovanni
Bossetti senza che esista agli atti il documento di analisi del Dna che lo
proverebbe. Si è andati per induzione con un ragionamento del tipo: un mezzo dna
ci dice che ignoto uno è figlio di Guerinoni, quel mezzo dna ha una parte
maggioritaria compatibile con quello di Massimo Bossetti e, pertanto, Massimo
Bossetti è figlio di Guerinoni... quindi è ignoto uno, ergo è l'assassino.
Motivo per cui non c'è motivo per fare un'analisi diretta che dimostri questa
ormai assunta verità. Questo ragionamento induttivo lo si è fatto senza
considerare che prima di rovinare una famiglia e far marcire in galera un uomo
incensurato, visti i migliaia di casi in cui l'errore ha mandato a morire in
carcere persone innocenti, sarebbe d'uopo fare anche quelle verifiche che pur
sembrando inutili servono da prova del nove per la verità...Parlare di anomalie
è riduttivo. Prendiamo quanto pare accertato mediaticamente e analizziamolo in
maniera seria senza trascendere nei soliti pettegolezzi. La dottoressa Gino dice
a processo che c'è stata una analisi fatta dalla famiglia a Torino e che Massimo
è figlio di un altro padre, non sa però se Guerinoni o chi altri visto che il
confronto diretto fra dna originali non c'è stato. Ammettiamo pure che il
documento in quel di Torino esista e che dica in sintesi che Massimo non è
figlio di Giovanni. Va tutto bene così? No. Primo, non sappiamo chi ha firmato
il documento e, secondo, sappiamo che l'analisi non è stata ripetuta in un altro
laboratorio... eppure non è certo la prima volta che un test successivo ribalti
gli esiti di un test precedente. Un errore è sempre possibile. I test si rifanno
anche per gli atleti che non ammettono di essersi dopati... perché non ripeterli
per chi rischia l'ergastolo? I documenti nella pratica scientifica vengono
pubblicati proprio perché possano essere ricontrollati da altri (riproducibilità
e ripetizione). Peraltro, in questo caso non sappiamo neppure con quali modalità
e su quali reperti è stato effettuato il test e non si conoscono i risultati
analitici (la dettagliata relazione tecnica comprensiva di cromatogrammi e
analisi statistica dei risultati, e i "dati grezzi" provenienti dalle
apparecchiature di analisi, utili per le verifiche). Un nuovo test di verifica
in un nuovo laboratorio sarebbe stato obbligatorio e lo doveva ordinare il
giudice a processo per essere certo di non incorrere, per superficialità, in un
errore grossolano ma enorme. Eppure nemmeno la cassazione ha deciso di
effettuarlo. Tutti certi, per induzione, sia che l'assassino di Yara sia il
proprietario del dna monco rimasto miracolosamente intatto su un lembo degli
slip dopo tre mesi di neve pioggia e sole, senza considerare i liquidi organici
che spazzano via qualunque cosa e gli animali attirati dal cadavere, sia che
ignoto uno si chiami Massimo Bossetti nonostante non ci sia mai stata una
comparazione diretta. L'imputato può chiedere al giudice che deve tutelare anche
il suo diritto alla difesa che le sue ragioni vengano ascoltate, che si faccia
una perizia in più per stabilire se mente o dice il vero. E quel giudice ha
l'obbligo giuridico di accogliere tale richiesta... se è un giudice che applica
la legge usando il buonsenso del padre di famiglia. Se poi oltre che al
buonsenso è dotato anche di un buon spirito critico, a maggior ragione quel
giudice deve accordare la perizia perché non può fare a meno di chiedersi il
motivo per cui l'accusa si opponga a tale richiesta. Se le induzioni della
procura sono giuste cosa può temere un procuratore da una analisi che non
farebbe altro che confermare la sua tesi accusatoria? Forse può temere di aver
sbagliato qualcosa e non può uscire dal seminato perché la condanna
dell'imputato sarebbe a rischio? Forse sa qualcosa che né noi né i giudici
sappiamo? Cosa sarebbe accaduto se una nuova perizia avesse dimostrato un
grossolano errore di laboratorio? Se avesse dimostrato che il dna di Massimo
Bossetti nulla c'entrava con l'omicidio? Un tale scenario, ora più che mai
puramente ipotetico, avrebbe aperto, proprio come nel testo manzoniano “La
storia della colonna infame”, molti interrogativi su come venga amministrata la
giustizia italiana. Mettiamo per ipotesi che la cassazione abbia accordato la
perizia sul dna. Mettiamo per ipotesi che si sia fatta oggi e che smentisca la
procura... cosa accadrebbe? Accadrebbe che sul banco degli imputati non ci
sarebbe più Massimo Bossetti ma tutto un sistema che pervicacemente si è
rifiutato per anni di ricontrollare gli esiti delle sue conclusioni e
l’affidabilità di sentenze di condanna dove di ragionevoli dubbi ce n’erano a
bizzeffe, come evidenziato dalla difesa del muratore, a cominciare da un Dna
(low copy number) che sopravvive intatto per mesi di ottima qualità in un campo
su un corpo a contatto con la terra, insetti e animali di tutti i tipi (nella
letteratura biologica non esiste nessun caso simile). E questo, si direbbe ora
in ogni media, non è solo un unicum ma è un evento impossibile. Una eventuale
dimostrazione che Massimo Bossetti non ha nulla a che fare con Guerinoni ma è
proprio figlio del padre legale sarebbe un colpo durissimo per il sistema
giustizia del nostro Paese, ben più destabilizzante del caso Tortora e di
Unabomber, e dimostrerebbe come l’esistenza di più gradi di giudizio non metta
al riparo da sentenze fotocopia dove - rispetto al garantismo per l’imputato con
una rigorosa verifica del già sentenziato - prevale (salvo lodevoli eccezioni)
la fiducia incondizionata nei giudici dei precedenti gradi di giudizio...
specialmente se questi sono capaci di scrivere bene le motivazioni (e se non ne
sono capaci di certo le fanno scrivere a chi ne è capace). Insomma, da decenni
vediamo un sistema giudiziario che non garantisce più l'equo processo
all'imputato, vediamo un sistema giudiziario che non guarda più con occhio
critico sia quanto porta la Difesa che quanto porta chi accusa, vediamo un
sistema giudiziario che preferisce appiattirsi alle tesi accusatorie e puntare
tutto sulla affidabilità di chi ha già deciso in precedenza. Come detto, invece
di evolversi la giustizia italiana è regredita. E' del tutto evidente che il
caso Bossetti riveste un’importanza che travalica il cold case, che sono
implicate considerazioni più generali sul funzionamento della giustizia dovuta
ad automatismi che vengono da lontano e che autori come Verri e Manzoni hanno
saputo rappresentare sul piano civile e con intenti epistemologici di rilievo.
In particolare l’opera manzoniana conserva intatta tutta la sua attualità
nonostante sia stata pubblicata nel lontano 1840 e si riferisca alle vicende
legate alla peste del 1630. Il caso Bossetti, per tutto quello che è stato
rilevato da più parti, dimostra che la forma mentis del sistema giustizia del
Bel Paese non è poi cambiata di molto rispetto a quanto il Manzoni ha denunciato
nella sua opera. Quella lentezza della storia della quale ha parlato uno storico
del calibro di Jacques Le Goff è dimostrata dai meccanismi psico-sociali che si
possono riassumere in quell'immagine tratta dalla psicologia sociale
definita effetto Pigmalione o profezia che si autoadempie. Paradossalmente i
rilievi epistemologici più pregnanti sono stati fatti non a livello filosofico
ma letterario. Un autore come il Manzoni ha saputo come nessun altro mettere in
risalto quali sono gli automatismi che agiscono surrettiziamente. Le voci che
corrono sono in grado di influenzare non solo il vasto pubblico ma a tutti i
livelli anche chi dovrebbe essere immune dal pregiudizio e dall'influenza della
suggestione che agisce sotterraneamente in tutti i contesti. Nemmeno la cultura
mette al riparo da certi meccanismi di influenza sociale. Proprio come nella
pubblicità-propaganda quando un fattoide entra a far par parte delle credenze
collettive subentrano poi meccanismi di conferma acritici, la suggestione è
talmente coinvolgente che si dà per scontata una cosa anche se non ne esiste
prova... o meglio, la prova diviene proprio quella voce che corre, ormai
considerata così evidente e così cogente da non aver più bisogno di ulteriori
verifiche. Il caso degli untori oggi potrebbe far sorridere, salvo poi
l’evidenza che, non nel 1600 ma ai giorni nostri, alcuni bambini non vaccinati
sono stati lasciati soli in un’aula perché considerati pericolosi... e da questo
si capisce che la paura degli untori è attuale. La realtà è che il concetto di
untore è commisurato a un contesto storico e geografico, a una modalità di
esclusione e di condanna aggiornato a nuove realtà socio-economiche e
ideologiche. La cecità dell’effetto Pigmalione riguarda quella influenza
collettiva per la quale si confonde la suggestione con il risultato di prove
tangibili. Il sistema dell’informazione dà fiato e sostanza alle minime voci che
poi amplificate divengono colpi di cannone! Da un lato c'è il giudice istruttore
che crede di sapere tutto del crimine e deve mantenere il segreto istruttorio,
dall'altro ci sono i giornalisti che dicono tutto anche quando non sanno niente.
Quando non dicono ciò che gli chiedono di dire. Queste due rappresentazioni
fanno sì che si assista a una strana compenetrazione dove le voci che corrono si
influenzano su vari piani in un crescendo che si rinforza e compenetra proprio
come nell'opera rossiniana. Nel caso Bossetti esiste un’unica prova chiamata
regina. Pochi nanogrammi di materiale genetico. Se li togliamo dal processo non
rimane più nulla... o meglio rimane l’effetto Pigmalione. Vediamo nel dettaglio
che cosa si intende per "effetto pigmalione" e come il caso Bossetti diverrebbe
se si dimostrasse che lui è proprio figlio di Giovanni. Il cold case diverrebbe
una telenovela partorita da una fervida immaginazione. L'effetto Pigmalione, o
effetto Rosenthal, deriva dagli studi classici sulla “profezia che si
autoadempie”: in pratica l’opinione che ci siamo fatti su qualcuno influenza il
nostro giudizio, quante volte vi è capitato, anche se non esiste nulla a riprova
della veridicità della nostra opinione. Questo vale in tutti i rapporti in cui è
implicata una qualche forma di valutazione influenzata da una premessa
pregiudiziale. Nel mito, Pigmalione è il re di Cipro che si innamora della
statua di Afrodite al punto di crederla vera e immaginare di potersi congiungere
ad essa. In Ovidio, Pigmalione è uno scultore che si innamora della sua statua e
implora Afrodite di trasformarla in una donna in carne ed ossa. In sostanza le
nostre credenze di partenza influenzano i nostri giudizi. Quante volte avete
pensato di essere di fronte a uno/a stronzo/a o, viceversa, a una persona
affascinante dall'animo gentile? Quante volte avete scoperto che vi sbagliavate?
Tutti sappiamo che sono tantissime, visti i divorzi e i femminicidi. Rosenthal
aveva prodotto un test di intelligenza con alcuni alunni (definiti come molto
intelligenti) coi risultati volutamente fittizi e lo aveva fornito agli
insegnanti. Quando tornò in quella scuola constatò, come aveva previsto, che
proprio quegli alunni che erano stati definiti come molto intelligenti mediante
un test fasullo erano diventati i migliori della classe. Gli insegnanti erano
stati influenzati da quel giudizio preliminare e avevano trattato di conseguenza
quegli alunni, con un occhio di riguardo e forse anche con valutazioni errate.
In questi casi accade che la suggestione elimina tutto quello che non conferma
(nel nostro caso il brillante test di intelligenza) e dà conferma a tutto quello
che in qualche modo potrebbe fare da supporto, convalidando emotivamente il dato
iniziale, l’input di partenza fasullo. D’altro canto il pregiudizio, positivo o
negativo, non si qualifica mai come tale. Grazie all'inferenza deduttiva, assume
l’aspetto esteriore della razionalità anche quando sono la suggestione e
l’emozione che costituiscono l’ossatura di un giudizio. Il caso Bossetti è il
prodotto di una gigantesca profezia che si autoadempie, a partire dal suo
arresto in pompa magna per arrivare alla prova di paternità che negli atti non
esiste ma è riuscita ad orientare tutta l'indagine e tutte le sentenze. Solo le
verifiche potrebbero dimostrare che il caso Bossetti non sia solo la
classica profezia che si autoadempie o effetto Pigmalione. Ma le verifiche chi
opera per la giustizia italiana non le ha volute fare. Per cui, al momento e
nonostante la condanna definitiva, l'assassino di Yara non si sa davvero chi sia
e la trama basata sul dna scritta dall'accusa e accettata dai giudici, a tutti
gli effetti è, e rimarrà fin quando non sarà corroborata da una nuova perizia a
conferma, uno sceneggiato di fantasia da quattro soldi che può attecchire solo
in chi è stato suggestionato dai media e portato a credere che chi accusa e
condanna Bossetti è intelligente a prescindere... come gli alunni di Rosenthal
agli occhi degli insegnanti dopo il test fasullo.
PRESUNTO COLPEVOLE. CATENO DE LUCA.
"Scateno", antenato degli impresentabili
fra strip e processi, scrive il 09/11/2017 Mario
Barresi su "La Sicilia". Dai domiciliari si difende su Facebook «Vittima dei
massoni, il caso fa ridere» Poi ai fan sotto casa cita Luther King e giura:
«Avanti senza se e senza ma». Un «delinquente». Ma anche «un benefattore». E poi
«il miglior sindaco della storia», anche perché ha portato a mille anime «200
milioni di opere pubbliche» compreso «un centro benessere». Ma anche uno «che se
noi sei con lui ti mette nella lista dei nemici e sei finito per sempre». Mentre
i messinesi, nel 1674, si rivoltavano contro i dominatori spagnoli, Fiumedinisi
fu uno dei pochi comuni a restare fedele alla Corona ispanica. E così, corsi e
ricorsi, è oggi per «u’ sinnucu». Criticato sottovoce e difeso a testa alta.
Cateno Roberto De Luca, qui in carica dal 2003 al 2011, ma anche sindaco di
Santa Teresa di Riva (dove ha lasciato il suo delfino Danilo Lo Giudice) e
aspirante primo cittadino di Messina con campagna elettorale già avviata con
pecora al seguito. Quarantacinque anni, in politica da quand’era quindicenne,
candidato a tutto. Anche a presidente della Regione, nel 2012, quando lanciò la
sua corsa solitaria con una kermesse scintillante e uno slogan chiarissimo: «Io
rivoluziono la Sicilia. Scateno De Luca». Prese l’1,2%, ma da lì in poi diventò
“Scateno”. Per tutti. Impresentabile prima che esistessero gli impresentabili,
De Luca ha un curriculum pieno di guai giudiziari, proteste clamorose e
citazioni indelebili. Cinque anni fa, dopo essere stato deputato regionale del
Mpa, si ribella al suo mentore: «Lombardo agisce con metodi politico-mafiosi. Se
ne vada affanculo una volta per tutte, lui e i suoi compagni di merende».
All’Ars i commessi lo ricordano atterriti quando, per protestare per la mancata
nomina in commissione Bilancio, restò in mutande, con una bibbia, un Pinocchio e
la bandiera della Trinacria ad avvolgere le nudità. Rieletto all’Ars nel 2008,
dopo un fugace ritorno con Lombardo, inizia un breve flirt politico con
Gianfranco Micciché. Dura poco. Perché lui, “Scateno”, è un individualista. Da
leader di Sicilia Vera chiede e ottiene ospitalità nella lista dell’Udc per le
ultime Regionali: è il più votato, eletto con 5.418 preferenze. Alle quali
bisogna aggiungere i 4.298 del suo seguace, Lo Giudice. Rieletto nonostante la
lettera scarlatta di “impresentabile” cucitagli addosso dai grillini. «Pupi
nelle mani del puparo di Genova», secondo De Luca, condannato dalla corte dei
conti a 13mila euro per le “spese pazze” dei gruppi all’Ars. Ma soprattutto
sotto processo per il “sacco di Fiumedinisi”, il quindicesimo dei «14
procedimenti penali chiusi a mio favore». Arrestato per abuso d’ufficio e
concussione, il pm ha chiesto per lui 5 anni di pena. Ma “Scateno” si difende
sempre contrattaccando. In tarda mattinata si diffonde la notizia dei suoi
domiciliari. E sotto casa sua c’è chi è già certo: «Anche stavolta ne combinerà
una delle sue». Infatti, violando le restrizioni degli arresti domiciliari,
imposta la sua autodifesa su Facebook. Prima con un post, corredato dalla foto
del «caffè del galeotto», in cui chiede: «Pregate per me e per la mia famiglia e
per gli altri indagati che nulla c'entrano in questa storia». Molto più
esplicito, poco dopo, in un video-selfie in pigiama. «La vicenda fa ridere»,
esordisce. Quindi racconta: «Io sono sereno perché già venerdì sera a piazza
Cairoli sono stato avvicinato da un noto personaggio della politica siciliana e
anche ritengo della massoneria nonché un parente molto stretto di magistrati, il
quale mi ha fatto i complimenti per la campagna elettorale e mi ha detto: “Lo
sai che è tutto inutile quello che hai fatto”. Questo stesso personaggio lunedì
- prosegue - ha telefonato a un nostro amico nonché suo collaboratore dicendogli
che era inutile l’elezione di Cateno perché sarebbe stato arrestato e sarebbe
subentrato il primo dei non eletti, Danilo Lo Giudice. Sapevo di scontrarmi
definitivamente con i poteri forti di Messina, massoneria e altri ambienti che
non vogliono che io faccia il sindaco». E chissà cosa avrebbe detto ancora, se
il suo avvocato Tommaso Micalizzi non l’avesse bloccato: «Basta social, sei ai
domiciliari». E se a mezzogiorno sceglie una frase del Vangelo, la sera vira su
Martin Luther King. «Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad
aprire e non trovò nessuno». Lui, Cateno, di porta ha aperto quella del suo
balcone e ha trovato un centinaio di fan capeggiati da Lo Giudice,
amministratori e “fenapini”, che si sono radunati sotto casa sua. Alle nove
della sera. Doveva essere una fiaccolata, diventa un semplice tributo di De
Luca. Legge compiaciuto lo striscione (“Cateno siamo con te senza se e senza
ma”) e appare come un pontefice dopo la fumata bianca. Un breve saluto. Poi
l’irrinunciabile post su Facebook. «Grazie di cuore per la splendida
manifestazione di solidarietà, mi avete veramente commosso. Si va avanti senza
se e senza ma». Silenzio surreale, si riflette. «Non ci sono i presupposti
perché stia agli arresti» mormora qualcuno all’avvocato Micalizzi. Che studierà
come tirarlo fuori dai guai. Per la sedicesima volta.
Sicilia, dall’allevamento di conigli
all’arresto: chi è Cateno De Luca, il Masaniello che si spogliava all’Ars.
Rieletto a Palazzo dei Normanni lunedì pomeriggio, è finito ai domiciliari per
evasione fiscale mercoledì mattina: battuto probabilmente ogni record registrato
sul fronte dei rapporti tra la politica e le ordinanze di custodia cautelare.
Prima, invece, aveva fatto parlare di sé perché si era denudato a Palazzo dei
Normanni. O perché era riuscito a controllare il sindaco, la maggioranza ma
anche l'opposizione nel suo piccolo comune, scrive Giuseppe Pipitone l'8
novembre 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Quando lo esclusero dalla commissione
Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ci rimase davvero male. Talmente
tanto che mise in scena la più ridicola delle proteste: si presentò
in mutande nella sala stampa del Parlamento regionale. Per poi coprirsi soltanto
con la Trinacria. Un chiodo fisso quello di Cateno De Luca per la bandiera
della Sicilia, ricamata persino sulla cravatta d’ordinanza fornita agli
esponenti di Sicilia Vera, il movimento da lui fondato dopo un
incessante pellegrinare da partito in partito. “Il colore che ho scelto
è rosso-aranciato, quello della bandiera della Sicilia. Il rosso mi piace molti
sostengono che io sia uno di sinistra che fa politiche di destra, forse un po’ è
vero”, si autoincensava il deputato regionale, che con quel movimento si è pure
candidato a governatore nel 2012. Sissignore: in Sicilia succede anche questo.
Che un consigliere regionale noto per essersi denudato in pubblico, dopo aver
conosciuto persino la galera, decida non di ritirarsi a vita privata ma di
rilanciare: “Il presidente lo faccio io”. Prese l’1,2%, ma non si diede per
vinto. E cinque anni dopo ci ha riprovato. Rieletto a Palazzo dei
Normanni lunedì pomeriggio, è finito ai domiciliari per evasione
fiscale mercoledì mattina: battuto probabilmente ogni record registrato sul
fronte dei rapporti tra la politica e le ordinanze di custodia cautelare. Caf e
sacchi edilizi – Per i giudici De Luca è “il dominus di una serie
di società ed enti”, utilizzati per sottrarre al fisco 1,7 milioni di euro. Sono
i vari Caf di un ente che si chiama Fenapi, acronimo di Federazione nazionale
autonoma piccoli imprenditori, di cui risulta essere il “direttore generale
nazionale”. Il presidente, invece, è tale Carmelo Satta, arrestato con lui
stamattina. E con lui coinvolto nell’inchiesta sul “sacco di Fiumedinisi”, il
minuscolo paesino in provincia di Messina di cui De Luca era sindaco. E in cui,
per i pm, avrebbe voluto realizzare una gigantesca speculazione edilizia con
l’immancabile mega albergo dotato di centro benessere. Purtroppo lo arrestarono
prima con l’accusa di tentata concussione e abuso d’ufficio, insieme al fratello
Tindaro: in famiglia evidentemente non piacciono i soliti Giuseppe e
Francesco. La Cassazione definì “ingiusta” la sua detenzione, ma il processo è
andato avanti: e sul capo del politico messinese pende ancora una richiesta di
condanna a 5 anni di carcere. Il caffè del galeotto del Masaniello di provincia
– Nel frattempo si è ricandidato: a questo giro ha scelto l’Udc e Nello
Musumeci. Ha preso 5mila voti ed è stato rieletto nonostante i problemi
giudiziari, che in campagna elettorale lo avevano fatto finire di diritto tra i
candidati impresentabili. “Ho avuto 15 procedimenti, 14 si sono conclusi con
l’archiviazione”, sosteneva lui, promettendo querele e chiedendo un immotivato
confronto pubblico col direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Lo
stesso stile con cui ha commentato l’ultimo arresto. Ristretto ai domiciliari,
ha accesso il computer senza neanche togliersi il pigiama: “Vi offro
il caffè del galeotto”, ha scritto su facebook. Poi, non contento, ha pubblicato
un video per spiegare di avere saputo in anteprima dell’arresto. “Me l’ha detto
un parente di magistrati e di massoni”, è la sua versione. “Dedico questa
ulteriore battaglia ai perseguitati dell’ingiustizia”, è invece il modo in cui
dipinge la sua situazione giudiziaria. Sì perché questo piccolo ras delle
preferenze di provincia crede davvero di essere un Masaniello del duemila. O
almeno è quello che vuole fare credere ai suoi elettori.
Dai conigli all’Ars – Sul suo personalissimo sito
racconta gli albori della sua carriera. “Da adolescente ho allevato conigli e
raccoglievo origano, noci e castagne che poi vendevo alle putie (letterale, cioè
negozi ndr) di Fiumedinisi sotto la severa vigilanza della mia mamma; quando
frequentavo la scuola media durante le estati facevo il muratore con mio padre;
mentre frequentavo il liceo passavo le mie estati a lavorare nei bar ed in
inverno frequentavo uno studio legale messinese che si occupava di diritto
previdenziale e sindacale”, scrive nella sua biografia. Chissà dove trovava il
tempo per studiare, verrebbe da chiedersi. Di sicuro è col diritto previdenziale
amministrato nei Caf della Fenapo che De Luca comincia a coltivare quel reticolo
di rapporti sociali, poi trasformati in voti ad ogni tornata elettorale.
Esordisce adolescente come attacchino della Dc, poi comincia la scalata:
consigliere comunale, presidente del consiglio, sindaco della sua piccola città.
Incarico che lascia dopo l’arresto nel 2011. E che non può più ottenere l’anno
dopo, perché nel frattempo si è fatto eleggere sindaco nel vicino comune
di Santa Teresa Riva. Sindaco e opposizione sono roba sua – È a quel punto che
il Masaniello peloritano si trasforma in Archimede Pitagorico della politica
locale: candida due aspiranti primi cittadini, entrambi sostenuti dalle sue
liste. Poi manda una lettera agli elettori, chiedendo di votare uno dei due
candidati sindaco, ma optando per i consiglieri comunali del suo avversario: in
pratica istituzionalizza il voto disgiunto. “È un chiaro e forte gesto di
ribellione”, dice, ma non si capisce verso che cosa si dovrebbero ribellare i
cittadini visto che nei precedenti due mandati il sindaco era sempre lui. Gli
elettori, però, non ci fanno caso e votano in massa come dice De Luca: che
quindi è riuscito nell’impresa di controllare il sindaco, la maggioranza, ma
anche l’opposizione. “Con questi metodi da Repubblica delle banane si vuole fare
del comune, invece che una casa di vetro, il cortile della propria abitazione”,
si lamentava all’epoca il deputato Pd Filippo Panarello. Opinione minoritaria,
evidentemente, visto che nella zona De Luca lo hanno sempre votato in massa: il
vassallo delle preferenze, inscalfibile neanche dopo indagini e arresti.
“Demoliamo la Regione” – All’Ars entra per la prima volta con il Movimento per
l’Autonomia di Raffaele Lombardo. Poi passa con Grande Sud, la formazione
autonomista di Gianfranco Micciché. Quindi opta per la Democrazia cristiana di
Gianfranco Rotondi, fino al 2011, anno in cui cambia per sei volte gruppo
parlamentare: in quello del Pdl arriva a “sostare” per tre ore e mezza, giusto
il tempo di far saltare gli equilibri in una delicata conferenza dei capigruppo.
Qualche anno prima, invece, riesce a riunire 12 deputati di destra, sinistra e
centro e crea un bellicoso gruppo bipartisan che chiede di indire un referendum:
la carica di parlamentare con quella di sindaco- sostengono – devono essere
incompatibili. E peccato che in quel momento De Luca fosse nello stesso momento
sindaco di Fiumedinisi e deputato regionale. “Sono un battitore libero”, ripete
spesso di se stesso. Durante una delle lussuose kermesse del suo movimento,
invece, si è presentato sotto il simbolo di un enorme piccone e lo slogan:
“Demoliamo la Regione siciliana”. Non si capiva se fosse una promessa o una
minaccia. In ogni caso, per il momento, dovrà posticiparla.
Cateno De Luca annuncia querela contro Il
Fatto Quotidiano. In un articolo del giornale diretto
da Marco Travaglio, il candidato alle regionali è indicato come condannato a 5
anni per concussione ed abuso d'ufficio: "ciò è ovviamente falso, ennesimo
attacco alla mia onorabilità", spiega l'ex sindaco di Santa Teresa, scrive
"Letteraemme" l'8 ottobre, 2017. “Ho appreso con stupore dall’articolo apparso
sul giornale Il Fatto Quotidiano che io sarei stato condannato a 5 anni per
concussione ed abuso d’ufficio unitamente a mio fratello Tindaro, e ciò è
ovviamente falso, e rappresenta l’ennesimo attacco alla mia onorabilità ed al
mio modo di fare politica radicalmente contro il vecchio sistema e le solite
logiche politiche parassitarie e farabutte”. Lo afferma Cateno De Luca, leader
di Sicilia Vera e capolista nel collegio di Messina della lista Udc- Sicilia
Vera. “Preciso – aggiunge De Luca – che ho avuto 15 procedimenti penali di cui
14 già chiusi a mio favore con assoluzioni perché il fatto non sussiste ed
archiviazioni per al’ inconsistenza delle accuse. Per quanto riguarda l’ultimo
processo ancora pendente, è stata richiesta dal pubblico ministero la condanna a
cinque anni per tentata concussione (e non concussione) ed abuso d’ufficio, ed
ancora questo processo è pendente perché la procura generale della Suprema Corte
di Cassazione ha aperto un procedimento nei confronti di un componente del
collegio giudicante per presunta violazione dell’obbligo di astensione causando,
con molta probabilità, l’annullamento di tutte le attività dibattimentali (in
essere da oltre 6 anni) e l’avvio di un nuovo processo con un collegio diverso”.
“Solo per onore di verità – aggiunge De Luca – è corretta la notizia in merito
ad una condanna di circa 13 mila euro che ho avuto dalla corte dei conti per le
spese effettuate nella qualità di capogruppo al parlamento siciliano ma sono
stato assolto in sede penale a differenza della stragrande maggioranza dei
parlamentari siciliani ed ho già pagato queste 13 mila euro (altri parlamentari
non lo hanno ancora fatto) pur avendo fatto ricorso alla suprema corte di
cassazione per violazione di legge perché non è logica l’assoluzione in sede
penale e la condanna in sede contabile per la medesima fattispecie di reato”.
Sicilia, De Luca posta un video dai
domiciliari: “Parente di magistrati sapeva dell’arresto e mi aveva avvisato”,
scrive "Il Fatto Quotidiano". Un video sulla sua pagina Facebook, girato in
pigiama davanti a una libreria con i simboli di Sicilia vera. Lo ha pubblicato
il neodeputato Cateno De Luca, finito agli arresti domiciliari due giorni dopo
l’elezione per evasione fiscale. Nel video il politico racconta quelli che, a
suo parere, sono i retroscena della vicenda. De Luca ribadisce in parte quanto
scritto sempre su Facebook poche ore fa, ossia che già nei giorni scorsi era a
conoscenza del suo possibile arresto. “Sono sereno, già venerdì sera in
piazza Cairoli sono stato avvicinato da un noto personaggio della politica
siciliana, e anche ritengo della massoneria nonché parente molto stretto
di magistrati, il quale mi ha fatto i complimenti per la campagna elettorale e
mi ha detto: ‘lo sai che è tutto inutile quello che hai fatto’. Questo stesso
personaggio, il lunedì, ha telefonato a un nostro amico nonché suo collaboratore
e gli ha detto, che era inutile l’elezione di Cateno (parla di sé in terza
persona ndr) perché sarebbe stato arrestato e sarebbe subentrato il primo dei
non eletti Danilo Lo Giudice”. E poi prosegue, soffermandosi sull’accusa di
evasione fiscale. Per gli inquirenti, De Luca insieme agli altri indagati aveva
organizzato un sistema di false fatture. “La vicenda che riguarda il mio arresto
fa ridere vengo accusato di essere il regista di un’evasione fiscale di un ente
collettivo, il Caf Fenav, che non è mio. Originariamente questo era uno dei 15
procedimenti penali aperti a mio carico: per 14 sono stato assolto o archiviato.
Questo prevedeva peculato, appropriazione indebita e evasione fiscale”.
Messina, il Grande Oriente d’Italia
contro Accorinti e De Luca. Il gran maestro
dell'obbedienza massonica si scaglia contro le dichiarazioni del sindaco
("estrema debolezza di un politico che cianfrusaglia solo per darsi un tono") e
del deputato regionale finito ieri ai domiciliari. E avverte: "Attenti alla
pericolosità sociale delle dichiarazioni", scrive il 9 novembre, 2017
"Letteraemme". Nuova puntata dell’ormai quinquennale battaglia tra il sindaco di
Messina Renato Accorinti ed il Grande Oriente d’Italia, la più grande obbedienza
massonica dello stivale. Oggetto delle rimostranze del gran maestro Stefano
Bisi, un’altra volta, sono le dichiarazioni di Accorinti dopo le regionali, in
cui paventava scenari di influenza massonica. “A Messina a quanto pare va sempre
più di moda attaccare la massoneria per deresponsabilizzarsi da politiche
fallimentari e da gravi situazioni giudiziarie personali – attacca Bisi – Il
sindaco di Messina, non nuovo a dichiarazioni generiche e stucchevoli sulla
Libera Muratoria, la vede ad ogni angolo della città – che non è più il gioiello
di un tempo e mostra evidenti crepe che tutti i cittadini possono constatare –
anzi probabilmente la sogna pure di notte e la utilizza forse per allontanare da
se’ tutte le problematiche non risolte dalla sua amministrazione. Le recenti sue
comparse post elezioni regionali – continua il gran maestro del Goi – sono, a
nostro avviso, solo il segno di estrema debolezza di un politico che
cianfrusaglia di Massoneria solo per darsi un tono e sparare nel mucchio. Non è
sparandola grossa e addossando le colpe a un’Istituzione antica e ricca di
valori e principi per l’elevazione dell’Uomo e dell’Umanità che si fa il bene
della collettività. Il primo cittadino dovrebbe stare anche molto attento alla
pericolosità sociale di certe sue dichiarazioni che possono scatenare gesti
inconsulti – avverte ancora Bisi – Appena qualche giorno fa a Roma, a Palazzo
Giustiniani, abbiamo ricordato la figura di Achille Ballori, Sovrano Gran
Commendatore del Rito Scozzese Antico Ed Accettato e futuro Gran Maestro, il
quale venne ucciso a colpi di pistola nel 1917 da un folle che credeva che tutti
i suoi mali provenissero dalla massoneria. Credo che ciò dovrebbe fare
riflettere il sindaco sulla pesantezza di certe parole”. Non è solo Renato
Accorinti il destinatario degli strali del numero uno dei grembiulini italiani:
c’è anche Cateno De Luca, che dopo l’arresto di ieri, dai domiciliari di
Fiumedinisi ha diffuso un video in cui sosteneva di aver ricevuto “avvertimento”
sull’arresto imminente da un importante esponente della politica e della
massoneria isolana. “Ci hanno lasciati esterrefatti le dichiarazioni affidate a
un videomessaggio del deputato messinese neoeletto all’Ars e finito a urne
chiuse al centro di un’inchiesta giudiziaria che ha fatto scattare nei suoi
confronti la detenzione ai domiciliari – dichiara Bisi – Anche quest’ultimo,
genericamente, ha utilizzato il termine “massoneria” e fatto riferimento a un
“noto personaggio della politica siciliana, probabilmente facente parte della
massoneria” che lo avrebbe preavvertito di quanto gli sarebbe accaduto dopo
l’elezione. Affermazioni proseguite con il solito ritornello dei poteri forti –
massoneria ovviamente in testa – che non avrebbero gradito la sua eventuale
candidatura a sindaco di Messina. Dichiarazioni roboanti da indirizzare
all’opinione pubblica e rese da un soggetto privato della libertà – affonda il
gran maestro – Noi auguriamo a questo politico di dimostrare la sua estraneità
ai fatti contestatigli ma lo Invitiamo a non lasciarsi andare a manifestazioni
di pensiero arbitrarie se non supportate da fatti che andrebbero comunque
denunciati agli organi competenti. Voglio rivolgermi ai cittadini messinesi –
conclude Stefano Bisi – per ribadire che la libera muratoria del Grande Oriente
d’Italia non si occupa di politica e non vuole essere strumentalizzata in
vicende che non la riguardano. Siamo tolleranti per principio ma adesso basta
col parlare a sproposito di massoneria”.
Potere, affari, massoneria. Viaggio
nell'immutabile Messina, scrive Salvo
Toscano Mercoledì 4 Ottobre 2017 su "Live Sicilia”. Raccontano che quando
l'ingegnere palermitano Antonio Zanca realizzò il celebre Palazzo che porta il
suo nome e ospita il municipio di Messina, incontrò grosse difficoltà a farsi
pagare. E questo malgrado le ripetute rassicurazioni. Fu così che l'estroso
progettista decise di abbellire la facciata con i pesci dalla bocca larga, che
sullo Stretto si chiamano “buddaci”, raccontando con quella trovata una
caratteristica della città dove non sempre i fatti seguono alle parole. Basti
pensare, per farsene un'idea, alla chimera del Ponte. Il nostro giro della
Sicilia sulle tracce del potere comincia lì dove comincia l'Isola. A Messina,
città archetipo di quell'immutabilità siciliana che resiste come una condanna
senza appello. Un luogo in cui, almeno apparentemente, ogni cosa resta o cerca
di restare com'è. Malgrado tutto. Uno scossone agli assetti parve assestarla
quattro anni fa la sorprendente elezione di Renato Accorinti. Il sindaco in
t-shirt e sandali scardinò alle urne i blocchi di potere che saldamente tenevano
in mano la città, proponendosi come antagonista dei poteri forti. Da allora, tra
gli alti e i bassi della sua sindacatura, i poteri forti però sembrano rimasti
ben saldi. Le cronache di questi giorni, con la sfida delle Regionali dietro
l'angolo, hanno riportato la città dello Stretto all'attenzione dei
giornali. Merito, se di merito si tratta, della candidatura di Luigi Genovese,
giovanissimo figlio di Francantonio, già sindaco, già parlamentare, già
segretario del Pd, socio della famiglia Franza nel grande business dei
traghetti, ma anche colosso della formazione professionale, dettaglio
quest'ultimo che gli è costato in primo grado una condanna a undici anni per una
serie di reati legati proprio ai “corsi d'oro”. Un processo che ha riservato
dispiaceri anche alla consorte di Genovese, alla sorella di lei e al marito di
quest'ultima, il deputato regionale uscente Franco Rinaldi. Tutti condannati,
condanna non definitiva è bene ricordare, a vario titolo. Ora tocca al giovane
Luigi, la cui segreteria politica in centro città in questi giorni è sempre
affollatissima, come affollata è stata la convention per il lancio della sua
candidatura in Forza Italia benedetta dal commissario Gianfranco Miccichè. Una
prova di forza per riaffermare un'esistenza in vita, dicono da queste parti.Dove
ci si attende un grande risultato dal rampollo della potente famiglia che già
prima del Luigi ventunenne ebbe un altro Luigi, il padre di Francantonio,
parlamentare e una punta di diamante come lo zio di Francantonio, Nino Gullotti,
sei volte ministro e signore delle tessere Dc. La famiglia è una cosa
importante, da queste parti più che altrove. In una città che non ha più
industrie da un pezzo, il potere si concentra in pochi, pochissimi luoghi, ed è
per l'appunto spesso un affare di famiglia. O di fratellanza, ma questa è
un'altra storia. Sì, perché oltre ai grandi centri di potere, che poi sono
quelli del business dei traghetti, dell'editoria e della sanità, e infine
dell'università, c'è poi sempre lo stesso fantasma, che si agita in tutti i
racconti, con un alone di leggenda. E cioè la massoneria, che qui a Messina ha
una lunghissima tradizione. Quanto contano ancora le logge? Nessuno sa dirlo con
certezza, ma tutti ne parlano. Di massoni illustri la storia di Messina è ricca.
Anche oggi qualcuno ha avuto i suoi momenti di gloria. Come Carlo Vermiglio,
avvocato e assessore regionale uscente ai Beni culturali, massone in sonno. In
giunta lo piazzarono gli alfaniani, per la precisione Nino Germanà, che in zona
Cesarini è tornato in Forza Italia a sostegno di Nello Musumeci, insieme a una
ricca compagnia di convertiti dell'ultima ora. Il suo comitato elettorale è
giusto di fronte a quello di Beppe Picciolo, uscente di Sicilia Futura. Tentano
di restare all'Ars come gli altri uscenti, da Giovanni Ardizzone, presidente
dell'Ars, a Santi Formica. Ma i riflettori in questa campagna sono tutti per
Genovese jr. Il figlio di “Franzantonio”, come da queste parti chiamano ancora
il padre, gode del sostegno di ben undici consiglieri comunali di Forza Italia.
Tra loro Emilia Barrile, presidente del consiglio comunale: “C'è un grande
consenso di persone che gli vogliono bene. Stiamo chiedendo il consenso per
Luigi, non per il figlio di Francantonio”, dice lei. I traghetti del socio
Pietro Franza, oggi meno forte di ieri dopo il salasso del Messina calcio, i
corsi di formazione e la politica di famiglia sono stati gli ingredienti del
potere di Genovese. Un forziere elettorale per la famiglia. Che adesso vuole
dimostrare che quel forziere non si è svuotato. La sfida è aperta con tutti i
candidati in corsa nelle diverse liste all'opera per contendersi i voti nei
quartieri popolari (e popolosi), come Giostra e Mangialupi. Le stanze del potere
stanno altrove. Un bel pezzo si concentra da sempre all'Università, luogo dalla
storia tormentata. Nelle stanze dei baroni si è tornato ad annusare l'odore
dello scandalo con l'inchiesta fiorentina che ha coinvolto i docenti di diritto
tributario e che ha lambito anche Messina. Poca cosa, certo, rispetto ai tempi
andati. L'ateneo messinese ha una lunga “tradizione” di scandali alle spalle,
dalla clamorosa parentopoli alle inchieste sugli esami truccati, con tanto
dell'ombra della 'ndrangheta, i cui rampolli hanno spesso frequentato le aule
dell'università messinese. Quella stessa università che diciannove anni fa fu
sconvolta dall'omicidio di Matteo Bottari, professore e genero dell'ex rettore
ucciso in un agguato rimasto impunito. Erano gli anni rimasti alla storia come
quelli del “verminaio” Messina. Oggi l'ateneo messinese è retto da Pietro
Navarra, che non era ancora nato quando lo zio Michele, boss di Corleone, fu
assassinato. La sua è tutt'altra storia, che lo ha portato a diventare il più
giovane Magnifico d'Italia con un brillante curriculum accademico. Navarra è
ritenuto vicino a Matteo Renzi e in queste elezioni l'ateneo è mobilitato a
sostegno della candidatura di Franco De Domenico, direttore generale
dell'Università, candidato del Pd. L'ateneo, in una città dall'economia
asfittica, rimane un baluardo di potere. Per il resto a Messina, al netto di
traghetti (dove accanto al gruppo Caronte dei Matacena e a Tourist della
famiglia Franza, ormai uniti, da qualche tempo si sono inseriti anche gli
aliscafi del gruppo Morace), editoria e sanità, resta poco o nulla. “La
provincia è ancora vivace, ci sono importanti realtà di manifatturiero
soprattutto sui Nebrodi, c'è Milazzo con le sue industrie. La città no –
racconta Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio -. Una quarantina di
anni fa in città ci fu lo spostamento del capitale dall'investimento alla
rendita”. Ne è seguita una decadenza che ha visto col tempo privare Messina
anche di altri fiori all'occhiello, dal Comando marittimo della Sicilia
all'Autorità portuale, con la città dello Stretto che finirà ora sotto l'orbita
di Gioia Tauro. Cosa resta in città? C'è la sanità, che qui come altrove
rappresenta anche un importante bacino elettorale. L'Asp è commissariata (come
la ex Provincia, oggi Città metropolitana), con al timone Gaetano Sirna. Accanto
a gruppi privati di un certo peso, spicca il Centro Neurolesi Bonino
Pulejo, struttura ad alta specializzazione che ha visto approdare ai
vertici Angelo Aliquò, già direttore della Seus. Ma il centro, che lega la sua
storia già nel nome a quello della famiglia della Gazzetta del Sud, ha come faro
indiscusso il professor Placido Bramanti, direttore scientifico con due pagine
di cariche nel curriculum, una delle figure di maggior rilievo della città. Di
poche settimane fa è la notizia di uno stanziamento ministeriale da 91 milioni
di euro in favore del centro messinese, una cifra che già da sola basta a
inquadrarne il peso negli equilibri di potere cittadini. E poi c'è appunto la
Gazzetta del Sud. Edita dalla Ses, in mano alla Fondazione Bonino Pulejo. Il
giornale-ponte, che ha unito la Sicilia e la Calabria conquistando lettori
soprattutto al di là dello Stretto. Ma anche il “giornale del Ponte” ai tempi
di Nino Calarco, quando in città c'era persino un centro informazioni
sull'infrastruttura che non vide mai la luce. Oggi al timone c'è il manager Lino
Morgante, protagonista dell'operazione che ha portato nell'orbita messinese il
Giornale di Sicilia, rilevato dalla famiglia Ardizzone. Un'operazione che
rafforza ulteriormente il peso della testata messinese, tradizionalmente
filo-governativa, che ha un altro punto di forza nella sua rotativa. Altra voce
dell'editoria cittadina è quella piccola ma agguerrita di Centonove, settimanale
lontano dal Palazzo, diretto da Enzo Basso. Che di recente ha fatto le pulci
all'affare Giornale di Sicilia con una succulenta inchiesta ricca di retroscena.
Qualcosa si muove, insomma, sullo Stretto. Ma gli attori restano sempre gli
stessi. Anche nell'era dell'anti-sistema Accorinti. La pensano così dalle parti
di Rifondazione comunista, che prima sostenne l'ascesa del sindaco pacifista,
salvo poi prenderne le distanze. “Per me non c'è stata assolutamente rottura col
passato – commenta Antonio Mazzeo, giornalista e attivista comunista -. Prova ne
sono il piano di riequilibrio del bilancio, che ha giovato ai grandi creditori
del Comune, o le operazioni immobiliari sempre con gli stessi personaggi. La
borghesia imprenditrice esce impunita dagli errori del passato”. Non sono
piaciute a sinistra ad esempio le sponsorizzazioni del gruppo Franza a eventi
organizzati dall'amministrazione, ma soprattutto il piano che nel nome
dell'ambientalismo si propone di spostare le cubature dalle colline alla zona
Sud, un'operazione che, secondo l'inchiesta “Beta” della Dda messinese avrebbe
solleticato gli appetiti anche di organizzazioni criminali interessate a
speculazioni edilizie. Già, la mafia. Che a Messina non ha una storia militare
ma piuttosto di infiltrazione negli affari. Con incroci pericolosi di Cosa
nostra palermitana, mafia catanese, il clan Santapaola in particolare, e
'ndranghetisti. Ma il tema in questi giorni di campagna elettorale latita,
proprio come quei latitanti eccellenti che da queste parti trovarono rifugio
negli anni d'oro di Cosa nostra. In una città dove il Palazzo di Giustizia è
stato per lunghi anni un luogo di ombre e veleni, in quella che veniva chiamata
“provincia babba”. Oggi la procura, che negli ultimi anni ha dato segnali di
vitalità, è passata nelle mani di un magistrato esperto come Maurizio De
Lucia, grande conoscitore del fenomeno mafioso con trascorsi alla Dna. Il suo
biglietto da visita la settimana scorsa con l'indagine che ha portato a un
maxi-sequestro ai Cuzzocrea, imprenditori della sanità, fratelli dell'ex rettore
dell'università messinese sulla base di accuse che la difesa degli indagati
respinge con forza. Questo il quadro di una città che si prepara a una raffica
di elezioni. Le Regionali alle porte, con un buon vento nelle vele di Nello
Musumeci, poi le Politiche e infine le amministrative. Dove Accorinti secondo
diversi osservatori potrebbe strappare un secondo mandato perché a pochi mesi
dal voto non si profila ancora un'alternativa. Sarà la volta buona per tentare
la strada del cambiamento o alla fine la maledizione dei “buddaci” di Zanca avrà
la meglio sull'immutabile città?
De Luca: "L'arresto? Lo sapevo. Vi offro
il caffè del galeotto", scrive Accursio Sabella l'8
novembre 2017 su "Live Sicilia". "Non mi vogliono come sindaco di Messina, un
parente di un magistrato sapeva del mio arresto". "Sapevo che mi avrebbero
arrestato, perché già certi ambienti mi avevano avvertito". Cateno De Luca parla
attraverso il suo profilo di Facebook e lo fa in calce a una foto che lo
immortala mentre sorseggia un caffè: "Il caffè del galeotto", scherza
rivolgendosi ai suoi elettori. "Oggi più di ieri - continua De Luca - vi dico
che anche questo procedimento finirà come gli altri quattordici: archiviati o
con sentenza di assoluzione. Nei prossimi giorni saprete il perché non vogliono
che io faccia il sindaco di Messina. Ringrazio i militari che stamattina alle
ore 7:25 hanno suonato alla mia porta per arrestarmi in quanto sono stati un
esempio di professionalità, gentilezza e riservatezza". E De Luca fa intendere
che l'arresto era ampiamente previsto: "Io - dice infatti - li aspettavo da
qualche giorno. Io sto bene, ora sono agli arresti domiciliari a Fiumedinisi e
penso solo a preservare mia moglie, i miei figli, la mia famiglia dall'ulteriore
calvario giudiziario che li attende". Poi un pensiero a chi ha votato per lui il
5 novembre, consentendogli di conquistare l'elezione a Sala d'Ercole: "Chiedo
scusa ai miei sostenitori ed elettori per ciò che subiranno nei prossimi giorni
- dice De Luca - Posso solo dirvi - prosegue - che i fatti contestati risalgono
al periodo 2007 - 2012 per i quali risulta pendente presso la commissione
tributaria regionale un procedimento: mi contestano che io avrei agevolato il
Caf Fenapi ad evadere il fisco e quindi non sarei io l'evasione ma il Caf Fenapi
di proprietà della Fenapi che ha oltre 300 mila soci". Insomma, De Luca non fa
fatica a definirsi un perseguitato: "Dedico questa ulteriore battaglia - scrive
infatti - ai perseguitati dell'ingiustizia che non hanno avuto la forza ed i
mezzi per ottenere giustizia. State sereni io non mollo. Preservate il nostro
meritatissimo ed onestissimo successo elettorale dagli attacchi dei medesimi
ambienti che già sapevano del mio arresto. Tale richiesta - prosegue - risale
al 10 gennaio 2017 ed il Gip per motivi a noi non troppo ignoti ha firmato
l'ordinanza di arresto il 3 novembre 2017". E il motivo, fa intendere De Luca,
sarebbe legato a questioni di natura politica. "Io - prosegue infatti - avevo
annunciato la mia candidatura a sindaco di Messina nel comizio del primo gennaio
2017 in Piazza Municipio a Santa Teresa di Riva. A dicembre 2016 avevamo
depositato l'ennesima denunzia nei confronti di una parte della magistratura di
Messina ed alcuni organi inquirenti che avevano commesso troppi "errori" nei
procedimenti penali aperti a carico di Cateno De Luca: ben 15 procedimenti
penali di cui già chiusi 14 con sentenze di assoluzione perché il fatto non
sussiste e varie archiviazioni per l'inconsistenza delle accuse. Pregate per me
- conclude - e per la mia famiglia e per gli altri indagati che nulla c'entrano
in questa storia". C'è spazio anche per una citazione evangelica: "'Beati i
perseguitati a causa della giustizia - dice - perché di essi è il regno dei
cieli'". Conclude poi con un appello agli elettori: "Condividete se potete il
presente post. Vi saluto offrendovi virtualmente il caffè del galeotto". "Sono
sereno, già venerdì sera in piazza Cairoli sono stato avvicinato da un noto
personaggio della politica siciliana, e anche ritengo della massoneria nonché
parente molto stretto di magistrati, il quale mi ha fatto i complimenti per la
campagna elettorale e mi ha detto: 'lo sai che è tutto inutile quello che hai
fatto. Questo stesso personaggio, il lunedì, ha telefonato a un nostro amico
nonché suo collaboratore e gli ha detto, che era inutile l'elezione di Cateno
perché sarebbe stato arrestato e sarebbe subentrato il primo dei non eletti
Danilo Lo Giudice". Così in un video su Fb, il deputato regionale appena eletto
Cateno De Luca, da stamani ai domiciliari con l'accusa di evasione fiscale.
“Riabilitiamo Messina” torna dopo
l’assoluzione di De Luca. Il fondatore, Antonio
Briguglio, aveva chiuso il gruppo Facebook mercoledi, dopo l'arresto del
deputato regionale, e lo ha riaperto oggi, dopo la sua assoluzione nel processo
per i fatti di Fiumedinisi. De Luca lo ha indicato come assessore designato
qualora diventasse sindaco, scrive il 10 novembre 2017 "Letteraemme". Da “Il
gruppo è stato archiviato” a “Antonio Briguglio ha annullato l’archiviazione del
gruppo”. Il suo creatore ha chiuso il gruppo Facebook Riabilitiamo
Messina mercoledì e lo ha riaperto venerdì: quarantotto ore di oblio, coincise
con la carcerazione ai domiciliari di Cateno De Luca come misura cautelare
nell’inchiesta per evasione fiscale nella galassia Fenapi di due giorni fa, e
l’assoluzione per due reati su tre (in uno è intervenuta la prescrizione) nel
processo su opere di urbanizzazione realizzate a Fiumedinisi. Il motivo del
ritorno lo ha spiegato lo stesso Briguglio, in un post in cui annuncia la
riapertura del gruppo che conta diecimila iscritti e si presenta come “un’ottica
apolitica per sensibilizzare le amministrazioni e i cittadini tutti alla cura ed
al senso civico nei confronti della nostra città, Messina!”. “Ho chiuso il
gruppo per qualche giorno per evitare che gente ignobile, gretta e meschina
potesse macellare una persona e una famiglia”. Non lo nomina direttamente, ma il
riferimento è a Cateno De Luca. Perchè Antonio Briguglio da De Luca è stato
indicato come assessore designato della sua giunta qualora riuscisse a diventare
sindaco di Messina, il prossimo giugno. Briguglio è stato presentato alla platea
lo scorso 21 ottobre quando, sul palco con lui De Luca c’era anche Carlo
Taormina, il legale che ha difeso l’ex sindaco di Fiumedinisi dalle accuse nel
processo, facendolo assolvere. “Da buon cristiano penso che solo Dio può
giudicare sulle nostre scelte, dispiace che molta gente aspetta gli errori di
altri per distruggerne la dignità – continua Briguglio nel post in cui annuncia
la riapertura – Facebook, come alcuni giornali e giornalisti politicizzati sono
il cancro della nostra società. Riapro Riabilitiamo Messina con l’augurio che
non diventi più una macelleria social, che nessuno si permetta più di inveire
contro le disgrazie altrui in questo gruppo”, ha concluso Briguglio.
Felice Cavallaro per il Corriere della Sera del 10
novembre 2017. Ribalta l'accusa Cateno De Luca, il deputato regionale di Messina
eletto a arrestato a tempo di record. Ma lo fa nel primo processo sul quale
pende la richiesta di condanna a 5 anni. Non nell' ultima inchiesta per evasione
fiscale. Ribalta il sospetto di avere pilotato appalti nel suo paesino,
Fiumedinisi. Sostenendo di essere vittima di una estorsione. Questa la verità
del vulcanico leader del partitino fatto in casa, «Sicilia Vera». Tesi declamata
ai giudici che emetteranno il verdetto oggi e ai quali si è presentato da
detenuto perché ai «domiciliari» per l'altro procedimento, il quattordicesimo,
legato ai pasticci della Fenami, una federazione di imprenditori costruita a sua
misura, seppur benedetta lo scorso aprile dal «cappellano di Sua Santità e
direttore Ufficio per la Pastorale universitaria», monsignor Lorenzo Leuzzi,
chiamato a parlare di «etica del lavoro». È loquace su Facebook, certo di non
commettere reato, nonostante la detenzione e i consigli dei legali. E lascia
trapelare cosa accadrà domani, quando il gip che lo ha fatto arrestare lo
interrogherà, come ha fatto sapere ai fedelissimi: «Sapevo della cattura e
rivelerò il nome di chi me l'ha detto, il parente di un magistrato». L' attesa
del possibile annuncio già inquieta Messina dove De Luca indossa i panni della
vittima di un presunto complotto descritto come una faida interna al
centrodestra. Un riferimento emerso fra le pieghe del processo di ieri quando i
carabinieri l'hanno scortato da casa al tribunale. Il «sacco» di Fiumedinisi
apparirebbe così legato al clamoroso spogliarello inscenato a Palazzo dei
Normanni contro l'allora governatore Raffaele Lombardo e contro Gianfranco
Miccichè quando lui era alla guida di un consorzio per la metanizzazione dei
paesini della costa ionica. «Volevano un altro». Per scalzarlo i suoi avversari
avrebbero fatto scattare «una manovra politica e giudiziaria». Cauto il suo
avvocato, Carlo Taormina, su una tesi che oggi potrebbe essere negata dal
verdetto. Ma è difficoltoso placare l'esuberanza di questo imputato eccellente
che deborda via Internet, sorprendendo il procuratore della Repubblica Maurizio
De Lucia, convinto che «non dovrebbe essere possibile», ma che forse occorrono
prescrizioni esplicite per una materia nuova. E, incurante, l'imputato irrompe
sui social piazzando video e foto di un centinaio di simpatizzanti che lo
incoraggiano a non mollare e cita Martin Luther King: «Un giorno la paura bussò
alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno». C' è anche la foto
dei genitori caricata lunedì con didascalia: «Mamma e papà mi hanno detto di
stare sereno». E le foto in chiesa, lui di spalle, la Madonna in primo piano:
«Maria Santissima Annunziata proteggici Tu». Ma è sua madre che lo accarezza:
«Mi ha visto sciupato e mi ha sbucciato le castagne». Diverso il tono di
domenica mattina con gli avversari che cercavano di fare votare altri: «A calci
in culo i lacchè davanti ai seggi! Abbiamo fatto intervenire la polizia». Ignaro
degli sviluppi. Ancorato ad un accostamento per tanti sacrilego perché il giorno
prima delle elezioni «postava» una foto di Falcone e Borsellino con una
citazione di quest' ultimo: «Il cambiamento si fa dentro la cabina
elettorale...».
Cateno De Luca assolto 15 volte, ma resta
dentro, scrive il 10 novembre 2017 l'Adnkronos e il
Dubbio. Il neo deputato Udc arrestato per una presunta evasione fiscale da 1,7
milioni di euro. Ora aspetta il 16esimo processo: «Anche stavolta dimostrerò la
mia innocenza». Cateno De Luca, il neo deputato Udc arrestato due giorni fa per
una evasione fiscale da 1,7 milioni di euro è stato assolto poco fa dal
Tribunale di Messina dall’accusa di tentata concussione e falso in atto
pubblico. I reati contestati, per cui il parlamentare finì anche in cella, sono
relativi a un periodo compreso tra il 2004 e il 2010, quando De Luca era sindaco
di Fiumedinisi. Secondo l’inchiesta della Procura messinese, l’ex sindaco
avrebbe stravolto il programma per favorire imprese edilizie della sua famiglia.
Cateno De Luca è stato assolto perché il fatto non sussiste. Alla lettura della
sentenza hanno assistito decine di persone, alcune delle quali al momento
dell’assoluzione hanno a lungo applaudito. Il procedimento per cui era sotto
processo De Luca cominciò per presunti reati commessi tra il 2004 e il 2010
all’interno di un programma di opere di riqualificazione urbanistica e
incentivazione dell’occupazione a Fiumedinisi (Me), Comune di cui era sindaco.
De Luca venne arrestato nel giugno 2011. Intanto si terrà domani mattina
l’interrogatorio di De Luca per l’arresto per evasione fiscale. Sospiro di
sollievo per De Luca: “Ringrazio il collegio che ha avuto il coraggio,
nonostante le pressioni, di assolvermi sulla maggior parte dei casi. Su alcuni è
stata sollevata la prescrizione e questo mi dispiace molto. Devo decidere cosa
fare perché non escludo di rinunciare alla prescrizione di alcuni capi
d’imputazione e di andare avanti fino in fondo facendo appello”. “In questi
sette anni – aggiunge – ho subito 15 procedimenti penali e sono stato assolto
sempre. Tante accuse sono state archiviate per l’inconsistenza delle stesse e io
voglio giustizia ed essere assolto”.
Cateno De Luca: "Ferite che rimarranno,
non cerco vendetta ma giustizia". Visibilmente
provato, Cateno De Luca dopo la sentenza che lo ha visto assolto ha affidato il
suo sfogo ancora una volta a un video messaggio su Facebook, scrive Venerdì 10
Novembre 2017 "Tempo stretto". "In questi sette anni ho subito quindici
procedimenti penali, sono stato assolto sempre. Molte accuse sono state
archiviate per l'inconsistenza, per altre è stata chiesta la prescrizione ma
adesso voglio valutare se rinunciare. Io desidero la giustizia giusta e voglio
essere assolto. Non accetto di essere indicato dagli improvvisati grillini come
impresentabile, di essere tacciato da quell'ignorante di Salvini che è venuto
anche ai nostri convegni della Fenapi e voleva lui che io entrassi nella Lega.
Sfido tutti al confronto sulla buona politica, se sono all'altezza. Io non sono
un politico, sono un amministratore, voglio che ci sia giustizia. Oggi è un
giorno importante per me, per la mia famiglia e per chi ha creduto in me.
Andiamo avanti, sono ancora in uno stato di detenzione ma mi difenderò anche da
questa ignobile accusa. Mi auguro che la politica prevalga sull'infamia della
calunnia e soprattutto che chi fa politica si misuri e si confronti sui temi
politici e la smetta di appioppare patenti di moralità soltanto per nascondere
la propria imbecillità politica".
Cateno De Luca dopo l’assoluzione: «Sono
più forte, le lobby non mi fermeranno», scrive
"Normanno" l'11 novembre 2017. Dopo essere stato assolto da tutti i capiti di
imputazione di cui era accusato per il processo conosciuto come “Sacco
Fiumedinisi”, il collegio di difesa di Cateno De Luca composto dal prof. Carlo
Taormina e dall’avvocato Tommaso Micalizzi, scrive una lettera in cui parla di
una vera e propria persecuzione ai danni del neo deputato all’ARS. “La sentenza
di oggi mette fine ad un’odissea giudiziaria che aveva come unico obiettivo
quello di mettere fuori gioco dalla politica l’on. Cateno De Luca. Chi pensava
di raggiungere tale scopo, gettando discredito sull’operato di De Luca e
avanzando pseudo ipotesi delittuose – spiega il collegio di difesa – si dovrà
ora ricredere. Sono quindici i processi nei quali ha ottenuto un’assoluzione o
un’archiviazione ed è ormai chiaro a tutti che si è trattata di una persecuzione
per fermare un personaggio scomodo, non controllabile, e che non scende a
compromessi. Tuttavia, questi anni di processi sono serviti ad alcuni
detrattori come alibi per alimentare voci in modo tendenzioso e per fomentare
odio nei confronti dell’ex sindaco di Fiumedinisi, descritto come un mostro
senza cuore e senza valori. Riteniamo che questi anni abbiano costretto l’on De
Luca a rallentare il suo percorso politico danneggiandolo oltremodo, ma queste
accuse infondate, non sono riuscite ad intaccare la dignità, la serietà e la
forza di De Luca che ha lottato in prima linea per far emergere la verità.
Riteniamo che anche quest’ultima vicenda relativa all’arresto di qualche giorno
fa per evasione fiscale, avvenuta con una tempistica alquanto inusuale, abbia
contorni poco chiari che cercheremo di evidenziare, dimostrando anche in questo
caso la totale estraneità di De Luca ai fatti contestati. Sembrerebbe, da una
prima analisi dei fatti, che ci siano regie occulte e sempre pronte ad agire
anche in questo caso solo con lo scopo di danneggiare l’uomo politico nei
momenti cruciali. Uno stato di diritto prevede che sia la giustizia a decidere
su queste vicende, ma sin da ora annunciamo che non permetteremo altre
speculazioni sulla questione”. Cateno De Luca, che si trova ai domiciliari, ha
autorizzato i suoi legali a diffondere queste sue dichiarazioni: «I
giustizialisti a tempo, gli ipocriti a comando, gli avvoltoi sempre vicini alla
stanza dei bottoni e i leoni da tastiera saranno rimasti delusi anche da questa
sentenza, la quindicesima a mio favore. Speravano fossi condannato per poter
gridare allo scandalo, ma ora non avranno nemmeno la decenza di chiedere scusa
per le tante nefandezze scritte o dette. Io ho sempre agito per il bene comune,
non ho mai pensato di sopraffare nessuno, e volevo solo realizzare delle opere
pubbliche utili per il mio territorio. Da parte mia c’è sempre e solo stato il
desiderio di servire la mia comunità e di agire per lo sviluppo della mia
terra. Penso che i giudici abbiano compreso le mie vere intenzioni, ed io ho
sempre avuto fiducia nella magistratura. Ritengo che questo processo, insieme
agli altri nei quali sono stato assolto, siano un esempio per tutti i
perseguitati dell’ingiustizia. Bisogna sempre credere che la verità trionferà.
E’ stato un periodo difficile per me, per la mia famiglia e per tutti i miei
familiari e sostenitori, ma è stata una prova che mi ha ritemprato rendendomi
più forte e determinato nella mia lotta contro la cattiva politica, i ladroni
autorizzati, gli scansafatiche senza meriti e gli improvvisati da strapazzo. Le
lobby e le consorterie non mi fermeranno, come non ci sono riuscite fino ad ora.
Sono ottimista anche relativamente a quest’ultima azione giudiziaria avvenuta
nei miei confronti, e sono certo che presto tornerò libero e dimostrerò la mia
innocenza. Durante questa azione mediatico giudiziaria che mi ha messo al centro
dell’attenzione nazionale, ho sentito delle incredibili dichiarazioni false e
molto lesive della mia onorabilità e ho dato già mandato ai miei legali di agire
di conseguenza querelando chi le ha proferite. Non permetterò che i burattini
del teatrino della politica gettino ulteriormente fango su di me, solo per mere
opportunità politiche. Mi fa sorridere vedere alcuni personaggi venuti dal Nord
che si sono sempre dimenticati del Mezzogiorno, ergersi ora a paladini del Sud e
a difensori dell’etica. Prima di parlare di me pensino al loro partito più volte
al centro di scandali vergognosi. Così, come non permetterò a qualche trombato
dell’ultima ora di sfogare il suo piccolo ego lanciando anatemi contro di me,
solo per trovare una giustificazione al motivo per il quale gli elettori hanno
pensato bene di non dargli più fiducia dopo che la sua azione politica è stato
un fallimento. Sono pronto a sfidare tutti in dibattiti pubblici dove dimostrerò
la pochezza delle loro idee e l’assenza della loro moralità che vanno
sbandierando ai quattro venti. Tornerò in parlamento portando sempre avanti le
mie battaglie contro gli sprechi, contro la corruzione e contro chi ha ridotto
la Sicilia in un letamaio. La gente è con me e mi chiede di andare avanti e io
non mi fermerò».
Carlo Taormina (legale di De Luca) ai
giornalisti: «Poi non vi lamentate delle testate»,
scrive l'11/11/2017 "La Sicilia”. La frase del difensore del deputato regionale
arrestato per evasione fiscale. L'Ordine dei giornalisti di Sicilia: «Frase
infelice e fuori luogo». E’ polemica a Messina per alcune frasi dette ai
cronisti dall’avvocato Carlo Taormina dopo l'interrogatorio di garanzia di
Cateno De Luca oggi al tribunale di Messina. Taormina prima di andarsene,
rispondendo alle domande dei cronisti sull'operato della Procura nei confronti
di De Luca, ha infatti detto: «Giudicate voi se è normale il comportamento della
Procura nei confronti di De Luca, valutate voi se è da paese civile. Poi vi
lamentate se vi danno le testate. Cercate di operare nell’interesse dei
cittadini». «Una frase infelice e fuori luogo quella dell’avvocato Taormina, -
replica il presidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia Giulio Francese -
che non si capisce perché tiri in ballo l’episodio della testata inferta a un
giornalista a Ostia. Bisognerebbe avere più rispetto per i cronisti e non
alimentare con certe dichiarazioni un clima d’odio che poi rischia di degenerare
in episodi violenti come è successo a Ostia. Per tornare a un clima più sereno
ognuno deve fare il proprio lavoro nel rispetto di tutti. Basta allusioni e
accuse gratuite».
Morta l'antimafia se ne fa
un'altra. Arrivano i santissimi sputtanatori,
scrive Giuseppe Sottile Giovedì 9 Novembre 2017 su "Live Sicilia". Il
mascariamento non finisce mai. Lo dimostra la campagna d'odio sugli
"impresentabili", targata M5S. (Dal Foglio). Diciamolo pure con un certo
sconforto, ma diciamolo: l'antimafia, quella che un tempo spaccava le ossa e
garantiva trionfi e carriere, non tira più. E per averne conferma basta guardare
tra le pieghe delle elezioni siciliane. Rosario Crocetta, che cinque anni fa era
diventato governatore grazie alle sue furbesche intemerate contro gli invisibili
spettri di criminalità e malaffare, è finito nella polvere con tutto
l'armamentario delle imposture spacciate come verità nel teatrino di Massimo
Giletti. Leoluca Orlando, altro campione dell'antimafia chiodata, ha tentano il
salto dal comune di Palermo alla Regione, ma le sue liste non hanno superato la
soglia di sbarramento e sono miseramente naufragate, come quelle di Angelino
Alfano, nel grande mare dell'irrilevanza. Stesso destino per Claudio Fava, che
pure è testimone di un impegno serio e rispettabile: la sua fatica con quel che
resta della sinistra non è andata oltre il 6 per cento dei voti e ha conquistato
appena un seggio a Sala d'Ercole. La disfatta, com'era prevedibile, ha travolto
anche le comparse del vecchio cinema antimafia, con tutti i loro attrezzi di
scena. Valeria Grasso – un'improbabile eroina del cerchio magico di Crocetta,
elevata dal ministero dell'Interno al ruolo di testimone di giustizia – ha
creduto che fosse finalmente arrivato il momento di salire sul palcoscenico
elettorale per riscuotere gli applausi. E per meglio commuovere gli spettatori
ha raccontato la storiellina, ovviamente “misteriosa e inquietante”, di un furto
in casa. Un furto “strano”, va da sé. Un'esperienza “traumatica e brutale”,
naturalmente, proprio perchè i ladri si sarebbero limitati, guarda un po', a
rubare la foto di Valeria ritratta con i figli. E nulla più. La storiellina,
finita sui giornali a pochi giorni dal voto, avrebbe dovuto quantomeno suscitare
consensi e solidarietà, trepidi abbracci e infiocchettati attestati di stima. Ma
le masse, chiamiamole ancora così, non hanno risposto all'appello e Valeria
Grasso ha raccolto nelle urne appena 501 voti. Gli elettori hanno mostrato verso
la sua antimafia la più assoluta e sincera indifferenza. Si è schiantato contro
un muro di gomma anche la sublime architettura messa in piedi per condizionare
il voto dalla cosiddetta Confraternita della Trattativa, una sorta di setta
conventicolare secondo la quale nessun magistrato, tranne Nino Di Matteo,
riuscirà mai a scoprire le trame oscure e i mandanti occulti che lo Stato-mafia
(col trattino piccolo piccolo) puntualmente nasconde tra le pieghe di ogni
processo. La Confraternita, alla quale aderiscono santoni e tromboni con tutte
le stimmate delle loro immacolate esistenze, ha tentato il colpo grosso. Da
cinque mesi vagavano – tra le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta – i
mille e mille discorsi fatti durante l'ora d'aria da Giuseppe Graviano, un boss
stragista rinchiuso da 23 anni nel carcere duro di Ascoli Piceno. Graviano, che
pure aveva sgamato di avere tutto intorno le cimici sistemate dagli agenti lungo
il cortile per intercettare le sue parole, parla a ruota libera e, con la
tecnica mafiosissima del dire e del non dire, lascia andare alcune frasi
smozzicate che comunque tirano in ballo il bersaglio di sempre: Silvio
Berlusconi. Una manna dal cielo per la Confraternita della Trattativa, e per i
pochi cronisti che ancora si ostinano a seguire il processo in Corte d'Assise
che si celebra nell'aula bunker dell'Ucciardone. E anche se il boss, chiamato
dalla Corte a testimoniare, spegne subito gli entusiasmi, avvalendosi della
facoltà di non rispondere, la Confraternita che affianca dall'esterno Di Matteo
(candidato da Grillo a diventare il ministro di legge e ordine in un futuro
governo a cinque stelle) non si arrende e spara il colpo di riserva: l'annuncio
che Berlusconi, con Graviano, è stato iscritto a Firenze nel registro degli
indagati. La notizia, anche se vecchia e usurata, doveva restare segreta. Ma la
Confraternita ha i suoi incappucciati sparsi un po' in tutti i sottoscala delle
procure. E la notizia è stata opportunamente veicolata, si dice così, sui due
principali quotidiani: Repubblica e Corriere della Sera. Teoricamente, avrebbe
dovuto fare sfracelli. Ma le elezioni siciliane hanno ratificato anche il
fallimento di quella particolare specie di antimafia che, giocando di sponda con
i magistrati politicamente più sensibili e più disponibili, si è trasformata da
tempo in una autonoma forza sbirresca. L'elettorato, messo di fronte
all'ennesima scempiaggine, non ha abboccato. La criminalizzazione di Berlusconi
non ha funzionato. Anzi, a giudicare di come sono andate le cose, c'è da pensare
che la manovra degli incappucciati abbia portato al centrodestra più consensi
che dissensi, più simpatie che antipatie. Ciò non significa tuttavia che il
tracollo dei professionisti dell'antimafia abbia restituito alla politica,
soprattutto a quella siciliana, la cultura della libertà e dello stato di
diritto. No. Perché morta un'antimafia se ne fa un'altra. E per rendersene conto
basta guardare alla scomposta – forsennata, si stava per dire – campagna
condotta dal Movimento cinque stelle contro i cosiddetti “impresentabili”: una
categoria molto vaga di impuri sui quali si sono scatenati in quest'ultimo mese
i puri e duri di Beppe Grillo. Giancarlo Cancelleri, che nella corsa alla
presidenza della Regione ha raccolto oltre il 34 per cento dei voti, non ha
accettato la vittoria di Nello Musumeci e ha platealmente respinto l'invito a
stringergli la mano: “La sua elezione si deve agli impresentabili di cui erano
piene le liste di centrodestra”, ha sentenziato. E mascariando e sputtanando, ha
cominciato a criminalizzare non solo il figlio di Francantonio Genovese, che fu
ras a Messina prima del Pd e poi di Forza Italia e che ha sulle spalle un
condanna in primo grado a 11 anni di carcere per avere abbondantemente lucrato
sui corsi di formazione della Regione; ma anche i candidati che malauguratamente
si ritrovano un indagato tra gli ascendenti o i discendenti, tra i nonni o gli
zii, tra i parenti vicini o i parenti lontani. Certo, uno scheletro negli armadi
può capitare a chiunque: ieri, a ventiquattr'ore dall'elezione, è finito agli
arresti domiciliari per evasione fiscale Cateno De Luca, un guitto della
politica reclutato dall'Udc di Lorenzo Cesa ma la scuola grillina pretende che
l'impresentabile appartenga sempre e comunque alla sponda opposta. Perché se
finisce sotto indagine un esponente del Movimento, come è successo al sindaco di
Bagheria o ai deputati rinviati a giudizio per le firme false, la macchia
giudiziaria diventa un semplice incidente di percorso al quale ovviare, se
proprio se ne avverte il bisogno, con una semplice autosospensione. La questione
degli impresentabili è diventata dunque non solo la nuova bandiera di moralisti
e moralizzatori. Ma anche e soprattutto il nuovo strumento di lotta politica che
il M5s impugna o per delegittimare l'avversario, esattamente come avveniva con
l'antimafia, o per sfuggire al dibattito in particolar modo quando il dibattito
pone la necessità di approntare risposte concrete a domande che non si possono
più eludere o rinviare. Sarà pure un caso, ma la scatola con dentro il giochino
dell'impresentabilità è stata regalata ai grillini proprio dalla Commissione
parlamentare antimafia che, non avendo più alte indagini da fare per mantenersi
a galla, promette a ogni vigilia elettorale di rivelare urbi et orbi chi sono
gli impresentabili veri o presunti nascosti dentro le liste. Poi puntualmente
non ci riesce e l'operetta immorale diventa automaticamente patrimonio esclusivo
di chiunque voglia fare politica con gli insulti, di chiunque pensi di
annientare il nemico con uno sfregio e con una diffamazione, di chiunque voglia
tenere ancora viva in questo paese la devastante cultura del sospetto. “Il
sospetto è l'anticamera della verità”, teorizzava trenta e passa anni fa Leoluca
Orlando, ancora sindaco di Palermo, quando spadroneggiava tra i circoli
antimafia con una arroganza che lo spingeva a insultare un giudice come Giovanni
Falcone o uno scrittore come Leonardo Sciascia. Oggi la sua stella si è
appannata e la sua antimafia non brilla più. S'avanzano i nuovi odiatori: da
Cancelleri a Gigino Di Maio, da Alessandro Di Battista al poco conosciuto Angelo
Parisi che, appena designato da Cancelleri tra gli assessori dell'immaginario
governo grillino, si è guadagnato gli onori, si fa per dire, della cronaca
lanciando la nobile proposta di mandare al rogo Ettore Rosato, il capogruppo del
Pd colpevole di avere proposto la legge elettorale poi approvata dai due rami
del Parlamento. Ebbene, diciamolo pure con un pizzico di cinismo, ma diciamolo:
meglio che la Sicilia sia finita nelle mani dell'onesto Nello Musumeci, anche se
eletto con i voti di Cateno De Luca e di altri tre o quattro candidati
impresentabili, che non in quelle di Cancelleri e dei suoi professionisti del
rancore. Abbiamo visto i guai e le nefandezze dell'antimafia forcaiola, che Dio
ci liberi dai guai e dalle nefandezze dei santissimi sputtanatori.
Il caso De Luca e la categoria
pre-giuridica dell'“impresentabilità”. Appena eletto
all’Assemblea Regionale Siciliana il deputato dell'Udc è stato arrestato e posto
ai domiciliari. Ma la novità risiede nel riconoscimento preventivo e, de facto,
dell’indegnità di una persona, scrive Fabio Cammalleri l'8 Novembre 2017 su "Il
Foglio". Cateno De Luca, appena eletto per il centro-destra, con l’UDC,
all’Assemblea Regionale Siciliana, è stato sottoposto a custodia cautelare nel
domicilio, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina. A suo modo, è
vicenda di perfetta esemplarità. Chiarisce il nuovo statuto delle libertà
politiche e civili in Italia; e il valore fondativo della categoria che ne è
alla base: “impresentabilità”. Eletto con poco più di cinquemila voti, era stato
incluso nell’omonima “lista degli impresentabili”, sciorinata, nel corso della
campagna elettorale, dal candidato del M5S, Cancelleri. Ma il nuovo conio
integra ormai la “grammatica politica” comune. Poche le eccezioni. Lo stesso
Musumeci, a chi gli contestava, mediante le liste di coalizione, il sostegno di
“impresentabili” (come De Luca), ha risposto, semplicemente, che “gli
impresentabili” non hanno votato per lui. Ma il lessico obliquo non è stato
discusso. Si procede anche nei confronti di altre otto persone, per associazione
per delinquere ed evasione fiscale. De Luca avrebbe conseguito, attraverso la
sua società CAF ENAPI S.r.l., illegittimi “risparmi d’imposta per circa 1.750.00
Euro”. Dove si discuta di flussi finanziari, il sostrato probatorio è, per
definizione, documentale, ed è stato già acquisito. Anche per questa ragione, le
misure cautelari personali non sono molto frequenti per titoli di questa specie.
Nel giugno del 2011, lo stesso De Luca era stato ristretto per la prima volta:
allora finendo addirittura in carcere, accusato di tentata concussione e abuso
d’ufficio. La corte di Cassazione aveva ritenuto illegittima la misura
cautelare, perchè non c’erano esigenze cautelari. Per quella prima vicenda, alla
fine del dibattimento in primo grado, il PM ha chiesto al Tribunale una condanna
a cinque anni di reclusione. Per novembre è attesa la sentenza. De Luca, di
recente, aveva precisato di essere già stato sottoposto ad indagine o a processo
quindici volte. A parte il processo che si deciderà a novembre (e il sedicesimo,
di oggi), ricevendo finora quattordici, fra assoluzioni o archiviazioni. La
Procura ha osservato di non voler commentare in alcun modo: se non per far
rilevare che non si può parlare di arresto ad orologeria. Vediamo. Il punto è la
selezione delle classi dirigenti elettive, e il suo intersecarsi con una
valutazione, di estrazione ma non di competenza giudiziaria: che tende a
determinare l’esautoramento, quasi formale, dell’elezione stessa. Come? Con
l’introduzione di quella nuova categoria: “impresentabili”; indefinita, nebulosa
e, soprattutto pre-giuridica: tratta dal discorso comune e dalla sua allusività
morale. Il caso della “impresentabilità”, però, è diverso dalla ormai “classica”
anticipazione impropria del giudizio; quella, per intenderci, che, con “l’avviso
di garanzia”, “bruciava” l’accertamento definitivo di
non-colpevolezza/colpevolezza: ma il “contenuto giudiziario” non agiva sulle
libertà politiche (chi vota e chi è votato), se non indirettamente. Per trarre
“le conseguenze politiche”, come le potrebbe qualificare un Borrelli d’Antàn,
erano necessari atti ulteriori, di varia specie (dimissioni o rinunce, più o
meno spontanee, e, a rincalzo, connesse “sollecitazioni” del Servizio
Propaganda). Né si tratta di “incandidabilità” o di “decadenza”: che,
rispettivamente, incidono sull’elettorato passivo, prima del suo concretarsi o
dopo, ma derivando da una valutazione formale. No. Qui lo scopo (e la novità)
risiede nel riconoscimento preventivo e, de facto, dell’indegnità di una persona
che, secondo le leggi vigenti, gode ancora della sua libertà politica. Ma
venendo, al contempo, “istituzionalmente indotta”, per effetto di quella
aleggiante qualificazione, di estrazione ma non di competenza giudiziaria, alla
“opportunità” di rinunciarvi. Per questo, la faccenda della tempestività di un
provvedimento giudiziario, rispetto al piano politico-elettivo, oggi si pone in
termini inediti. Ad un’osservazione smagata, sembrerebbe che il “dispositivo”,
essendo abbastanza nuovo, debba ancora affermarsi: la mera “opportunità”,
rischiava perciò di essere inefficace. Occorreva provvederla di una più vivida
credibilità. Mutando “l’opportunità” in temibilità. Riguardato in questo modo
l’insieme, da un arresto maturato a 48 ore dalle elezioni, scocca allora una
tempestività, magari “riflessa”, ma certo di rimarchevole incisività. Non si
interviene sulla formazione del voto, durante la sua espressione; ma, “prima”
che si esprima, viene “indotto” nella comunità una sorta di orientamento
autorevole, e non ancora autoritario: vale a dire, che il voto possa esprimersi
solo su destinatari selezionati secondo certi criteri. Criteri, la cui posizione
dipende, esclusivamente, da due Autorità: ciascuna, in astratto, indipendente
dall’altra: Autorità Giudiziaria e Commissione Antimafia. Ma dal loro agire
combinato, che si compone di, rispettive, “mezze competenze” (l’autorità
giudiziaria non pronuncia dichiarazioni di voto, la commissione d’inchiesta non
si occupa di reati), finisce col prendere corpo una sorta di terza entità: “la
Commissione commissaria”. Se, rispetto al processo penale strettamente inteso,
nell’Anno XXV dell’Era Mani Pulite, si era già conclamato il “non esistono
presunti innocenti”, da oggi, per “trarre le conseguenze politiche”,
direttamente dai materiali giudiziari ancora in formazione, si è costruita
questa categoria nuova, “l’impresentabilità”: la “terra promessa” paranormativa
dei primi, timidi, auspici del dottor Borrelli. L’onorevole Bindi ha dichiarato:
“è un fatto gravissimo”. Ma non si riferiva all’accusa penale in sè: “così si
droga il risultato elettorale”, ha proseguito, (De Luca) era “segnalato dalla
Procura e dalla Prefettura”. Si riferiva alla concatenazione: l’avevamo detto, è
mancata l’obbedienza; e si deve sapere che “gravissimo” è il disobbedire al “si
induce”, non meno che al “si comanda”. Sicilia, insula feracissima.
Ardizzone: "Arresto De Luca non mi
sorprende. La mafia è tornata all'Ars". Per il
presidente uscente dell'Assemblea regionale siciliana, che non è stato rieletto,
i partiti avevano il dovere di dire no agli impresentabili e Musumeci deve avere
il coraggio di tenere la mafia fuori dal palazzo, scrive Mercoledì 8 Novembre
2017 "Tempo Stretto". "La notizia dell'arresto del primo deputato eletto non mi
meraviglia, purtroppo avevo chiesto, inutilmente, che i partiti verificassero
gli impresentabili, gente nota all'opinione pubblica che non risparmia nessun
partito. I partiti avevano questo dovere, ma i candidati presidenti dovevano
avere la forza e il coraggio di imporre ciò nella formazione delle liste". E'
quanto denuncia all'Adnkronos Giovanni Ardizzone, Presidente uscente
dell'Assemblea regionale siciliana, commentando l'arresto di Cateno De Luca. "In
questi anni, ho tenuto lontana dal palazzo la mafia, che c'è e resiste e,
purtroppo, è tornata. Perchè la corruzione è mafia. Mi auguro che Musumeci, che
ne ha le qualità, sappia resistere alle sollecitazioni che gli impresentabili
sicuramente gli faranno. Se, per necessità, Musumeci si è fatto carico in queste
elezioni del loro voto, una volta eletto, dovrà avere il coraggio, che non gli
manca, di tenerli fuori", ha aggiunto.
Sicilia, impresentabili e liste
specchiate: arrestato anche un grillino, scacco matto al giustizialismo a cinque
stelle. Con oggi ogni schieramento all’Ars ha il suo
impresentabile, segno che il terremoto giudiziario e politico che si sta
abbattendo in Sicilia non risparmia nessuno degli eletti e dei candidati a
Palazzo d’Orleans, scrive il 14 novembre 2017 Serena Guzzone su "Stetto Web".
“Il M5s mi chiede di scusarmi per la vicenda che ha coinvolto il neo deputato
Cateno De Luca? Loro farebbero bene a guardare all’interno delle loro
liste”. Così giorni fa Musumeci replicava alle accuse mosse dai Cinquestelle
dopo l’arresto del neo deputato De Luca e mai parole furono più vere, dal
momento che con oggi viene a galla che anche le liste del M5s in Sicilia non
erano poi così specchiate. Sale a tre il numero degli arresti “eccellenti” della
compagine politica siciliana e stavolta nel mirino ci è finito un grillino. La
macchina della giustizia non fa sconti, neanche nei confronti di chi, come i
pentastellati, hanno giocato tutta la campagna elettorale a colpi bassi,
ergendosi a paladini della legalità, additando gli impresentabili delle altre
liste. Stamane La Squadra mobile di Agrigento ha infatti tratto in arresto con
l’accusa di estorsione Fabrizio La Gaipa, imprenditore di 42 anni, primo dei non
eletti della lista M5s nella provincia di Agrigento alle elezioni regionali
siciliane. Con oggi ogni schieramento all’Ars ha il suo impresentabile, segno
che il terremoto giudiziario e politico che si sta abbattendo in Sicilia non
risparmia nessuno degli eletti e dei candidati a Palazzo d’Orleans. Con La
Gaipa sono quindi tre ad oggi gli impresentabili eletti o solo candidati all’Ars
tratti in arresto, ecco di chi si tratta:
Cateno De Luca, il leader di Sicilia Vera, ha
sostenuto la campagna elettorale del neo presidente della Regione Nello
Musumeci ed è stato arrestato a 48 ore dallo spoglio con la pesante accusa di
associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, per un totale
di circa un milione e 750mila euro di tasse evase. De Luca è stato rieletto dopo
cinque anni con 5.400 voti.
Grane con la giustizia anche per Edy Tamajo, neo
deputato di Sicilia futura indagato dai pm di Palermo per associazione a
delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Il “mister preferenze” di
Trapani è stato eletto nella coalizione di centro/sinistra e supportava la
candidatura a governatore di Micari: è accusato di associazione a delinquere
finalizzata alla corruzione elettorale. Il 41enne eletto all’Ars è il
candidato che appoggiava Fabrizio Micari, all’interno della lista dell’ex
ministro Cardinale. Ha totalizzato esattamente 13.984 preferenze, 8.038 delle
quali a Palermo. Secondo l’accusa avrebbe comprato i voti del 5 novembre in
Sicilia al prezzo di 25 euro a preferenza.
Il grillino La Gaipa sarebbe accusato da
dipendenti dello stesso imprenditore che gestisce un albergo ad Agrigento. Con
oltre quattromila voti il 5 novembre è stato il primo dei non eletti subito
dopo Matteo Mangiacavallo (14 mila voti) e Giovanni Di Caro (5.900 voti).
“Musumeci stamattina in un’intervista ha detto che
gli impresentabili sono un problema di tutti. Mente nuovamente!”
diceva Cancelleri qualche giorno fa, aggiungendo che “sono un suo problema,
visto che non solo li ha portati in Parlamento, ma uno glielo hanno pure già
arrestato. I condannati ce li ha lui nella sua maggioranza. Uno glielo hanno
arrestato e per gli altri è conto alla rovescia. A Musumeci dico che per porre
fine agli impresentabili non servono codicicchi etici che puntualmente poi non
rispettano, come quello scritto proprio da Musumeci quando era presidente della
commissione antimafia e che neanche lui ha rispettato. Sia serio, se riesce a
esserlo, e la finisca di mentire ai siciliani”.
Parlano gli avvocati Carlo Taormina e
Tommaso Micalizzi: "L'obiettivo era metterlo fuori dalla politica".
Cateno De Luca: "Contro di me le lobby, ma non mi arrendo",
scrive Venerdì 10 Novembre 2017 "Tempo Stretto". “La sentenza di oggi mette
fine ad un'odissea giudiziaria che aveva come unico obiettivo quello di mettere
fuori gioco dalla politica un uomo di talento e di grande spessore umano come
l'on. Cateno De Luca". A dirlo il collegio di difesa del neo deputato regionale
dell'Udc-Sicilia Vera composto dal professor Carlo Taormina e dall'avvocato
Tommaso Micalizzi, dopo la sentenza del tribunale di Messina che ha assolto De
Luca nel processo nato su una presunta speculazione edilizia a Fiumedinisi.
"Sono quindici i processi nei quali ha ottenuto un'assoluzione o
un'archiviazione, ed è chiaro che si è trattata di una persecuzione per fermare
un personaggio scomodo, non controllabile. Tuttavia, questi anni di processi
sono serviti ad alcuni detrattori come alibi per fomentare odio nei confronti
dell'ex sindaco di Fiumedinisi. Riteniamo che questi anni abbiano costretto l'on
De Luca a rallentare il suo percorso politico danneggiandolo oltremodo, ma non
sarà più permesso a nessuno di creare ad hoc altre infamie contro un
amministratore capace, onesto e sempre al servizio della comunità.
Anche l’ultima vicenda relativa all'arresto per evasione fiscale, avvenuta
con una tempistica alquanto inusuale abbia contorni poco chiari che cercheremo
di evidenziare, dimostrando anche in questo caso la totale estraneità ai fatti
contestati di De Luca. Sembrerebbe che ci siano regie occulte anche in questo
caso solo con lo scopo di danneggiare l'uomo politico nei momenti cruciali. Uno
stato di diritto prevede che sia la giustizia a decidere su queste vicende, ma
sin da ora annunciamo che non permetteremo altre speculazioni sulla questione".
Il neo deputato dell'Udc che si trova ai domiciliari, ha autorizzato i suoi
legali a diffondere queste sue dichiarazioni: "I giustizialisti a tempo, gli
ipocriti a comando, gli avvoltoi sempre vicini alla stanza dei bottoni e i leoni
da tastiera saranno rimasti delusi anche da questa sentenza, la quindicesima a
mio favore in cinque anni. Speravano fossi condannato per poter gridare allo
scandalo, ma ora non avranno nemmeno la decenza di chiedere scusa per le tante
nefandezze scritte o dette. Io ho sempre agito per il bene comune e volevo solo
realizzare delle opere pubbliche utili per il mio territorio. Da parte mia c'è
sempre e solo stato il desiderio di servire la mia comunità e di agire per lo
sviluppo della mia terra. Penso che i giudici abbiano compreso le mie vere
intenzioni, ed io ho sempre avuto fiducia nella magistratura. Ritengo che questo
processo, insieme agli altri nei quali stato assolto, rappresenti un esempio per
tutti i perseguitati dell'ingiustizia. E' stato un periodo difficile per me, per
la mia famiglia e per i miei sostenitori ma le lobby, le consorterie non mi
fermeranno, come non ci sono riuscite fino ad ora”. De Luca si è detto ottimista
anche relativamente alla nuova vicenda giudiziaria che domani lo vedrà
interrogato dal giudice e che definisce “arresto ad orologeria”. Annuncia
inoltre di aver dato mandato ai legali per agire nei confronti di quanti
“Durante questa azione mediatico giudiziaria che mi ha messo al centro
dell'attenzione nazionale, hanno fatto dichiarazioni false e molto lesive della
mia onorabilità. Non permetterò che i burattini del teatrino della politica
gettino ulteriormente fango su di me. Mi fa sorridere vedere alcuni personaggi
venuti dal Nord ergersi ora a paladini del Sud e a difensori dell'etica. Prima
di parlare di me pensino al loro partito più volte al centro di scandali
vergognosi. Così, come non permetterò a qualche trombato dell'ultima ora di
sfogare il suo piccolo ego lanciando anatemi contro di me, solo per trovare una
giustificazione al motivo per il quale gli elettori hanno pensato bene di non
dargli più fiducia dopo che la sua azione politica è stata un fallimento”.
Cateno De Luca conclude dicendosi pronto a “sfidare” chiunque in un dibattito
pubblico sui temi dell’isola e si dichiara pronto a tornare all’Ars per
continuare le sue battaglie contro gli sprechi avviate in questi anni.
Cateno De Luca dilaga su Facebook: e il
gip lo censura, scrive il 14/11/2017 "Il Giornale
D’Italia". Il deputato agli arresti domiciliari ha esultato “troppo” sul social
network per l’assoluzione da un precedente provvedimento. Troppo smodato nei
commenti. E la tagliola della magistratura si abbatte sul profilo Facebook
dell’imputato eccellente. Con la variante del social network, quindi, un nuovo
caso per far dividere gli italiani tra chi ritiene censurabile l’arroganza dei
politici, chi lo strapotere dei magistrati e chi, forse la maggioranza,
entrambi. Fatto sta che Cateno De Luca, ha esultato per l'assoluzione dal
processo per concussione, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, per il
cosiddetto "sacco di Fiumedinisi" (il Comune di cui era stato sindaco anni fa),
non è passata inosservata. La procura non ha gradito e il gip, accogliendo
l’istanza dei pm, ha inasprito la misura cautelare degli arresti domiciliari
disposta nei suoi confronti vietandogli ogni rapporto (anche telematico) con
l’esterno. ll gip deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di revoca della
misura cautelare dei domiciliari, che sabato scorso i legali di De Luca hanno
presentato. Intanto, però, un'altra tegola si è abbattuta sul deputato
siciliano. Pare che i suoi avvocati gli avessero consigliato cautela, evitando
di esporsi troppo. Ma De Luca non ha sentito ragioni e si è scatenato sui
social, rivolgendosi pure direttamente al presidente della Regione siciliana,
Nello Musumeci: "La smetta di inseguire l’antimafia di facciata - afferma, non
digerendo la presa di distanza del neo governatore - non invada anche lei il
campo della magistratura con codici etici. Non sono diventato improvvisamente
rognoso. Se lei oggi è presidente, lo deve anche al presentabile De Luca che a
luglio scorso, mentre nel centrodestra la stavano scaricando, io l’ho
pubblicamente sostenuta. Aspetto di confrontarmi con lei in parlamento sulle
questioni vere". De Luca ha già fatto il nome del suo assessore per la giunta
Musumeci: "Ho chiesto a Lorenzo Cesa di avanzare il nome del messinese Giuseppe
Lombardo". De Luca, come si ricorderà, si trova agli arresti domiciliari per
associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale: il provvedimento è
scattato poche ore dopo le elezioni regionali.
Accusato di evasione fiscale Sicilia,
revocati domiciliari per neo eletto Cateno De Luca,
scrive Rai news il 20 novembre 2017. Lui su Facebook: "Ora denuncio
tutti" Per il giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza ma si sarebbero
affievolite le esigenze cautelari Tweet Cateno De Luca assolto da falso e abuso
d'ufficio. Prescritta la tentata concussione Sicilia, bufera politica dopo
l'arresto di De Luca Evasione fiscale, arrestato neo deputato regione Sicilia De
Luca. Lui: verrò assolto o archivieranno 20 novembre 2017 Il gip di Messina ha
disposto la revoca degli arresti domiciliari per il neo deputato regionale
Cateno de Luca, accusato di evasione fiscale sostituendo la misura con quella
interdittiva del divieto di esercizio di posizioni apicali negli enti coinvolti
nell'inchiesta. Per il giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza di De
Luca ma si sarebbero affievolite le esigenze cautelari. La settimana scorsa,
dopo le continue esternazioni sui social del deputato il gip aveva disposto il
divieto di comunicazione con l'esterno. De luca su Facebook: e ora denuncio
tutti" "Libero !". Così sbotta su Facebook il neo deputato regionale Udc Cateno
De Luca, dopo la decisione del Gip di Messina di revocare gli arresti
domiciliari cui era sottoposto dal 7 novembre. Peraltro gli era stato interdetto
l'uso dei social dopo il suo massiccio utilizzo sin dall'applicazione della
misura cautelare. "E vaff... a tutte le forme di mafia compresa quella
giudiziaria. Stiamo - avverte - denunziano tutti!".
Cateno De Luca libero: “Adesso denuncio
tutti”, scrive il 20 novembre 2017 "Articolo tre".
"Sono un uomo libero. State tranquilli. Il gip ha revocato l'arresto, il
sequestro, ha sconfessato tutte le porcherie che noi abbiamo subito in questi
giorni". Così il neo deputato regionale Cateno De Luca, con un video pubblicato
sul suo profilo Facebook, annuncia la decisione di revoca degli arresti
domiciliari. Il Gip del Tribunale di Messina ha revocato i domiciliari per il
deputato Udc e Carmelo Satta, arrestati due settimane fa per associazione per
delinquere finalizzata all'evasione fiscale. Il gip ha applicato nei loro
confronti la misura interdittiva del divieto di esercizio di uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. In merito al sequestro, sono
stati liberati dal vincolo i beni personali degli indagati. In sostanza, il
Giudice ritiene che non sussistano ragioni cautelari tali da far permanere i due
in vinculis, poiché entrambi - allo stato - non ricoprono cariche sociali negli
enti Fenapi e i reati fine sono cristallizzati in atto, non vi è dunque pericolo
d'inquinamento probatorio. L'esigenza di applicare il divieto di esercizio degli
uffici direttivi nasce per "limitare la probabilità che possano ricostituire una
nuova associazione". "Ho bisogno di due tre giorni per completare le denunce che
stiamo presentando perché - afferma De Luca su FB - stiamo depositando tutto,
per falso in atti giudiziari, per infedele patrocinio, per calunnia. Ce n'è per
tutti. Ho bisogno di stare concentrato con i miei avvocati per un paio di
giorni, poi faremo una bella conferenza stampa e ricominciamo la nostra attività
politica". "Abbiamo un conto aperto - sottolinea - con alcuni personaggi nel
tribunale di Messina e noi non stiamo assolutamente col capo chino: denunciamo
qualunque tipo di mafia, anche quella giudiziaria. Andrò avanti con forza. Vi
ringrazio, siete stati grandiosi, non mi è mancato il vostro calore".
Messina: revocati i domiciliari a Cateno
De Luca, lui attacca i giudici su Fb. Per il deputato
resta il divieto a ricoprire ruoli apicali negli enti coinvolti nell'inchiesta
per evasione fiscale, scrive Manuela Modica il 20 novembre 2017 su "La
Repubblica". "Guardate che sono un uomo libero", annuncia così la revoca dei
domiciliari, su Facebook, Cateno De Luca, il deputato Udc arrestato lo scorso 8
novembre per evasione fiscale. Il gip Carmine De Rose ha accolto la richiesta di
revoca avanzata dal difensore di De Luca, Carlo Taormina, durante
l’interrogatorio di garanzia. Il gip ha però riconosciuto la fondatezza delle
accuse disponendo la misura interdittiva a ricoprire ruoli apicali negli enti
coinvolti nell'inchiesta per evasione fiscale. Le esigenze cautelari erano
venute meno da quando Carmelo Satta, arrestato anche lui nell'inchiesta, si era
dimesso dalla Fenapi, l'ente principale dell'inchiesta. E De Luca torna a
sfogarsi sul social network dopo che martedì, 14 novembre, il gip aveva
ristretto i limiti della misura cautelare dell’ex sindaco di Fiumedinisi
impedendo la comunicazione con l’esterno e l’utilizzo dei social network. "Due
giorni, datemi due giorni", chiede De Luca nel video sul suo profilo, per
raccogliere documenti e preparare denunce, avverte, mentre non risparmia ancora
una volta la magistratura di Messina, che definisce addirittura "mafiosa": "Un
conto aperto con alcuni personaggi della magistratura di Messina - ha detto
esattamente De Luca -, noi denunceremo qualunque tipo di mafia anche quella
giudiziaria". Anche dopo l’arresto De Luca aveva lanciato messaggi di fuoco
contro massoneria e giudici tramite il suo profilo Facebook, aveva postato video
e immagini, alcuni ritraevano anche la manifestazione in suo supporto dei
fedelissimi sotto la sua abitazione a Fiumedinisi. A proposito delle
dichiarazioni del neodeputato dell’Ars si è espressa in una nota Magistratura
indipendente: «Esprimiamo solidarietà e vicinanza a tutti i magistrati del
distretto di Corte d’Appello di Messina di recente destinatari di attacchi
violenti volti a mettere in discussione l’onestà di tutta la categoria tacciata
come corrotta», così esordisce la nota. «In particolare - prosegue la nota del
gruppo di magistrati guidato da Antonello Racanelli e Giovanna Napoletano - è
inaccettabile che un neoeletto rappresentante delle istituzioni siciliane, in
costanza di detenzione domiciliare, ponga in essere, sia a mezzo social network
sia all’interno di un Tribunale al termine di un processo a suo carico, condotte
fortemente delegittimanti nei confronti della magistratura messinese definita
"verminaio" e massonica». «Chiediamo che la Giunta esecutiva centrale dell’Anm
intervenga e prenda posizione a tutela della magistratura messinese in luogo
della Giunta esecutiva sezionale, il cui intervento potrebbe prestare il fianco
a strumentalizzazioni e soprattutto potrebbe pregiudicare l’immagine di terzietà
di coloro che sono e potrebbero essere chiamati a pronunziarsi sulla condotta
contestata al deputato», conclude la nota di Mi.
De Luca torna in libertà e si scatena:
"Ora denuncio la mafia giudiziaria". L'attacco del
deputato Udc: «Certi magistrati infangano la toga», scrive Mariateresa Conti,
Martedì 21/11/2017, su "Il Giornale". «Scateno De Luca», diceva un suo
manifesto elettorale di qualche anno fa, giocando sul suo nome. E si è scatenato
davvero, ieri, su Facebook, Cateno De Luca, il deputato regionale siciliano
arrestato per evasione fiscale appena chiuse le urne che il 5 novembre scorso lo
avevano rieletto, nelle file dell'Udc, con una valanga di preferenze. Eh sì,
perché ieri il Gip di Messina, accogliendo le richieste della difesa, ha
revocato il suo arresto rimettendolo immediatamente in libertà al termine
dell'interrogatorio di garanzia. Una vittoria che arriva a pochi giorni da
un'altra importante sentenza, quella che ha assolto lo stesso De Luca in primo
grado dall'accusa di abuso d'ufficio per il sacco edilizio di Fiumedinisi, il
comune del Messinese di cui è stato sindaco. Di qui il suo grido liberatorio, su
Facebook: «Libero!... E aff... tutte le forme di mafia compreso quella
giudiziaria!». Un post accompagnato da un video in cui annuncia che nel giro di
pochi giorni denuncerà investigatori e magistrati messinesi, gli artefici, a suo
dire, della persecuzione giudiziaria nei suoi confronti: «Giudicate voi, in 7
anni 15 procedimenti penali tutto archiviato, assoluzioni, per le prescrizioni
faremo appello». Un attacco durissimo, quello di De Luca, che sin dall'inizio,
sino a quando i giudici non gliene hanno inibito l'uso durante la detenzione, si
è difeso sui social protestando la sua assoluta innocenza. «Le mafie dei palazzi
- si è sfogato uscendo dal Palazzo di giustizia - non si possono accettare
supinamente. Io presenterò il terzo esposto nei confronti di determinati
personaggi che continuano a sporcare questo palazzo. Faremo nomi e cognomi, si
tratta di magistrati, qualche pubblico ministero, organi inquirenti che hanno
infangato, falsificato in atti giudiziari tante cose. Stiamo completando le
denunce». Sulle accuse ai magistrati è intervenuta con una nota Magistratura
indipendente, che ha espresso solidarietà ai colleghi chiedendo l'intervento
della giunta esecutiva centrale del sindacato delle toghe: «È inaccettabile che
un neoeletto rappresentante delle istituzioni siciliane ponga in essere, sia a
mezzo social network sia all'interno di un Tribunale al termine di un processo a
suo carico, condotte fortemente delegittimanti nei confronti della magistratura
messinese definita verminaio e massonica». In attesa delle ulteriori denunce,
caduti gli arresti domiciliari, De Luca potrà insediarsi all'Assemblea regionale
siciliana alla prima seduta utile. E intanto va anche oltre, visto che ha
manifestato l'intenzione di candidarsi a sindaco di Messina, dove si voterà nel
2018. A De Luca era stato contestato di avere sottratto al fisco circa 1 milione
e 750mila euro. Il difensore del deputato, l'avvocato Carlo Taormina, ha chiesto
l'incidente probatorio.
Sicilia, scarcerato Cateno De Luca: «Ora
denuncio la mafia giudiziaria». Il gip del tribunale
di Messina ha deciso di revocare gli arresti domiciliari al deputato siciliano
che fuori dal palazzo di giustizia attacca al magistratura: «Noi denunciamo
qualsiasi tipo di mafia anche quella giudiziaria», scrive il 20 novembre 2017
"Lettera 43". Cateno De Luca si è scatenato, dopo che il gip gli ha revocato i
domiciliari a 12 giorni dall'arresto per evasione fiscale e a 10 giorni
dall'assoluzione in primo grado per il sacco di Fiumedinisi, davanti alle
colonne del tribunale messinese ha accusato «un sistema in cui ai magistrati non
si può dire che hanno fatto una minchiata» e quei pm che «infangano e
falsificano la giustizia». «Abbiamo un conto aperto con alcuni personaggi del
tribunale di Messina», ha detto ancora il deputato regionale del Centrodestra,
«Noi non stiamo col capo chino, noi denunciamo qualsiasi tipo di mafia anche
quella giudiziaria. Il Gip ha sconfessato porcherie che abbiamo subito».
PER IL GIP GLI INDIZZI DI COLPEVOLEZZA RESTANO
GRAVI. Il giudice Carmine De Rose ha annullato i domiciliari e imposto la misura
interdittiva del divieto di esercizio di posizioni apicali negli enti coinvolti
nell'inchiesta sull'evasione fiscale, di cui De Luca è direttore generale. Per
il giudice sussistono i gravi indizi di colpevolezza ma si sarebbero affievolite
le esigenze cautelari. De Luca si è poi scagliato contro «i geometri
improvvisati che non hanno mai versato un contributo Inps e stilano liste di
impresentabili». «Faccio la politica del 'fare', non mi piacciono i fannulloni
che prendono lo stipendio e si ricandidano». Il deputato siciliano ha annunciato
l'intenzione di andare avanti nel progetto per la sindacatura a Messina: «Se la
città mi vuole io ci sono. È il simbolo della battaglia politica». «Ho fatto due
esposti e il 21 ne farò un terzo: falso in atti giudiziari, calunnia, infedele
patrocinio», ha spiegato, «Denuncio chi sporca il Palazzo di giustizia, chi si
vendica perchè gli si dice che ha sbagliato. Chiedetelo al pm Vincenzo Barbaro,
l'abbiamo denunciato. Domani mi arrestano di nuovo? Ci siamo abituati, la
valigia per la cella è già pronta». «È possibile», ha continuato, «che mi hanno
abbiano fatto sei indagini e quattro verifiche in sette anni sulle carte
finanziarie?» si è chiesto il deputato regionale che ora potrà sedere
all'Assemblea regionale siciliana non appena verrà convocata dal presidente
della Regione Nello Musumeci.
DOMICILIARI REVOCATI ANCHE A SATTA. De Luca dopo
la notizia della revoca dei domiciliari, disposta anche per Carmelo Satta, ex
presidente della Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori, su cui
ruota l'inchiesta per evasione fiscale, ha partecipato all'udienza del tribunale
della libertà cui è stato chiesto di togliere anche la misura interdittiva e di
dissequestrare i beni immobili della Fenapi: il gip ha già dissequestrato i
conti correnti della federazione e di De Luca. L'avvocato Carlo Taormina, uno
dei legali del politico ha detto: «Noi non siamo ancora soddisfatti perché
l'ordinanza del giudice è un pochino confusa ed evidentemente preoccupata di
raggiungere quello che era il suo obiettivo cioè scagionare totalmente De Luca e
quindi ci sono incertezze che vogliamo fare eliminare». Rivolgendosi ai
giornalisti Taormina ha anche detto: «Sono sorpreso che una stampa attenta non
capisca cosa è accaduto. Se sei anni fa De Luca è stato arrestato riciclando un
processo nel quale era stato tutto archiviato e ora dopo sei anni viene fatta la
stessa operazione rispetto a processi di carattere fiscale nei quale c'era già
stata la sentenza di non doversi procedere del gup di Messina, tutto ciò non vi
lascia perplessi?».
TAORMINA: «OPERAZIONE GUIDATA DA QUALCUNO». «Se
poi l'arresto dopo le elezioni non vi dice ancora nulla», ha concluso, «dubito
del vostro equilibro. È chiaro che nei confronti di De Luca c'è un'operazione
guidata da qualcuno che abbiamo già individuato. Vi rendete conto che rispetto
al sacco di Fiumedinisi è stato deciso che il fatto non sussiste e un gip dopo
un interrogatorio di garanzia giunge alla conclusione di revocare i domiciliari?
Contro di lui c'e' killeraggio».
De Luca libero attacca i Pm. Il
parlamentare finito ai domiciliari per «evasione fi scale» è stato scarcerato
dal Gip. «Se la città mi vuole mi candido a sindaco, andrò all’Ars per
insediarmi», scrive Nuccio Anselmo il 21/11/2017 su "Gazzetta del Sud". Niente
più arresti domiciliari nella sua casa di Fiumedinisi per l’on. Cateno De Luca,
che da ieri mattina è tornato libero perché «... il quadro indiziario pur non
risultando del tutto caducato nella sua complessiva gravità e consistenza...
appare meno schiacciante e più sfumato». A tredici giorni dal suo clamoroso
arresto per evasione scale della “galassia Fenapi”, il 7 novembre scorso, appena
due giorni dopo essere stato eletto all’Ars, il parlamentare regionale è tornato
in libertà su decisione del gip Carmine De Rose, che ieri mattina ha depositato
su questa vicenda un lungo provvedimento di tredici pagine per spiegare i motivi
delle sue decisione. Il gip ha sostituito i domiciliari con una misura meno
afflittiva, il “divieto di esercizio di uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese”, ovvero una misura interdittiva. Identica sorte
giudiziaria il gip ha deciso per l’altro indagato dell’inchiesta che era finito
ai domiciliari il 7 novembre scorso come presidente della Fenapi nazionale ed ex
sindaco di Alì, Carmelo Satta, che nel frattempo si è dimesso dalla carica.
Anche per lui quindi, fine dei domiciliari e misura interdittiva. Un altro
aspetto importante del provvedimento è legato al cosiddetto “sequestro per
equivalente” disposto contestualmente all’arresto dei due, per oltre un milione
e 700 mila euro, la somma cioè che si presume sia stata evasa al fisco dalla
“galassia Fenapi”. Il gip De Rose ha accolto le richieste dei legali di De Luca
e Satta, formulate in sede di interrogatorio di garanzia, ed ha in pratica
“spostato” il sequestro, indirizzandolo non più sui beni personali e sui conti
correnti dei due indagati e sui beni economici del “Caf Fenapi srl”, come era
stato deciso in un primo momento, ma sugli strumenti finanziari in attivo e
soprattutto sul patrimonio immobiliare dello stesso “Caf Fenapi srl”, «... già
stimato per un valore di oltre due milioni di euro...». Nelle sue tredici pagine
il gip De Rose passa in rassegna tutta la vicenda, a cominciare dalle ipotesi
d’accusa formulate dal sostituto procuratore Antonio Carchietti, e le struttura
in cinque punti: l’illecito risparmio d’imposta; l’associazione a delinquere; le
tre società di servizi come “complici” dell’evasione scale (Dioniso srl,
Sviluppo Sociale srl, Delnisi srl); l’emissione “a supporto” dell’evasione di
fatture per operazioni inesistenti; il presunto “ostacolo” alle indagini con
atti «... inconferenti e avulsi». Rispetto all’associazione a delinquere
ipotizzata, premettendo che De Luca è innegabile che «... abbia sempre
rappresentato il referente apicale...», spiega poi che a suo avviso «...
l’apporto degli ipotizzati singoli associati ai fini perseguiti ed ancor prima
alle dinamiche illecite associative, deve considerarsi blando e sfumato... ai
limiti del concorso»; in relazione poi alla «attualità del vincolo associativo»
afferma che «... è ad oggi poco apprezzabile». Il “nocciolo” del provvedimento è
legato poi ai reati fiscali contestati. Il gip scrive infatti che «... anche in
termini di esiti di vaglio tecnico ad opera di terzi Organi Giudiziari
Tributari... ci si trova di fronte ad un compendio indiziario che si reputa non
del tutto granitico, dirimente ed indiscutibile». Il riferimento è alla
produzione difensiva «... segnatamente da parte della difesa del Satta», sul
ricorso che pende alla Commissione tributaria su questi fatti, organo che ha
emesso «... un provvedimento di sospensione dell’esecutività degli avvisi di
accertamento». Un fatto che «... è indubbio» produca un effetto «... se non
altro, riconducibile ad una plausibilità di fondatezza del ricorso».
"98zero" intervista l’Avvocato Taormina:
“De Luca deve fare il presidente della Commissione Antimafia Regionale”,
scrive Enzo Cartaregia il 22 novembre 2017. Le rabbiose urla di Cateno De Luca
squarciano le prime pagine della stampa nazionale. Sulla soglia del tribunale di
Messina, il deputato regionale eletto ed arrestato nel giro di poche ore non
perde tempo ad aprire una nuova fase del proprio conflitto con le toghe. Ed
appena rimesso in libertà, De Luca rompe le attese: parla en tranchant di “mafia
giudiziaria”, incassato in appena dodici giorni il dietrofront sugli arresti
domiciliari legati all’inchiesta Fenapi. E’ tutto un record, nella storia di De
Luca: assolto quattordici volte in altrettanti processi, l’onorevole eletto
nelle liste dell’UDC riverserà oggi negli uffici della procura di Reggio
Calabria una valanga di documenti e denunce all’indirizzo di alcuni magistrati
messinesi. E la sua vicenda è già un caso nazionale, se a confermarlo corrono
anche le parole del capo del suo collegio difensivo, il prof. Carlo Taormina. Il
celebre penalista, ai microfoni di 98zero.com, ha delineato i tratti del braccio
di ferro tra la magistratura ed il proprio assistito, soffermandosi sul rilievo
dell’inchiesta anche a livello nazionale e sul futuro in politica di Cateno De
Luca.
Professor Taormina, ha definiti quelli di De Luca
degli “arresti da Uganda”. Il GIP fa retromarcia perché si configura un abuso
della custodia cautelare?
“E’ la dinamica dei fatti a dimostrare che ciò è
stato. Abbiamo subito stigmatizzato il comportamento dell’autorità giudiziaria.
Meno male che ci sono dei meccanismi correttivi all’interno della sua stessa
struttura. Nello stesso interrogatorio di garanzia non potevamo dire molto di
nuovo: sta però di fatto che un giudice ha ritenuto che il suo collega avesse
commesso un errore. Aldilà di questo, suscitano forti perplessità le circostanze
in cui l’arresto è stato fatto”.
Cosa non la convince, aldilà del merito
dell’inchiesta?
“Credo sia la prima volta nella storia della
Repubblica che un cittadino che viene eletto deputato, seppure regionale, venga
arrestato dopo due giorni. Anzi, fossi nell’autorità giudiziaria io lo
arresterei prima. Non sarebbe molto più logico, per impedire che venga eletto?”.
La legislatura non è ancora cominciata. E se non
fosse stata disposta la scarcerazione?
“Così facendo è stata messa a rischio la
costituzione della stessa Assemblea Regionale. La legge dice che sono settanta,
i deputati e che entrano in Sala d’Ercole tutti insieme. L’arresto di De Luca
non avrebbe comportato lo scorrimento al primo dei non eletti, ma la semplice
impossibilità del parlamento di insediarsi. E’ gravissimo”.
Quattordici processi, nessuna condanna. Eppure
nell’ordinanza di custodia cautelare è scritto che De Luca possiede
“spregiudicatezza e pervicacia criminale”. Motivazioni e casellario giudiziario
collidono?
“Queste parole dimostrano la pervicacia
dell’autorità giudiziaria. Il suo operato è stato chiaramente smentito ed è
questo l’unico punto fermo di questa vicenda. Per di più inserire nelle carte
delle valutazioni di questo genere dimostra come ci sia una sorta di
risentimento, fino all’iniziativa persecutoria nei confronti di una persona
della quale nulla era possibile dire, come i fatti hanno dimostrato”.
De Luca ha urlato che smonterete l’impianto
accusatorio pezzo per pezzo. In altri processi valutate la rinuncia alla
prescrizione.
“La precedente inchiesta ha visto – salvo alcuni
particolari su cui lavoreremo in appello – la totale assoluzione dell’on. De
Luca. Per i fatti contestati in questi giorni è evidente che la scarcerazione
disposta dal GIP passa addirittura dall’esclusione dell’esistenza degli indizi
di colpevolezza. Se non è questo fumus persecutionis, non ci sarebbe possibilità
di trovarne altro esempio…”
L’ennesimo capitolo del conflitto tra eletti e
procure. Ma teme che la rilevanza mediatica assunta dal caso possa forzare gli
equilibri nelle aule del palazzo di giustizia?
“Mi auguro che De Luca sia fermo nell’iniziativa
che ha intrapreso e nella volontà che ha manifestato. L’onorevole vuole partire
dalla sua vicenda per dimostrare il marciume della giustizia italiana. Come dal
punto di vista politico la Sicilia vorrebbe essere, dopo queste elezioni, la
fonte della rinascita per il nostro paese, così tutto quello che sta accadendo
attorno alla persona di Cateno De Luca si vorrebbe che fosse l’inizio di un
percorso che abbatta questa giustizia politicizzata, fatta di rancori, di
iniziative personali, di magistrati che si sovrappongono ad altri magistrati e
li obbligano ad assumere certi azioni”.
Le regionali in Sicilia hanno inaugurato, nel
linguaggio politico, la stagione degli “impresentabili”. Da insigne espero del
diritto non crede che, nei termini di legge, sia un dibattito sgrammaticato?
“Giuridicamente l’unico impresentabile è quello
che, per legge, non può essere nemmeno candidato. Servono sentenze passate in
giudicato per definire un cittadino così, o al massimo situazioni come quelle
previste dalla legge Severino. Una legge, tra l’altro, che è certamente
incostituzionale. Si è quindi trattato di un linguaggio inaugurato dalla
Commissione Antimafia, che naturalmente ha preso il sopravvento in un mondo
politico vuoto di potere, vuoto di autorevolezza. Quest’organismo parlamentare è
diventato uno strumento di battaglia politica per escludere chi non è gradito, o
comunque è un pericoloso avversario”.
E De Luca lo è?
“E’ certamente un uomo pericoloso. Non
dimentichiamo che il 5 novembre ha portato circa 10.000 voti alla coalizione di
quel presidente Musumeci che oggi lo schiaffeggia. Quegli stessi voti che
probabilmente sono stati determinanti per la sua vittoria. Ha dimostrato nella
sua storia di saper mettere in crisi la regione siciliana, avendo tallonato
prima Cuffaro e poi Lombardo, riducendoli alla necessità di abbandonare il
terreno”.
Più che la regione, però, al suo assistito
interessa la città di Messina.
“Ed è infatti quella stessa persona che ha fatto
battaglie antimafia a non finire nella città di Messina ed oltre, schierandosi
contro i poteri forti ad iniziare la massoneria. Pare naturale che nel momento
in cui ha annunciato la volontà di candidarsi a sindaco della città dello
Stretto ha scatenato il caos all’interno di questi corpi”.
Come spiega la ripresa della vicenda giudiziaria
riguardante la Fenapi?
“Dobbiamo essere consapevoli che proprio la
magistratura si è fatta braccio esecutivo, nell’attacco dei poteri forti. Credo
non a caso che quel Palazzo di Giustizia abbia bisogno di essere ben
visitato, perché i tanti magistrati onesti e competenti che lo abitano vengono
sporcati da alcuni che perseguono invece obiettivi diversi”.
Cateno De Luca continua quindi la corsa a Palazzo
Zanca?
“La carriera politica di De Luca ha ormai bisogno
un respiro ben più ampio. Personalmente gli ho sempre consigliato di iniziare a
pensare ad una collocazione nel parlamento nazionale, invece che di passare da
Messina. Lui fa dell’amministrazione la politica, seppure si faccia sempre
l’inverso. E’ questo il suo tratto distintivo e naturalmente i territori sono il
luogo privilegiato della sua azione. Credo allora che non riuscirò a sottrarlo
all’iniziativa di correre per la poltrona di sindaco di Messina. Mi auguro che
ci riesca”.
Con dicembre parte la nuova legislatura in
regione. E Musumeci lavora alla giunta. De Luca si insedia, ma come gli ha
consigliato di muoversi?
“Intanto gli ho raccomandato di rifuggire
dall’assunzione di responsabilità di governo. Seppure queste gli spettano, per
il consenso popolare che ha totalizzato, l’ho consigliato di non farlo né di
indicare persone di fiducia al suo posto. Ciò che deve fare Cateno De Luca è
un’altra cosa”.
Ovvero?
“L’onorevole De Luca deve andare a fare il
presidente della Commissione Antimafia di Palazzo dei Normanni. E’ quello il suo
posto. Da lì potrà dimostrare come si comporta un cittadino onesto che ha deciso
di dare le sue forze alla politica”.
Cateno De Luca si difende: "La sentenza
mi dà ragione". Scrive "Live Sicilia" martedì 21
novembre 2017. "Mi è arrivata in questo momento la sentenza della commissione
tributaria provinciale che attendevamo da tempo: ha stabilito che non c'è
evasione né raggiri né “tracchigi” come aveva ipotizzato il pubblico ministero
che mi ha fatto arrestare. L'altra cosa importante è che oltre il 50% dei costi
la commissione provinciale tributaria provinciale li ha riconosciuti inerenti
cioè legittimi". Lo dice in un video su Facebook il deputato regionale dell'Udc
Cateno De Luca, indagato con l'accusa di evasione fiscale. Ieri il Gip di
Messina ha disposto la revoca dei domiciliari sostituendoli col divieto di
esercizio di posizioni apicali negli enti coinvolti nell'inchiesta. "Aspettiamo
un'altra sentenza - prosegue-, però ci tenevo a dirvi che l'organo tecnico,
deputato a fare queste valutazioni, è la commissione tributaria e ieri ha
depositato questa sentenza; il che significa che più di qualcuno dovrebbe essere
ricoverato in qualche manicomio psichiatrico". (ANSA). Con una sentenza
depositata lo scorso 16 novembre, la Commissione tributaria di Messina ha
accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Fenapi il 15 gennaio 2016,
contro l'Agenzia delle entrate e riguardante alcuni avvisi di accertamento per
l'attività dell'ente di formazione Fenapi (di cui il deputato regionale Cateno
De Luca, uscito ieri dagli arresti domiciliari, era presidente) negli anni che
vanno dal 2007 al 2010. Secondo gli accertamenti compiuti dalla Guardia di
finanza, la Fenapi non avrebbe potuto operare la deducibilità fiscale di alcuni
costi. Gli imponibili, nei quattro anni, ammontano a oltre 1,7 milioni di euro.
La Commissione, nell'accogliere in parte il ricorso, ha stabilito il ricalcolo
degli importi soggetti a tassazione. (ANSA).
Giustizia a orologeria “ma non mi farò macinare
dal fango”, scrive mercoledì 15 novembre 2017 Adriano Todaro su "Giro di vite".
Cateno? Ma che nome è Cateno? Come si fa uno a chiamarsi Cateno? Non era meglio
Alfio o Filippo? Oppure Giovanni, oppure Ignazio? Eh no, troppo semplice. Così
ho fatto delle ricerche e ho appreso che Cateno è un bel nome, di sapore antico,
che ha una storia che risale, nientemeno, al terzo secolo prima di Cristo. Erano
definiti così gli schiavi che stavano in cima e in fondo alla fila degli
incatenati. E così i siciliani, che sono esperti, ogni tanto, come buon
auspicio, chiamano così il figlio nato alla fine o all’inizio dell’anno. Allora
ricapitoliamo: Cateno De Luca, detto confidenzialmente Scateno, è nato il 18
marzo del 1972. Mese sbarazzino e ventoso, terzo mese dell’anno e ha, quindi,
tutto il diritto di chiamarsi Cateno. Fin qua ci siamo. Bisogna poi dire che
tutti noi quando nasciamo, abbiamo già una strada tracciata e un carattere che
si forma già dopo i primi mesi di vita. Cateno, così ha deciso il fato, in tutta
la vita dovrà sempre svolgere il ruolo di cireneo, quello che ha aiutato Cristo
a portare la croce. Fin dalle elementari che frequentava in via Roma, a
Fiumedinisi in provincia di Messina, si era fatto notare per la precoce
intelligenza e per la bontà insita nel suo animo. I compagni, però, ne
approfittavano di questa sua mitezza e si facevano fare da lui i compiti. Cateno
assolveva questa incombenza con spirito di missione, di sacrificio così come ha
fatto, anni dopo, come sindaco proprio di Fiumedinisi e consigliere regionale.
Diventato adulto, dopo essersi laureato in Giurisprudenza, ha cominciato a
interessarsi di politica. Quando però sei cireneo, cireneo rimani e così ha
portato al fascista gentile, Musumeci, ben 93 mila e 232 voti. Invece di essere
ringraziato, Cateno si è trovato con le catene ai polsi. E questo non è giusto.
Altro che giustizia a orologeria; in questo caso l’orologio si è fermato al 1992
quando si arrestavano i politici. Un secolo fa. Ora siamo in una fase nuova,
siamo moderni e ottimisti anche nel rubare. E poi, dai, arrestare un politico
all’indomani di una vittoria elettorale non è neppure fine. E perché l’hanno
arrestato? E’ accusato, figuriamoci, di essere tra i promotori di
un’associazione per delinquere finalizzata a una rilevante evasione fiscale,
quantificata in circa 1.750.000 euro. Bazzecole, quisquilie, pinzillacchere. Chi
non evade in Italia? Lo faccio anch’io quando posso e do anche un aiutino. Ad
esempio quando non chiedo lo scontrino al mio panettiere. Cateno ha anche
un’altra particolarità: è uomo di pensieri profondi, di elaborazione
scientifica, una vera testa in lega leggera. E così ha capito perché è stato
mazzolato. In un video se la prende con i Pm, i poteri forti e la massoneria, e
avverte parlando in terza persona: "Cateno De Luca non si farà macinare dal
fango. Fino a quando avrà l’ultimo respiro, si difenderà in tutti i luoghi". Fa
bene anche perché lui parla chiaro. Il suo slogan, infatti, era: “Su di me
parlano i fatti”. Appunto. Uomo di profonde letture, nella sua pagina Facebook
ci sono alcune massime cui lui ama. Una così recita: “Senza soddi non si canta a
missa”. E così ha chiarito a tutti del perché dell’evasione. L’ha fatto per
poter cantare "a missa". Lui, che proviene dalla Dc, sa bene che la messa
importante è quella cantata e per questo ci voglio i “soddi”. Uno dei film più
amati di Cateno è “Uccelli di rovo”. Padre Ralph è un ribelle ambizioso prete
irlandese. Ribelle e ambizioso come Cateno perché, oltre a tutti gli incarichi
che ha, voleva diventare anche sindaco di Messina, dopo aver costruito cinque
piani di un Centro benessere, 16 villette e la realizzazione di un muro di
contenimento del torrente Fiumedinisi, tutte opere che, secondo l’accusa,
avrebbero favorito la società dell’allora sindaco Cateno. Tutto questo lo aveva
fatto a fin di bene. Come padre Ralph. E, poi, pochi giorni fa, per questa
speculazione, è stato assolto dall’abuso d’ufficio e prescritto per falso in
atto pubblico e tentata concussione. Per fortuna il suo partito, l’Udc (che non
è l’acronimo di Unione dei carcerati) lo difende dall’ultima accusa di evasione
fiscale perché “convinti che De Luca sarà in grado di chiarire i fatti e di
dimostrare la sua innocenza…”. Ne siamo convinti anche noi perché sarebbe un
peccato non avere più nel Parlamento siciliano uno come Cateno che un giorno ha
slegato non la catena ma la cravatta, si è tolta la giacca, la camicia, i
pantaloni, per protestare contro l’allora presidente dell’Ars Gianfranco
Micciché, rimanendo in mutande, per poi coprirsi con la bandiera della Sicilia,
la Trinacria. Mizzeca che ciriveddru! (Sarebbe il cervello siciliano-Ndr). Uno
così non lo trovate più, cari siciliani. Non fatevelo scappare. Manifestate per
la sua libertà. Un màsculu unico nella sua specie. A proposito: il suo movimento
si chiama “Sicilia Vera”. Pensate un po’. Se questa è la Sicilia vera,
figuriamoci quella falsa.
Fascismi giudiziari e aggravanti
televisive, scrive Vittorio Sgarbi, Martedì
21/11/2017, su "Il Giornale". Assistiamo da anni a una aggressione giudiziaria,
di stampo fascista. Penso agli insensati scioglimenti di Comuni per mafia,
all'arresto plateale (seguito dall'incongrua liberazione) di Cateno De Luca, ai
processi illegittimi come quello a Contrada, alle condanne arbitrarie di
Dell'Utri e di Cuffaro, alle indagini su Berlusconi, e alla farsa degli alimenti
a Veronica, conclusa con un risarcimento di lei a lui (in un impressionante
squilibrio dei collegi giudicanti), al processo infondato per Mafia capitale,
all'arbitrario arresto, fino a farlo morire, dell'innocente sindaco di
Campobello di Mazara, Ciro Caravà, all'inverosimile metodo Woodcock, all'abuso
di Cantone su Carla Raineri. Una lunga serie di veri e propri errori, per
ignoranza o malafede. Fino all'arresto di Spada, per «testata» con l'aggravante
di mafia, in un carcere di massima sicurezza. «Ha sbagliato, ma non ci scordiamo
che Sgarbi schiaffeggiò la Mussolini in diretta televisiva», ricorda il cugino
di Spada. Ricorda male. Fu lei a farmi cadere gli occhiali, e io le dissi
semplicemente: «Fascista». Vero invece, e più pertinente al caso Spada, che io
spaccai il tapiro in testa a Staffelli. Certo un cattivo esempio. Il cugino
osserva: «Ma dove sta questa mafia? La mafia ve la state inventando voi». Ha
evidentemente ragione. Roberto Spada, nella sua aggressione era solo, e la mafia
prevede una associazione. La sola aggravante è quella televisiva.
Brizzi, De Luca, Tavecchio: i tre volti
della gogna, scrive Piero Sansonetti il 21 Novembre
2017, su "Il Dubbio". Il regista, il politico, il capo del calcio italiano, tre
vicende diverse, ma il linciaggio mediatico è sempre lo stesso. Sono tre storie
diverse, e riguardano tre personaggi diversissimi tra loro, ma tutte e tre hanno
in comune un elemento: la voglia di gogna, di linciaggio, di ricerca del capro
espiatorio e poi di realizzazione della cerimonia dello scannamento. Le storie
di Carlo, Cateno e Fausto. Chi sono lo capite dalle fotografie: Carlo è Carlo
Tavecchio, presidente della Figc (cioè della federazione italiana gioco calcio)
fino a ieri verso mezzogiorno, quando si è dimesso, travolto dalla sconfitta
della nazionale con la Svezia e dalla furia dei giornali e dell’opinione
pubblica. Cateno (nome singolarissimo) è Cateno De Luca, consigliere regionale
siciliano appena eletto, arrestato per motivi francamente misteriosi due giorni
dopo la vittoria elettorale, e ieri finalmente scarcerato dopo essere stato
trattato dai giornali come un criminale conclamato. Fausto, infine, è il regista
Fausto Brizzi, annientato da giornali e Tv, dipinto come un maniaco sessuale e
uno stupratore, demolito nell’immagine e nel morale ma, forse, innocente. Le
dimissioni di Tavecchio, diciamolo pure, erano doverose e scontate. Perché dopo
una grande sconfitta sportiva è vecchia usanza che l’allenatore e il capo della
federazione siano sostituiti. Successe così nel 1958, dopo la mancata
qualificazione ai mondiali di Svezia, e successe così anche nel 1966, dopo
l’eliminazione ai gironi per mano della nazionale della piccola Corea del Nord
(gol di un dentista, calciatore dilettante) che allora era governata dal nonno
del terribile Kim Yong (anche il nonno, Kim Il Sung, era parecchio spietato).
Doverose le dimissioni ma non era doveroso il linciaggio. Tavecchio non è un
personaggio simpaticissimo, il suo mandato in Figc è stato costellato di gaffe
ed errori diplomatici. Tuttavia non è stato il peggio dei peggio. È lui che nel
2015 riuscì a reclutare Antonio Conte, uno degli allenatori più forti del mondo.
E riuscì a trovare gli sponsor che permettessero di pagare il suo stipendio
altissimo senza prosciugare le casse della federazione (e Conte ottenne ottimi
risultati con una nazionale modesta); è lui che ha introdotto la Var nel
campionato (sarebbe la moviola Tv in campo: clamorosa innovazione); è lui che ha
messo in ordine i conti della Figc (l’Italia è quasi l’unica federazione
calcistica coi conti in ordine). Forse, prima di mandarlo via, potevamo dirgli
grazie, invece di coprirlo di sputi. Ha sbagliato a prendere Ventura quando
Conte ha lasciato? Non c’era di molto meglio sul mercato degli allenatori. E
poi, Ventura, prima del pasticcio svedese era stato un discreto allenatore e
aveva avuto diversi successi. Su Brizzi non voglio sbilanciarmi. Non conosco i
fatti. Se ha molestato, se ha stuprato, se ha commesso dei reati, che a me
paiono gravissimi, deve essere processato. Però mi sembra che nessuno lo abbia
denunciato, e quindi che è impossibile processarlo. Allora forse l’uso vigliacco
della potenza dell’informazione (senza certezze, senza riscontri, senza prove,
con pochi indizi) non è uno strumento di avanzamento della trasparenza ma
piuttosto di una idea giustizialista che sfiora il totalitarismo. Poi c’è
Cateno, che ieri finalmente è stato scarcerato e ha rilasciato dichiarazioni
dure. Questo Cateno è stato processato negli anni scorsi 14 volte e sempre
assolto. Quindi, tecnicamente, è un perseguitato. Quando l’altro giorno l’hanno
messo in mezzo di nuovo, e arrestato, i mass media si sono scatenati (scusate il
gioco di parole) contro di lui. Impresentabile, corrotto, mafioso. Quando due
giorni dopo è arrivata la quindicesima assoluzione, silenzio. Nemmeno un accenno
di scuse. Anzi, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo di Massimo Fini
che chiedeva che gli fossero tolti i domiciliari e fosse sbattuto il cella.
Crucifige, Crucifige. Era il verso ripetuto di una famosa poesia del duecento,
di Jacopone da Todi. A lui era chiaro che il giustizialismo era un’infamia.
Quasi mille anni fa. Oggi invece torna, il giustizialismo, e torna sempre più
tronfio, spietato, altezzoso. Sulle ali del grillismo. Su twitter, ieri (per
fortuna) ho letto un twitt di Enzo Bianchi, teologo e monaco piuttosto noto nel
mondo cristiano. C’era scritto così: «Ancora oggi ci sono persone rigide e
legaliste che passano la vita a spiare i peccati degli altri e a scovare le
presunte eresie degli altri: dopo una tale fatica, incattiviti, hanno la faccia
che si meritano». E di seguito al twitt don Enzo – che oltre ad essere un
teologo è anche molto spiritoso – ha pubblicato la faccia che viene ai
giustizialisti. È quella che vedete in questa pagina, sotto il titolo.
L’arrestocrazia e il potere del “Coro
antimafia”, scrive Piero Sansonetti l'11 Novembre 2017
su "Il Dubbio". Dal caso De Luca al caso Spada, quando l’arresto mediatico e a
furor di popolo conta più le regole del diritto. E chi dissente è considerato un
complice dei farabutti. Ieri pomeriggio Cateno De Luca è stato assolto per la
quattrodicesima volta. Niente concussione, nessun reato. A casa? No, resta agli
arresti perché dopo 15 accuse, 15 processi e 15 assoluzioni, martedì scorso era
arrivata la 16ima accusa. E ci vorrà ancora un po’ prima che sia assolto di
nuovo. Stavolta l’accusa è evasione fiscale. Non sua, della sua azienda. Cateno
De Luca è un deputato regionale siciliano. Era stato eletto martedì. Lo hanno
ammanettato 24 ore dopo. L’altro ieri sera invece era stato fermato Roberto
Spada. Stiamo aspettando la conferma del suo arresto. Lui è in una cella a
Regina Coeli. Roberto Spada è quel signore di Ostia che martedì ha colpito con
una testata – fratturandogli il naso – un giornalista della Rai che gli stava
facendo delle domande che a lui sembravano inopportune e fastidiose. È giusto
arrestare Spada? È stato giusto arrestare Cateno De Luca? A favore dell’arresto
ci sono i giornalisti, gran parte delle forze politiche, una bella fetta di
opinione pubblica. Diciamo: il “Coro”. Più precisamente il celebre “Coro
antimafia”. Che ama la retorica più del diritto. Contro l’arresto c’è la legge e
la tradizione consolidate. Prendiamo il caso di Spada. La legge dice che è
ammesso l’arresto preventivo di una persona solo se il reato per il quale è
accusata è punibile con una pena massima superiore ai cinque anni. Spada è
accusato di lesioni lievi (perché la prognosi per il giornalista è di 20 giorni)
e la pena massima è di un anno e mezzo. Dunque mancano le condizioni per la
custodia cautelare. Siccome però il “Coro” la pretende, si sta studiando uno
stratagemma per aggirare l’ostacolo. Pare che lo stratagemma sarà quello di dare
l’aggravante della modalità mafiosa. E così scopriremo che c’è testata e
testata. Ci sono le testate mafiose e le testate semplici. Poi verrà il concorso
in testata mafiosa e il concorso esterno in testata mafiosa. Mercoledì invece,
dopo l’arresto di Cateno De Luca, non c’erano state grandi discussioni. Tutti –
quasi tutti – contenti. Sebbene l’arresto per evasione fiscale sia rarissimo. Ci
sono tanti nomi famosi che sono stati accusati in questi anni di evasione
fiscale per milioni di euro. Alcuni poi sono stati condannati, alcuni assolti.
Da Valentino Rossi, a Tomba, a Pavarotti a Dolce e Gabbana, a Raul Bova e
tantissimi altri. Di nessuno però è stato chiesto, ovviamente, l’arresto
preventivo. Perché? Perché nessuno di loro era stato eletto deputato e dunque
non c’era nessun bisogno di arrestarlo. L’arresto, molto spesso, specie nei casi
che più fanno notizia sui giornali, dipende ormai esclusivamente da ragioni
politiche. E il povero Cateno ha pagato cara l’elezione. I Pm non hanno
resistito alla tentazione di saltare sulla ribalta della politica siciliana.
Comunque qui in Italia ogni volta che qualcuno finisce dentro c’è un gran
tripudio. L’idea che ormai si sta affermando, a sinistra e a destra, è che
l’atto salvifico, in politica, sia l’arresto. Mi pare che più che in democrazia
viviamo ormai in una sorta di “Arresto- Crazia”. E che la nuova aristocrazia che
governa l’arresto-crazia sia costituita da magistrati e giornalisti. Classe
eletta. Casta suprema. Gli altri sono colpevoli in attesa di punizione. Poi
magari ci si lamenta un po’ quando arrestano i tuoi. Ma non è niente quel
lamento in confronto alla gioia per l’arresto di un avversario. Il centrodestra
per esempio un po’ ha protestato per l’arresto pretestuoso di Cateno De Luca. Il
giorno prima però aveva chiesto che fosse sospesa una fiction in Rai perché
parlava di un sindaco di sinistra raggiunto da avviso di garanzia per
favoreggiamento dell’immigrazione. Il garantismo moderno è così. Fuori gli amici
ed ergastolo per gli avversari. Del resto la sinistra che aveva difeso il
sindaco dei migranti ha battuto le mani per l’arresto di Cateno. L’altro ieri
intanto è stato minacciato l’avvocato che difende il ragazzo rom accusato di
avere stuprato due ragazzini. L’idea è quella: “se difendi un presunto
stupratore sei un mascalzone. Il diritto di difesa è una trovata farabutta. Se
uno è uno stupratore è uno stupratore e non serve nessun avvocato e nessunissima
prova: condanna, galera, pena certa, buttare la chiave”. Giorni fa, a Pisa, era
stato aggredito l’avvocato di una ragazza accusata di omicidio colposo (poi, per
fortuna, gli aggressori hanno chiesto scusa). Il clima è questo, nell’opinione
pubblica, perché questo clima è stato creato dai politici, che sperano di
lucrare qualche voto, e dai giornali che un po’ pensano di lucrare qualche
copia, un po’, purtroppo, sono scritti da giornalisti con doti intellettuali non
eccezionali. E se provi a dire queste cose ti dicono che sei un complice anche
tu, che stai con quelli che evadono le tasse, che stai con quelli che danno le
testate. Il fatto che magari stai semplicemente col diritto, anche perché il
diritto aiuta i deboli mentre il clima di linciaggio, il forcaiolismo, la
ricerca continua di punizione e gogna aiutano solo il potere, beh, questa non è
nemmeno presa inconsiderazione come ipotesi. Tempo fa abbiamo pubblicato su
questo giornale “La Colonna Infame” di Manzoni. Scritta circa due secoli fa. Due
secoli fa? Beh, sembra ieri…
P. S. Ho letto che Saviano ha detto che Ostia
ormai è come Corleone. Corleone è la capitale della mafia. A Corleone operavano
personaggi del calibro di Luciano Liggio, Totò Riina, Bernardo Provenzano.
Corleone è stato il punto di partenza almeno di un migliaio di omicidi. Tra le
vittime magistrati, poliziotti, leader politici, sindacalisti, avvocati.
Paragonare Ostia a Corleone è sintono o di discreta ignoranza o di poca
buonafede. Ed è un po’ offensivo per le vittime di mafia. P. S. 2. Il
giornalista Piervincenzi, quello colpito con la testata da Spada, ha rilasciato
una intervista davvero bella. Nella quale tra l’altro, spiega di non essere
stato affatto contento nel sapere dell’arresto di Spada. Dice che lui in genere
non è contento quando arrestano la gente. Davvero complimenti a Piervincenzi. Io
credo che se ci fossero in giro almeno una cinquantina di giornalisti con la sua
onestà intellettuale e con la sua sensibilità, il giornalismo italiano sarebbe
una cosa sera. Purtroppo non ce ne sono.
Gli abitanti di Corleone
ora attaccano Saviano: "Diffama il nostro paese".
A denunciarlo è il Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del
Movimento Antimafia di Corleone che attacca lo scrittore Roberto Saviano, che
ieri, parlando dell'aggressione di Roberto Spada ai danni di un giornalista Rai
ad Ostia aveva paragonato il quartiere romano a "Corleone o Scampia", scrive
Luca Romano, Giovedì 09/11/2017, su "Il Giornale". "Per l'ennesima volta,
vergognosamente, l'immagine di Corleone e dei suoi cittadini onesti viene
diffamata e additata". A denunciarlo è il Centro Internazionale di
Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia di Corleone che attacca lo
scrittore Roberto Saviano, che ieri, parlando dell'aggressione di Roberto Spada
ai danni di un giornalista Rai ad Ostia aveva paragonato il quartiere romano a
"Corleone o Scampia". "Il risveglio di stamattina ci lascia un po' l'amaro in
bocca. Ci dispiace constatare che la nomea di Corleone città della mafia non
riguarda solo persone andate avanti a pane e Padrino ma anche Roberto Saviano
che da anni "combatte" contro la camorra e incontra quotidianamente persone che
a causa della camorra hanno perso parenti, sorrisi e speranza - dicono i ragazzi
del Museo sulla mafia di Corleone - L' avevamo invitato a venire: se solo avesse
accolto l'invito, si sarebbe reso conto che Corleone sì, ha da raccontare storie
di lupare e dolore, ma oggi può raccontare storie di grandi lotte e di
riscatto". "Grazie Roberto Saviano per l'ennesima spinta indietro che ci
costringi a fare - dicono - Noi barcolliamo un po', ma non perdiamo l'equilibrio
e andiamo avanti camminando sulle idee dei giudici Falcone e Borsellino. La
legalità ci ha insegnato e ci insegna ancora a splendere di luce propria...non
riflessa "caro Saviano". Buona giornata da chi ogni giorno lotta per sentire il
fresco profumo di libertà che non ha colore politico". Anche sui social c'è
stata una rivolta contro le parole di Saviano. "Che delusione - scrive Patrizia
Gariffo su Facebook - Dare un giudizio così netto e senza appelli, senza neanche
essere venuto a Corleone. Prima di parlare, è bene pensare un po’, mentre lo
storico Pasquale Hamel bolla Saviano come "un presuntuoso che ha speculato per
creare il proprio personaggio". Dino Paternostro, storico attivista per i
diritti di Corleone invita lo scrittore in città: "Roberto Saviano, vieni a
visitare Corleone. Sarai mio ospite. Poi, solo poi, potrai dare un giudizio
fondato sulla nostra città".
SONO INNOCENTE.
In libreria: INNOCENTI.
Il nuovo libro di Alberto Matano, scrive l'1 aprile 2018 "Da Sapere". “L’errore
umano esiste in ogni campo, ma dobbiamo ricordarcelo, prima di puntare il dito
su chiunque venga anche solo indagato, figuriamoci se viene arrestato. Potrebbe
capitare anche a noi. La realtà è complessa, il sistema giudiziario affaticato,
la giustizia, parola meravigliosa, a volte sembra un’utopia. Non per questo
dobbiamo smettere di crederci e di pretenderla”.
Dalla Prefazione di Daria
Bignardi. Gridare la propria innocenza e restare inascoltati. Trovarsi
all’improvviso a fare i conti con un marchio indelebile. È l’incubo che ciascuno
di noi potrebbe trovarsi a vivere, con le foto segnaletiche, le impronte
digitali, i processi, gli sguardi della gente e i titoli sui giornali,
l’esperienza atroce del carcere tra pericoli e privazioni. Un inferno, e in
mezzo a tutto questo sei innocente. È una ferita che rimane aperta, anche a
distanza di anni, nonostante le assoluzioni e – non sempre – le compensazioni
economiche. Lo sanno e lo raccontano i protagonisti di questo libro, presunti
colpevoli, riconosciuti innocenti. Maria Andò, accusata di una rapina e di un
tentato omicidio avvenuti in una città in cui non è mai stata. Giuseppe Gulotta,
la cui odissea di processi e detenzioni in seguito a un clamoroso errore
giudiziario dura quarant’anni, di cui ventidue in carcere. Diego Olivieri,
onesto commerciante che finisce in carcere per una storia di droga, per colpa di
un’intercettazione male interpretata. E gli altri protagonisti di queste pagine,
che raccontano le loro esperienze e i loro incontri, i loro traumi e la loro
ostinata volontà di rinascita. Alberto Matano costruisce in questo libro una
narrazione intensa e cruda, in cui ogni singola vicenda è un capitolo avvincente
di una storia più grande, quella dell’ordinaria ingiustizia che accade accanto a
ognuno di noi, senza che la vediamo. Un invito a esercitare la nostra attenzione
e la nostra umanità, ogni giorno. “Quando finisci in carcere e dici di essere
innocente non ti crede nessuno, lì sono tutti innocenti”. Immaginatevi, soltanto
per qualche secondo, di trovarvi in questa situazione, di finire dietro le
sbarre, senza neanche capire perché, e con la consapevolezza di non aver fatto
nulla. Gridare la propria innocenza, e restare inascoltati. Trovarsi
all’improvviso a fare i conti con quel marchio indelebile, anche a distanza di
anni quando tutto è finito, quando la giustizia, che ha sbagliato, alla fine è
giusta. È l’incubo che ciascuno di noi può trovarsi a vivere e di cui sappiamo
spesso troppo poco.
Alberto Matano, giornalista,
conduttore del Tg1 delle 20, dal 2017 è autore e conduttore della trasmissione
di Rai3 “Sono Innocente”, giunta alla sua seconda edizione.
L’8 aprile torna, su Rai3,
“Sono Innocente”. Alberto Matano racconta le novità della nuova edizione, scrive
il 31.03. 2018 Renato Franco su Il Corriere della Sera. L’impersonalità della
legge e la fallibilità dell’uomo, la giustizia che diventa ingiusta, persone
innocenti la cui vita si trasforma in incubo. È in questo perimetro narrativo in
cui si muove «Sono innocente», il programma condotto da Alberto Matano che torna
da domenica 8 aprile in prima serata su Rai3. «Raccontiamo storie di gente come
noi, persone comuni, che all’improvviso si ritrovano in una prospettiva di vita
ribaltata — spiega il giornalista —. Persone che senza sapere bene perché
finiscono ingiustamente in carcere». In questa nuova stagione il racconto si
dividerà in tre momenti, con tre storie differenti tra loro: le vicende di
persone comuni; quelle di persone famose; quelle a tinte più oscure che trattano
di pedofilia, satanismo e omicidi efferati. Cosa c’è alla radice di questi
clamorosi errori giudiziari? «Indagini frettolose e fatte male, la necessità di
trovare un colpevole, in molti casi uno scambio di persona, spesso il
pregiudizio: sulla famiglia di origine, sulle frequentazioni, sul luogo dove si
vive, come è successo a due ragazzi — uno di Scampia e l’altro di Casal di
Principe — che sono stati accusati e condannati per il solo motivo di abitare
nel luogo sbagliato. L’errore è umano, ma quando si può influire così tanto
sulla vita delle persone, un supplemento di responsabilità e rigore è
necessario». Sulla storia più dura Matano non ha dubbi: «La vicenda di Aldo
Scardella, lo studente universitario di Cagliari, ingiustamente accusato di
omicidio e morto suicida in carcere». «Sono innocente» rievoca anche quei casi
di ingiustizia di rilevanza nazionale che hanno segnato il vissuto collettivo:
da Enzo Tortora, con la presenza in studio della figlia Gaia, al delitto
di Meredith Kercher, con la testimonianza di Patrick Lumumba. Anche lo
chef Filippo La Mantia finì in carcere negli anni 80 per un delitto di mafia:
«All’epoca faceva il fotoreporter a Palermo e fu accusato di favoreggiamento
nell’ambito delle indagini sull’omicidio Cassarà. La Mantia racconta che nelle
cucine del carcere sviluppò quell’attenzione al gusto che è poi è diventata la
passione della sua vita». Il risarcimento però è una magra consolazione. Chi
baratterebbe 22 anni di carcere con 6 milioni di euro quando esci a 60 anni?
«Tutti gli innocenti ingiustamente condannati dicono la stessa cosa, nessun
risarcimento ti darà indietro quello che hai vissuto, quello che hai provato,
quello che hai perso». Anche la riabilitazione sociale non ha lo stesso impatto
che hanno avuto le condanne sulla vita delle persone: «Quando la giustizia
rimette le cose a posto, l’eco è decisamente minore rispetto al clamore
precedente. Vito Gamberale, il dirigente pubblico arrestato con l’accusa di
abuso d’ufficio e concussione, mostrerà la rassegna stampa che lo riguarda:
centinaia di pagine sulla sua condanna, appena tre fogli sull’assoluzione con
formula piena».
Vite distrutte dalla (mala) giustizia.
Troppi innocenti all’angolo. Arresti mai commessi,
accuse inesistenti, risarcimenti dopo 30 anni per negligenze di giudici e
avvocati: già oltre 7mila segnalazioni all’Associazione che li segue, scrive
Paola D’Amico il 15 settembre 2018 su "Il Corriere della Sera". Stordite,
incapaci di reagire, risucchiate in un labirinto senza uscita. Così le vittime
di malagiustizia raccontano di essersi sentite il giorno in cui si sono trovate
coinvolte in una vicenda giudiziaria di cui erano totalmente all’oscuro. Chi ha
dovuto affrontare un giudice fallimentare senza sapere perché, chi è stato
portato in carcere per reati mai commessi, chi s’è trovato il decreto di
sequestro preventivo sulla casa. Choc destinato a perpetuarsi nel tempo: riavere
la fedina penale immacolata può richiedere decenni. Mentre la vittima
invischiata in un’oscura vicenda giudiziaria viene trascinata in basso, i
risarcimenti (spesso) restano un miraggio. Infine, può suonare come una beffa il
fatto che, quand’anche una Corte avrà dettato l’agognata formula («assolto
perché il fatto non sussiste»), non ci sarà tribunale disposto a portare sul
banco degli imputati l’autore/autori dell’errore.
Tunnel senza uscita. Questa è la storia di Michele
Tedesco, imprenditore di Bari assolto con formula piena nove anni dopo l’arresto
per traffico internazionale di stupefacenti: nove anni che gli hanno distrutto
la vita. Che dire, poi, della vicenda del piccolo Angelo, morto a 3 anni,
investito da un pirata della strada: era il maggio 1984. Il risarcimento ai
genitori è arrivato 33 anni dopo. E ancora Luca, bollato come delinquente
abituale per uno scambio di persona: gli fu vietato di far ritorno nella
frazione di Frosinone dove lavorava. Fu riabilitato dopo un’istanza al Ministero
dell’Interno. La direzione centrale della Polizia Criminale cancellò i dati
erronei. Ma lui ne fu informato solo due anni dopo. Chi entra in questa spirale
- spiega Mario Caizzone, che ha fondato nel 2012 l’Associazione italiana vittime
di malagiustizia (Aivm)- viene triturato dal sistema». Ne è testimone diretto.
Nel ‘92, nel clima rovente di Mani Pulite, fu arrestato per colpe non sue: «Sono
trascorsi 22 anni per poter riavere la fedina penale immacolata». Per dieci non
ha potuto svolgere l’attività di commercialista: «Mi ha salvato la mia famiglia.
Ho sempre detto che se ne uscivo vivo - aggiunge - avrei fatto qualcosa per gli
altri. Ero benestante, sono finito sul lastrico». Le vittime, dice, sono i
«nuovi poveri». Come loro, «all’epoca fui sopraffatto dal panico, incapace di
reagire». Nell’ufficio milanese che s’affaccia sulla Stazione Centrale, in
piazza Luigi di Savoia 22, ogni giorno s’alternano 4/5 volontari: Valentina,
Carlo, Nicola e Tea, che ricorda il caso di un’anziana «alla quale
l’amministratore di sostegno sottrasse 40 mila euro». Molti sono laureandi in
giurisprudenza o esperti di marketing e comunicazione. Alle spalle hanno un pool
di consulenti. Il supporto alle «vittime» di malagiustizia è totalmente
gratuito. Il telefono squilla con insistenza. È una donna: «Non so cosa devo
fare», dice. Da due mesi scrive all’avvocato di fiducia per sapere com’è finita
la transazione con l’ex socio. L’udienza in tribunale è imminente. «Chieda al
giudice un rinvio, intanto prendiamo in mano il caso», risponde Caizzone, che
precisa: «Non rappresentiamo in giudizio queste persone ma le aiutiamo a
sbrogliare la matassa, le facciamo uscire dall’angolo».
Segnalazioni. In sei anni Aivm ha raccolto la
segnalazioni di 7 mila persone. Uomini, donne, giovanissimi e pensionati, oltre
la metà nei guai con la giustizia penale, altri a causa di banali querelle
familiari divenute per incanto tragedie apocalittiche. «Non di rado a monte di
tutto c’è la negligenza di un avvocato - aggiunge Caizzone - che perde la causa,
perché non fa le giuste contestazioni o non presenta il ricorso nei tempi
corretti». L’associazione, su invito della Commissione Giustizia della Camera ha
proposto la revisione della carcerazione preventiva: «Non ha senso, distrugge la
persona». Ha poi chiesto «la creazione di un intergruppo parlamentare per
ridiscutere il gratuito patrocinio a spese dello Stato». Attualmente, per come è
strutturato, «non dà garanzia. Chi controlla l’operato dell’avvocato
d’ufficio?». Infine, Aivm sottolinea un aspetto cruciale: «I nomi degli imputati
non devono essere divulgati fino all’udienza preliminare o al rinvio a giudizio,
per dare la possibilità agli imputati stessi di difendersi». Il tema al centro
è, innanzi tutto, la professionalità di avvocati e magistrati. «La giustizia
arranca». Serve una sorta di «tribunale del malato, una Corte di giustizia -
conclude Caizzone - che, oltre a dare supporto a chi si sente abbandonato, possa
entrare nel merito del loro operato».
Dentro il call center che ascolta le
vittime della malagiustizia. Innocenti in carcere e
sentenze scandalose. L'Aivm ha raccolto un dossier con 5mila casi, scrive Nino
Materi, Lunedì 09/04/2018, su "Il Giornale". C'è chi giura di aver visto l'ombra
di Marco Rivasi entrare nel portone in piazza Luigi di Savoia 22, a Milano,
proprio difronte alla stazione Centrale. Qui, al quarto piano, c'è la sede
dell'Associazione italiana vittime di malagiustizia (Aivm). Marco Rivasi non
esiste in carne ed ossa; lui è solo il personaggio letterario protagonista di
Malanni di stagione (Cairo Editore): riflessivo romanzo fresco di stampa del
giornalista Rai, Oreste Lo Pomo, imperniato appunto su un caso di malagiustizia.
Vicenda immaginaria, ma con trama terribilmente verosimile. Marco Rivasi viene
arrestato dopo che un imprenditore ha ammesso di aver corrotto politici e
funzionari per ottenere le autorizzazioni necessarie alla propria azienda. «È
solo un equivoco e presto verrà chiarito», ripete Davide, l'amico che fa il
cronista di giudiziaria. Ad affiorare è invece il nervo scoperto di un sistema
malato, capace di infettare chi si ritrova con corpo e anima maciullati nel
tritacarne dei tribunali. Un'esperienza dolorosa che Mario Caizzone, presidente
dell'Aivm, conosce bene per averla patita direttamente. Caizzone infatti - a
differenza del Mario Rivasi uscito dalla penna di Lo Pomo - della malagiustizia
è stato una vittima reale, e proprio da questa sventura nel 2011 nacque l'idea
di fondare l'Aivm. In sei anni di attività l'associazione ha seguito circa 5
mila casi di persone che si sono trovati a combattere contro il moloc di una
scritta falsamente rassicurante: «La Legge è uguale per tutti». «La legge non è
uguale per tutti, ma - ciò che è più grave - la legge non sempre è giusta - dice
Caizzone, portandoci in una stanza dove due studentesse di Giurisprudenza si
dividono tra computer e telefono -. Il nostro è un osservatorio e un centro di
ascolto unico nel suo genere. In Italia non c'è nulla di simile, perché non
interessa a nessuno aiutare gratuitamente chi si perde nei labirinti dei codici
o delle aule giudiziarie». E questo in un Paese considerato la culla del
diritto. Un diritto che spesso rischia di essere inghiottito nelle sabbie mobili
dei tempi lunghi, dimenticando che - come ripeteva Indro Montanelli - una
giustizia che arriva dopo anni di attesa è sempre una giustizia negata, anche (e
soprattutto) in caso di assoluzione. In galera, da innocenti; vite distrutte, da
innocenti; esistenze segnate, da innocenti. In questa sorta di «call center
della malagiustizia» che è l'Aivm, di storie simili ne passano decine ogni
settimana. «Un'esperienza umana e professionale coinvolgente che vale più di
tante lezioni universitarie», ci dicono le «giuriste» volontarie
dell'Associazione. «Voi giornalisti non avete il coraggio di raccontare certe
vicende - ci sfida Caizzone -. Come quella di un avvocato che, pur sapendo che i
termini per il ricorso in Cassazione erano scaduti, lo ha presentato ugualmente
e - cosa ancor più grave - si è fatto pagare la parcella: denaro, tra l'altro,
incassato senza rilasciare alcuna fattura. Il suo cliente lo ha denunciato, ma
non è riuscito a trovare nessun avvocato disposto a difenderlo. E sa il motivo?
Perché il legale denunciato è il presidente dell'Ordine degli avvocati della sua
regione. Abbiamo segnalato il caso in procura, ma il risultato è che abbiamo
trovato in foto quello stesso avvocato insieme con il magistrato che avrebbe
dovuto dare corso alla nostra denuncia». Sul sito dell'Aivm scorrono le vicende
di Luca, «cui è stato vietato di far ritorno nel suo paese, per reati che non ha
mai commesso»; di Michele che «è rimasto vittima di un errore giudiziario che
gli ha stravolto la vita»; di Giuseppe «titolare di un'attività di alimentari
truffato dal suo legale di fiducia». Odissee che ricordano i drammi trattati da
Sono innocente la trasmissione di Rai3 di Alberto Matano che, proprio da quel
programma, ha ora tratto un libro: «Non sarebbe male se i soldi guadagnati col
libro fossero destinati alla nostra associazione - scherza Caizzone -. Nella sua
trasmissione Matano ha trattato un caso seguito dall'Aivm, ma la parte in cui il
protagonista ci ringraziava non l'ha mandata in onda. Inoltre perché Matano non
cita mai i nomi dei giudici? Cosa fa, in concreto, Matano per le vittime del
sistema giudiziario? Pubblicizzare in tv le loro storie può rivelarsi più
dannoso che utile, riaprendo vecchie ferite». Sarà d'accordo anche Marco Rivasi?
Sono Innocente: Alberto Matano torna su
Rai3 con nuovi casi di «giustizia ingiusta», scrive
domenica 8 aprile 2018 Marco Leardi su "Davide Maggio". Se, da una parte, i
nuovi programmi di Rai3 faticano a decollare negli ascolti (Cyranosta
addirittura cadendo in picchiata), dall’altra il canale diretto da Stefano
Coletta può contare su un ritorno che, in tal senso, fa almeno nutrire qualche
speranza. Ci riferiamo al debutto della seconda edizione di Sono Innocente, il
programma condotto da Alberto Matano e dedicato ai casi di “giustizia ingiusta”.
La trasmissione ripartirà stasera in prime time con un ciclo di sei nuove
puntate. Al centro del racconto, guidato dall’anchorman del Tg1 approdato a Rai3
sotto la direzione di Daria Bignardi, ci saranno ancora storie di errori
giudiziari, di innocenti condannati ingiustamente, detenuti, poi scarcerati e
risarciti dallo Stato. Veri e propri drammi consumatisi nelle aule di tribunale,
ma anche vicende di riscatto presentate attraverso la voce dei loro protagonisti
e delle persone che le hanno condivise. Le testimonianze saranno supportate
da dettagliate ricostruzioni. In questa nuova stagione, il racconto si dividerà
in tre momenti distinti, con tre storie differenti tra loro, ma con lo stesso
denominatore: la “giustizia ingiusta”. La prima puntata si aprirà con la storia
di Elaine Silva, una ballerina di origini brasiliane giunta in Italia all’età di
23 anni per lavorare come barista e animatrice nei parchi acquatici della
riviera romagnola. La sua vita cambia quando viene arrestata per traffico di
droga. Nell’appartamento che condivide con un’amica, una sera, a sua insaputa,
si ferma a dormire uno spacciatore internazionale. Il giorno successivo si trova
coinvolta in una retata effettuata all’interno dell’abitazione. Elaine viene
così portata via e rinchiusa in carcere. Passeranno 9 mesi prima che possa
essere riconosciuta innocente. Il secondo caso è considerato l’errore
giudiziario più clamoroso dei nostri tempi. La notte del 17 giugno del 1983
avviene il blitz anticamorra più spettacolare della storia. Vengono arrestati
camorristi, assassini, ergastolani e spacciatori. Fra di loro spicca però un
uomo insospettabile: Enzo Tortora. L’accusa è di partecipazione alla Nuova
Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Sono dei pentiti ad accusarlo di essere
un affiliato alla NCO, nonché un trafficante di droga. Il carcere, l’umiliazione
delle manette, la gogna mediatica. Per diversi mesi Enzo Tortora è il mostro da
sbattere in prima pagina. Dopo sette mesi in prigione, gli vengono concessi gli
arresti domiciliari; si candida alle elezioni europee con i radicali per poter
portare il suo caso in Europa. E’ il giugno del 1984 quando viene eletto, pochi
mesi prima della condanna in I° grado: 10 anni per spaccio di droga. In appello,
dopo una potente arringa di 20 minuti contro i suoi accusatori, viene assolto.
Muore nel 1988 dopo una lunga malattia. Alberto Matano ne parlerà in studio con
la figlia Gaia Tortora. Lorena Morselli, protagonista dell’ultima vicenda, è
stata accusata del crimine peggiore che si possa immaginare: aver abusato dei
propri figli e di altri bambini con la complicità di un gruppo di adulti. A
puntare il dito contro di lei, suo marito e altre 18 persone, tutte residenti
nella provincia di Modena, sono gli stessi bambini, che tra il 1997 e il 1998,
ascoltati da un’assistente sociale dell’Asl di Mirandola, raccontano di abusi
sessuali, messe nere e riti satanici con sacrifici umani. Uno scenario da film
horror che, dopo quasi vent’anni di processi, si rivelerà essere uno dei più
gravi errori giudiziari del nostro Paese.
SONO INNOCENTE. ELAINE ARAUCO DA SILVA.
La ballerina di Rimini e Riccione
condannata, poi assolta, stasera su Rai 3, scrive l'8
aprile 2018 romagnauno.it. Alberto Matano torna questa sera, domenica 8 aprile,
con la nuova stagione di Sono innocente, in onda su Rai3 a partire dalle 21.25.
Apre la serie Eliana, la ballerina brasiliana di Rimini e Riccione,
condannata per traffico di droga ingiustamente e scarcerata dopo un anno di
galera. Elaine, una ballerina di origini brasiliane che si esibiva nei locali
tra Rimini e Riccione: è stata accusata di traffico di droga. Nella stessa casa
dove era ospite aveva dormito uno spacciatore e tanto è bastato a inguaiarla. Ma
lei non lo conosceva neppure. La ragazza, bellissima, si era semplicemente
trovata al posto sbagliato al momento sbagliato. Fidandosi degli amici
connazionali, aveva accettato la loro ospitalità. Mai avrebbe immaginato che
quella sera sarebbe giunto dall’Olanda un uomo imbottito di droga, che aveva
ingoiato decine e decine di ovuli colorati pieni zeppi di cocaina. E mai avrebbe
pensato che quel trafficante internazionale alloggiava proprio lì, a casa degli
amici che le avevano offerto ospitalità per qualche tempo. Quando il giorno dopo
aveva aperto allibita ai carabinieri di La Spezia che senza tanti complimenti le
avevano infilato le manette ai polsi, lei aveva urlato la sua innocenza a più
non posso. E così Elaine Arauco Da Silva, questo il suo nome, si è trovata
carcere dove è rimasta per un anno. Il 10 novembre del 2009 è stata pronunciata
la parola fine sul quell’incubo. Un incubo che per lei è stato ancora più brutto
perché le ha spazzato via un sogno, quello di sposare il suo bel Emin Boztepe,
campione di arti marzali di origine turca, diventato poi divo di Hollywood.
L’uomo era volato dalla California a Rimini per testimoniare davanti ai giudici
e spiegare che la ragazza con quell’affare di droga non poteva centrare nulla,
visto che i due avevano altri progetti, tra cui i fiori d’arancio. Ma poi,
chiusa la parentesi, il bel giovane aveva rotto il fidanzamento, forse temendo
un coinvolgimento che avrebbe potuto danneggiare la sua immagine di divo.
Stasera in Tv parla Eliana.
Elaine Arauco Da Silva. La ballerina
brasiliana assolta dopo 1 anno di galera: ma perde tutto (Sono innocente).
Il caso di Elaine Arauco Da Silva, ballerina brasiliana assolta dopo un anno di
galera, sarà al centro della prima puntata di "Sono innocente" in onda su Rai,
scrive l'8 Aprile 2018 Morgan k. Barraco su "Il Sussidiario". L'incubo di Elaine
Arauco Da Silva è ormai finito anni fa, in seguito all'accusa per droga e al
successivo arresto. A causa di quella vicenda tuttavia la ballerina brasiliana
ha perso tutto, amici, connazionali e persino l'uomo che avrebbe voluto sposare.
Tutto inizia nella notte del 2008, quando un uomo imbottito di droga, Gabriel
Arcangel Sanchez Guerrero, viene arrestato in seguito all'arrivo in Italia
dall'Olanda e durante un soggiorno a casa di alcuni amici della donna. Il caso
di Elaine Arauco Da Silva verrà approfondito nella puntata di Sono Innocente di
questa sera, domenica 8 aprile 2018, grazie al programma di Rai 3. Nessuno
all'epoca decide di credere alla donna, che viene fermata dai carabinieri di La
Spezia e trasportata in carcere. A nulla serve che sottolinei la propria
innocenza: nessuno vuole crederle. Rimarrà quindi in carcere per un anno,
sottolinea Romagna Noi, e la sua vicenda giudiziaria si concluderà solo sei mesi
più tardi. Il mancato matrimonio con il campione di arti marziali, il turco Emin
Boztepe, è solo una delle conseguenze di quel giorno: l'uomo verrà convocato a
Rimini per testimoniare a favore dell'imputata, ma deciderà comunque di rompere
il loro fidanzamento.
Le accuse e la fine del fidanzamento. La sua colpa
è stata di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato: Elaine Arauco Da
Silva pagherà caro l'ospitalità richiesta ad alcuni amici di Rimini, alcuni
giorni prima dell'arresto di un Olandese ritrovato con un forte carico di droga
nel corpo. La ballerina brasiliana in quei giorni crede di trovarsi in vacanza,
mentre il fidanzato Emin Boztepe la aspetta in California. I due stanno
organizzando il loro matrimonio imminente, frutto di un fidanzamento pieno di
passione. Eppure quel giorno tutto è destinato a cambiare: i Carabinieri si
presenteranno alla porta di quell'appartamento in cui Elaine si trova da pochi
giorni e l'arrestano. L'uomo arrestato è stato infatti trovato con decine e
decine di ovuli di cocaina che ha ingoiato prima del suo viaggio che dall'Olanda
lo ha portato fino in Italia. A nulla serviranno le parole della donna, che si
dichiarerà subito innocente. Ed a nulla servirà la testimonianza del fidanzato,
che confermerà di fronte ai giudici come i loro progetti in comune non prevedano
di certo il traffico internazionale di droga. Elaine verrà rilasciata solo
diverso tempo dopo e perderà la possibilità di sposare il divo californiano, che
ha deciso di lasciarla sola al suo destino. Elaine non è la sola ad essere stata
arrestata quel giorno: tutte le altre persone che in quel giorno si trovano
nello stesso appartamento verranno tradotte in carcere. Fra queste, sottolinea
Errori Giudiziari, anche la madre anziana di una delle inquiline. In seguito i
giudici stabiliranno come la colpa fosse solo di Sanchez Guerrero, condannato a
8 anni per traffico di droga. Grazie all'aiuto del legale, l'avvocato Piero
Venturi, Elaine verrà infine riconosciuta come innocente e chiederà allo Stato
Italiano un risarcimento che comprenda i danni morali per via del matrimonio
mancato, oltre che per la detenzione ingiusta. Sembra che un anno dopo abbia
ritrovato l'amore grazie all'incontro con un altro uomo, riuscendo a coronare il
suo sogno di diventare madre. La tragedia vissuta tuttavia rimarrà sul suo corpo
come una cicatrice indelebile.
I motivi dell’arresto. Perché le autorità italiane
hanno deciso di prolungare il carcere di Elaine Arauco Da Silva, la ballerina
brasiliana che nel 2008 è stata accusata di traffico internazionale di droga?
Tutto parte dalle indagini dei Carabinieri di La Spezia su Gabriel Arcangel
Sanchez Guerrero, che al fianco di altre undici persone verrà individuato come
spacciatore di un cartello che comprende diverse regioni e Paesi. Dall'Emilia
Romagna fino all'Olanda e dalla Spagna fino alla Toscana. Il gruppo di criminali
opera su diversi territori grazie allo spaccio di cocaina ed eroina. Guerrero,
all'epoca dei fatti 34enne, viene individuato come parte dell'anello di
congiunzione fra l'estero e Rimini, dove operava al fianco della madre Olinda
Santiago Ogando, di 70 anni, e la sorella Matilde. Quest'ultima avrebbe
coinvolto, secondo quanto sottolinea Il Secolo XIX, l'amica e ballerina Elaine
Arauco Da Silva. In quegli anni appena 30enne, la ragazza infatti soggiornava
nell'appartamento della famiglia Sanchez Guerrero proprio nei giorni in cui
vengono effettuati i primi arresti all'interno del cartello. In seguito al fermo
di Francisca Gomez, una connazionale e corriere di droga, Guerrero avrebbe
infatti deciso di ritirare di persona il carico in Olanda.
SONO INNOCENTE. ENZO TORTORA.
Enzo Tortora. Dopo 30 anni le scuse del
pm che fece arrestare il giornalista (Sono Innocente).
Il caso di Enzo Tortora, giornalista accusato di essere colluso con la camorra,
sarà trattato nella prima puntata di "Sono innocente", in onda questa sera su
Rai, scrive l'8 Aprile 2018 Morgan k. Barraco su "Il Sussidiario". A distanza di
trent'anni dalla sua morte, Enzo Tortora rimane il simbolo dell'ingiustizia
giudiziaria. Il giornalista è stato infatti al centro di un'oscura vicenda che
lo ha portato dietro le sbarre da innocente, anche se riconosciuto come tale
solo diversi anni dopo il suo arresto. Il caso di Enzo Tortora verrà discusso
nella puntata di Sono Innocente di questa sera, domenica 8 aprile 2018, grazie
alla prima puntata del programma di Rai 3. Rimangono nella storia le lettere che
il conduttore di Portobello scrisse all'epoca a Francesca Scopelliti, la sua
compagna, in seguito a quella retata che lo confinò in carcere con l'accusa di
collusione con la Camorra. Sono recenti invece le scuse del Magistrato Diego
Marmo, che durante il maxi processo di Raffaele Cutolo fu fra i più grandi
accusatori di Tortora. "Dopo trent'anni è arrivato il momento. Mi sono portato
dietro questo tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla famiglia di Enzo
Tortora per quello che ho fatto", ha detto Marmo a Rai News nel 2014. Parole che
l'ex magistrato, oggi in pensione, ha pronunciato tra l'altro per la prima volta
in seguito alle critiche ricevute riguardo alla sua entrata in politica.
Le lettere a Francesca. Il caso di Enzo
Tortora verrà sempre associato all'ingiustizia giudiziaria. Il giornalista,
negli anni Ottanta fra i più in vista della tv italiana, viene accusato nel
giugno dell'83 in base ad alcune parole di un pentito della Camorra. L'arresto è
immediato: è qui che inizia il calvario di Tortora, che lo spingerà a impegnarsi
in modo attivo nella difesa dei diritti umani. La sua assoluzione arriva solo
quattro anni più tardi grazie a una sentenza della Cassazione, ma ormai il suo
caso è diventato simbolo del malfunzionamento delle ruote della giustizia
italiana. Di quegli anni trascorsi dietro le sbarre rimangono come documento
storico le lettere che a pochi giorni dal suo arresto invia alla compagna
Francesca Scopelliti. Dalla sua cella 16 bis di Regina Coeli, Tortora spedisce
una lettera in cui denuncia il proprio dolore per via di quelle accuse che lo
vedono come trafficante di droga al soldo della camorra. Sarà il primo di 45
testi che in seguito formeranno il libro edito da Pacini e dal titolo “Lettere a
Francesca”, come sottolinea La Repubblica. Nei suoi scritti Enzo Tortora
sottolinea come sia rimasto colpito dall'arresto, avvenuto grazie ad una maxi
retata che porterà in manette 856 persone. Nelle sue parole il dramma di quel
momento, soprattutto per le condizioni in cui è costretto a vivere e per
l'impossibilità di avere un confronto diretto con chi lo ha accusato.
Enzo Tortora e l’arresto nel 1983. L'arresto
di Enzo Tortora viene effettuato nel giugno del 1983, grazie all'intervento dei
Carabinieri di Roma che bussano alla sua porta alle quattro del mattino. Le
accuse di traffico di droga e associazione a organizzazione di stampo mafioso
sono dovute alle rivelazioni di Giovanni Melluso, Giovanni Pandico e Pasquale
Barra, pentiti mafiosi che al fianco di altri otto imputati, indicheranno nel
giornalista uno dei conniventi della camorra. Il tutto viene avvalorato grazie a
un'agendina ritrovata nell'abitazione del camorrista Giuseppe Puca, in cui è
presente il nome del giornalista. Un elemento che in seguito venne attribuito a
un errore calligrafico, in cui la lettera “r” del cognome di Tortora era stata
scambiata per la “n” del nome scritto in realtà fra quelle pagine. Emergono nei
giorni seguenti altri particolari, fra cui alcuni centrini che Giovanni Pandico
invia al conduttore perché li vendesse all'asta grazie al programma di cui è a
guida, Portobello. In seguito allo smarrimento degli oggetti, Tortora scrive
infatti una lettera di scuse al camorrista, allegando un assegno di rimborso.
Il sostegno di Indro Montanelli e Enzo Biagi. Da
non sottovalutare l'impatto mediatico ed emotivo che ha avuto sulla popolazione
l'arresto di Enzo Tortora. All'epoca infatti il caso crea un grande scandalo
nazionale, tanto che tv e stampa continuano a pubblicare e trasmettere le
immagini che inquadrano il giornalista in manette, in occasione del suo arresto.
Tortora viene tra l'altro attaccato anche in ambiente giornalistico, soprattutto
per via di quella fuga di notizie avvenuta pochi giorni prima il suo arresto, e
tale da permettere a diversi colleghi di affondare il colpo. Dalla parte di
Tortora si schierano invece grandi firme, come quella di Indro Montanelli e Enzo
Biagi. Soprattutto quest'ultimo decide di andare contro corrente e scrivere una
lettera al presidente Sandro Pertini, pubblicandola su La Repubblica nell'agosto
del 1983 e con cui chiede che possa intervenire nel caso di Enzo Tortora. Biagi
in particolare non riesce a spiegarsi come mai 200 arrestati in quella stessa
maxi retata erano riusciti a ritornare in libertà, mentre il collega continuava
a rimanere in carcere, senza alcuna possibilità di difendersi.
Enzo Tortora chi?
Trent’anni dopo il gioco a far finta di niente.
Il giornalista liberale perseguitato dalla magistratura e dai giornalisti e
difeso solo dai radicali moriva ucciso da un cancro maturato durante la
detenzione ingiusta, scrive Piero Sansonetti il 18 Maggio 2018 su "Il Dubbio".
Trent’anni fa moriva Enzo Tortora. Il 18 maggio del 1988. Era un grande
giornalista, conservatore e liberale. Aveva subìto una persecuzione giudiziaria
feroce e assolutamente irragionevole. Tortora è stato il testimone di come la
giustizia possa esercitare il suo enorme potere in modo malvagio e in spregio
del diritto. Assecondata e applaudita dal giornalismo. Fu arrestato all’alba del
17 giugno del 1983, a Roma, trascinato in manette in una caserma dei carabinieri
e poi, in manette, mostrato ai giornalisti e ai fotografi e infine, a sera,
chiuso in cella per sette mesi. Più molti altri mesi di arresti domiciliari. Era
accusato di essere un camorrista, uno spacciatore di droga e un mercante di
morte. Era del tutto, del tutto, del tutto innocente. Qualche giorno dopo il suo
arresto Camilla Cederna, giornalista ultra- liberal, di sinistra, indipendente,
spregiudicata, cronista di inchiesta e di prima linea, prestigiosissima,
scrisse: «Mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole: non si va ad
ammanettare uno del cuore della notte se non ci sono buone ragioni. Il
personaggio non mi è mai piaciuto». C’è tutto in questa breve frase. C’è il
cuore del colpevolismo cieco (” se lo hanno arrestato vuol dire che qualcosa
l’ha fatta”: pare che sia la stessa frase che fu ripetuta migliaia di volte in
Argentina, dopo il golpe di Videla e gli arresti di massa degli oppositori). C’è
l’idea che l’accusa è essa stessa dimostrazione della colpa. C’è l’infallibilità
dei giudici. C’è l’antipatia personale come prova a carico. C’è il principio
dell’intoccabilità rovesciata, e cioè la convinzione che il prestigio personale,
o la fama, o il potere di una persona, presunta intoccabile, siano in realtà
evidenze certe di reato. Tortora era innocentissimo ma l’intera stampa italiana
si schierò contro di lui e lo riempì di fango, tranne pochissime eccezioni:
Biagi, Montanelli. E l’intera magistratura diede totale copertura prima al
giudice istruttore che lo aveva fatto incarcerare senza prove e senza indizi, e
poi ai pubblici ministeri che – senza prove e senza indizi – lo fecero
condannare a 10 anni di carcere. La magistratura poi si riscattò, con la
sentenza di appello, che fu di piena assoluzione e di furiosa e appassionata
condanna del lavoro sciatto e indegno svolto dai magistrati che lo avevano
condannato. Tortora fu condannato sulla semplice testimonianza di alcuni
pentiti, del tutto inaffidabili, e teleguidati – che ottennero in cambio sconti
di pena – senza la possibilità del minimo riscontro. In appello gli indizi e le
testimonianze furono smontati uno ad uno, in modo inconfutabile, ma erano stati
già smontati nel primo grado e in istruttoria, però i giudici del primo grado e
dell’istruttoria se ne erano infischiati delle prove a difesa. La magistratura
si riscattò con la sentenza d’appello. Il giornalismo non si riscattò mai. Anche
la politica ebbe in gran parte un atteggiamento infame sul caso Tortora. Più o
meno tutto il mondo politico, eccetto, naturalmente, i radicali (che si
batterono al suo fianco in modo eroico, subissati dalle critiche e dagli
scherni), e i socialisti. E’ stato il caso più famoso di errore giudiziario.
Voluto, cercato, difeso con arroganza dal potere. Il più famoso: non l’unico,
tranquilli, non l’unico. Dal caso Tortora nacque il referendum sulla
responsabilità civile dei magistrati, vinto dai radicali, ma poi smantellato dal
governo. E dal caso Tortora nacquero le prime battaglie garantiste, che piano
piano ottennero dei risultati: gracili, sparuti, ma non inesistenti. Oggi il
trentesimo anniversario della morte di Tortora, ucciso da un cancro che aveva
maturato in carcere, coincide con la presentazione del programma del nuovo
governo. E in questo programma ci sono delle proposte di riforma della macchina
giudiziaria che fanno tremare le vene e i polsi. Più intercettazioni (oggi siamo
il paese con più intercettazioni al mondo, ne abbiamo cento volte cento – più
della Gran Bretagna), riduzione o cancellazione della prescrizione, aumento
delle pene per i reati contro il patrimonio e per la corruzione, fine delle
conquiste di politica carceraria ottenute dagli anni ottanta (riforma Gozzini)
in poi dalle forze democratiche, introduzione degli agenti provocatori che si
affiancherebbero ai pentiti in una logica vicinissima a quella che guidò i Pm
del caso Tortora ( i quali Pm, salvo uno, non hanno mai chiesto scusa). E’ molto
triste questa coincidenza. È anche molto preoccupante. Per fortuna un programma
di governo non è legge. Va portato in Parlamento, va discusso, deve superare il
vaglio della Corte Costituzionale. Esistono in Parlamento le forze liberali in
grado di opporsi a questa svolta di ispirazione autoritaria, che non ha
precedenti nella storia della Repubblica? Avranno, queste forze, la capacità e
il coraggio per battersi e per fermare questa svolta? Dipenderà anche dai
giornali, dalle Tv. Dall’atteggiamento che assumeranno nei confronti del
programma di governo. A leggere i giornali di questi giorni si ha l’impressione
che l’intellettualità italiana, e il giornalismo, non siano molto preoccupati
per il futuro della giustizia. Li indigna, forse giustamente, l’organo di
garanzia previsto dal “contratto” e probabilmente incostituzionale, ma nessuno è
indignato, o colpito, anzi nessuno si occupa, della proposta di mettere in
prigione i bambini. E questo non è di buon auspicio. Possibile che il
giornalismo italiano sia rimasto quello delle frasi tremende di Camilla Cederna?
Enzo Tortora, la pagina più
nera per il giornalismo e la magistratura.
Trent’anni fa moriva il giornalista, stroncato da un tumore dopo aver subito
anni di persecuzione giudiziaria e mediatica volontaria e in malafede, scrive
Valter Vecellio il 18 Maggio 2018 su "Il Dubbio". Riavvolgere il nastro del
ricordo, perché il caso Tortora non scolorisca nella memoria collettiva e
individuale; e perché tanti sono quelli che possiamo definire “gli eroi della
sesta giornata”: coloro che ora si “esibiscono” nel tentativo di accaparrarsi
dei meriti che non hanno, ben altro è stato a suo tempo il comportamento tenuto;
ben altre le posizioni assunte. Il 18 maggio 1988 Enzo Tortora ci lasciava,
stroncato da un tumore, conseguenza – si può fondatamente ritenere – anche del
lungo e ingiusto calvario patito. Anni dopo, Carlo Verdelli (non l’ho mai fatto,
me ne dolgo, lo ringrazio ora), su “Repubblica”, scrive: “Non fosse stato per i
radicali (da Pannella a Bonino, da Giuseppe Rippa a Valter Vecellio) che lo
elessero simbolo della giustizia ingiusta e lo fecero eleggere a Strasburgo. Non
fosse stato per Enzo Biagi che a sette giorni da un arresto che, dopo gli
stupori, stava conquistando travolgenti favori nell’opinione pubblica, entrò
duro sui frettolosi censori della prima ora con un editoriale controcorrente: “E
se Tortora fosse innocente?”. Non fosse stato per l’amore e la fiducia
incrollabile delle figlie e delle compagne (da Pasqualina a Miranda, prima e
seconda moglie, fino a Francesca, la convivente di quell’ultimo periodo). Non
fosse stato per i suoi avvocati, Raffaele Della Valle e il professor Alberto
Dall’Ora, che si batterono per lui con una vicinanza e un ardore ben al di là
del dovere professionale. Non fosse stato per persone come queste, i 1.768
giorni che separano l’inizio del calvario di Enzo Tortora (17 giugno 1983,
prelevato alle 4 del mattino all’hotel Plaza di Roma) dalla fine della sua
esistenza (18 maggio 1988, cancro ai polmoni), sarebbero stati di meno, nel
senso che avrebbe ceduto prima”. Tortora è arrestato nel cuore della notte e
trattenuto nel comando dei carabinieri di via Inselci a Roma, fino a tarda
mattinata: lo si fa uscire solo quando si è ben sicuri che televisioni e
giornalisti sono accorsi per poterlo mostrare in manette. La prima di una
infinita serie di mascalzonate. Con Enzo nasce una solida amicizia; conservo
parecchie sue lettere, scritte dal carcere, a rileggerle ancora oggi, trascorsi
tanti anni, corre un brivido.
16 settembre 1983: “Da tempo
volevo dirti grazie… Hai “scommesso” su di me, subito: con una purezza e un
entusiasmo civile che mi commossero immensamente. Vincerai, naturalmente, la tua
“puntata”. Ma a prezzo di mie sofferenze inutili e infinite. Io sono stato il
primo a dire che il “caso Tortora è il caso Italia”. Non intendo avere
trattamenti di favore, o fruire di scorciatoie non “onorevoli”. Se dal mio male
può venire un po’ di bene per la muta, dolente popolazione dei 40mila sepolti
vivi nei lager della democrazia, e va bene, mi consolerà questo”.
2 maggio 1984: “… Che si
faccia strame della libertà di un uomo, della sua salute, della sua vita, come
può esser sentito come offesa alla libertà, alla vita, alla salute di tutti in
un Paese che non ha assolutamente il senso sacro, della propria dignità e delle
libertà civili? Non è vero che l’Italia “ha abolito la pena di morte”. Abbiamo
un boja in esercizio quotidiano, atroce, instancabile. Ma non vogliamo vederlo.
La sua scure si abbatte, ogni minuto, sul corpo di uomini e di donne, e li
squarta vivi, in “attesa” di un giudizio che non arriva mai. L’uomo qui è
niente, ricordatevelo. L’uomo qui può, anzi deve attendere. L’uomo qui è una
“pratica” che va “evasa” con i tempi, ignobili, della crudeltà nazionale…”.
15 luglio 1985: “… In questa
gara, tra chi pianta più in fretta i chiodi, come al luna park dell’obbrobrio
giudiziario, e i pochi che si ribellano, sta tutta la mostruosa partita. Vedere
a che lurido livello s’è ridotta la dignità di questo Paese è cosa che mi
annienta più d’ogni altra. So che sei coi pochi. Da sempre. Te ne ringrazio,
fraternamente”.
7 ottobre 1985: “… Sono stato
condannato e processato dalla N. G. O., Nuova Giustizia Organizzata. Io spero
che questa fogna, che ormai nessun tombino può contenere, trabocchi e travolga
chi lo merita…”.
2 aprile 1986: “… Diffamatori
è poco: sapevano quel che facevano. Ma per pura voluttà scandalistica, per pura,
stolida ferocia, qui si getta fango sino all’estremo. Ho paura di questi
cannibali. Ho soprattutto vergogna di essere italiano…”.
17 agosto 1987: “… Siamo
molti… ma troppo pochi per spezzare la crosta di ottusa indifferenza che copre e
fascia la rendita di alcuni farabutti mascherati da Magistrati. Tanto più
importante e notevole il vostro impegno. Tenteremo, sul caso Melluso, quel che
si potrà. Ho inviato al ministro Vassalli l’incredibile servizio, gli ho anche
detto che i responsabili hanno nome e cognome: Felice Di Persia, Lucio Di
Pietro, Giorgio Fontana, Achille Farina, Carlo Spirito… Sono ancora lì, al loro
posto… Staremo a vedere…”.
Manca, tuttavia, a distanza di
tanti anni da quei fatti, la risposta alla quinta delle classiche domande
anglosassoni che dovrebbero essere alla base di un articolo: “Perché?”. Alla
ricerca di una soddisfacente risposta, si affonda in uno dei periodi più oscuri
e melmosi dell’Italia di questi anni: il rapimento dell’assessore
all’urbanistica della Regione Campania, il democristiano Ciro Cirillo da parte
delle Brigate Rosse di Giovanni Senzani, e la conseguente, vera, trattativa tra
Stato, terroristi e camorra di Raffaele Cutolo.
Il cuore della vicenda è qui.
Sono le 21.45 del 27 aprile 1981 quando le Brigate Rosse sequestrano Cirillo.
Segue una frenetica, spasmodica trattativa condotta da esponenti politici della
DC, Cuto- lo, uomini dei servizi segreti per “riscattarlo”. Viene chiesto un
riscatto, svariati miliardi. Il denaro viene trovato. Durante la strada una
parte viene trattenuta non si è mai ben capito da chi. Anche in situazioni come
quelle c’è chi si prende la “stecca”. A quanto ammonta il riscatto? Si parla di
circa cinque miliardi. Da dove viene quel denaro? Raccolto da costruttori amici.
Cosa non si fa, per amicizia! Soprattutto se poi c’è un “ritorno”. Il “ritorno”
si chiama ricostruzione post- terremoto, i colossali affari che si possono fare;
la commissione parlamentare guidata da Oscar Luigi Scalfaro accerta che la torta
era costituita da oltre 90mila miliardi di lire. Peccato, molti che potrebbero
spiegare qualcosa, non sono più in condizione di farlo: sono tutti morti
ammazzati, da Vincenzo Casillo luogotenente di Cutolo a Giovanna Matarazzo,
compagna di Casillo; da Salvatore Imperatrice che ebbe un ruolo nella
trattativa, a Enrico Madonna, avvocato di Cutolo; e Antonio Ammaturo, il
poliziotto che aveva ricostruito il caso Cirillo in un dossier spedito al
Viminale, “mai più ritrovato”. Questo il contesto. Ma quali sono i fili che
legano Tortora, Cirillo, la camorra, la ricostruzione post- terremoto?
Ripercorriamoli qui i termini di una questione che ancora “brucia”. Cominciamo
col dire che: Tortora era un uomo perbene, vittima di un mostruoso errore
giudiziario. Che il suo arresto costituisca per la magistratura e il giornalismo
italiano una delle pagine più nere e vergognose della loro storia, è assodato.
“Cinico mercante di morte”, lo definisce il Pubblico Ministero Diego Marmo; e
aggiunge: “Più cercavamo le prove della sua innocenza, più emergevano elementi
di colpevolezza”. Le “prove” erano la parola di Giovanni Pandico, un camorrista
schizofrenico, sedicente braccio destro di Cutolo: lo ascoltano diciotto volte,
solo al quinto interrogatorio si ricorda che Tortora è un camorrista. Pasquale
Barra detto ‘ o nimale: in carcere uccide il gangster Francis Turatello e ne
mangia l’intestino… Con le loro dichiarazioni, Pandico e Barra danno il via a
una valanga di altre accuse da parte di altri quindici sedicenti “pentiti”:
curiosamente, si ricorda-no di Tortora solo dopo che la notizia del suo arresto
è diffusa da televisioni e giornali. Arriviamo ora al nostro “perché?” e al
“contesto”. A legare il riscatto per Cirillo raccolto dai costruttori –
compensati poi con gli appalti – e la vicenda Tortora, non è un giornalista
malato di dietrologia e con galoppante fantasia complottarda. È la denuncia,
anni fa, della Direzione Antimafia di Salerno: contro Tortora erano stati
utilizzati “pentiti a orologeria”; per distogliere l’attenzione della pubblica
opinione dal gran verminaio della ricostruzione del caso Cirillo, e la
spaventosa guerra di camorra che ogni giorno registra uno, due, tre morti
ammazzati tra cutoliani e anti- cutoliani. Fino a quando non si decide che
bisogna reagire, fare qualcosa, occorre dare un segnale. E’ in questo contesto
che nasce “il venerdì nero della camorra”, che in realtà si rivelerà il “venerdì
nero della giustizia”: 850 mandati di cattura, e tra loro decine di arrestati
colpevoli di omonimia, gli errori di persona. Nel solo processo di primo grado
gli assolti sono ben 104… Documenti ufficiali, non congetture. Come un documento
di straordinaria e inquietante efficacia, l’intervista fatta per il “TG2” con
Silvia, la figlia di Enzo.
Quando suo padre fu arrestato,
oltre alle dichiarazioni di Pandico e Barra cosa c’era?
“Nulla”.
Suo padre è mai stato
pedinato, per accertare se davvero era uno spacciatore, un camorrista?
“No, mai”.
Intercettazioni telefoniche?
“Nessuna”.
Ispezioni patrimoniali,
bancarie?
“Nessuna”.
Si è mai verificato a chi
appartenevano i numeri di telefono trovati su agende di camorristi e si diceva
fossero di suo padre?
“Lo ha fatto, dopo anni, la
difesa di mio padre. E’ risultato che erano di altri”.
Suo padre è stato definito
cinico mercante di morte. Su che prove?
“Nessuna”.
Suo padre è stato accusato di
essersi appropriato di fondi destinati ai terremotati dell’Irpinia. Su che
prove?
Nessuna. Chi lo ha scritto è
stato poi condannato”.
Qualcuno le ha mai chiesto
scusa per quello che è accaduto?
“No”. Candidato al Parlamento
Europeo nelle liste radicali, eletto, chiede sia concessa l’autorizzazione a
procedere, che invece all’unanimità viene negata. A questo punto, Tortora si
dimette e si consegna all’autorità, finendo agli arresti domiciliari. Diventa
presidente del Partito Radicale e i temi della giustizia e del carcere diventano
la “sua” ossessione. Ora tutti lo evocano, quando ci si vuole accreditare come
perseguitati della giustizia. La cosa che si fa, si è fatta, viene fatta, è
occultare con cura il Tortora politico, che si impegna a fianco di Marco
Pannella e dei radicali per la giustizia giusta. Che il suo arresto costituisca
per la magistratura e il giornalismo italiano una delle pagine più nere e
vergognose della loro storia, è cosa ormai assodata. Nessuno dei “pentiti” che
lo ha accusato è stato chiamato a rispondere delle sue calunnie. I magistrati
dell’inchiesta hanno tutti fatto carriera. Solo tre o quattro giornalisti hanno
chiesto scusa per le infamanti cronache scritte e pubblicate. Stroncato dal
tumore, Enzo ha voluto essere sepolto con una copia della “Storia della colonna
infame”, di Alessandro Manzoni. Sulla tomba un’epigrafe, dettata da Leonardo
Sciascia: “Che non sia un’illusione”.
Tortora, storia di un perseguitato senza
pace. Trent'anni fa veniva scarcerato Tortora. Ma il
suo incubo prosegue ancora oggi. Tra giudici che rifiutano di pentirsi e
mascalzoni che si paragonano a lui, scrive Massimo Del Papa il 15 Settembre 2016
su "Lettera 43". Enzo Tortora, stella di prima grandezza del giornalismo e
dell'intrattenimento televisivo, diventa di colpo un criminale mafioso per la
giustizia e per l'opinione pubblica: la sua storia impossibile (guarda le foto)
diventerà un modo di dire, usurpato da fior di mascalzoni che, appena
inchiodati, puntualmente proclamano: «Sono come Tortora, il mio è un nuovo caso
Tortora». Non è quello che avrebbe voluto la vittima del «più grande esempio di
macelleria giudiziaria all'ingrosso del nostro Paese», come lo definì uno dei
suoi rari sostenitori, Giorgio Bocca. Poche grandi firme – lo stesso Bocca,
Biagi, Montanelli pur tra qualche caduta di stile - proveranno a non perdere la
testa di fronte ai furori di una opinione pubblica che invoca il crucifige, col
solo Partito radicale di Marco Pannella coinvolto in una durissima battaglia per
opporsi alla marea montante di una magistratura i cui protagonisti, lungi dal
pagare in alcun modo, faranno tutti clamorosi balzi in carriera, fino a
conquistare i massimi ermellini oppure nella pubblica amministrazione. Dal canto
loro, i pentiti menzogneri avranno sorte altrettanto benevola, uno addirittura
insignito del “premio della libertà”. Era una buona compagnia: dare addosso a
Tortora è facile, la stampa si scatena, moltissimi opinionisti, come la radical
chic Camilla Cederna, dimostreranno carognesca superficialità: «Se uno viene
preso in piena notte, qualcosa avrà fatto». E sono gli stessi che non credono
per princìpio alla magistratura e alle istituzioni, che firmano appelli contro
lo Stato e i suoi 'commissari torturatori'. È difficile, in quella temperie,
considerare Tortora innocente, e scriverlo. Si rischia di venire contagiati
dalle accuse che lo travolgono. Il calvario: 1.768 giorni dall'arresto alla
morte. Il conduttore ha due avvocati di prestigio, Raffaele Della Valle e il
professor Alberto Dall'Ora, che nel difenderlo si identificano nel dramma del
loro assistito oltre i limiti del mandato professionale: quando Tortora verrà
riabilitato, saranno visti piangere come lui, insieme a lui. Il calvario di Enzo
Tortora dura 1.768 giorni, dal quello dell'arresto (17 giugno 1983, prelevato
alle 4 del mattino all'Hotel Plaza di Roma) alla fine della sua vita (18 maggio
1988, cancro ai polmoni, nella sua casa milanese di via Piatti 8). Gli italiani
scopriranno che possono venire svegliati in qualsiasi momento da un battere alla
porta in piena notte, come nei regimi di polizia e portati via, in un incubo
senza fondo dove le spirali della vergogna e dell'impotenza sembrano non avere
mai fine. Alla vigilia dell'arresto di Tortora, circola tra i cronisti di nera
la voce di una retata imminente, con tanto di nome forte, uno della televisione.
Uno grosso. Chi? «Uno che sta nelle ultime lettere dell'alfabeto». Quella giusta
è la “T”. Rintracciano “mister T.”, lo avvertono: lui ironizza, ci ride sopra,
attacca e non ci pensa più. Lo andranno a prendere poche ore dopo. È tutto
predisposto, giornalisti e fotografi sono stati avvertiti. Gli mettono le
manette, ad effetto; ma ne fa di più la sua faccia stupefatta e sfatta. Fioccano
i “pentiti” che lo azzannano in un delirio di accuse folli: ha rubato i soldi
raccolti per il terremoto dell'Irpinia, ha uno yacht comprato con i guadagni
dello spaccio, si incontra con Turatello, Pazienza e Calvi scambiando valigette
di droga e dollari. Titola il Messaggero: «Tortora ha confessato». Quando, dove?
L'accusa: una partita di droga che il presentatore si sarebbe intascato. Nessuno
difende Tortora, specie a sinistra: è considerato un reazionario, un
rompicoglioni moralista. Un antipatico. Più avanti si sarebbe detto: un
nazionapopolare, col suo Portobello strappalacrime e stracciapalle. Scriveva
su la Nazione del petroliere Attilio Monti in odor di fascismo, ce n'è
abbastanza per scordarsi il garantismo, che con gli amici si osserva, coi nemici
si cancella. Quando la madre Silvia si reca in chiesa, trova sempre lo stesso
bigliettino, grondante carità cristiana: «Tuo figlio spaccia la droga». E dire
che tutto nasce da una meschinità infantile, come si racconta nel bel libro di
Vittorio Pizzuto Applausi e sputi. Un detenuto del carcere di Porto Azzurro,
Domenico Barbaro, spedisce alcuni centrini alla redazione di Portobello nella
speranza di venderli. Non li vede mai e allora comincia a perseguitare il
presentatore con letteracce scritte dal killer Pandico, perché lui è analfabeta.
Un bel giorno Tortora si scoccia: «Se lei continua ad insistere», risponde,
«passerò la faccenda all'ufficio legale della Rai». I centrini non si trovano,
il detenuto riceve dalla Rai un assegno di 800 mila lire più per pietà che per
altro. Barbaro e Pandico si “sdebiteranno” raccontando ai giudici, per bocca del
secondo, che i centrini erano un nome in codice per indicare una partita di coca
da 80 milioni che il presentatore si sarebbe intascato imbrogliando i compari.
Sarebbe la prima prova d'accusa: i legali a difesa producono le lettere
minatorie del galeotto, ma per i magistrati «a scrivere è un altro Barbaro», un
omonimo. Altra prova considerata definitiva: si trova il nome di Tortora
nell'agendina di Giuseppe Puca, detto "o Giappone", sicario tra i preferiti di
Cutolo. Ma l'agendina è della donna di Puca, il nome, scarabocchiato a mano è
"Tortosa" non "Tortora", e corrisponde al proprietario di un deposito di bibite
di Caserta, amico della signora. Il prefisso è 0823, «Provate a chiamà,
dottore...». Cinque mesi ci mettono, i giudici, a "provare". Gli accusatori: da
un serial killer all'altro. Chi sono gli accusatori di Tortora? Il principale è
il citato Giovanni Pandico, killer di professione, segretario di Cutolo, il capo
della camorra: ha ucciso due impiegati comunali perché tardavano a dargli un
certificato, ha tentato senza successo di annientare i parenti: padre, madre e
fidanzata. «Schizoide e paranoico» per i medici, bocca della verità per i
giudici. È il primo, il più meschino, quello che eccita e contagia altri degni
compari. Dal 2012 torna libero cittadino. Non migliore è Pasquale Barra, detto
'o "animale", serial killer delle galere, 67 omicidi in carriera tra cui lo
squartamento di Francis Turatello al quale mangia pezzi di cuore: è morto in
carcere, sotto regime privilegiato, con uno speciale programma di protezione. Il
più appariscente però è Gianni Melluso, detto "il bello" o "cha cha cha",
aspetto di cialtronesca, volgare ricercatezza, da cantante da crociera. Già
libero, è tornato in galera qualche anno fa per sfruttamento della
prostituzione. Da accusatore di Tortora, in carcere viveva come un pascià, amava
quando voleva la fidanzata, puntualmente messa incinta e sposata con due
giornalisti come testimoni e un meraviglioso completo sartoriale di Valentino.
Dirà Melluso, ma solo nel 2010, in una intervista all'Espresso: «Lui non
c'entrava nulla, di nulla, di nulla, l'ho distrutto a malincuore, dicendo che
gli passavo pacchetti di droga, ma era l'unica via per salvarmi la pelle. Ora mi
inginocchio davanti alle figlie». Replicherà Gaia, la terzogenita: «Resti pure
in piedi». Un altro che lo accusa di spacciare negli studi di Antenna 3
Lombardia è il pittore fallito Giuseppe Margutti: anche lui, a giochi fatti,
ammetterà di essersi inventato tutto per mitomania finalizzata a raccogliere
qualche soldo. Il primo grado: condanna a 10 anni e 50 milioni di multa. Tortora
passa per sodale del boss dei boss Raffaele Cutolo. Accusa risibile, che infatti
suscita ironia allo stesso supercriminale: nel carcere dell'Asinara, dove sconta
l'ergastolo, don Rafaé incontra il presunto colpevole Tortora, nel frattempo
diventato europarlamentare. Il breve dialogo che ne consegue, è surreale:
«Dunque, io sarei il suo luogotenente». Poi porge la destra: «Sono onorato di
stringere la mano a un innocente». La cosa non turba i magistrati, che non si
scomodano a disporre alcun controllo, verifica, riscontro bancario (cosa che
Tortora li invita espressamente a fare), appostamento, pedinamento,
intercettazione (non sono ancora di moda), e, inchiodati alle versioni dei
pentiti, tutte tra l'altro discordanti fra loro, costruiscono il loro castello
accusatorio. I sostituti procuratori titolari delle indagini a Napoli sono Lucio
Di Pietro, definito il Maradona del diritto, e Felice Di Persia. Ottengono dal
giudice istruttore Giorgio Fontana 857 ordini di cattura, con 216 errori di
persona, tanto che i rinviati a giudizio alla fine saranno solo 640, di cui 120
assolti già in primo grado (in appello, le assoluzioni saranno 114 su 191). Il
processo di primo grado, sempre a Napoli, si apre nel febbraio 1985, un anno e
otto mesi dopo l'arresto di Tortora, e si conclude il 17 settembre 1985 con il
conduttore condannato a 10 anni e 50 milioni di multa, ma nel frattempo divenuto
deputato radicale al Parlamento europeo. Il presidente Luigi Sansone scrive una
omerica sentenza di 2 mila pagine, in sei tomi, uno dei quali appositamente su
Tortora, per il quale ribalta ogni logica di diritto: «L'imputato non ha saputo
spiegarci il perché di una congiura contro di lui», quanto a dire l'inversione
dell'onere della prova. Da parte sua, il pubblico ministero Diego
Marmo definisce Tortora «un uomo della notte, ben diverso da come appariva
a Portobello»; poi insinua che sia stato votato dai camorristi. Ma ammette: «Lo
sappiamo tutti, purtroppo, che se cade la posizione di Enzo Tortora si scredita
tutta l'istruttoria». L'appello: la Corte di Napoli smonta il castello
accusatorio. Non sia mai: Tortora riceve una condanna inevitabile. Già eletto a
Strasburgo per i Radicali, prontamente si dimette da eurodeputato, rinuncia
all'immunità e torna in Italia per farsi arrestare. Nel frattempo è cambiato, ha
maturato una consapevolezza nuova, l'impegno totale in favore dei carcerati:
«Ero liberale perché ho studiato, sono radicale perché ho capito». Passa ai
domiciliari, ricorre in appello, non smette di combattere, fino alla fine. «Io
sono innocente», dice ai giudici. «Spero, dal profondo del cuore, che lo siate
anche voi». Gli credono, finalmente. Il 15 settembre 1986 la Corte d'Appello di
Napoli sfascia mattone per mattone il castello accusatorio del primo grado, ma
lui è già minato. Torna davanti agli italiani venerdì 20 febbraio 1987, con
quelle pochissime, memorabili parole, «Dove eravamo rimasti?». Ma non è più lui,
la voce è incrinata, il volto segnato, le lacrime sempre in agguato: salgono
dagli incubi che, la notte, lo scaricano ancora in cella. Lo hanno spezzato.
Racconterà la figlia Silvia: «Ricordo che Manganelli, il capo della Polizia,
incontrandomi mi disse: quella di tuo padre è stata la merda più gigantesca
della storia. Hanno fatto una commissione parlamentare su tutto, persino su
Mitrokhin: su Tortora no». I giudici coinvolti: «Ma di cosa ci dovremmo
vergognare?» Già malato terminale, Tortora aveva presentato una citazione per
danni: 100 miliardi di lire. Il Csm archivia. Archiviato anche il referendum del
1987, nato sulle ceneri del caso Tortora, sulla responsabilità civile dei
magistrati: vota il 65%, i sì sono l'80%, arriva la legge Vassalli e lo
disinnesca. Nel frattempo la Cassazione ha confermato l'assoluzione in appello,
il 13 giugno 1987, quattro anni dopo la notte delle manette. L'ultima
intervista, al programma Il Testimone di Giuliano Ferrara (che poi rimedierà una
querela da tre giudici), è atroce. Tortora, rantolando, ansimando, rinfaccia al
magistrato Alessandro Olivares la condotta processuale: «Mi disse allora: "Ma
sììì, facciamo sei anni. Da dieci facciamone sei...". E io dissi: 'Guardi che
non siamo al mobilificio Aiazzone. Lei ha una mentalità da barcaiolo giuridico
veramente ripugnante. Lei ha una mentalità da barcaiolo...'». Poi non riesce più
a parlare, stava già morendo. «Ma di che cosa ci dovremmo scusare, noi?», ha
ringhiato ancora di recente uno dei giudici coinvolti - e premiati - in questo
splatter giudiziario. «CHE NON SIA UN'ILLUSIONE». Restano le lettere di Tortora,
strazianti, alla compagna Francesca Scopelliti, che recentemente le ha raccolte
in un libro di cui si è stati molto attenti a non parlare. Resta l'impegno di
Tortora per i detenuti, per condizioni carcerarie umane, impegno che non è
sopravvissuto né a lui, né al suo più grande sostegno, Pannella. Se volete
andare a trovare Tortora, sta al cimitero Monumentale di Milano, dentro una
colonna di marmo. Qualcuno ha infilato l'immaginetta di un Cristo in croce con
la scritta: «Uno che ti chiede scusa». Sotto l'urna, che dietro il vetro sembra
ricordare a tutti un uomo ridotto in cenere prima ancora di morire, una frase
urla la sua muta disperazione: «Che non sia un'illusione».
Tortora dalla prigione: «L'uomo qui è
niente, ricordatevelo», scrive Valter Vecellio il 14
set 2016 su "Il Dubbio". Il presentatore viene arrestato nel cuore della notte e
trattenuto nel comando dei carabinieri. Lo fanno uscire solo quando si era ben
sicuri della presenza di tv e giornali. Muore il 18 maggio del 1988, stroncato
da un tumore. Dopo sette mesi di ingiusto carcere e arresti domiciliari Enzo
Tortora viene definitivamente assolto dalle accuse di associazione di stampo
camorristico e traffico di stupefacenti. È il 15 settembre di trent'anni fa. Un
calvario che lo segna in modo indelebile. Il 18 maggio del 1988 muore, stroncato
da un tumore, conseguenza - non è arbitrario sostenerlo - anche del lungo e
ingiusto calvario patito. Chi scrive fu tra i primi a denunciare che in
quell'operazione che aveva portato Enzo in carcere assieme a centinaia di altre
persone, c'era molto che non andava; e fin dalle prime ore. Tortora viene
arrestato nel cuore della notte e trattenuto nel comando dei carabinieri di
via Inselci a Roma, fino a tarda mattinata. Lo fanno uscire solo quando si era
ben sicuri che televisioni e giornalisti fossero accorsi per poterlo mostrare in
manette. Sarebbe interessante sapere chi dà quell'ordine che porta alla prima di
una infinita serie di mascalzonate. Rileggo ancora con emozione, indignazione,
sgomento le lettere che Enzo mi invia dal carcere; e ancora corre un brivido
lungo la schiena. Credo sia utile, necessarie, rileggerle, in giorni in cui
tanti, mostrano di aver smarrito la memoria di quello che è stato.
16 settembre 1983 «Da tempo volevo dirti grazie?
Hai "scommesso" su di me, subito: con una purezza e un entusiasmo civile che mi
commossero immensamente. Vincerai, naturalmente, la tua "puntata". Ma a prezzo
di mie sofferenze inutili e infinite. Io sono stato il primo a dire che il
"caso Tortora è il caso Italia". Non intendo avere trattamenti di favore, o
fruire di scorciatoie non "onorevoli"? Se dal mio male può venire un po' di bene
per la muta, dolente popolazione dei 40mila sepolti vivi nei lager della
democrazia, e va bene, mi consolerà questo».
2 maggio 1984 «Che si faccia strame della libertà
di un uomo, della sua salute, della sua vita, come può esser sentito come offesa
alla libertà, alla vita, alla salute di tutti in un Paese che non ha
assolutamente il senso sacro, della propria dignità e delle libertà civili? Non
è vero che l'Italia "ha abolito la pena di morte". Abbiamo un boia in esercizio
quotidiano, atroce, instancabile. Ma non vogliamo vederlo. La sua scure si
abbatte, ogni minuto, sul corpo di uomini e di donne, e li squarta vivi, in
"attesa" di un giudizio che non arriva mai. L'uomo qui è niente, ricordatevelo.
L'uomo qui può, anzi deve attendere. L'uomo qui è una "pratica" che va "evasa"
con i tempi, ignobili, della crudeltà nazionale?».
15 luglio 1985 «In questa gara, tra chi pianta più
in fretta i chiodi, come al luna park dell'obbrobrio giudiziario, e i pochi che
si ribellano, sta tutta la mostruosa partita. Vedere a che lurido livello s'è
ridotta la dignità di questo Paese è cosa che mi annienta più d'ogni altra. So
che sei coi pochi. Da sempre. Te ne ringrazio, fraternamente».
7 ottobre 1985 «Sono stato condannato e processato
dalla Ngo, Nuova giustizia organizzata. Io spero che questa fogna, che ormai
nessun tombino può contenere, trabocchi e travolga chi lo merita?».
2 aprile 1986 «Diffamatori è poco: sapevano quel
che facevano. Ma per pura voluttà scandalistica, per pura, stolida ferocia, qui
si getta fango sino all'estremo. Ho paura di questi cannibali. Ho soprattutto
vergogna di essere italiano?».
17 agosto 1987 «Siamo molti? Ma troppo pochi per
spezzare la crosta di ottusa indifferenza che copre e fascia la rendita di
alcuni farabutti mascherati da Magistrati. Tanto più importante e notevole il
vostro impegno. Tenteremo, sul caso Melluso, quel che si potrà. Ho inviato
al ministro Vassalli l'incredibile servizio, gli ho anche detto che i
responsabili hanno nome e cognome: Felice Di Persia, Lucio Di Pietro, Giorgio
Fontana, Achille Farina, Carlo Spirito? Sono ancora lì, al loro posto?
Staremo a vedere?».
Manca, tuttavia, a distanza di tanti anni da quei
fatti, la risposta alla quinta delle classiche domande anglosassoni che
dovrebbero essere alla base di un articolo: perché? Alla ricerca di una
soddisfacente risposta, si affonda in uno dei periodi più oscuri e melmosi
dell'Italia di questi anni: il rapimento dell'assessore all'urbanistica della
Regione Campania, il democristiano Ciro Cirillo da parte delle Brigate Rosse
di Giovanni Senzani, e la conseguente, vera, trattativa tra Stato, terroristi e
camorra di Raffaele Cutolo.
Il cuore della vicenda è qui. Sono le 21.45 del 27
aprile 1981 quando le Brigate Rosse sequestrano Cirillo. Segue una frenetica,
spasmodica trattativa condotta da esponenti politici della Dc, Cutolo, uomini
dei servizi segreti per "riscattarlo". Viene chiesto un riscatto, svariati
miliardi. Il denaro si trova. Durante la strada parte è "stornato", non si è mai
ben capito da chi. Anche in situazioni come quelle c'è chi si prende la
"stecca". A quanto ammonta il riscatto? Si parla di circa cinque miliardi. Da
dove viene quel denaro? Raccolto da costruttori amici. Cosa non si fa, per
amicizia! Soprattutto se poi c'è un "ritorno". Il "ritorno" si chiama
ricostruzione post-terremoto, i colossali affari che si possono fare; la
commissione parlamentare guidata da Oscar Luigi Scalfaro accerta che la torta
era costituita da oltre 90mila miliardi di lire. Peccato, molti che potrebbero
spiegare qualcosa, non sono più in condizione di farlo: sono tutti morti
ammazzati, da Vincenzo Casillo luogotenente di Cutolo a Giovanna Matarazzo,
compagna di Casillo; da Salvatore Imperatrice che ebbe un ruolo nella
trattativa, a Enrico Madonna, avvocato di Cutolo; e Antonio Ammaturo, il
poliziotto che aveva ricostruito il caso Cirillo in un dossier spedito al
Viminale, «mai più ritrovato». Questo il contesto. Ma quali sono i fili che
legano Tortora, Cirillo, la camorra, la ricostruzione post-terremoto?
Ripercorriamoli qui i termini di una questione che ancora "brucia". Cominciamo
col dire che: Tortora era un uomo perbene, vittima di un mostruoso errore
giudiziario. Che il suo arresto costituisca per la magistratura e il giornalismo
italiano una delle pagine più nere e vergognose della loro storia, è assodato.
«Cinico mercante di morte», lo definisce il Pubblico Ministero Diego Marmo; e
aggiunge: «Più cercavamo le prove della sua innocenza, più emergevano elementi
di colpevolezza». Le "prove" erano la parola di Giovanni Pandico, un camorrista
schizofrenico, sedicente braccio destro di Cutolo: lo ascoltano diciotto volte,
solo al quinto interrogatorio si ricorda che Tortora è un camorrista. Pasquale
Barra detto 'o nimale: in carcere uccide il gangster Francis Turatello e ne
mangia l'intestino? Con le loro dichiarazioni, Pandico e Barra danno il via a
una valanga di altre accuse da parte di altri quindici sedicenti "pentiti":
curiosamente, si ricordano di Tortora solo dopo che la notizia del suo arresto è
diffusa da televisioni e giornali. Arriviamo ora al nostro "perché? " e al
"contesto". A legare il riscatto per Cirillo raccolto ai costruttori, compensati
poi con gli appalti e la vicenda Tortora, non è un giornalista malato di
dietrologia e con galoppante fantasia complottarda. È la denuncia, fatta anni
fa, della Direzione antimafia di Salerno: contro Tortora erano stati utilizzati
"pentiti a orologeria"; per distogliere l'attenzione della pubblica opinione dal
gran verminaio della ricostruzione del caso Cirillo, e la spaventosa guerra di
camorra che ogni giorno registra uno, due, tre morti ammazzati
tra cutoliani e anti-cutoliani. Fino a quando non si decide che bisogna reagire,
fare qualcosa, occorre dare un segnale. E' in questo contesto che nasce "il
venerdì nero della camorra", che in realtà si rivelerà il "venerdì nero della
giustizia": 850 mandati di cattura, e tra loro decine di arrestati colpevoli di
omonimia, gli errori di persona. Nel solo processo di primo grado gli assolti
sono ben 104? Documenti ufficiali, non congetture. Candidato al Parlamento
europeo nelle liste radicali, eletto, chiede sia concessa l'autorizzazione a
procedere, che invece all'unanimità viene negata. A questo punto, Tortora si
dimette e si consegna all'autorità, finendo agli arresti domiciliari. Diventa
presidente del Partito Radicale e i temi della giustizia e del carcere diventano
la "sua" ossessione. Nessuno dei "pentiti" che lo accusa è chiamato a rispondere
delle sue calunnie. I magistrati dell'inchiesta fanno tutti carriera. Solo tre o
quattro giornalisti hanno chiesto scusa per le infamanti cronache scritte e
pubblicate. Un errore, ed insieme un orrore, l'affaire Tortora. Un orrore per
quello che è stato, che implica, fa intuire; e definirlo un errore è forse
troppo semplice, perfino assolutorio; che quella patita da Tortora è stata
un'ingiustizia che, manzonianamente, poteva essere veduta da quelli stessi che
la commettevano, «un trasgredir le regole ammesso anche da loro». E si torna al
punto di partenza: perché è accaduto, perché si è voluto accadesse. Né si
possono assolvere dicendo che non sapevano quello che facevano: se davvero non
sapevano è perché decisero consapevolmente, di non sapere. Insomma, una colpa,
se possibile, ancora più grave. Ora tutti riconoscono che l'intero castello
accusatorio era più fragile di un castello di sabbia; e che Tortora era una
persona perbene. Enzo diceva sempre che non era, il "suo" il "caso Tortora", ma
"il caso Italia"; che resta, rimane, a cominciare dalla situazione delle
carceri, e dall'irragionevole durata dei processi. Lo avevano ben compreso Marco
Pannella, suo amico di sempre, che per lui si batte come un leone; e Leonardo
Sciascia, che fin da subito si dichiara certo della sua innocenza? Sarà per
questo che assistiamo a tante celebrazioni post mortem e alla memoria, molte
certo in buona fede (altre se ne però lecitamente dubitare), senza che i
radicali vengano mai invitati, tacitati, esclusi?
Enzo Tortora, trentatré anni fa l’arresto
a “orologeria”, scrive Valter Vecellio il 16 giugno
2016 su “Il Dubbio”. Ventotto anni fa, stroncato da un tumore che forse ci
sarebbe stato ugualmente, ma che certamente è esploso per via del calvario
patito, Enzo Tortora ci lasciava. Tortora lo incrocio a Bologna, quando ancora
pasticcio di giornalismo, e divido il mio tempo tra esami di legge e in quello
che ancora oggi credo sia chiamato angòl di cretén o cantàn d’inbezéll a
raccogliere firme per referendum radicali che i bolognesi sottoscrivono a
migliaia, in barba al Pci di allora che li boicotta. Tra i giornali, allora come
ora, Il Resto del Carlino e per un po’ Il Foglio, che non è quello di Giuliano
Ferrara, ma lo sfortunato tentativo editoriale di Luigi Pedrazzi ed Ermanno
Gorrieri, per rompere appunto il monopolio del Carlino; e contemporaneamente
nasce Il Nuovo Quotidiano, anch’esso effimero; e diretto appunto da Tortora. Un
periodo di schermaglie e polemiche, perché Il Nuovo Quotidiano è addirittura più
conservatore del Carlino. Poi altre storie ed esperienze, fino al giorno
dell’arresto, con quelle accuse infamanti: affiliazione alla camorra, spaccio di
cocaina. Di quell’“affaire” mi sono occupato fin dal primo momento; e fin dal
primo momento, senza dubbi ed esitazioni, innocentista, con pochissimi altri:
Piero Angela, Giacomo Ascheri, Massimo Fini… “Affaire Tortora”, ma non solo: che
in realtà si tratta di centinaia di persone arrestate (il “venerdì nero della
camorra”, siamo nel giugno del 1983), per poi scoprire che sono finite in
carcere per omonimia o altro tipo di “errore” facilmente rilevabile prima di
commetterlo; ma no: si è voluto dare credito, senza cercare alcun tipo di
riscontro, a personaggi come Giovanni Pandico, Pasquale Barra ‘o animale, Gianni
Melluso. Ho visto decine e decine di volte le immagini di quel maxi-processo,
per “montare” i miei servizi per il Tg2, e decine e decine di volte quella
convinta requisitoria del Pubblico Ministero che a un certo punto pone una
retorica domanda: «…Ma lo sapete voi che più cercavamo le prove della sua
innocenza, più emergevano elementi di colpevolezza?». E quali gli elementi di
colpevolezza che emergevano durante il paziente lavoro di ricerca delle prove di
innocenza? N-E-S-S-U-N-O. E per capirci: nessuno significa nessuno. Che fosse
qualcosa di simile allo scespiriano regno di Danimarca lo si capisce fin dalle
prime ore: lo arrestano nel cuore della notte, lo trattengono nel comando dei
carabinieri di via Inselci a Roma, fino a tarda mattinata, lo fanno uscire solo
quando sono ben sicuri che televisioni e giornalisti sono accorsi per poterlo
mostrare in manette. Già quel modo di fare è sufficiente per insinuare qualche
dubbio, qualche perplessità. Ancora oggi non sappiamo chi diede quell’ordine che
porta alla prima di una infinita serie di mascalzonate. E veniamo al perché
tutto ciò è accaduto, si è voluto accadesse. Forse una possibile risposta sono
riuscito a trovarla, e a suo tempo, sempre per il Tg2, riuscii a realizzare dei
servizi che non sono mai stati smentiti, e ci riportano a uno dei periodi più
oscuri e melmosi dell’Italia di questi anni: il rapimento dell’assessore
all’urbanistica della Regione Campania Ciro Cirillo da parte delle Brigate Rosse
di Giovanni Senzani, e la conseguente, vera, trattativa tra Stato, terroristi e
camorra di Raffaele Cutolo. Per la vita di Cirillo viene chiesto un riscatto,
svariati miliardi. Il denaro si trova, anche se durante la strada una parte
viene trattenuta non si è mai ben capito da chi. Anche in situazioni come quelle
c’è chi si prende la “stecca”. A quanto ammonta il riscatto? Si parla di circa
cinque miliardi. Da dove viene quel denaro? Raccolto da costruttori amici. Cosa
non si fa, per amicizia! Soprattutto se poi c’è un “ritorno”. Il “ritorno” si
chiama ricostruzione post-terremoto, i colossali affari che si possono fare; la
commissione parlamentare guidata da Oscar Luigi Scalfaro accerta che la torta è
costituita da oltre 90mila miliardi di lire. Peccato, molti che potrebbero
spiegare qualcosa, non sono più in condizione di farlo, sono tutti morti
ammazzati: da Vincenzo Casillo luogotenente di Cutolo, a Giovanna Matarazzo,
compagna di Casillo; da Salvatore Imperatrice, che ha un ruolo nella trattativa,
a Enrico Madonna, avvocato di Cutolo; e, tra gli altri, Antonio Ammaturo, il
poliziotto che aveva ricostruito il caso Cirillo in un dossier spedito al
Viminale, mai più ritrovato. Questo il contesto. Ma quali sono i fili che legano
Tortora, Cirillo, la camorra, la ricostruzione post-terremoto? Ripercorriamoli.
Che l’arresto di Tortora costituisca per la magistratura e il giornalismo
italiano una delle pagine più nere e vergognose della loro storia, è assodato.
Lo si sia fatto in buona o meno buona fede, cambia poco. Le “prove”, per
esempio, erano la parola di Giovanni Pandico, camorrista schizofrenico,
sedicente braccio destro di Cutolo: lo interrogano diciotto volte, solo al
quinto si ricorda che Tortora è un cumpariello; e Pasquale Barra: un tipo che in
carcere uccide il gangster Francis Turatello e ne mangia per sfregio
l’intestino. Con le loro dichiarazioni danno il via a una valanga di altre
accuse da parte di altri quindici sedicenti “pentiti”: curiosamente, si
ricordano di Tortora solo dopo che la notizia del suo arresto è diffusa da
televisioni e giornali. C’è poi un numero di telefono trovato in un’agendina di
una convivente di un capo clan. Sotto la T, leggono Tortora; in realtà quel nome
corrisponde a Tortona, riscontrarlo è facile, basta comporre il numero. Non lo
fa nessuno. C’è poi un documento importante che rivela come vennero fatte le
indagini, ed è nelle parole di Silvia Tortora, la figlia. Le chiedo di
rispondere con un sì o con un no alle mie domande. Quando suo padre viene
arrestato oltre alle dichiarazioni di Pandico e Barra c’era altro? «No». Suo
padre è mai stato pedinato, per accertare se davvero era uno spacciatore, un
camorrista? «No, mai». Intercettazioni telefoniche? «Nessuna». Ispezioni
patrimoniali, bancarie? «Nessuna». Si è mai verificato a chi appartenevano i
numeri di telefono trovati su agende di camorristi e si diceva fossero di suo
padre? «Lo ha fatto, dopo anni, la difesa di mio padre. E’ risultato che erano
di altri». Suo padre è stato definito cinico mercante di morte. Su che prove?
«Nessuna». Suo padre è stato accusato di essersi appropriato di fondi destinati
ai terremotati dell’Irpinia, con che prove? «Nessuna». Chi lo ha scritto è stato
poi condannato? Qualcuno ha chiesto scusa per quello che è accaduto? «No». A
legare il riscatto raccolto per Cirillo, i costruttori, compensati poi con gli
appalti, e la vicenda Tortora, non è un giornalista malato di dietrologia e con
galoppante fantasia complottarda. È la denuncia, anni fa, della direzione
antimafia di Salerno: contro Tortora erano stati utilizzati “pentiti a
orologeria”; per distogliere l’attenzione della pubblica opinione dal gran
verminaio della ricostruzione del caso Cirillo, e la spaventosa guerra di
camorra che ogni giorno registra uno, due, tre morti ammazzati tra cutoliani e
anti-cutoliani. Fino a quando non si decide che bisogna reagire, fare qualcosa,
occorre dare un segnale. È in questo contesto che nasce “il venerdì nero della
camorra”, che in realtà si rivelerà il “venerdì nero della giustizia”. Nessuno
dei “pentiti” che ha accusato Tortora è stato chiamato a rispondere per
calunnia. I magistrati dell’inchiesta hanno fatto carriera. Solo tre o quattro
giornalisti hanno chiesto scusa per le infamanti cronache scritte e pubblicate.
Anni dopo il pubblico ministero accusatore di Tortora dice di aver agito in
buona fede e chiede scusa. Diamo pure credito alla “buona fede”, anche se subito
viene in mente quella terrificante figura di magistrato magistralmente descritta
da Leonardo Sciascia in Una storia semplice; forse, quel pubblico ministero è
ferrato in italiano come il magistrato di Sciascia. La questione, comunque, va
ben al di là della buona fede di un singolo. Stroncato dal tumore, Enzo ha
voluto essere sepolto con una copia della Storia della colonna infame di
Alessandro Manzoni. Sulla tomba un’epigrafe, dettata da Leonardo Sciascia: “Che
non sia un’illusione”. Sta a noi fare in modo che non lo sia.
Pezzuto: «Enzo, la condanna e quel giorno
nero che non è mai finito», scrive Errico Novi il 16
set 2016 su "Il Dubbio". Parla il biografo di Tortora: «Il 17 settembre 1985 il
Tribunale pronunciò la sentenza di primo grado: dieci anni di carcere. Da allora
altri 25mila italiani innocenti sono finiti in galera. E a pagare sono stati, in
tutto, 7 magistrati» «Quel 17 settembre nero della giustizia non finisce mai».
Quel giorno di 31 anni fa il Tribunale di Napoli condannò Enzo Tortora in primo
grado a dieci anni di carcere. È una data che fa parte di una tragica cronologia
cabalistica ricostruita dal giornalista Vittorio Pezzuto nel suo Applausi e
sputi, per diversi anni l'unico libro ad aver esplorato la mostruosa vicenda
giudiziaria che travolse il presentatore».
Pezzuto, perché l'ingiustizia di quel giorno
non è mai finita?
«Dal '92 a oggi
si sono contati altri 25mila casi Tortora: è il numero dei cittadini innocenti
sbattuti in carcere, per i quali hanno pagato solo sette magistrati, quelli per
i quali si sono chiuse azioni di responsabilità civile. Vicende come quella di
Tortora si verificano ancora e nel frattempo si è ridotta di molto la cultura
garantista».
Davvero quel processo non ha cambiato nulla
nella giustizia italiana?
«Se qualcosa è
cambiato, rispetto all'idea di giustizia prevalente nel Paese, è cambiato in
peggio. Davvero possiamo dire che la maggioranza degli italiani crede nella
presunzione di non colpevolezza? Non scherziamo. Oggi l'opinione pubblica che
finge di commuoversi per la vicenda Tortora considera sicuro colpevole chi ha
ricevuto un avviso di garanzia. Ed è evidente come riflessi di questo
atteggiamento si irradino anche sulle scelte normative».
A cosa si riferisce?
«Al fatto che
chi mormora 'ah, povero Tortora' spesso poi approva l'ipotesi di allungare i
tempi della prescrizione. Senza rendersi conto che così facendo si
condannerebbero decine di migliaia di imputati a una sorta di limbo giudiziario
in cui dopo un eventuale condanna in primo grado devi aspettare anni prima di
una sentenza definitiva».
Probabilmente nemmeno all'epoca delle deliranti
tesi accusatorie contro Tortora c'era il furore giustizialista di oggi.
«Tortora
condannato in primo grado per associazione mafiosa e spaccio di droga oggi
sarebbe massacrato sul web con decine di migliaia di insulti e con decine di
articoli che istigherebbero a insultare ancora».
Perché i pentiti scelsero Tortora?
«A dare
l'innesco è una scintilla di follia. I primi due camorristi a fare il nome di
Tortora sono Pasquale Barra e Giovanni Pandico, entrambi noti per gli
impressionanti risultati delle perizie psichiatriche effettuate a loro carico.
Il primo aveva addentato le viscere ancora calde del boss milanese Francis
Turatello dopo averlo ucciso, il secondo aveva ammazzato tre impiegati del
comune di Nola perché tardavano a rilasciargli un certificato. Entrambi fanno il
nome di Tortora come affiliato alla Nuova camorra, ma collocandolo nelle
retrovie».
Da lì l'ordine di arresto.
«Quella è la
parte della mostruosa vicenda che ancora può essere rubricata come clamoroso
errore professionale e non, come è invece doveroso per le fasi successive, sotto
la voce dolo e colpa grave. Il punto di svolta è nella cosiddetta prova, il
numero telefonico di Tortora trovato nell'agendina di un camorrista ucciso,
Salvatore Puca. Si scopre che era di un certo Enzo Tortona. È lì che Tortora
commenta: non sono vittima di un errore giudiziario, sono un refuso».
Sarebbe dovuta finire lì.
«Il presidente
del Tribunale prova a non arrendersi all'evidenza. A questo Tortona, che è in
Aula, dice: 'E dov'è la prova che il numero appartiene proprio a lei? '. E
quello risponde: 'Facite 'o nummero... '. Gli inquirenti nemmeno avevano
verificato con una semplice telefonata se davvero quell'utenza fosse di Tortora».
Da lì si scivola nel dolo.
«Da lì inizia
il il tiro a Tortora, agevolato da alcuni, diciamo così, accorgimenti. Diversi
camorristi si rendono conto che chiamare in causa il presentatore significa
essere trasferiti dal carcere alla caserma Pastrengo di Napoli, dove si può
avere vitto migliore, donnine compiacenti, e la sera ci si può riunire per
meglio concordare le dichiarazioni da rendere al processo».
Che si chiude appunto con una sentenza di
condanna pronunciata il 17 settembre 1985.
«La tesi
accusatoria accolta dal Tribunale ha un carattere quantitativo: ci si richiama
non alla consistenza delle accuse ma al numero di persone da cui le accuse
provengono. Che è appunto elevatissimo. Quella data, quel numero non irrilevante
nella smorfia napoletana, il 17, non risuonò solo alla condanna di primo grado».
A cosa si riferisce?
«Il 17 è la
data che ha segnato le tappe più importanti di quella che in Applausi e sputi
definisco la seconda vita di Enzo Tortora. Il 17 giugno 1983 c'è l'arresto. Il
17 gennaio 1984 la concessione molto faticosa e a lungo ostacolata degli arresti
domiciliari. Il 17 giugno 1984 l'elezione al Parlamento europeo con il Partito
radicale. Il 17 luglio 1984 il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio.
Fino appunto alla condanna in primo grado, emessa alle ore 17 del 17 settembre
1985».
Perché i giudici non si fermarono?
«Perché Tortora
era diventato il simbolo del maxiblitz contro la Nco, e il sacco delle accuse
che ogni volta veniva svuotato dai suoi avvocati doveva essere necessariamente
riempito con nuove incredibili altre accuse. Se cadeva l'imputazione contro
Tortora crollava tutta l'impalcatura processuale».
E perché la sua posizione divenne così
determinante?
«Nello stesso
giorno in cui arrestarono Tortora finirono in manette 856 persone. Di queste,
117 finirono dentro per omonimia. L'impalcatura scricchiolava fin dall'inizio,
tanto che alla fine dei tre gradi di giudizio gran parte degli imputati venne
riconosciuta innocente. I magistrati si resero conto presto che l'unica era
puntare tutto sul clamore assicurato dalle accuse a Tortora».
Pensa ci sia chi crede in quelle accuse ancora
oggi?
«No. Il caso
Tortora serve oggi ad alcuni come pretesto per dire che quella vicenda è stata
unica e irripetibile. E per negare così la verità: ovvero che continua a esserci
strage di giustizia e ancora nuovi Enzo Tortora».
E l’accusatore di Tortora disse: anche il
Califfo è un camorrista, scrive Valter Vecellio il 2
agosto 2016 su "Il Duggio”. Una villetta a Primavalle a Roma, lui in giardino
passeggia e gesticola. Parla a un telefono cellulare, con la mano fa cenno di
entrare… Con qualcuno parla di canzoni, di un disco da fare, di come farlo; e
intanto fa cenno di entrare in casa. C’è un salone, divani immacolati, poltrone,
su un lungo tavolo riviste, giornali; alle pareti quadri astratti, dischi d’oro
incorniciati, fotografie in abbondanza, piante ben curate. «Scusate, ma era una
telefonata di lavoro, bisogna pur campare, non si vive d’aria…». Indica il
cellulare, e ride: «Pensa che coglioni. Sono agli arresti domiciliari, e va
bene; non posso uscire, al massimo passeggio in giardino, e va bene; una volta
al giorno passa la polizia per un controllo, sempre alla stessa ora. Mi hanno
disattivato il telefono, perché non devo avere contatti con l’esterno, vai a
capire che pericolo pensano sia, e va bene anche questo. E poi mi lasciano il
cellulare? ». Eccolo, Franco Califano. Fino a qualche mese fa, solo un cantante
e a volte un attore con qualche disavventura giudiziaria, anche il carcere, per
uscirne comunque sempre assolto, pulito. Alla radio ascolti le sue canzoni, sui
giornali dei suoi tanti amori… Poi arriva uno che dice di essere un pentito di
camorra, che lo accusa di essere un “cumpariello”. Lo arrestano, un filone della
stessa mega-inchiesta napoletana definita “il venerdì nero della camorra”, che
ha già portato in carcere Enzo Tortora, e con lui centinaia di altre persone
(tantissime poi dichiarate innocenti, arrestati per omonimia o assolti per non
aver commesso il fatto imputato). Quando è in carcere, prima a Poggioreale a
Napoli, poi a Rebibbia a Roma, gli scrivo per capire meglio in che pasticcio si
è venuto a trovare. In quelle lettere si sfoga con amara ironia; a volte
inveisce, e puntiglioso spiega che sì, in passato ha consumato cocaina, non l’ha
mai nascosto; non ha neppure ha mai nascosto la sua amicizia con il gangster
milanese Francis Turatello, ma che con la camorra non ha niente a che fare…
«Vuoi bere qualcosa?». Coca Cola. «Astemio?». Birra e pochissimo vino, balbetto.
«E allora meglio la birra; che poi la Coca Cola non ce l’ho neppure…Io mi faccio
un caffè, stanotte voglio lavorare sui testi di alcune canzoni». Lo osservo
mentre traffica in cucina con la moka, spiega che è sua madre ad avergli
insegnato come farlo. La madre che lo ha fatto nascere per caso a Tripoli di
Libia: incinta, era partita da Johannesburg per Roma, «ma le acque si sono rotte
prima, atterraggio d’emergenza, così nasco a Tripoli. Ma a me della Libia non me
ne importa nulla». Mi blocco: stavo per dirgli che anch’io faccio parte dei
“tripolini”. Parla come se ci si conosca da sempre; al contrario, è la prima
volta che ci si vede: «Sai, non sono tanti ad aver avuto il coraggio di
difendermi, non sono cose che si dimenticano…». Ti sei fatta un’idea di come sei
finito in questo tritacarne? «Secondo me hanno fatto una specie di cambio: hanno
cominciato con Tortora, però più andavano avanti, più si infognavano, si
rendevano conto che il teorema non reggeva, e allora mettono in mezzo me. Come
colpevole sono molto più credibile. Altrimenti non si spiega perché vengo
arrestato dopo un anno dall’apertura dell’istruttoria. Ma ti pare che questi
pentiti si ricordano di me dopo un anno? Ahò, non sono mica Mario Rossi… Franco
Califano camorrista te lo ricordi dopo un anno, e non lo dici subito? Dopo un
anno mi hanno tirato in ballo…». Mentre parla, penso che c’è una logica: il
Tortora alle vette del suo successo professionale, ascolti record con il suo
Portobello, è l’immagine dell’Italia “buona” e “per bene”, “l’insospettabile”; e
c’è chi comincia a chiedersi con troppa insistenza che Tortora non sia il
“mostro” che si dice sia. In tanti cominciano a domandarsi perplessi: «E se
fosse innocente?». Così entra in scena “il Califfo”: lui ha quella che si dice
la faccia del colpevole; lui sì, in quel giro di “cumparielli” ci può stare;
Califano insomma può rendere credibile il teorema che comincia a traballare.
Fantasie da inguaribile sospettoso che non si fida neppure della sua ombra e
ogni volta che un magistrato o un poliziotto ti fa un “favore” si chiede: qual è
il suo guadagno? Chissà. Restiamo ai fatti…L’imputazione è grave: associazione
per delinquere di stampo camorristico, traffico di droga; già che ci sono ci
mettono anche detenzione di armi. Ride amaro: «Mi trovo dichiarato camorrista da
un giorno all’altro. Una follia. Non conosco nessuno dei miei coimputati o
accusatori. Ho fatto spettacoli ovunque, non posso escludere di averne fatto uno
anche per dei camorristi. Vai a capire con quali prestanome, magari in qualche
locale di proprietà di camorristi, ma come pensi che lo possa sapere? Io bado
soltanto ai contratti, ai soldi, e canto». Che mi dici delle accuse di Gianni
Melluso che dopo aver calunniato Tortora racconta di vostri mirabolanti
incontri… «Questo Melluso che mi accusa l’ho visto per la prima volta quando
hanno organizzato un confronto. Io lo guardo e dico: “Ma chi è questo, che
vuole?”, e lui: “Franchino, dì la verità, che è meglio…”. Franchino a me… Dice
di avermi consegnato non so quanti chili di “roba” a casa mia, a corso Francia,
nel sottoscala del numero 84. Io a corso Francia non ci ho mai abitato, e all’84
non esiste alcun sottoscala. Ma vuoi fare una verifica, prima di mettere uno in
galera? Vuoi vedere le carte? Tre pagine di istruttoria, che non stanno né in
cielo né in terra. Almeno a Tortora hanno riservato centocinquanta pagine…». Non
avertene a male, l’hai detto anche tu: come colpevole di queste cose ci stai
tutto: amico di Turatello…la droga che non hai mai negato di aver usato, i
precedenti arresti… «I precedenti arresti si sono conclusi con proscioglimenti.
La cocaina l’ho usata. Ma farsi di cocaina non significa spacciarla, significa
che parte dei miei soldi li ho buttati via in quel modo lì, come tanti altri li
ho usato per beneficenza; chiedi alla gente di questa borgata, che mi vuole bene
e te lo può raccontare. Di Turatello e della nostra amicizia si sa tutto da
sempre, sai certo che suo figlio l’ho messo nella copertina di un mio disco,
“Tutto il resto è noia”». Come nasce questa tua amicizia con Turatello? «A
Milano. Ero stato in carcere, mi ero comportato da uomo, senza rompe li cojoni,
non mi lamentavo. Mi stimava per questo, diventiamo amici. Voleva aprire una
società di produzione cinematografica intestata proprio al figlio e a me, ma poi
morì e nun se ne fece nulla. Lo sai, vero, chi ha ucciso Turatello in carcere?».
Pasquale Barra, detto ‘o animale. Per sfregio gli ha addentato le viscere…
«Quello era un camorrista. E ti pare che io posso essere affiliato personaggi
come quella bestia?». Dillo ai magistrati, non a me… «Uno schifo di paese,
quello in cui ti puoi trovare in queste macellerie… Davvero è incredibile che
possano aver creduto a uno come Melluso». E in carcere? «Se non dai fastidio, ti
lasciano in pace. Vivi e lascia vivere. Poi certo, io sono sempre “il
Califfo”…». C’è chi ne è uscito schiantato: Lelio Luttazzi, hai voglia a dirgli
dopo che ci si è sbagliati, intanto il mondo ti crolla addosso… «Ognuno reagisce
a modo suo. Io la mia rabbia e la mia amarezza l’ho trasferita in alcune canzoni
per un nuovo disco, si intitola “Impronte digitali”». Prende la chitarra, la
voce è quella roca di sempre, impasto di whisky e mille sigarette fumate; canta
e strimpella: «Impronte digitali sulla stessa carta. / E il cuore ricucito un
po’ così così, trapasso quella porta. / M’hanno stracciato i pensieri. / Non
certo uomini seri. / Sono solo da tempo e la mia vita mi costa tanto. / Ma non
rallento il passo, continuo la salita. /Vedo innocenze ferite con le lacrime
agli occhi. / Che tristezza la vita. /Io cerco amore da sempre, vendo solo
canzoni. / Non spaccio altro e in ciò che vendo non trovi che emozioni /
difficile spiegare che sei uno pulito / quelli che non sanno bene come hai
sempre vissuto / se la legano al dito. / Il cuore mio sta pagando chi l’ha
colpito nell’ombra. / Vorrei portarlo più in alto / e certe leggi sbagliate
scavalcare in un salto. / Io volto pagina e cammino. / E anche se alle volte
sono andato contromano. / Non ho ferito mai nessuno. / Voglio anch’io una donna
che mi sappia amare / e con i miei amici andare a farmi un avvenire. / Io volto
pagina e cammino. / Cosa devo fare non vedere più nessuno / andare sempre più
lontano. / Sono ancora solo con il mio destino / vado sempre dritto / ma questo
sembra sia un delitto. / Impronte digitali, foto contro il muro. / Un numero sul
petto ed i colori addio, diventa tutto nero. / Quando comincia è finita, si paga
tutta la vita. / Sei in alto mare e non hai niente nemmeno un salvagente. / Io
volto pagina e cammino / e anche se alle volte sono andato contromano / non ho
ferito mai nessuno. / Voglio anch’io una donna che mi sappia amare / e con i
miei amici andare a farmi un avvenire. / Io volto pagina e cammino. / Cosa devo
fare non vedere più nessuno / Andare sempre più lontano / sono ancora solo con
il mio destino. / Vado sempre dritto / Ma questo sembra sia un delitto…». Quando
finalmente si celebra il processo, come Tortora, come tanti altri, anche
Califano viene assolto: si riconosce che è assolutamente estraneo ai fatti che
gli sono stati addebitati. Esce a testa alta dal carcere, è vero. Il problema è
che ci entri a testa bassa, e passano settimane, mesi, prima che riconoscano di
essersi sbagliati… E dopo averlo fatto, come il magistrato di Detenuto in attesa
di giudizio, il vecchio film di Nanni Loy con Alberto Sordi, ti guardano
aspettandosi che gli dici «grazie». Grazie per aver riconosciuto che si sono
sbagliati…Finora mi sono limitato a trascrivere “in bella” frettolosi appunti
presi su taccuini ingialliti dal tempo. Il ricordo però è ben vivo. Fummo
davvero in pochi, all’epoca, a osservare che anche per quel che riguardava “il
Califfo” i conti non tornavano. Il primo è Gino Paoli: scrive un accorato
appello al presidente della Repubblica, per richiamare l’attenzione su Califano,
detenuto da mesi, e malato. Scrivo i primi articoli nei quali esprimo qualche
dubbio, qualche perplessità; convinco un deputato del Partito Radicale ad
accompagnarmi nel carcere di Rebibbia in visita. La consegna, ferrea, è
guardare, ma non parlare con nessuno. L’unica cosa che si può fare è lasciare un
recapito per chi eventualmente ci vuole scrivere. Qualche giorno dopo arriva una
lettera di Califano: «Sono frastornato e distrutto, perché un uomo non è un
diamante, non ha il dovere di essere infrangibile… Ho in testa brutte
cose…venitemi a salvare, sono innocente, e non è giusto che muoia, che mi spenga
così…». Califano racconta che le accuse vengono soprattutto da due “pentiti”,
Pasquale D’Amico e Melluso. D’Amico poi ritratta. Melluso rincara le accuse. Una
fantasia galoppante: Califano, in compagnia di camorristi avrebbe effettuato un
viaggio da Castellammare fino al casello di Napoli, a bordo di una Citroen, ma
forse era una Maserati, comunque era di sua proprietà. Peccato che Califano in
vita sua non abbia mai avuto una Citroen, e neppure una Maserati. Per accertarlo
non bisogna essere Sherlock Holmes o Hercule Poirot, ma nessuno si prende la
briga di farlo. Queste le indagini; per come state condotte non poteva che
finire in una assoluzione piena: per Tortora, per Califano, per tanti altri. Ma
a prezzo di sofferenze indicibili e irrisarcibili. Furono pochi a vedere per
tempo quello che poteva essere visto da tutti; magra consolazione aver fatto
parte di quei “pochi”.
Il Pm accusatore di Tortora perseguita un
altro innocente, scrive Errico Novi il 5 ago 2016 su
“Il Dubbio”. È il 25 febbraio dell'anno scorso. «Sono innocente signor giudice,
sono finito in un incubo da quattro anni, mi accusano di spaccio di droga ma io
non ho mai commesso un reato, tutto per l'assurda interpretazione data ad alcune
cose che ho detto al telefono». Francesco Raiola quel giorno ha 34 anni. È nel
tunnel dal 21 settembre 2011, giorno dell'arresto per spaccio di droga. Parla
con passione, si difende davanti al gup di Nocera Inferiore senza che i suoi
avvocati aprano bocca. Dice una cosa forse decisiva nell'indurre il magistrato a
credergli: «Finalmente ho l'onore di parlare con un giudice che abbia effettiva
competenza sul mio caso». Fino a quel momento coincidenze, carambole e difetti
di giurisdizione lo hanno trascinato in una gimkana di sostituti e interrogatori
a vuoto. Alla fine dell'esame in udienza Francesco legge negli occhi del gup e
dei cancellieri «il rammarico di chi crede alla mia innocenza e vede la tortura
che ho passato». L'avvocato Andrea Castaldo lo guarda e gli dice: «Come hai
fatto a non piangere?». Non lo sa nemmeno lui. Verrà prosciolto a poco più di un
mese di distanza «perché il fatto non sussiste». «Le mie parole hanno suscitato
l'attenzione del giudice, quel mio incipit gli ha spalancato gli occhi». Peccato
non sia avvenuto lo stesso quattro anni prima, con la Procura di Torre
Annunziata. Da lì è partita l'indagine, operazione su un traffico di
stupefacenti denominata "Alieno". Al vertice dell'ufficio inquirente di Torre
Annunziata non c'è un magistrato qualsiasi: il procuratore della Repubblica è
Diego Marmo. Sì, proprio lui, l'accusatore di Tortora. La toga che diede a Enzo
del «cinico mercante di morte». E che trent'anni dopo si sarebbe cosparso il
capo di cenere in un'intervista a Francesco Lo Dico sul Garantista: «Chiedo
scusa ai familiari di Tortora», disse. Tre anni prima di quell'ammissione Marmo
non si era accorto del caso di Francesco Raiola. Da capo della Procura di Torre
Annunziata non si era reso conto che nelle maglie dell'indagine affidata ai suoi
sostituti era finito anche questo caporal maggiore dell'esercito, allora 30enne,
originario di Scafati, provincia di Salerno, e di stanza a Barletta. Una ragazzo
di valore: due missioni in Kossovo, una in Afghanistan con l'82esimo reggimento
fanteria. Pilota di mezzi corazzati e, quando ancora non aveva ottenuto
l'arruolamento definitivo nelle forze armate, già esperto nella guida dei
carrarmati di ultima generazione. Prima della folle vicenda giudiziaria
Francesco seguiva la specializzazione per i Vbm, i mezzi per i quali la Difesa
aveva speso decine di milioni di euro e che si era deciso di sperimentare
proprio nell'area di crisi afghana. Un uomo forte, integro, con la passione per
la vita militare, accusato - forse giustamente in questo caso - dalla moglie di
«aver sacrificato troppo per le forze armate», tanto da rinviare tre volte la
data delle nozze pur di rispondere alla chiamata per le missioni. Tutto
precipita per una telefonata in cui Francesco parla di televisioni. «Allora non
preoccuparti, te la porto io in caserma, la prendo dalle mie parti». Si tratta
di una tv full hd che Filippo, l'interlocutore, commilitone della stessa caserma
a Barletta, non troverebbe dalle sue parti. Non a un prezzo competitivo: ad
Altamura non ci sono grossi centri commerciali. A Scafati sì e si risparmia. Ma
invece che di hi-tech, i carabinieri incaricati dalla Procura di Torre pensano
che Francesco parli di carichi di droga. E che faccia da intermediario con i
trafficanti campani finiti nell'inchiesta per portare grosse quantità di
stupefacenti in Puglia, dove svolge l'attività di militare. In una delle
conversazioni il caporal maggiore parla di una «partita». È quella che l'amico
vorrebbe vedere su uno schermo piatto con inserimento diretto della scheda pay
tv. I carabinieri che trascrivono i brogliacci pensano che la «partita» sia una
partita di droga: cocaina e marijuana. Ci sarebbe da ridere se non fosse una
tragedia. Arriva l'alba del 21 settembre, l'arresto per spaccio. Francesco viene
prelevato a Barletta, direttamente in caserma. Tre settimane in carcere a Santa
Maria Capua Vetere, in isolamento, poi gli arresti domiciliari, revocati dal gip
di Napoli oltre quattro mesi dopo. L'avvocato Guido Sciacca comincia ad andare
in processione periodica dal pm di Torre a cui Marmo ha chiesto di condurre le
indagini. L'errore è chiaro. Le certezze del magistrato trascolorano in dubbi.
Ma né lui né il suo capo, Diego Marmo, hanno il coraggio di confutare il teorema
dei carabinieri. Ci vorrà un'istanza per incompetenza territoriale e il
passaggio del procedimento al Tribunale di Nocera Inferiore. C'è un'altra
Procura, un altro gup. In mezzo anche molti rinvii, perché l'inchiesta è grossa,
73 indagati, una sessantina di misure cautelari, e la Dia di Salerno chiede gli
atti. Francesco è - parole sue - «in un tritacarne che non finisce mai». Fino a
quella mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare di Nocera, «allo
sfogo in cui ho tirato fuori tutto, anni di sofferenze». Pochi giorni dopo
l'udienza e prima della sentenza di proscioglimento, al militare di Scafati
viene diagnosticato un melanoma. Operazione d'urgenza al Pascale, mesi con
l'incubo delle metastasi. Che per fortuna non ci sono, ma intanto Francesco
neppure pensa più alla fine dell'incubo giudiziario, non si scrolla di dosso
l'angoscia per la malattia. La moglie, i due figli piccoli, il padre in questi
mesi riescono a scuoterlo. A spingerlo ad occuparsi delle istanze per essere
reintegrato nell'esercito, che avranno esito forse in autunno. «Sono stati più
di cinque anni, cominciati prima dell'arresto, con appostamenti, perquisizioni
improvvise, che nemmeno capivo da dove venissero: andavo a comprare giubbotti al
mercatino di via Irno, a Salerno, e le gazzelle mi fermavano armi in pugno, con
i carabinieri convinti che dentro la borsa nascondessi chili di droga».
Verifiche andate tutte a vuoto: neppure questo ha scalfito l'atarassia dei pm e
del loro capo Marmo, contagiati da un'ostinazione che ricorda purtroppo quella
terribile sfoderata dallo stesso magistrato trent'anni prima contro Enzo
Tortora. Il Tribunale di Nocera ha riconosciuto 41mila euro d'indennizzo per
errore giudiziario, «ma io ne ho spesi 32mila per gli avvocati e il resto». Il
vicepresidente del Copasir Peppe Esposito, senatore campano di lungo corso, ha
presentato un'interrogazione ai ministri della Giustizia e della Difesa, oltre
che a Renzi. Francesco Raiola, soldato, marito, padre, e uomo ancora in piedi
dopo il calvario dice di credere ancora nella giustizia: «Perché ho trovato
magistrati che mi hanno ascoltato, creduto e si sono messi a cercare nelle carte
riscontri della mia innocenza che io non avevo tirato fuori. Agli innocenti come
me dico di non mollare». Altri magistrati sono distratti. Qualcuno che se ne
accorge, corregge e fa giustizia, prima o poi arriva.
Enzo Tortora. Errore giudiziario epocale. Fu
accusato di gravi reati, ai quali in seguito risultò totalmente estraneo, sulla
base di accuse formulate da soggetti provenienti da contesti criminali; fu per
questo arrestato e imputato di associazione camorristica e traffico di droga.
Dopo 7 mesi di reclusione la sua innocenza fu dimostrata e riconosciuta e venne
infine definitivamente assolto. Durante questo periodo, Tortora fu eletto
eurodeputato per il Partito Radicale, di cui divenne anche presidente. Tortora
morì poco dopo la sentenza che metteva fine al suo calvario.
Lo sfregio dell'ex pm Grasso: negato il
Senato per Tortora. Il presidente vieta l'incontro:
fuori da fini istituzionali Poi tira fuori la par condicio: la compagna di
Tortora è candidata, scrive Patricia Tagliaferri, Sabato, 18/06/2016, su "Il
Giornale". La vicenda del protagonista di uno degli errori giudiziari più
clamorosi della nostra storia, di un uomo che ha saputo trasformare la sua
sofferenza di innocente stritolato da una giustizia ferma al Medioevo e
dall'assenza di diritto in una battaglia per una giustizia giusta, «non è
collegata alle finalità istituzionali del Senato». Almeno non è lo per chi, da
quando non è più magistrato, il Senato lo presiede, Pietro Grasso, il quale non
ha concesso alla compagna di Tortora, Francesca Scopelliti, una delle sale di
Palazzo Madama per presentare «Lettere a Francesca», il libro che raccoglie una
selezione delle struggenti missive scritte in carcere dal conduttore Tv
ammanettato nel giugno del 1983 e divenute ora testimonianza della battaglia
politica che Tortora ha combattuto fino all'ultimo insieme al partito Radicale
per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, della terzietà
del giudice e della separazione delle carriere. A 33 anni dal suo arresto sulla
base di false accuse per associazione camorristica e spaccio di droga, Tortora
fa ancora discutere. La polemica la solleva la stessa Scopelliti presentando il
libro insieme al presidente dell'Unione delle Camere penali, Beniamino
Migliucci. Presentazione che dopo l'illustre «sfratto» è avvenuta al Tempio di
Adriano, con Emma Bonino e Giuliano Ferrara. È lei a raccontare che l'incontro
si sarebbe dovuto tenere nel Palazzo della Minerva, nella biblioteca del Senato,
sede che aveva chiesto come ex senatrice e che le era stata concessa, tanto che
erano già partiti i primi inviti con quell'indicazione. Mancava solo il sigillo
della presidenza. Ma gli uffici di Grasso hanno detto no, anche se ora corrono
ai ripari ponendo una questione di par condicio: per il portavoce del presidente
la sala è stata negata perché la Scopelliti è candidata al consiglio comunale di
Milano e l'evento di ieri era troppo a ridosso del ballottaggio. È del 7 giugno
la lettera in cui la coordinatrice della segreteria del presidente Grasso scrive
che «la presentazione del libro non è collegata alle finalità istituzionali del
Senato». La Scopelliti legge e non riesce a credere che esuli dalle finalità del
Senato il racconto di un uomo che ha trasformato l'infamia subita in una
battaglia non tanto per dimostrare la sua innocenza ma per parlare del «caso
Italia». Un paese dove, come scriveva Tortora, «solo i bimbi, i pazzi e i
magistrati non rispondono dei loro crimini» e dove un uomo onesto può diventare
«bersaglio» della «miserabile vanità di due Autorevoli che non possono per
definizione sbagliare». La risposta della Scopelliti arriva il 16 giugno. In
essa elenca i motivi per i quali le lettere avrebbero dovuto avere la giusta
attenzione del Senato. «Il libro - spiega a Grasso - parla di un uomo perbene,
accusato da alcuni magistrati per male che nonostante questo hanno fatto
carriera, denuncia il nostro sistema penale che abbisogna di una riforma non più
rinviabile proprio perché non ci siano più innocenti in carcere e il nostro
sistema carcerario più volte denunciato dall'Europa». La compagna di Tortora si
chiede se tutto questo possa non rispecchiare le finalità istituzionali del
Senato. «Spero che la decisione - gli dice - non sia stata dettata più dal suo
passato di magistrato che dalla sua attuale veste di seconda carica del Paese».
Nel motivare la sua assenza alla presentazione del libro il senatore Giorgio
Napolitano parla del caso Tortora come «esemplare di indagini e sanzioni penali
non fondate su basi probatorie adeguate né rispettose d garanzie basilari della
libertà e dei diritti delle persone». «Problemi di sistema ancora aperti»,
ammette.
L'Italia umilia ancora Enzo Tortora:
sfregio al Senato, scatta la denuncia, scrive di
Roberta Catania il 18 giugno 2016 su “Libero Quotidiano”. L'ex procuratore Piero
Grasso, nella veste di presidente del Senato, ha valutato il caso di Enzo
Tortora «scollegato da finalità istituzionali» e ha negato al comitato
organizzativo un'aula di Palazzo Madama per la presentazione di un libro sul
presentatore televisivo vittima della magistratura. La vicenda che 33 anni fa
portò in carcere il presentatore di Portobello è stata ripercorsa in un volume
in cui la sua compagna dell'epoca, Francesca Scopelliti, ha dato voce a Enzo,
rendendo note 45 lettere che Tortora le scrisse dal carcere. Missive «spietate»,
in cui il giornalista scriveva degli inquirenti: «Solo tre categorie di persone
(ho scoperto) non rispondono dei loro crimini: i bambini, i pazzi e i
magistrati». Dalle lettere viene fuori la rabbia per essere stato tradito dal
suo Paese, dagli amici, dai colleghi: «Sto pensando di chiedere il cambio di
cittadinanza. Questo Paese non è più il mio», e ancora: «Non mi parlare della
Rai, della stampa, del giornalismo italiano. È merda pura». I 33 anni dall'
arresto ricorrevano ieri e per allora era stata fissata la presentazione del
libro Lettere a Francesca, ma Grasso ha negato il consenso. Eppure il suo via
libera avrebbe dovuto essere un semplice proforma. «Tutti gli uffici mi avevano
dato la disponibilità», racconta a Libero la Scopelliti, che aggiunge: «Sembrava
cosa fatta, tanto che avevo già fatto preparare gli inviti con il logo del
Senato. Oltretutto mi avevano concesso l'aula a titolo gratuito per
"l'iniziativa meritevole", ma all' ultimo è arrivata la comunicazione del
presidente Grasso che bloccava tutto». La presentazione c' è stata comunque, ma
altrove: al Tempio di Adriano, nella centralissima piazza di Pietra, dove sono
intervenuti - tra gli altri- Giuliano Ferrara e Emma Bonino. La vedova di
Tortora non ha però rinunciato, con la stessa schiettezza dell'ex compagno, a
rispondere alla lettera con cui Gabriella Persi, la segretaria del presidente
del Senato, informava del diniego di Grasso a offrire il palazzo istituzionale
come teatro della presentazione. «Il libro denuncia il nostro sistema penale»,
aveva quindi replicato la Scopelliti, «che abbisogna di una riforma non più
rinviabile proprio perché non ci siano più innocenti in carcere, cosa che invece
accade ancora. Così come denuncia il nostro sistema carcerario più volte e
aspramente denunciato dall' Europa perché non corrispondente ai parametri di
civiltà e di rispetto dell'uomo. Il libro parla di un uomo che, a dispetto di
chi lo voleva vittima, si è fatto protagonista di una nobile battaglia per la
giustizia diventando così un grande leader politico, in Italia e in Europa. Se
tutti questi argomenti», ha concluso la donna, «non rispecchiano «le finalità
istituzionali del Senato», allora mi deve spiegare quali sono e come giustifica
tante altre iniziative che hanno invece ottenuto il «sigillo» senatoriale.
Naturalmente rispetto la decisione del Presidente del Senato ma - mi si
perdonerà la franchezza - spero non sia stata dettata più dal suo passato di
magistrato che dalla attuale veste di seconda carica istituzionale del Paese.
Sarebbe un'ulteriore ferita per Enzo Tortora. Una lesione per le nostre povere
istituzioni. Un affronto». A cose fatte, la Scopelliti ha scoperto che come ex
segretario del Senato avrebbe avuto diritto a fare la presentazione a Palazzo
Madama, ma «alla fine sono stata felice di essere stata accolta nel Tempio di
Adriano, che fu un grande imperatore».
Caso Tortora trent'anni dopo, Di Persia:
“Nessun errore giudiziario”. "Se Marmo è convinto del
suo pentimento deve autocancellarsi dalla vita sociale", scrive “Il Velino”.
“Vuole sapere cosa penso del caso Tortora? Si legga Il Mattino di mercoledì 8
giugno 1988 quando fui costretto a difendermi in sede disciplinare e dissi
Ministro anch’io sono innocente”. A primo impatto risponde così in esclusiva al
VELINO Felice Di Persia il magistrato che con Lucio Di Pietro fu titolare
dell’inchiesta che mise alla sbarra Enzo Tortora, il popolare conduttore
televisivo. Un caso giudiziario che ancora scotta e fa discutere soprattutto
alla luce delle dichiarazioni di questi giorni rilasciate al Garantista
da colui che sostenne l’accusa in aula contro Tortora, Diego Marmo, oggi
nominato tra le polemiche assessore alla Legalità del Comune di Pompei. Ha fatto
le sue scusa per aver chiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente con
sentenza passata in giudicato. Da anni di Pietro e Di Persia non parlano di quel
capitolo della loro storia professionale. Di Persia, contattato dal VELINO
ribadisce: “Ci vogliono ore per affrontare il caso Tortora”. Dopo lunghe
insistenze Di Persia commenta però le recenti dichiarazioni di Marmo. “Non ho
letto quello che ha detto con precisione, ho saputo che si è pentito: di cosa?
Di aver apostrofato Tortora in aula come mercante di morte? Allora ha ragione la
signora Scopelliti (compagna di Tortora, ndr) a dire che si è pentito con
trent’anni di ritardo e fa bene a chiedere scusa perché un magistrato non può
mai scomporsi, tanto meno in aula. Se si è pentito invece per aver chiesto la
condanna, doveva farlo il giorno dopo. Non oggi. E se è convinto del suo
pentimento deve auto cancellarsi dalla vita sociale. Tra l’altro avrebbe dovuto
chiedere scusa anche ai circa 130 imputati del cosiddetto troncone Tortora,
assolti con il presentatore". "Di quei 130 liberati, a differenza di Tortora
morto in condizioni così tragiche, un numero imponente venne successivamente
ammazzato in conflitti a fuoco tra clan di camorra, altri addirittura si
pentirono tutti offrendo la prova ulteriore della correttezza della nostra
indagine istruttoria che portò alla condanna di ben 480 imputati. Tortora fu
assolto - continua Di Persia - e rispetto il dispositivo di quella sentenza
perché nella dialettica processuale non ritennero le prove raccolte idonee a una
condanna: questo fa parte della fisiologia del processo. Dunque non ci furono
errori giudiziari di magistrati che con la loro carriera quarantennale hanno
onorato la magistratura”. Di Persia aggiunge: “Nel processo Tortora, Marmo
c’entra come il cavolo a merenda visto che non ha fatto nulla: è andato a
giudizio ripetendo meccanicamente ciò che era scritto nei faldoni dell’accusa”.
L’ex titolare dell’inchiesta non vuole dilungarsi e conclude: “A quanto pare
Marmo è il primo magistrato pentito della storia italiana. In questo caso, come
fanno i pentiti, dia riscontri chiari alle sue tesi. Perché ha chiesto la
condanna di Tortora? Spero lo faccia, ma non rifugiandosi però nel nome di
qualcuno che non può smentirlo perché morto”.
Di Persia, un’occasione persa per tacere,
scrive Francesco Lo Dico
su “Il Garantista”. Anche lui da molti anni non parlava della condanna inflitta
a Enzo Tortora. E che Felice Di Persia abbia
voluto rompere il lungo riserbo sulla vicenda, è un dato che andrebbe accolto
con favore. Non fosse che l’intervista rilasciata al Velino è
un’occasione perduta. Allora titolare, insieme con Lucio Di Pietro,
dell’inchiesta che portò Tortora alla sbarra, Di Persia avrebbe potuto fare
ammenda per un’inchiesta che portò al più grande caso di macelleria giudiziaria
della storia italiana. Ferma la buona fede, la toga avrebbe potuto chiarire
anche lui perché senza prove di bonifici, controlli bancari, pedinamenti e
intercettazioni montò un castello di carte che fece finire in gattabuia il
presentatore di Portobello sulla base delle dichiarazioni di pentiti farlocchi
che sono costate la vita, a detta di Francesca Scopelliti, ma senza lo stupore
di nessuno, a quel galantuomo di Enzo Tortora. Ma l’unico pentito verso il quale
l’ex magistrato sembra puntare il dito è invece Diego Marmo. «Ho saputo che si è
pentito: di cosa? Di aver apostrofato Tortora in aula come mercante di morte?
Allora ha ragione la signora Scopelliti a dire che si è pentito con trent’anni
di ritardo», chiosa Di Persia. Ma nell’intervista che l’ex procuratore di Torre
Annunziata ha dato al Garantista, è palese che sono solo ed esclusivamente le
scuse ad essere arrivate in ritardo di trent’anni. “Il rammarico – ha spiegato
l’ex pm al nostro giornale – c’era da tempo”. Lucio Di Persia, però, concede a
Marmo il lusso di una seconda ipotesi accusatoria. «Se si è pentito invece per
aver chiesto la condanna – continua Di Persia – doveva farlo il giorno dopo. Non
oggi. E se è convinto del suo pentimento deve autocancellarsi dalla vita
sociale”. ”Autocancellarsi dalla vita sociale”, dice Di Persia. Che forse
sarebbe a dire chiudersi in qualche eremo a recitare il penitentiagite
per dimostrare l’autenticità del rammarico. È
proprio in questa sottile e violentissima fatwa,
che la magistratura appare incapace di sincero cordoglio e capacità di
autoriformarsi. «A quanto pare – commenta Di Persia – Marmo è il primo
magistrato pentito della storia italiana. In questo caso, come fanno i pentiti,
dia riscontri chiari alle sue tesi. Perché ha chiesto la condanna di Tortora?
Spero lo faccia, ma non rifugiandosi però nel nome di qualcuno che non può
smentirlo perché morto». Marmo è trattato insomma alla stregua di un pentito che
il clan pretende di allontanare dal cerchio magico per vendetta. Marmo è il
reprobo dal quale si pretende di estorcere, a dimostrazione di un sincero
disagio interiore, la colpa assoluta e annichilente dell’autoesclusione sociale.
Non se ne comprende invece il rammarico che chi scrive, insieme a pochi come
Ambrogio Crespi, reputa sincero. Di quelle scuse alla famiglia, di quelle poche
note che con molta discrezione Marmo ha affidato a Il Garantista a
proposito del processo, si sottolinea nient’altro che la perversa intenzione di
tirarsi fuori dalla melma. Ma la vera angoscia che forse generano le scuse di
Marmo, inammissibili, spiazzanti e meravigliose, è la paura di restare ammollo
al sangue innocente di Tortora. Un aspetto che Diego Marmo, ancora avvezzo a
decriptare messaggi in codice, non trascura di cogliere nelle dichiarazioni che
affida al nostro giornale. «Nella mia intervista a Il Garantista che
peraltro Di Persia dice di non aver letto con precisione – ci scrive l’ex
procuratore di Torre Annunziata – non ho accusato nessuno. Mi sono limitato
soltanto a dire quali erano stati i ruoli dei singoli partecipanti».
Le dichiarazioni che Felice Di Persia ha rilasciato a
Il Velino, sono la prova inconfutabile
che le scuse di Diego Marmo alla famiglia Tortora hanno scavato un solco
profondo nella coscienza dei protagonisti di quella storia giudiziaria, e
nell’autopercezione che ha di se stessa la magistratura italiana. Intoccabile,
unita come un sol uomo, sacerdotale, la casta dei giudici sembra di colpo
cominciare a ruzzare dentro la piccola stia dei risentimenti. Le scuse del
Grande Inquistore italiano, dell’ “assassino morale” di Tortora che solo su di
sé aveva attratto i fulmini della storia lasciando all’asciutto tutti gli altri
carnefici, devono avere mosso qualche disagio negli altri complici della
“congiura”. «Le mie scuse sono vere. Se arrivano con ritardo bisogna anche
considerare che il tempo fa maturare, in molti casi. Per porgerle, d’altra
parte, ci doveva anche essere l’occasione», ci scrive Diego Marmo. Come bene ha
detto Ambrogio Crespi su queste colonne, il tempo della rivoluzione è arrivato.
E reca in effigie il volto di Torquemada.
«Taci Di Persia, sei solo una soubrette», scrive
Francesco Lo Dico su “Il Garantista”. «Quando Di Persia fu eletto al Csm dopo
aver condannato Tortora, l’allora presidente della Repubblica, Francesco
Cossiga, si rifiutò di stringergli la mano. Per Di Persia parla la storia».
Raggiunta al telefono da Il Garantista Francesca Scopelliti, compagna di
Enzo Tortora nel suo calvario giudiziario prima, e nelle file dei Radicali poi,
non riesce a capacitarsi.
L’intervista che Felice Di Persia, il titolare
dell’inchiesta che mise alla sbarra Enzo Tortora, ha concesso al Velino a
proposito della condanna di Tortora, e delle scuse di Diego Marmo rivolte ai
familiari del presentatore dalle nostre colonne, la lascia una volta di più
esterrefatta. Dopo Diego Marmo, che ha rotto il lungo silenzio per fare le scuse
ai familiari, anche Di Persia ha deciso di parlare. Che cosa ne pensa delle sue
dichiarazioni?
«Penso che
quanto meno, anche se non posso accettarle perché tardive e insufficienti, Marmo
ha fatto le sue scuse. Spero che gli siano utili a pacificarsi con la sua
coscienza. Di Persia, visto quello che ha detto, ha perso invece un’ottima
occasione per tacere. Sarebbe stato più dignitoso per lui restare in silenzio».
Che cosa l’ha turbata più di tutto delle
dichiarazioni di Di Persia?
«Di Persia ha
confermato ancora una volta quello che allora apparve evidente a tutti: c’era il
progetto di crocifiggere Tortora. C’era un piano, studiato a tavolino per fare
di Enzo il condannato eccellente, da dare in pasto all’opinione pubblica in nome
della vanità e dell’esibizionismo. Colpisce molto, nell’intervista concessa, la
maniera in cui Di Persia commenta la sentenza di assoluzione di Tortora. ”Non
ritennero le prove raccolte idonee a una condanna: questo fa parte della
fisiologia del processo. Dunque non ci furono errori giudiziari di magistrati
che con la loro carriera quarantennale hanno onorato la magistratura”. Sono
parole che si commentano da sole. Di Persia non è disposto a tornare indietro,
si arrocca nelle posizioni di trent’anni fa e in buona sostanza rivendica
l’assurda pretesa di avere avuto ragione a perseguitare un innocente. Una
questione di soubrettizzazione».
Che cosa intende di preciso?
«Basterebbe
guardare i titoli e i giornali di allora per comprendere quali benefici
mediatici si sono assicurati quelli come Di Persia. Si facevano ritrarre in
atteggiamenti sportivi, come piccoli eroi da rotocalco o moderne soubrette.
Erano diventati personaggi pubblici grazie alla persecuzione di un personaggio
pubblico vero, amato, da scagliare nella polvere e umiliare. Di Persia dichiara
a un certo punto che “Marmo c’entra come il cavolo a merenda visto che non ha
fatto nulla: è andato a giudizio ripetendo meccanicamente ciò che era scritto
nei faldoni dell’accusa”. È una chiosa che aggrava ancora di più la sua
posizione e che ribadisce quello che ho sempre detto. Mi fa piacere che dopo
trent’anni anche Di Persia concordi con me: fa passare il pubblico ministero di
quel processo come il commediante di un’enorme farsa. Esattamente quello che ho
sempre pensato. Di Persia ha invitato tra l’altro Marmo, a suo dire ”il primo
magistrato pentito della storia” ad autocancellarsi dalla vita sociale per
dimostrare il suo pentimento. È una frase dal sen sfuggita, del tutto
rivelatrice di una mentalità castale che tratta Marmo alla stregua di un pentito
da isolare secondo la tipica mentalità del clan. Allora ci fu perfetta concordia
tra pm e giudici istruttori. Lucio Di Pietro e Felice Di Persia inchiodarono
Tortora. E ora che qualcuno ha fatto un passo indietro, si è rotto il sacro
sigillo di quella istruttoria che ancora Di Persia difende senza un briciolo di
rimorso. Ha infatti specificato che non ci furono errori giudiziari nella sua
inchiesta. E che l’assoluzione di Tortora fa parte della dialettica processuale.
Nessun cenno al carcere e alla malattia di Tortora. Ha definito l’assoluzione
del presentatore come parte della “fisiologia del processo”. Espressioni di
questo genere dicono ancora una volta di quanta demenziale presunzione è nutrito
il personaggio di Di Persia. Più delle mie considerazioni, valgono le moltissime
pagine che spinsero i giudici dell’appello a spazzare via menzogna dopo
menzogna, il castello di carte costruito da Di Persia e Di Pietro. Di Persia
rivendica ancora la correttezza del suo operato. Nessun rammarico, sembra. Erano
eccitati dal brivido di incastrare un personaggio noto ed amatissimo da 26
milioni di persone. In nome di questo progetto ne sacrificarono sull’altare la
sua innocenza per ergersi a giustizieri e prendersi le luci della ribalta. Se
non fosse così protervo e arrogante, Di Persia dovrebbe aprire il dispositivo di
sentenza e rileggersi parola dopo parola, le prove dell’assurdità delle sue
invenzioni. Lo spiega la sentenza d’appello quale fu la qualità del lavoro di Di
Persia».
Si riferisce alla famigerata “nazionale dei
pentiti”?
«Costruirono
un’accusa fondata su calunnie ed infamie, alcune persino ridicole come quelle di
Margutti e della valigetta di droga. È la sentenza dell’appello che meglio di me
ha espresso quali considerazioni si possono fare sull’operato di Di Persia. Fu
un pessimo magistrato che sparò nel mucchio e lavorò all’ammasso: colpevoli e
innocenti nello stesso calderone indistinto».
Che cosa le ha raccontato di lui Enzo Tortora?
«Le riferisco
soltanto un piccolo particolare. Spesso, al termine di estenuanti interrogatori,
Di Persia guardava Enzo negli occhi e gli sibilava: «Buona fortuna». Gli
lasciava intendere che l’avrebbe stritolato. Era come mi scriveva Enzo dal
carcere: “Questi, per salvarsi la faccia, fottono me”. È quello che fecero.
Nell’intervista, Di Persia dà a Marmo del “magistrato pentito”. È come se l’ex
procuratore, con le sue scuse, avesse rotto una sacra alleanza. Un gesto umano,
che dal resto della casta viene letto come una sorta di tradimento, il primo
della storia. La reazione di Di Persia spiega meglio di molti ragionamenti
perché è impensabile sperare che i magistrati possano autoriformarsi da soli. Ma
allo stesso tempo, come è evidente da anni, è piuttosto ingenuo pensare che la
politica possa giungere a un’autentica riforma. Il Parlamento vive sotto
ricatto. E l’intervista di Di Persia è l’ennesimo capitolo di una storia di
sacro terrore verso un potere assoluto e intoccabile, che si chiama magistratura
italiana.»
Il pm Diego Marmo: “Su Tortora ho
sbagliato, chiedo scusa alla famiglia, scrive
Francesco Lo Dico su “Il Garantista”.
«Ho richiesto
la condanna di un uomo dichiarato innocente con sentenza passata in giudicato. E
adesso, dopo trent’anni, è arrivato il momento. Mi sono portato dentro questo
tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla famiglia di Enzo Tortora per quello
che ho fatto. Agii in perfetta buona fede».
Dopo un lungo corpo a corpo fatto di reciproci
pregiudizi, di frasi smozzicate e di estrema diffidenza, Diego Marmo, il pm che
inchiodò Enzo Tortora con una dura requisitoria rimasta negli annali, si è
finalmente svestito della toga. Ma prima, prima di questo, c’è la foga di
chiedere, di giudicare senza appello a nostra volta.
Ci sono state molte polemiche per la sua nomina
ad assessore alla Legalità a Pompei. Ma ha dichiarato al Velino che il caso
Tortora è un “episodio” della sua carriera. Non le pare di aver liquidato la
vicenda con troppa sufficienza?
«A domanda ho
risposto. Si parlava della mia nomina ad assessore a Pompei. La storia del mio
coinvolgimento sul caso Tortora è tutto un altro capitolo, un capitolo di
un’attività professionale lunga 50 anni, che non può essere affrontato in due
minuti. La cosa è molto più complessa.»
Eppure lo ha fatto. Ha definito come “episodio”
il più grande caso di macelleria giudiziaria della storia italiana. É sembrato
che stesse dicendo: “Ora faccio l’assessore, e chissenefrega di Tortora”.
«In trent’anni
non ho mai pensato o detto “chissenefrega del caso Tortora”. Immaginavo che
potessero sorgere polemiche sulla mia nomina. Ma alla fine ho deciso di
accettare perché la situazione degli scavi di Pompei mi sta particolarmente a
cuore. Esercitando la funzione di procuratore a Torre Annunziata, mi sono
convinto dello stato di abbandono nel quale si trova la città antica.»
Verrà pagato per questo incarico?
«Lavorerò a
titolo gratuito, mi pagherò anche la benzina. E se la mia presenza dovesse
provocare difficoltà al buon funzionamento della giunta, sono pronto a lasciare.
Il sindaco mi ha scelto senza conoscermi personalmente perché probabilmente ha
apprezzato il mio lavoro da procuratore. Ho accettato perché sono dell’avviso
che la legalità non va predicata ma praticata. Ho lasciato la Procura di Torre
Annunziata con amarezza.»
A che cosa si riferisce?
«Parlo
dell’omicidio di Vero Palumbo. Faceva il meccanico. La notte del 31 dicembre,
mentre giocava a scopa, è stato ucciso dai colpi d’arma da fuoco della camorra
che festeggiava barbaramente il Capodanno. Ho promesso alla sua famiglia che
avrei trovato l’assassino. Non ci sono riuscito. Questa nomina potrebbe aiutarmi
a sollecitare il legislatore ad estendere i benefici che riguardano le vittime
della camorra anche alla vedova e alla figlia, alle quali questo status non
viene riconosciuto.»
Sembra un uomo capace di provare rammarico.
Perché per Tortora non ne ha mai provato?
«È quello che
ha sempre pensato il circo mediatico. Quello che avete sempre pensato tutti voi.
Ma il rammarico c’era da tempo. L’unica difesa che avevo era il silenzio.»
Se provava rammarico, non era meglio
manifestarlo? Perché ha taciuto?
«Perché nessuno
prima d’ora me lo aveva mai chiesto. Vi siete accaniti contro di me. Mi avete
condannato. Venivo sempre aggredito. Ma nessuno ha mai pensato di interpellarmi
o ascoltarmi.»
È lei che ha chiesto la condanna di Tortora
senza prove. La ascolto volentieri.
«Il mio lavoro
si svolse sulla base dell’istruttoria fatta da Di Pietro e Di Persia. Tortora fu
rinviato a giudizio da Fontana. Io feci il pubblico ministero al processo. E
sulla base degli elementi raccolti, mi convinsi in perfetta buona fede della sua
colpevolezza. La richiesta venne accolta dal Tribunale.»
Non avevate niente: nessun controllo bancario,
nessun pedinamento, nessuna intercettazione. Solo la “nazionale dei pentiti”.
Come ha potuto chiedere 13 anni per il presentatore?
«Mi vuole fare
il processo?»
No, voglio delle risposte.
«A ciascuno il
suo. Mi faccia rispondere di quello che ho fatto io. Gli elementi raccolti in
fase istruttoria mi sembrarono sufficienti per richiedere una condanna. Ma
Tortora non era l’unico imputato di quel processo. Insieme a lui c’erano altri
246 imputati. Io chiesi un terzo di assoluzioni. Si sono dette anche molte
menzogne sul mio conto. Tempo fa mio figlio mi chiamò allibito. Mi disse: “Papà,
in televisione hanno appena detto che hai fatto arrestare Tortora”.»
Si sente il capro espiatorio?
«Molte anime
belle, e anche tanti giornalisti e colleghi, batterono allora la gran cassa
contro l’imputato eccellente. Molti sono gli stessi che ancora oggi gridano allo
scandalo. Ma in Italia si dimentica in fretta. E pochi sanno che in Procura mi
indignai per le sfilate degli uomini in manette davanti alle telecamere. Nei
trent’anni successivi di carriera, come in precedenza, non lo permisi mai.»
Incise la pressione mediatica sul processo?
Perdere l’imputato eccellente sarebbe stato un duro colpo per il vostro operato?
«Facemmo di
tutto per perdere l’imputato eccellente. Era una presenza che avrebbe creato una
bufera. La pressione mediatica fu terrificante, lo ammetto. Ma c’era molta più
sete di sangue di quanto non sembri oggi. Erano molti, in giro, i “Diego Marmo”.
Ma sul banco degli imputati sono rimasto io solo.»
È vero. Ma nell’immaginario è rimasto come il
carnefice di Tortora perché lo definì un “cinico mercante di morte”, un “uomo
della notte” ben diverso dal bravo presentatore di Portobello. Non giudicò
l’imputato, giudicò anche l’uomo. Lei andò oltre, lo ammetta.
«La
requisitoria durò circa una settimana, quella nei confronti di Tortora durò
alcune ore. La frase venne inserita in un contesto accusatorio. Certamente mi
lasciai prendere dal mio temperamento. Ero in buona fede. Ma questo non vuol
dire che usai sempre termini appropriati, e che non sia disposto ad ammetterlo.
Mi feci prendere dalla foga.»
Come le venne in mente di dire che Tortora era
stato eletto con i voti della camorra?
«Non l’ho
detto.»
Si, lo ha fatto. Lo abbiamo sentito tutti.
«Non era quello
che è stato inteso. Il mio discorso era molto più articolato. Pur precisando che
né Tortora né i Radicali avevano chiesto voti alla camorra, feci notare
viceversa che la malavita aveva sponsorizzato alcune candidature per trarne
vantaggio. Ne ebbi riscontro dalla stampa e dai tabulati che mi consegnarono i
carabinieri. Era emerso che al carcere di Poggio Reale, e nel triangolo
Bagheria, Altavilla, Casteldaccia, i radicali avevano preso moltissimi voti. Ma
sono altre le cose che mi rimprovero.»
Che cosa?
«Tortora si
comportò da uomo vero, ma lo capii successivamente.»
Sta dicendo che ha provato ammirazione per
Tortora?
«Fu un imputato
esemplare. Più passa il tempo e vedo l’Italia che ho intorno, e più mi rendo
conto della differenza tra lui e chi lo chiama in causa oggi a sproposito.»
Che cosa intende esattamente?
«Tortora
avrebbe potuto appellarsi all’immunità ma non lo fece. Volle farsi la galera pur
di difendere la sua innocenza. E mi fanno arrabbiare certi quaquaraquà di oggi
che invocano il suo nome per nascondere magagne e miserie e ottenere visibilità.»
Perché chiese la condanna?
«Ripeto. Non
fui il solo a reputare Tortora colpevole: la mia richiesta venne accolta. Il
rispetto del mio ruolo di magistrato mi impone di non parlare di altri. Dico
solo che mi sbagliai. E che dopo le sentenze di assoluzione, mi resi conto
dell’innocenza di Tortora e mi inchinai.»
Non aveva mai ammesso di avere sbagliato.
Mi sta dicendo che è pentito?
«Non ho mai
pensato di raccontare il mio stato d’animo sino ad ora. Ho creduto che ogni mia
parola non sarebbe servita a niente. Che tutto mi si sarebbe ritorto contro. Ho
preferito mantenere il silenzio. Ero Diego Marmo, l’assassino morale di Tortora.
E dovevo tacere.»
Ha parlato di colpa. Una parola forte per uno
che ha definito la richiesta di condanna per Tortora come un “episodio” della
sua carriera.
«Non ho usato
quel termine in senso riduttivo. In 50 anni di lavoro gli “episodi” sono stati
tanti. Molti drammatici: processi di terrorismo, camorra, vita blindata per
dieci anni con inevitabili disagi per me e soprattutto per la mia famiglia. E
tuttavia che cosa crede? Ho richiesto la condanna di un innocente. Porto il peso
di quello sbaglio nella mia coscienza. Sono un cattolico osservante. E ho sempre
pensato di dovermela vedere con me stesso, e con Dio.»
Poteva vedersela anche con i familiari di
Tortora, non pensa?
«Ci ho pensato
a lungo. Ma alla fine non l’ho mai fatto. Mi sono detto che non si poteva
tornare indietro, e che niente che potessi fare o dire sarebbe servito a
qualcosa. “Si, potrei anche provare a incontrarli”, ragionavo tra me e me. Ma
temevo che il mio gesto potesse risultare sgradito.»
E forse ha paura di chiedere perdono.
«Ho richiesto
la condanna di un uomo dichiarato innocente. Ma adesso, dopo trent’anni, è
arrivato il momento. Mi sono portato dentro questo tormento troppo a lungo.
Chiedo scusa alla famiglia di Enzo Tortora per quello che ho fatto. Posso dire
soltanto che l’ho fatto in buona fede.»
Grazie dottor Marmo. A me le sue parole sembrano
molto importanti. Le cose che mi ha detto le fanno onore. E sbriciolano i
pregiudizi sui pm visti come sceriffi implacabili. Magari avessero tutti il
coraggio di ammettere i propri errori. Non l’avrei immaginato. Ci ha dato una
lezione. Non come pm, ma come uomo.
Il caso Tortora trent'anni dopo.
Nel giugno del 1983 l'arresto del popolare conduttore televisivo. Le accuse dei
pentiti, la gogna pubblica, l'assoluzione in Cassazione, la malattia e la morte.
Per quello che Giorgio Bocca definì "il più grande esempio di macelleria
giudiziaria" nessuno ha mai pagato, scrive Carlo Verdelli su “La Repubblica”.
Qualsiasi cosa ci sia dopo, il niente o Dio, è molto probabile che Enzo Tortora
non riposi in pace. La vicenda che l'ha spezzato in due, anche se ormai lontana,
non lascia in pace neanche la nostra di coscienza. E non solo per l'enormità del
sopruso ai danni di un uomo (che fosse famoso, conta parecchio ma importa
pochissimo), arrestato e condannato senza prove come spacciatore e sodale di
Cutolo. La cosa che rende impossibile archiviare "il più grande esempio di
macelleria giudiziaria all'ingrosso del nostro Paese" (Giorgio Bocca) è il fatto
che nessuno abbia pagato per quel che è successo. Anzi, i giudici coinvolti
hanno fatto un'ottima carriera e i pentiti, i falsi pentiti, si sono garantiti
una serena vecchiaia, e uno di loro, il primo untore, persino il premio della
libertà. Non fosse stato per i radicali (da Pannella al neo ministro Bonino, da
Giuseppe Rippa a Valter Vecellio) che lo elessero simbolo della giustizia
ingiusta e lo fecero eleggere a Strasburgo. Non fosse stato per Enzo Biagi che
proprio su Repubblica, a sette giorni da un arresto che, dopo gli stupori, stava
conquistando travolgenti favori nell'opinione pubblica, entrò duro sui
frettolosi censori della prima ora (da Giovanni Arpino, "tempi durissimi per gli
strappalacrime", a Camilla Cederna, "se uno viene preso in piena notte, qualcosa
avrà fatto") con un editoriale controcorrente: "E se Tortora fosse innocente?".
Non fosse stato per l'amore e la fiducia incrollabile delle figlie (tre) e delle
compagne (da Pasqualina a Miranda, prima e seconda moglie, fino a Francesca, la
convivente di quell'ultimo periodo). Non fosse stato per i suoi avvocati,
Raffaele Della Valle e il professor Alberto Dall'Ora, che si batterono per lui
con una vicinanza e un ardore ben al di là del dovere professionale. Non fosse
stato per persone come queste, i 1.768 giorni che separano l'inizio del calvario
di Enzo Tortora (17 giugno 1983, prelevato alle 4 del mattino all'Hotel Plaza di
Roma) dalla fine della sua esistenza (18 maggio 1988, cancro ai polmoni, nella
sua casa milanese di via Piatti 8, tre camere più servizi), sarebbero stati di
meno, nel senso che avrebbe ceduto prima. Paradossali i destini dei nomi
impressi sulla tenaglia che ha stritolato Tortora, uno dei volti più noti di
quando lo schermo era piccolo. Immaginiamo le due ganasce. Su una stanno gli
accusatori, almeno i tre principali, tutti galeotti. Il capo cordata è Giovanni
Pandico, ha ucciso due impiegati comunali perché tardavano a dargli un
certificato, ci ha provato senza successo anche con padre, madre e fidanzata,
"schizoide e paranoico " per i medici, diventa lo scrivano di Cutolo ed è lui a
mettere nel calderone Tortora e a condizionare con la sua versione e la sua
perversione molti altri affiliati: dal 2012 è un libero cittadino. Poi ci sono
Pasquale Barra, detto "o 'nimale", killer dei penitenziari, 67 omicidi in
carriera tra cui lo sbudellamento di Francis Turatello: è ancora dentro, ma gode
di uno speciale programma di protezione. Lo stesso di Gianni Melluso, detto "il
bello" o "cha cha cha", uscito di galera e rientrato nel luglio scorso, ma per
sfruttamento della prostituzione: durante i beati anni della delazione contro
Tortora, usufruì di trattamenti di particolare favore, come gli incontri molto
privati con Raffaella, che resterà incinta e diverrà sua moglie in un memorabile
matrimonio penitenziario con lo sposo vestito Valentino. Va detto che Melluso fu
l'unico di tutta la compagnia, magistrati compresi, a chiedere perdono ai
familiari di Tortora, in un'intervista all'Espresso del 2010: "Lui non c'entrava
nulla, di nulla, di nulla. L'ho distrutto a malincuore, dicendo che gli passavo
pacchetti di droga, ma era l'unica via per salvarmi la pelle. Ora mi inginocchio
davanti alle figlie". Risposta di Gaia, la terzogenita: "Resti pure in piedi".
Stupirà, forse, che nel tiro a Tortora non compaia mai il nome di Raffaele
Cutolo, il capo di quella Nuova camorra organizzata che aveva messo a ferro e
fuoco la Campania per prenderne il controllo e contro cui venne organizzato il
grande blitz del 1983. Tempo dopo, i due, Cutolo e Tortora, che intanto era
diventato presidente del Partito Radicale, si incontreranno nel carcere
dell'Asinara, dove "don Raffaé" albergava all'ergastolo. Il boss fu anche
spiritoso: "Dunque, io sarei il suo luogotenente ". Poi allungò la destra: "Sono
onorato di stringere la mano a un innocente". E siamo all'altra ganascia della
tenaglia, quella di quei magistrati che, senza neanche l'ombra di un controllo
bancario, un pedinamento, un'intercettazione telefonica, basandosi solo sulle
fonti orali di criminali di mestiere, sono riusciti nell'impresa di mettere in
galera Tortora e condannarlo in primo grado a 10 anni di carcere più 50 milioni
di multa. I due sostituti procuratori che a Napoli avviano l'impresa si chiamano
Lucio Di Pietro, definito "il Maradona del diritto", e Felice Di Persia. Sono
loro a considerare Tortora la ciliegiona che da sola cambia l'immagine della
torta, loro a convincere il giudice istruttore Giorgio Fontana ad avallare
questo e gli altri 855 ordini di cattura, anche se incappano in 216 errori di
persona, tanto che i rinviati a giudizio alla fine saranno solo 640, di cui 120
assolti già in primo grado (con l'appello, l'impalcatura accusatoria franerà un
altro po', con 114 assoluzioni su 191). Contraccolpi sul piano professionale? A
parte il giudice Fontana, che infastidito da un'inchiesta del Csm sul suo
operato si dimette sdegnato e ora fa l'avvocato, i due procuratori d'assalto
spiccano il volo. Di Pietro (nessuna parentela con l'ex onorevole e onorato
Tonino) è procuratore generale di Salerno, dopo aver sostituito Pier Luigi Vigna
addirittura come procuratore nazionale antimafia. Non è andata malaccio neanche
a Di Persia, oggi in pensione, ieri membro del Csm, l'organo di autocontrollo
dei giudici (ma Cossiga presidente pare abbia rifiutato di stringergli la mano
durante un plenum). Restano ancora due indimenticabili protagonisti del primo
processo di Napoli, che inizia nel febbraio 1985, un anno e otto mesi dopo
l'arresto di Tortora, e si conclude il 17 settembre 1985, con il presentatore
che subisce la condanna ma già da deputato radicale al Parlamento europeo: il
presidente Luigi Sansone, che firma una corposa quanto friabile sentenza di 2
mila pagine, in sei volumi, uno interamente dedicato a Tortora (con questa
apoteosi: "L'imputato non ha saputo spiegarci il perché di una congiura contro
di lui"), e il pubblico ministero Diego Marmo, arringa leggendaria la sua, con
le bretelle rosse sotto la toga e una veemenza tale da fargli scendere la bava
all'angolo sinistro della bocca, specie quando dipinge l'imputato come "un uomo
della notte ben diverso da come appariva a Portobello" e quando erutta che i
voti presi da Tortora alle Europee sono anche voti di camorristi. La
conclusione, poi, è da pietra tombale sul diritto: "Lo sappiamo tutti,
purtroppo, che se cade la posizione di Enzo Tortora si scredita tutta
l'istruttoria". Non cadrà, almeno in quei giorni, come non cadranno Luigi
Sansone, che si consolerà con la presidenza della sesta sezione penale di
Cassazione, né il focoso Marmo, in pensione dal novembre scorso dopo essere
stato, tra l'altro, procuratore capo di Torre Annunziata. Nessuno dei delatori
sbugiardati è stato incriminato per calunnia. Quanto ai magistrati, poco prima
di morire, Tortora aveva presentato una citazione per danni: 100 miliardi di
lire la richiesta. Il Csm ha archiviato, risarcimento zero. Archiviato anche il
referendum del 1987, nato proprio sulla spinta del caso Tortora, sulla
responsabilità civile dei magistrati: vota il 65 per cento, i sì sono l'80 per
cento, poi arriva la legge Vassalli e di fatto ne annulla gli effetti. Quel che
resta di Enzo Tortora ("Io non sono innocente. Io sono estraneo", ripeteva come
un mantra) non riposa in pace dentro una colonna di marmo con capitello corinzio
al cimitero Monumentale di Milano. La colonna è interrotta a metà da un vetro.
Infilata dall'esterno, un'immaginetta di un Cristo in croce con la scritta: "Uno
che ti chiede scusa". Dietro il vetro, c'è l'urna dorata con le ceneri e due
date (1928-1988). Sotto, un'iscrizione abbastanza misteriosa: "Che non sia
un'illusione". La spiega Francesca Scopelliti, l'ultima compagna: "Enzo ha
voluto farsi cremare insieme ai suoi occhiali, quelli che gli servivano per
leggere e che perdeva di continuo, e a una copia della Storia della colonna
infame del Manzoni, con la prefazione di Leonardo Sciascia, di cui era amico.
Era venuto a trovarlo pochi giorni prima della fine. Ne scrisse subito dopo sul
Corriere della sera, confidando parte di quello che Enzo gli aveva detto:
speriamo che il mio sacrificio sia servito a questo Paese, e che la mia non sia
un'illusione". Venticinque anni dopo quel 18 maggio 1988, dubitare è lecito,
specie in un'Italia che sembra avere nel proprio Dna la caccia al mostro quale
che sia, proprio come nella cronaca del Manzoni. Siamo nel1630, a Milano c'è la
peste, vengono arrestati, sulla base della denuncia di alcune comari, due
presunti untori accusati di spargere unguenti che propagano l'epidemia.
Condannati sbrigativamente allo squartamento, sulle macerie della bottega di
barbiere di uno dei due, incenerita a memento, viene eretta una colonna, a
dannazione eterna dell'"infame". L'accusa, all'"infame" di Portobello, piove
sulla testa, come un pezzo di marmo caduto da un balcone, venerdì 17 giugno
1983. E da quel giorno, Enzo Claudio Marcello Tortora, figlio di un napoletano
che faceva il rappresentante di cotone a Genova, giornalista e presentatore
televisivo in gran spolvero, diventa all'improvviso "il caso Tortora". Intanto
sta nascendo a Napoli la prima bambina in provetta, la Fiat lancia la Uno,
scompare Emanuela Orlandi, Federico Fellini firma la quart'ultima tappa del suo
magistero con E la nave va, Vasco Rossi la prima: Vita spericolata. In
televisione, spopola su RaiDue appunto Portobello, un mercatino alla londinese
di varia umanità, dovesi vendono e si comprano le cose più strane, dove tra le
centraliniste, guidate da "sua soavità" Renée Longarini, spuntano le acerbe
glorie di Paola Ferrari, Gabriella Carlucci, Eleonora Brigliadori, dove capitano
tizi come quello che propone di abbattere il Turchino per risolvere il problema
della nebbia in Val Padana, dove la valletta di colore si guadagna il soprannome
di "Goccia di caffè" e dove Tortora, al massimo di se stesso, governa la platea
come un lord inglese, esibisce un pappagallo che si chiama Portobello, chiude le
trattative con una frase entrata nella piccola storia della televisione: "Il Big
Ben ha detto stop". Nella storia entrano anche i risultati del programma: 22
milioni di spettatori di media, con punte ineguagliate all'epoca di 28 milioni.
"Tutta farina di Enzo. Una domenica, si era messo a leggere gli annunci sul
giornale: vendo coccodrillo impagliato eccetera. Aveva cominciato a telefonare e
aveva scoperto un mondo dietro quei trafiletti. Poi ci aggiunse il pappagallo,
perché, mi diceva, un animale ci vuole, fa tenerezza ai bambini ". A ricordare è
Gigliola Barbieri, storica assistente di Tortora, fin dai tempi (1969) della sua
Domenica sportiva. Ora la "Barbi", come la chiamava lui, è produttore esecutivo
a Mediaset. "La mattina che venne arrestato, il primo che mi chiamò fu
Berlusconi: signora, ha saputo? Stava trattando con Enzo il suo passaggio a
Retequattro. Dopo i funerali, mi ha ricontattato: signora, se vuole venire a
lavorare da noi...". Parla come una vedova, la Barbi, una vedova non consolata.
"Enzo aveva tanti di quei difetti che ci metterei giorni a fare l'elenco. Ma con
quella cosa non c'entrava. L'hanno rovinato gratis". Il giovedì prima di quel
venerdì 17 giugno 1983, che segna l'inizio della fine di Tortora, l'allora
direttore del Giorno, Guglielmo Zucconi, chiamò un giovane cronista degli
spettacoli, Paolo Martini, egli rivelò di aver ricevuto una soffiata su una maxi
retata imminente, che avrebbe riguardato anche un grosso nome dello spettacolo.
Chi? "So solo che sta nelle ultime lettere dell'alfabeto". Cominciarono a
spulciare l'elenco dal fondo: Vianello, Tortora, Tognazzi. Martini si attaccò al
telefono. Trovò Tortora a Roma: "Quando lo avvertii che circolava il suo nome
tra i possibili implicati in un blitz di camorra, si mise a ridere. E in
effetti, da quella mia chiamata all'arresto la notte successiva, non fece
assolutamente niente, non chiamò il suo avvocato né qualche amico del Partito
liberale in cui militava né della cerchia di Craxi, acui pure aveva accesso.
Tortora era il classico signore borghese di provincia, un bel po' reazionario,
lupo solitario assoluto. Non faceva serata, non beveva, aveva orrore per la
delinquenza e la droga. L'unica cosa che tirava era un po' di tabacco da fiuto".
Ma la soffiata era giusta. All'alba, tre carabinieri irrompono in una stanza
dell'Hotel Plaza di Roma, prologo di quel che per le cronache diventerà il
"venerdì nero di Cutolo": 856 ordini di cattura. Tra questi, un nome che da solo
dà senso e ribalta all'operazione (non a caso battezzata in codice
"Portobello"): Enzo Tortora, indicato dal pentito Giovanni Pandico come
camorrista ad "honorém" (con l'accento sulla "e", come dirà al primo
interrogatorio), numero 60 di una lista che viene consegnata ai magistrati di
Napoli e fa scattare la retata. Mentre lo portano via dal Plaza, Tortora è
ancora convinto che si tratti di un caso di omonimia e che tutto si risolverà in
poche ore. Sbagliato. Aspettando l'ora buona perché si ammassassero troupe
televisive e fotografi, il re di Portobello viene fatto uscire dalla caserma dei
carabinieri per essere trasferito a Regina Coeli, ammanettato e con la faccia
sfatta. Sente i cameraman invocare "i polsi, i polsi!", dalla folla i primi
verdetti: "Farabutto, pezzo di merda, ladro". La vendetta sul "famoso" prenderà
rapidamente le dimensioni della valanga. L'indimenticato "Tognazzi capo delle
Br" brevettato dal Maledi Sparagna&Vincino nel 1978 viene surclassato dalla
cronaca: Tortora capo della camorra. I pentiti che l'accusano si moltiplicano
come nella parabola dei pani e dei pesci: da uno diventano 19, complice la
fresca legge Cossiga del 1982 che, pensata per sconfiggere il terrorismo,
introduce sconti di pena per chiunque collabori a qualunque titolo. È una corsa
folle a chi la spara e la scrive più grossa: Tortora ha rubato i soldi raccolti
per il terremoto dell'Irpinia, ha uno yacht comprato con i guadagni dello
spaccio, si incontra con Turatello, Pazienza e Calvi scambiando valigette di
droga e dollari. Un tornado inarrestabile, con Il Messaggero che titola:
"Tortora ha confessato". Falso. Il garantismo di sinistra? Assente. Portobello è
un programma da lista nera, e poi il suo conduttore, oltre ad essere un liberale
di destra, è pure antipatico per il suo fare tra il lacrimoso e lo snob, e in
più ha un passato da inviato della Nazione del petroliere Attilio Monti, non
proprio un sincero democratico, durante il quale si è distinto per una campagna
contro Valpreda e l'anarchia milanese quali responsabili della strage di piazza
Fontana. Che la madre Silvia, quando andava in chiesa a pregare, trovasse spesso
il foglietto lasciato da qualche anima buona con la scritta "tuo figlio spaccia
la droga ", era il segno, uno dei tantissimi, che gli argini erano rotti e che
poco si opponeva alla marea montante delle calunnie. Ma perché proprio Tortora,
e non qualche altra star capace di attrarre la morbosa attenzione da spalti del
Colosseo? Per una storia di centrini di seta. Un detenuto del carcere di Porto
Azzurro, Domenico Barbaro, ne spedisce alcuni alla redazione di Portobello nella
speranza che vengano messi all'incanto. Non vedendoli comparire (la trasmissione
riceveva allora 2.500 lettere al giorno), Barbaro comincia a bombardare Tortora
di lettere sempre più minacciose: essendo però analfabeta, gliele scrive il
compagno di cella Pandico. Alla fine, esasperato, Tortora risponde pure, in tono
secco, avvertendo che passerà la pratica all'ufficio legale della Rai (nel
frattempo, i centrini sono andati persi), che infatti provvede a rimborsare il
detenuto con un assegno di 800 mila lire. Caso chiuso? Al contrario: Pandico
decide di vendicarsi di Tortora, spiega ai magistrati che i centrini erano un
nome in codice per indicare una partita di coca da 80 milioni, che il
presentatore si sarebbe intascato fregando i compari. È la prima prova d'accusa
presentata ai legali del presentatore, che la smontano in un secondo esibendo la
corrispondenza tra Barbaro e Portobello. Risposta: "Trattasi di altro Barbaro".
Ugualmente surreale la seconda prova "schiacciante": trovato il nome di Tortora
nell'agendina di Giuseppe Puca, detto "'o giappone", uno dei killer di Cutolo.
Ci vorranno cinque mesi perché i magistrati si arrendano all'evidenza:
l'agendina è della donna di Puca, il nome scritto a mano è "Tortosa" non
"Tortora", e corrisponde al proprietario di un deposito di bibite di Caserta,
amico della signora. Il prefisso è 0823, "provate a chiamà, dottore...". Finisce
come era impossibile finisse: Tortora condannato per camorra e spaccio. Tortora,
prima della sentenza, eletto a Strasburgo con i Radicali ("sono stato liberale
perché ho studiato, sono diventato radicale perché ho capito") con 451 mila
preferenze (Alberto Moravia, candidato per il Pci, ne prese 130 mila). Tortora
che si dimette da eurodeputato, rinuncia all'immunità e torna in Italia per
farsi arrestare. Tortora che ricorre in appello, sfida la giuria prima del
verdetto ("Io sono innocente, spero con tutto il cuore che lo siate anche voi")
e il 15 settembre 1986 viene assolto da entrambe le accuse (dirà laconico il
giudice a latere Michele Morello: "Facemmo giustizia "), cosa che si ripeterà in
Cassazione. Tortora che, venerdì 20 febbraio 1987, ricompare in tv e apre la
nuova edizione di Portobello con la stessa frase che disse Luigi Einaudi quando
riprese a collaborare al Corriere della sera dopo il fascismo: "Heri dicebamus".
Dove eravamo rimasti. Silvia Tortora, la figlia di mezzo, la prima che Tortora
chiama quando l'arrestano ("Silvia, non crederci, non crederci, tu conosci
papà"), vive in un borgo antico alle porte di Roma. È giornalista, sposata dal
1990 con il turbolento e fascinoso attore Philippe Leroy, che le ha dedicato una
meravigliosa frase d'amore: "Con Silvia sono tranquillo come una capra felice
che gira intorno al suo palo". Due i figli: Michelle, 17 anni, e Philippe, 21.
Conserva due libri, che Enzo Tortora ha scritto per Mondadori (Cara Italia, ti
scrivo, 1984, dove racconta la sua vita da detenuto, e Se questa è Italia, 1987,
sulla sua vita da imputato). Dice che non si trovano più. Tra tutte le cose che
hanno dedicato a suo padre, strade, piazze, premi, quella che Silvia trova più
giusta è una biblioteca, voluta da Walter Veltroni in una strada appena fuori
Saxa Rubra. "I libri erano importanti per lui, erano lui, in qualche senso".
Rabbia ancora, Silvia? "Ricordo che Manganelli, il capo della Polizia appena
morto, incontrandomi mi ha detto: quella di tuo padre è stata la merda più
gigantesca della storia. Hanno fatto una commissione parlamentare su tutto,
persino su Mitrokhin: su Tortora no. Eppure Portobello, che ai tempi mi sembrava
una schifezza di show, rivisto dopo l'ho trovato bellissimo".
L’ultimo smacco a Enzo Tortora,
scrive Domenico Ferrara su “Il Giornale”. Questi sono alcuni estratti testuali
della requisitoria
del pm Diego Marmo
nel luglio 1985:
“Enzo Tortora
ha sempre accusato la giustizia napoletana di averlo coinvolto in questa
vicenda, non capisco bene perché, non è un mistero per nessuno che io sono
convinto della responsabilità di Tortora ma non perché ne fossi convinto nel
momento in cui ho messo piede in quest’aula ma perché me ne sono convinto
leggendo gli atti, valutando il comportamento processuale ed extra processuale
dell’imputato che mi serve non al fine di criminalizzare Tizio, Caio, Sempronio
o Mevio, assolutamente no, ma mi serve soltanto il comportamento dell’imputato
al fine di valutare la personalità dell’imputato”.
“Lo sappiamo tutti purtroppo che se cade la
posizione di Enzo Tortora si discredita tutta l’istruttoria, questo lo sa
Tortora ma lo sanno anche coloro che mandano i vari compagni a immolarsi su
questo altare per potere screditare questa accusa”.
“Di Monaco, interrogato dal giudice
istruttore Spirito che cosa dice: “Lo Iaculli mi fece il nome del presentatore
Enzo Tortora”. Cioè significa che non ci può essere errore, non ci può essere
dubbio, Enzo Tortora è uno solo, è l’uomo di
Portobello, è l’uomo di Cipria, è il presentatore
della televisione. Però poi si dirà che Enzo Tortora è Enzo Berri, ma io
napoletano non lo conosco, non l’ho mai visto, gli auguro di avere la stessa
notorietà di Enzo Tortora ma sicuramente non ha la stessa notorietà di Enzo
Tortora”.
“Se prima ci poteva essere equivoco, adesso
l’equivoco non c’è più. “Ecco il nostro compare”, perché gli altri detenuti
sapevano, non si può giustificare diversamente, non si può dire che c’è stato
errore di persona. Vuol dire che dietro queste lettere c’è un regista, c’è Enzo
Tortora che fa di tutto per salvarsi da questa imputazione, e lo capisco perché
lo fanno tutti gli imputati, ma non ha il diritto assolutamente di dire io
combatto per voi, no, lui combatte solo per se stesso”.
“Di Enzo Tortora deputato non mi interessa
assolutamente niente, e ci tengo a precisare ma non per giustificarmi, perché le
istituzioni sono dalla mia parte, perché il fatto che il capo del mio ufficio
abbia ribadito la sua fiducia nei miei confronti è un fatto che mi onora
profondamente, quando sarò chiamato nelle sedi istituzionali dirò le mie
ragioni. Però quando io ho parlato del voto camorrista non intendevo
criminalizzare le centinaia di migliaia di persone che hanno votato Tortora,
nemmeno mia madre che probabilmente ha votato Enzo Tortora. Però insisto nel
dire che il voto del carcere di Poggioreale significa voto camorrista. Io
analizzavo solo quella parte del voto, per dire che è un camorrista che ha
chiesto l’appoggio degli altri camorristi, il signor
Enzo Tortora è un camorrista,
io sto qua per scalzare la presunzione di
innocenza, é il mio mestiere quando me ne
convinco, e ne sono convinto”.
“Questo Enzo Tortora è quello che ha detto
sempre: “Io uscirò dal carcere solo se assolto perché sono innocente”, e se così
avesse fatto io l’avrei rispettato veramente perché i signori d’onore io li
rispetto, il signor Tortora invece ha pensato che il
processo fosse uno spettacolo. Si
è verificato che ha chiesto quello che tutto sommato chiedono tutti i detenuti,
adombrato delle situazioni di salute per poter uscire dal carcere, con questo
non voglio dire che un imputato deve morire in
carcere, chi è malato deve essere curato, lo
Stato deve attrezzarsi per curare i detenuti. Enzo Tortora ci dice che è malato,
e che non può stare in carcere, non faccio della facile ironia, e sarebbe facile
farlo sul carcere di Bergamo, la perizia conclude in un certo modo, il giudice
disattende, il tribunale della sorveglianza concede. Però se andate a rileggere
quelle cartelle cliniche, vedete che quell’imputato viene presentato come uno
veramente malato. È quello stesso imputato che ha una vita frenetica, io che
sono iperteso non riuscirei a fare un decimo di quello che fa questo signore.
Allora sei malato o non sei malato, è vero o non è vero. Tortora non fa una vita
tranquilla, in questo lo invidio, ben per lui, hai detto che uscirai dal carcere
o libero o con i piedi davanti e invece fai di tutto per uscire dal carcere”.
“Sapete perché Tortora è in questo processo?
Perché più si cercavano le prove della sua
innocenza e più uscivano le prove della sua
colpevolezza. Gli accusatori sono tanti e tutti hanno una estrazione diversa, il
signor Tortora abbia la dignità di dire ho sbagliato e di chiedere clemenza”.
Cosa è successo da quel lontano 1985 a oggi?
- Ieri 19 giugno 2014 il pm Diego Marmo è
stato nominato assessore per la Legalità
a Pompei, ma avrà anche la delega alla Difesa del patrimonio archeologico e
ambientale.
- Lui, insieme con gli altri giudici istruttori
del processo Tortora, non ha subìto alcun procedimento disciplinare.
- I delatori del conduttore tv non sono mai stati
incriminati per calunnia.
- La citazione di Tortora nei confronti delle
toghe è stata archiviata dal Csm.
- Il referendum a favore della responsabilità
civile dei magistrati non ha avuto alcun seguito.
- E naturalmente Tortora non era un camorrista.
C’è da indignarsi o no?
Lui è Diego
Marmo, ed è il pubblico ministero del processo a
Enzo Tortora, che
venne arrestato il 17 giugno 1983 con l'accusa di associazione camorristica e
traffico di droga, scrive “Libero Quotidiano”. Una delle più clamorose storie di
malagiustizia in
Italia, quella di Tortora. Una storia alla quale però non seguirono né scuse né
autocritiche da parte del pm che lo accusava. Una storia di cui si ricorda il
travaglio dell'innocente Tortora, i suoi problemi di salute, le violente
campagne di stampa, la sofferenza del carcere e una carriera professionale
completamente distrutta. Una storia che in qualche modo continua anche oggi:
Marmo, infatti, è stato scelto dal sindaco di
Pompei per diventare assessore.
Nando Uliano, il sindaco
neoeletto, lo ha chiamato a far parte della sua squadra: l'ex pm sarà uno dei
cinque assessori, si occuperò di legalità e
sicurezza ma avrà anche la delega alla Difesa del
patrimonio archeologico ed ambientale. Marmo è in pensione dopo una lunga
carriera, che lo ha visto anche essere procuratore aggiunto di Napoli, prima di
assumere la guida della procura di Torre Annunziata. Nel 2012 curò l'inchiesta
sui crolli della schola armaturarum e della casa del moralista. Sulla
nomina ad assessore ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno: "Quando ho
sentito della proposta il mio primo impulso è
stato dire no. Poi ha prevalso il fascino della
parola Pompei. E quindi mi sono detto che non era giusto rifiutare. Ho deciso di
metterci la faccia".
Marmo, il pm del caso Tortora ora è
assessore alla legalità, scrive Piero Sansonetti
su “Il Garantista”. Si chiama Diego Marmo ed è
stato nominato assessore alla legalità del Comune di Pompei. Che c’è di strano?
Che Diego Marmo è un ex Pm e non è un ex Pm qualunque: è quel Pm che spedì in
carcere Enzo Tortora, ce lo tenne mesi e mesi, si fidò di pentiti bugiardi, non
gli indizi e definì Tortora un cinico mercante di
morte. Va bene difendere coi denti la
non-responsabilità civile dei giudici; va bene esaltare i meriti della
magistratura; va bene pretendere autonomia indipendenza e insindacabilità. Va
bene tutto, ma addirittura divertirsi ad esaltare la figura del pm che
perseguitò Enzo Tortora, lo calunniò in modo feroce, cercò di annientarlo, e poi
fu censurato da una clamorosa sentenza di assoluzione, diventando il simbolo dei
simboli della giustizia ingiusta e della persecuzione, e decidere, proprio
nell’anniversario del barbaro arresto del presentatore, di nominare questo ex pm
assessore alla legalità del comune di Pompei…beh, è un po’ esagerato. Credo che
persino molti magistrati perbene, onesti, seri, considerino offensiva la
decisione del sindaco di Pompei che ha stabilito di affidare questo incarico
all’ex pm Diego Marmo. Figuratevi se non siamo
favorevoli al diritto all’oblio, anche per i
giudici che sbagliano clamorosamente un processo. Figuratevi se siamo noi del
Garantista a chiedere pene o vendette. Per carità! Però il valore
simbolico di certe scelte non può essere negato. E l’ex pm Marmo è stato
nominato assessore alla Legalità proprio nell’anniversario (il trentunesimo)
dell’arresto di Enzo Tortora e dell’inizio del calvario che lo portò prima al
linciaggio morale e al carcere, poi alla malattia e alla morte. Gli eroi non
esistono, naturalmente. Però Enzo Tortora è un po’
un eroe del nostro tempo. Ha sopportato con
incredibile dignità la persecuzione e non ha mai rinunciato a lottare. E’
riuscito a sgretolare il castello di accuse e a dimostrare la sua innocenza. Non
ha mai perso i nervi, neppure quando il pubblico ministero Diego Marmo lo definì
, testualmente, «un cinico mercante di morte», e neanche quando lesse il capo di
accusa per colpa del quale gli mettevano le manette e lo chiudevano a San
Vittore: ”associazione camorristica e traffico di droga”.
Il caso-Tortora lo conoscete tutti: è stato un
caso giudiziario vergognoso. Tra l’altro, i radicali proposero il referendum
sulla responsabilità civile dei magistrati proprio come risposta a quella
incredibile ingiustizia, dovuta alla superficialità dei magistrati dell’accusa.
E vinsero il referendum: i cittadini decisero che i giudici avrebbero dovuto
rispondere dei loro errori, come tutti gli altri cittadini, ma poi il governo
cancellò quella decisione, stravolgendola. Tortora, al processo di appello,
prima che la Corte si riunisse per emettere la sentenza, la sfidò pronunciando
parole famosissime: «Io sono innocente. Spero dal
profondo del cuore che lo siate anche voi». I
giudici che emisero la sentenza, per fortuna, erano innocenti: e assolsero
Tortora senza l’ombra di un dubbio. Adesso, senza
eccessi di polemiche, vorremmo rivolgerci anche
all’Anm. Con una domanda sommessa: non vi sentite, in qualche modo, offesi anche
voi da una decisione così sfacciata? Non credete che, ingiustamente, si finisce
in questo modo per offuscare la buona reputazione di tanti magistrati forti e
seri, dando a un pm che si porta addosso l’immagine e la responsabilità di quel
clamoroso errore giudiziario, addirittura l’incarico di vigilare sulla legalità?
Che messaggio si vuole trasmettere? Che la legalità si realizza meglio
perseguitando un po’ alla cieca?
LA DRAMMATICA LETTERA DI GAIA TORTORA A “IL
TEMPO” SULLA GIUSTIZIA ITALIANA.
- Scrive Dimitri Buffa - Uno, dieci, cento,
mille e forse persino centomila errori
giudiziari come quello che colpì Enzo Tortora caratterizzano la giustizia
italiana odierna. Parola di Gaia
Tortora, intervenuta oggi con una drammatica lettera a “Il Tempo” (nuova
gestione a cura dell’ex inviato del “Giornale”, Gian Marco Chiocci, ndr) che ha
aperto il giornale con il titolo “Cinquantamila innocenti in prigione”. Quante
volte anche da queste colonne, on line, abbiamo parlato di fabbrica seriale di
errori giudiziari. Era intuitivo. Ma “Il Tempo” oggi ha tirato fuori i dati
tenuti nascosti da via Arenula sul numero esatto dei poveri Cristi finiti in
galera per errori attribuibili ai vari pm d’assalto in Italia dal 1989 a
oggi. Cioè dall’entrata in vigore del codice firmato dalla buonanima di Giuliano
Vassalli sino ai giorni nostri: e il numero, la quantità, lasciando perdere per
un attimo, la “qualità”, dell’errore, fa paura: 50 mila unità. In ventiquattro
anni fa la media di duemila errori giudiziari completi ogni anno. Una persona
ogni 40mila in Italia, considerando anche neonati e centenari, ogni anno si
becca la galera gratis perché magari qualche investigatore deve finire in prima
pagina e qualche giornalista amico suo lo pompa. Così il
caso Tortora non è servito a niente, ammette desolatamente la figlia dell’ex
presentatore che oggi lavora a “La7” e che per
anni ha sempre diffidato, giustamente, chicchessia a paragonarsi a suo
padre. Ora però, constatato il fallimento verticale, senza sé e senza ma,
dell’impresa giustizia nel Bel Paese, i paragoni con enorme onestà intellettuale
li fa lei. E cita il caso del povero Giuseppe Gulotta. Che in un libro sulla
propria lunga Odissea nelle carceri e nella giustizia italiana sostiene che
siccome “Giuseppe Gulotta non è Enzo Tortora nessuno si occupa del suo caso...”
Cosa che purtroppo rappresenta altra vergognosa realtà del sistema. Insomma
oramai il paragone con Tortora viene sdoganato
anche perché in fondo era proprio lui che da vivo si metteva sullo stesso piano
di “chi non ha voce”. Per dargliela. E mai come
in questo momento il docufilm sulla vicenda umana
e giudiziaria di Enzo Tortora, curato da Ambrogio Crespi
e prodotto dal Gruppo Datamedia, appare l’iniziativa giusta al
momento giusto.
Questa è la prova che mio papà è morto invano.
Quante volte mi è stato chiesto un ricordo, un commento, una intervista sulla
vicenda di mio padre? Molte. Com’è normale che sia in questi casi. Le stesse
volte in cui ho accettato e poi mi sono..., scrive Gaia Tortora su “Il Tempo”.
Quante volte mi è stato chiesto un ricordo, un commento, una intervista sulla
vicenda di mio padre? Molte. Com’è normale che sia in questi casi. Le stesse
volte in cui ho accettato e poi mi sono ritrovata davanti al computer e a tanti
ricordi e parole e immagini nella testa. Questa volta però, mentre da «Il Tempo»
mi spiegavano come sarebbe uscita l’inchiesta del giornale, la mia mente è
tornata a poche settimane fa. Ad un libro. Alla storia di un uomo. Lui si chiama
Giuseppe Gulotta. Il suo libro Alkamar - la mia vita in carcere da innocente. È
la storia di un uomo che per 36 anni è stato considerato un assassino. È stato
costretto a firmare una confessione con le botte e le torture. Oggi ha 55 anni.
Ha passato in cella gran parte della sua vita. È un uomo innocente finito in un
meccanismo che può stritolare chiunque. Ho letto d’un fiato la sua storia, che
pure conoscevo. Ma non così nei dettagli. Mi sembrava in alcune pagine di
rivivere l’incubo. Quel senso di impotenza che ti soffoca. Anche in quel caso
tutto è cambiato in una notte. Esattamente come per mio padre. E per noi. Dalle
4 del mattino del 17 giugno 1983 l’esistenza di mio padre viene stroncata.
Giorgio Bocca lo ha definito «il più grande caso di macelleria giudiziaria della
storia italiana». Dall’arresto di quella notte alla morte di nostro padre
passarono 5 anni. In mezzo, una condanna a 10 anni di carcere, poi la piena
assoluzione e infine il cancro ai polmoni che lo ha portato via. Potrei dire
molte cose in queste righe che mi è stato chiesto di scrivere. Molte e forse
troppe ne ho già dette. Allora, come spesso mi capita quando mi chiedono
qualcosa su mio padre, chiudo gli occhi e cerco di riascoltare le sue
raccomandazioni. «Date voce a chi voce non ha». Ecco oggi i casi Tortora ci sono
ancora. Sono molti e non li conosciamo. Mio padre era un uomo famoso. E nel bene
e nel male questo ha avuto un peso. I riflettori si sono inevitabilmente accesi.
Cosi riprendo tra le mani il libro di Giuseppe Gulotta e quelle parole a pag
127: «Gli anni 80 sono anni caldi per chi amministra la giustizia. Un referendum
promosso dai radicali chiede una legge sulla responsabilità civile dei
magistrati. Troppi errori, dicono i promotori citando il caso Tortora. Ma
Giuseppe Gulotta non è Enzo Tortora, nessuno si occupa del suo caso, non c'è una
campagna innocentista né un garantista, fra i tanti che si definiscono tali, che
parli di lui». È terribilmente vero. Ieri come oggi. I casi Tortora non hanno
voce. Ieri come oggi siamo ancora qui a dibattere di riforma della giustizia. A
firmare di nuovo referendum per i quali gli italiani si erano già espressi e che
poi come spesso accade i nostri politici hanno fatto diventare carta straccia.
Mentre infuria la battaglia sulla magistratura i processi vanno avanti.
Lentamente. Le persone aspettano. La sete di giustizia in questo Paese è
diventata arsura. In molti risvolti delle nostre vite. Il problema non è la
magistratura italiana, ma alcuni uomini che ne fanno parte. E che possono
sbagliare come tutti. Ma che avendo per le mani la vita di un essere umano
dovrebbero avere maggior scrupolo proprio come un chirurgo con il bisturi o un
giornalista con la penna. Sulle responsabilità dei magistrati è stato vinto un
referendum nel 1987. Non chiedo che vada limitata la loro libertà. Ma i
magistrati che sbagliano almeno non dovrebbero essere promossi. Basterebbe un
po’ di buonsenso e di coerenza. Invece, nella maggior parte dei casi, non ti
chiedono neanche scusa.
SONO INNOCENTE. LORENA MORSELLI.
Lorena Morselli. Assolta col marito dalle
accuse di pedofilia non vede i 4 figli da 20 anni (Sono Innocente).
Il caso di Lorena Morselli e del marito Delfino Covezzi sarà al
centro della prima puntata di "Sono innocenti", in onda domenica 8 aprile su
Rai, scrive l'8 Aprile 2018 Morgan k. Barraco su "Il Sussidiario". A quasi
vent'anni di distanza dalla sua assoluzione, Lorena Morselli e il marito Delfino
Covezzi sono ancora alla ricerca di giustizia. I coniugi di Massa Finalese sono
stati accusati infatti alla fine degli anni Novanta di pedofilia, motivo per cui
le autorità avevano ordinato un anno prima l'allontanamento dei quatto figli
dalla casa di famiglia. Covezzi è morto a causa di un infarto nel 2013 e questo
ha spinto Lorena ad assumere da sola il testimone e il fardello che porta sulle
sue spalle nonostante l'assoluzione decisa dalla Cassazione nel dicembre del
2014. Il caso di Lorena Morselli verrà approfondito nel corso della puntata di
Sono Innocente di questa domenica, 8 aprile 2018. Il calvario dei coniugi
Covezzi è durato sedici anni, fra udienze e accuse che si sono dissolte di
fronte alla conferma della loro innocenza. Tutto è iniziato nel marzo del 1999,
quando Lorena e il marito Delfino ricevono il primo avviso di garanzia: l'inizio
di un incubo che non sembra avere una soluzione.
L’allontanamento dai figli. Anche se dichiarata
innocente dell'accusa di pedofilia, Lorena Morselli non è mai riuscita a
riabbracciare i quattro figli che le sono stati tolti per via di un errore
giudiziario. Alla donna e al marito Delfino Covezzi non è mai stato permesso di
poter vedere i figli, come sottolinea a Quotidiano.net, che così hanno finito
per credere di essere stati abbandonati. Un particolare che la primogenita aveva
riferito alla zia Anna Rosa, la sorella di Lorena, in un'occasione. L'unica che
le era stata concessa per vedere i nipoti. Mentre i genitori sono stati
incarcerati e sottoposti a diversi processi, i figli sono stati inoltre separati
e affidati ad altre famiglie. L'unico figlio che è riuscito a rimanere al fianco
della madre Lorena Morselli è il quinto, Stefano, di cui era incinta nel 1999.
Oggi la donna vive in Francia, dove ha dato alla luce il suo ultimo figlio e
dove ha deciso di mettere radici. Ed è proprio in Provenza che il marito Delfino
ha esalato l'ultimo respiro, a causa di un infarto che lo ha spento nell'agosto
del 2013.
La lettera del figlio Stefano. Lorena Morselli non
ha mai smesso di cercare giustizia per sé e per il defunto marito Delfino
Covezzi. Entrambi assolti dalle accuse di pedofilia, non sono riusciti a poter
riabbracciare i quattro figli che le autorità hanno deciso di affidare ad altre
famiglie. La donna ha ripercorso il suo calvario durante una puntata de I Fatti
Vostri, sottolineando come alla fine anche il figlio Stefano, l'unico che è
riuscita a tenere al proprio fianco, è stato privato della possibilità di
conoscere i suoi fratelli. Proprio per questo Lorena ha deciso di lanciare un
nuovo appello tramite le tv nazionali, non chiedendo di poter essere perdonata
dai figli, ma di permettere ai fratelli di poter trovare un punto di incontro.
Di recente è intervenuto anche don Erio Castellucci, il Vescovo di Modena che lo
scorso febbraio ha deciso di dare il proprio aiuto a Stefano Covezzi. Il figlio
di Lorena Morselli aveva infatti scritto una lettera commovente al senatore
Giovanardi, chiedendo di poter finalmente chiudere la tragedia che ha colpito
tutta la sua famiglia. Lo stesso scritto infatti era stato inviato a don Erio
perché Agnese, Paolo, Enrico e Valeria, i suoi fratelli, potessero almeno
incontrarlo.
La lettera ai figli. All'epoca dell'arresto
di Lorena Morselli e Delfino Covezzi, i quattro figli avevano solo 11, 9, 8 e 3
anni. Ora più che maggiorenni, i figli della coppia vivrebbero nel Reggiano in
quattro famiglie diverse, una decisione che le autorità hanno preso andando
contro la richiesta della coppia di poter tenere uniti i fratelli. Secondo le
ultime notizie riportate da Il Resto del Carlino e diffuse dalla stessa Lorena,
solo la figlia Agnese sarebbe andata a vivere in provincia di Parma. Nel corso
degli anni, la donna si è dovuta difendere da pesanti accuse, additata come
pedofila e parte di accuse di massa che nello stesso periodo hanno colpito
diverse famiglie. Alcune delle vittime hanno confermato una volta maggiorenni
gli abusi subiti dagli stessi familiari, come sottolinea La Repubblica, anche se
queste accuse non riguardano i figli di Lorena. Quest'ultima invece ha
approfittato della riapertura del dibattito in seguito a un'inchiesta del
quotidiano nazionale per scrivere una lettera indirizzata ai quattro figli,
quelli che non ha potuto crescere e di cui non ha mai avuto notizie. La “mamma
dei quattro fratellini di Massa Finalese”, come è stata spesso indicata in
seguito allo scandalo, si difende. Nel suo lungo scritto sottolinea di non aver
mai accusato i figli di aver mentito, scegliendo di contro di manifestare ancora
una volta l'affetto che l'ha sempre legata ai suoi bambini.
Sono Innocente torna in onda domenica 15
aprile 2018 con Alberto Matano: le storie di Domenico Morrone, Stefano Messore e
Aldo Scardella al centro della puntata, scrive Stella
Di Benedetto il 15 aprile 2018 su "Il Sussidiario". Oggi, domenica 15 aprile,
alle 21.20 su Raitre, torna l’appuntamento con Sono Innocente, il programma
condotto dal giornalista Alberto Matano che racconta le storie di persone che si
sono ritrovati ad essere coinvolti in vicende giudiziarie pur essendo innocenti.
Storie di uomini e donne che, da un giorno all’altro, si ritrovano in carcere
pur essendo totalmente estranei alla vicenda. Mesi, in alcuni casi anni
trascorso dietro le sbarre di una cella non riuscendo a spiegarsi il motivo. In
ogni puntata, Alberto Matano racconta tre casi giudiziari diversi e uguali allo
stesso tempo.
IL CASO DI DOMENICO MORRONE. Il primo caso della
serata è quello di Domenico Morrone, pescatore tarantino di 27 anni, che nel
1991 è stato accusato dell’omicidio di due ragazzini minorenni. Gli inquirenti
non hanno dubbi convinti che Morrone abbia agito per vendicarsi di un affronto
subito da uno dei ragazzini. L’uomo viene condannato a 21 anni di reclusione. La
sua innocenza è stata dimostrata dopo 15 anni unitamente alla testimonianza di
due pentiti e a cinque richieste di revisione di processo.
IL CASO DI STEFANO MOSSORE. La seconda storia
della puntata odierna di Sono Innocente è quella di Stefano Mossore, ex
paracadutista della Folgore, da molti anni impegnato nel volontariato, dopo il
terremoto del 2016 che ha distrutto il Centro Italia, decide di andare ad
aiutare quelle popolazioni. Affitta così un furgone, lo riempie di cibo,
vestiti, giocattoli e con un amico parte per Amatrice. Mossore si impegna per
aiutare quelle popolazioni e contribuisce a costruire anche la tendopoli. Il 3
settembre 2016 torna a casa sua dove, ad attenderlo, trova i carabinieri che lo
accusano di sciacallaggio. Mossore trascorre cinquanta giorni di carcere e dieci
mesi agli arresti ai domiciliari. Prima di essere assolto, Stefano Mossore ha
subito anche il dramma di perdere il lavoro.
IL CASO DI ALDO SCARDELLA.
La terza ed ultima storia dell’appuntamento di
oggi con Sono Innocente è quella di Aldo Scardella che nel 1985 a soli 25 anni,
viene accusato dell’omicidio del titolare di un piccolo market di liquori
durante un tentativo di rapina. La banda è formata da tre persone, ma viene
arrestato solo Aldo Scardella. Gli inquirenti sono convinti che sia uno dei
colpevoli perché nei pressi del palazzo dove abita viene ritrovato uno dei
passamontagna usati dai banditi e sulle testimonianze di alcuni, che nei giorni
precedenti lo avrebbero visto nei pressi del locale rapinato. Aldo viene
arrestato e trascorre quasi sei mesi dietro le sbarre in regime di totale
isolamento, senza poter vedere i suoi avvocati e i suoi familiari. Non reggendo
il peso della situazione e non potendo dimostrare la sua innocenza, Aldo si
impicca nella sua cella il 2 luglio del 1986. Prima di togliersi la vita lascia
un biglietto che si conclude con le seguenti parole: "Muoio innocente".
SONO INNOCENTE. DOMENICO MORRONE.
DOMENICO MORRONE. Risarcito dopo 15 anni
di carcere: “Ma la libertà non ha prezzo” (Sono innocente).
Questa sera, domenica 15 aprile, a Sono innocente sarà raccontata la storia di
Domenico Morrone, che ha trascorso 15 anni in carcere prima di essere assolto
dall'accusa di duplice omicidio, scrive Morgan k. Barraco il 15 aprile 2018 su
"Il Sussidiario". “Sono innocente” ha raccontato nella puntata di oggi la storia
di Domenico Morrone, che ha trascorso 15 anni in carcere a causa della condanna
definitiva per il duplice omicidio di due studenti minorenni. Era il 1991 e a
Taranto era in corso una guerra tra clan. L'unica colpa di Morrone è quella di
aver litigato con un ragazzino che è stato poi ucciso. Contro di lui c'è un
movente fortissimo: si sarebbe vendicato dell'agguato subito, quindi viene
arrestato. Testimoni oculari, un esame dello stub dall'esito incerto e un
movente fortissimo: questi sono gli elementi che lo portano in cella. Morrone
durante il processo tira in ballo due testimoni che confermano il suo alibi, ma
entrambi vengono denunciati per falsa testimonianza. Il caso si tinge di giallo
quando dall'ufficio corpi di reato spariscono prove che lo scagionano. Nei 15
anni di carcere ha però conosciuto l'umanità di guardie e operatori carcerari.
Dopo nove anni dietro le sbarre ottiene un permesso di tre giorni che decise di
trascorrere con sua madre. In due pentiti ripose le sue uniche speranze di
scarcerazione. Per i suoi 15 anni trascorsi in carcere da innocente ha ricevuto
4 milioni di euro di risarcimento. A tal proposito ha dichiarato: «La libertà di
ogni singolo giorno della nostra vita non ha prezzo». (agg. di Silvana Palazzo)
Oggi 55enne, Domenico Morrone aveva 42 anni quando
è stato riconosciuto innocente per l'accusa di duplice omicidio ai danni di due
studenti minorenni. Il tarantino dovrà trascorrere infatti 15 anni in carcere a
causa della condanna definitiva, prima di poter riavere la propria libertà. Il
caso di Domenico Morrone si chiuderà definitivamente nel 2006, quando la Corte
d'Appello di Lecce stabilirà grazie al processo di revisione che si è trattato
di un errore giudiziario. Quanto accaduto a Domenico Morrone verrà raccontato
nella puntata di oggi, domenica 15 aprile 2018, del programma “Sono Innocente”.
Si tratta forse del caso più eclatante di errore giudiziario della storia
italiana, come ha sottolineato il suo legale, l'avvocato Claudio DeFilippi,
pochi giorni prima del rilascio del suo assistito. All'epoca dell'arresto,
Morrone è incensurato ed è un pescatore di Taranto dalla fedina impeccabile. Il
giorno del suo arresto non perderà tuttavia solo la propria libertà e dignità,
ma anche la fidanzata. Ed anche se affermerà fin dalle prime ore di non essere
colpevole del duplice delitto dei due studenti, gli inquirenti saranno convinti
della sua colpevolezza. A dimostrarlo delle prove inconfondibili per il pm
Vincenzo Petrocelli, ricorda Il Corriere della Sera, due testimonianze che
affermano di averlo visto sulla scena del crimine.
Domenico Morrone e l’omicidio di due minorenni.
Domenico Morrone verrà considerato per 15 anni il responsabile della morte di
Giovanni Battista, all'epoca dei fatti 17enne, e del quindicenne Antonio
Sebastio. I due ragazzi infatti sono stati uccisi mentre si trovavano di fronte
alla scuola alla periferia di Taranto che frequentavano entrambi. Un delitto
brutale, compiuto con una calibro 22 da un sicario che ha sparato diversi colpi
verso le due vittime. Secondo gli inquirenti, Morrone ha ucciso i due studenti
per via di una lite avvenuta con Battista qualche giorno prima e durante la
quale era stato ferito. Alcuni testimoni riferiranno in sede processuale di aver
sentito l'imputato minacciare di morte le due vittime, accusandoli di essere
legali alla criminalità locale. A nulla sono servite le prove portate
all'attenzione dei giudici dal difensore Claudio DeFilippi. Secondo il legale di
Morrone, infatti, i due delitti erano da collegare ad uno scippo messo in atto
dalle due vittime ai danni di una donna. Eppure la condanna per omicidio verrà
confermata, anche se l'imputato fornirà subito un alibi confermato nel corso
dell'iter processuale. La Cassazione infatti, ricorda Il Corriere della Sera,
non terrà in considerazione il fatto e della conferma dei coniugi Masone, che
come la madre di Morrone verranno accusati invece di falsa testimonianza.
In carcere a 27 anni. Il giorno del suo
arresto Domenico Morrone aveva appena 27 anni e riuscirà a uscire dal carcere
solo in età adulta. L'esperienza carceraria non impedirà solo all'uomo di poter
vivere la sua vita da incensurato, ma provocherà nel suo animo profondi
turbamenti. Al momento del rilascio, Morrone infatti mostrerà un fisico
stravolto dalla sofferenza, in preda a forti depressioni e malattie virali.
Oltre al danno anche la beffa: Morrone perderà a causa della condanna anche la
fidanzata, mentre la madre verrà ridotta in povertà. La donna infatti riusciva a
sostenersi solo grazie al lavoro di pescatore del figlio e in sua assenza non
era più in grado di avere una vita agiata. La madre di Morrone tra l'altro
morirà l'anno successivo alla scarcerazione del figlio, dietro le sbarre fin dal
1991. Per l'errore giudiziario subito, l'uomo chiederà infine un risarcimento di
12 milioni allo Stato italiano. Soprattutto alla luce dei due annullamenti
avvenuti in Cassazione e delle successive conferme della condanna a 21 anni
invece messe in atto dalla Corte d'Assise di Bari. I giudici infatti hanno
scelto di non tenere in considerazione dell'alibi di Morrone, confermato dai
vicini di casa Masone, dalla madre e da un amico appuntato. Il movente del
duplice delitto di Giovanni Battista e Antonio Sebastio era riconducibile ai
loro occhi a quella denuncia che l'uomo aveva sporto contro i due ragazzini, per
via di una strana attività collegata a dei motorini. Per questo e per le
testimonianze di due minorenni, sottolinea La Repubblica, verrà considerato
autore della tragedia.
È il più
clamoroso errore giudiziario del dopoguerra. Ora il ministero dell’Economia ha
deciso di staccare l’assegno più alto mai dato a un innocente per risarcirlo: 4
milioni e 500mila euro. Circa nove miliardi di lire, a fronte di 15 anni, 2 mesi
e 22 giorni trascorsi in carcere per un duplice omicidio mai commesso.
Il caso di
Domenico Morrone, pescatore tarantino, si chiude qua: con una transazione
insolitamente veloce nei tempi e soft nei modi. Il ministero dell’Economia ha
capitolato quasi subito, riconoscendo il dramma spaventoso vissuto dall’uomo che
oggi può tentare di rifarsi una vita.
Così, per il
tramite dell’avvocatura dello Stato, Morrone si è rapidamente accordato con il
ministero e la corte d’appello di Lecce ha registrato come un notaio il
«contratto». In pratica, Morrone prenderà 300mila euro per ogni anno di carcere.
E i soldi arriveranno subito: non si ripeteranno le esasperanti manovre
dilatorie già viste in situazioni analoghe, per esempio nelle vertenza aperta da
Daniele Barillà, rimasto in cella più di 7 anni come trafficante di droga per
uno sfortunato scambio di auto.
Morrone fu
arrestato mezz’ora dopo la mattanza, il 30 gennaio ’91. Sul terreno c’erano i
corpi di due giovani e le forze dell’ordine di Taranto cercavano un colpevole a
tutti i costi. La madre di una delle vittime indirizzò i sospetti su di lui. Lo
presero e lo condannarono. Le persone che lo scagionavano furono condannate per
falsa testimonianza. Nel ’96 alcuni pentiti svelarono la vera trama del
massacro: i due ragazzi erano stati eliminati perché avevano osato scippare la
madre di un boss. Morrone non c’entrava, ma ci sono voluti altri dieci anni per
ottenere giustizia. E ora arriva anche l’indennizzo per le sofferenze subite:
«Avevo 26 anni quando mi ammanettarono - racconta lui al Giornale - adesso è
difficile ricominciare. Ma sono soddisfatto perché lo Stato ha capito le mie
sofferenze, le umiliazioni subite, tutto quello che ho passato». Un procedimento
controverso: due volte la Cassazione annullò la sentenza di condanna della corte
d’assise d’appello, ma alla fine Morrone fu schiacciato da una pena definitiva a
21 anni. Non solo: beffa nella beffa, fu anche processato e condannato a 1 anno
e 8 mesi per calunnia. La sua colpa? Se l’era presa con i magistrati che avevano
trascurato i verbali dei pentiti.
Ora, finalmente,
la giustizia si mostra comprensiva con chi è stato vittima di un errore così
grave: la corte d’appello di Lecce nota anzitutto che l’Avvocatura dello Stato
«non si oppone alla liquidazione» della cifra. La scorsa estate Morrone aveva
chiesto allo Stato un risarcimento di 12 milioni di euro; il tempo di condurre
una rapida trattativa e il ministero si è detto disponibile a chiudere la
pratica a quota 4, 5 milioni di euro. Senza opposizioni e contestazioni. La
somma totale di 4,5 milioni è così ripartita: 1 milione e 300mila euro per la
privazione della libertà; 1 milione e 700mila euro per i danni non patrimoniali;
1 milione per il danno patrimoniale da mancato guadagno; 500mila euro per le
spese legali e per gli onorari del difensore. Un record per l’Italia. E anche un
primato di velocità.
Ma non finisce
qui. Morrone vuole presentare il conto anche ai magistrati che hanno sbagliato e
per questo ricorrerà alla legge sulla responsabilità civile dei giudici. Il
pescatore, come impone la norma, si rivolgerà alla Presidenza del consiglio,
chiedendo 8 milioni di euro per l’operato di Vincenzo Petrocelli, il magistrato
di Taranto che l’aveva messo sotto accusa.
SONO INNOCENTE. STEFANO MESSORE.
“Nonostante l'ingiustizia subita,
aiuterei ancora i terremotati” (Sono innocente).
Stefano Messore è stato accusato di sciacallaggio dopo il terremoto del 24
agosto 2016. Dopo 50 giorni di galera e 10 mesi di domiciliari è stato assolto.
La sua storia a "Sono innocente", scrive Morgan k. Barraco il 15 aprile 2018 su
"Il Sussidiario". “Sono innocente” racconta oggi la storia di Stefano Messore,
il volontario arrestato per sciacallaggio dopo il terremoto di Amatrice. «Sono
solo riuscito a dire: aiuto, mi stanno portando in carcere», ha raccontato in
merito al momento dell'arresto. Finito 50 giorni in carcere con l'accusa di
sciacallaggio, sente di essersi «ritrovato in una storia surreale». Un racconto
doloroso quello di Stefano: «Avevo dato tutto per aiutare i terremotati, ma non
rinuncerei mai alla solidarietà». E infatti ha chiesto una cosa alle sue figlie:
«Ho detto loro che non dovevano cambiare per quello che mi è successo». E
infatti non si è detto pentito di essersi offerto volontario: «Rifarei tutto,
nonostante l'ingiustizia subita. Correrei ad aiutare queste popolazioni».
L'amarezza però resta: «Chi mi restituirà quei giorni trascorsi in carcere?».
Sono innocente ha intervistato anche sua figlia Giada: «La vita è tornata come
prima, anche se i miei genitori lavorano di più ora. Ho imparato che, anche se
poteva succedere a chiunque, non dobbiamo smettere di aiutare le persone, perché
è una cosa bellissima». (agg. di Silvana Palazzo)
Stefano Messore, il volontario arrestato per
sciacallaggio. L'incubo di Stefano Messore inizia il 24 agosto del 2016, data
che viene ricordata per il terremoto che ha colpito il Centro Italia. Sono stati
tanti i cittadini a perdere tutto nel tragico evento, così come molti sono
intervenuti in massa per prestare soccorso come volontari. Un'occasione che ha
dato modo anche a degli sciacalli di farsi avanti e sottrarre gli aiuti ai
disagiati. Messore sarà fra chi cercherà di aiutare i terremotati, ma la sua
presenza sul posto lo porterà a finire in galera per 50 giorni. L'accusa è di
aver derubato le vittime del terremoto. La storia di Stefano Messore verrà
raccontata nella puntata di “Sono Innocente” di oggi, domenica 15 aprile 2018.
Originario del quartiere romano Labaro, Messore è un istruttore di arti marziali
e gestisce una palestra di sua proprietà. Sposato con tre figlie, non si tirerà
indietro di fronte alla possibilità di aiutare quanti hanno perso tutto a causa
del terremoto. Il 3 settembre, racconta a Today, stav assistendo le vittime e
sta allestendo delle tende ad Acquasanta Terme, quando i Carabinieri lo accusano
di aver rubato il materiale che lui stesso ha portato sul posto. Sulle prime
Messore crede che si tratti di un equivoco che si risolverà in poco tempo, ma ad
attenderlo ci sarà quella cella in cui verrà confinato per oltre un mese.
Stefano Messore, da soccorritore a sciacallo.
Stefano Messore è stato etichettato come un criminale nonostante fosse
accreditato fra i soccorritori del terremoto del 2016. In quel momento si
trovava al fianco di moglie e figlie per aiutare le vittime e gestire i prodotti
inviati grazie agli aiuti, gli stessi che poi trasportava con un furgone
viaggiando da Labaro fino al Centro Italia. Quel giorno anche Messore si
ritroverà a perdere qualcosa. Il primo giorno di scuola di una delle bambine,
diversi compleanni e infine anche i clienti della sua palestra. Dopo essere
stato rilasciato, Messore infatti dovrà trascorrere dieci mesi agli arresti
domiciliari prima di essere riconosciuto innocente delle accuse. Un periodo di
tempo che permetterà ai clienti della palestra di disdire le iscrizioni. Una
tragedia nella tragedia visto che, come sottolinea a Today, era lui a portare a
casa i soldi per sostenere la famiglia, mentre la moglie si dedicava al ruolo di
mamma. L'arresto di Messore va comunque visto all'interno di un contesto molto
più ampio. Le autorità infatti sospetteranno della sua malafede a causa delle
informazioni ricevute sulla malavita presente ad Amatrice per sottrarre gli
aiuti destinati ai terremotati. Un'operazione che infine porterà a dieci arresti
e diverse denunce. I criminali in questione, ricorda Il Corriere della Sera, si
erano fatti accreditare come soccorritori per poter superare i posti di blocco
senza problemi. Anche per questo il lasciapassare di Messore non lo aiuterà a
dimostrare la propria innocenza.
Arrestato con Massimiliano Pietroletti. Stefano
Messore non sarà l'unico accusato di concorso in furto aggravato durante il
terremoto di Amatrice del 2016. Quello stesso giorno di settembre, le autorità
fermeranno infatti un altro cittadino romano, Massimiliano Pietroletti. Secondo
le indagini, entrambi avrebbero approfittato del furgone Doblò che riportava il
simbolo della Regione Lazio e della Protezione civile per derubare gli aiuti
umanitari, compresi i giocattoli destinati ai bambini. Una volta informate dello
sciacallaggio in corso, le forze dell'ordine iniziano a battere a tappeto la
zona, aumentando di 20 agenti il contingente già presente sul campo. Vengono
controllate le case e le macerie, abitazione inagibili e integre. Fra le dieci
persone arrestate non c'è solo un innocente come Stefano Messore, ma anche due
pregiudicati con un passato per rapina e di origine romena, oltre ad alcuni
soggetti che al momento dell'arresto vengono sorpresi con arnesi da scasso a
bordo della propria auto. Lo sciacallaggio verrà visto con estrema gravità
soprattutto perché la tragedia ha messo in ginocchio il Centro Italia: la
volontà della Polizia è di dare una pena esemplare a chi cerca di approfittarsi
di una situazione simile. Anche per questo occorrerà molto tempo prima che
Messori venga riconosciuto come innocente. Nemmeno la prima udienza, sottolinea
Il Corriere della Sera, in cui l'uomo accuserà Pietroletti di averlo ingannato e
di essersi approfittato della sua buona fede per portare via del materiale.
SONO INNOCENTE. ALDO SCARDELLA.
Lo studente sardo che si suicidò dopo
dopo 185 giorni in prigione (Sono innocente). Questa
sera nella trasmissione “Sono innocente” su Rai3 si parlerà della tragica
vicenda dello studente universitario Aldo Scardella, accusato ingiustamente di
omicidio nel 1985, scrive Morgan k. Barraco il 15 aprile 2018 su "Il
Sussidiario". Il caso Aldo Scardella rimarrà nella storia degli errori
giudiziari commessi in Italia. E non solo perché il giovane studente di Cagliari
verrà ritenuto responsabile dell'omicidio dell'imprenditore Giovanni Battista
Pinna: i 185 giorni che Scardella trascorrerà in carcere lo spingeranno infine
verso il suicidio. Le accuse contro il ragazzo riguardano un omicidio avvenuto
due giorni prima di Natale, nel 1985. In quel giorno due (o tre) criminali
vengono avvistati mentre prendono di mira il titolare di una rivendita di
liquori sita a Cagliari, mentre sta preparando la chiusura. Nonostante non ci
fosse alcuna prova, sarà l'universitario cagliaritano a essere accusato del
delitto e infine rinchiuso in una cella di isolamento del penitenziario di
Oristano. La storia di Aldo Scardella verrà raccontata da “Sono Innocente”, il
programma di Rai 3, nella puntata di oggi, domenica 15 aprile 2018. Una storia
agghiacciante che dimostra come il ragazzo sia stato costretto non solo a subire
un'accusa ingiusta, ma anche a rimanere del tutto isolato. Gli inquirenti
infatti stabiliranno che nessuno, né la famiglia né il suo difensore, possano
avvicinarlo. Da quel carcere, ricorda Il Giornale, Scardella uscirà solo una
volta morto, nei primi giorni di luglio del 1986.
Il passamontagna trovato nel giardino di casa
Scardella. Perché Aldo Scardella è stato considerato colpevole del delitto di
Giovanni Battista Pinna? Tutto ruota attorno a un passamontagna che i killer
dell'imprenditore cagliaritano lasceranno nel giardino dello studente, a poche
centinaia di metri dalla scena del crimine. Secondo le prime ricostruzioni,
l'omicidio di Pinna è avvenuto per la rapina messa in atto dai due killer,
intenzionati a derubare il titolare del Bevimarket dell'incasso. Tre giorni dopo
l'omicidio, la Squadra Mobile di Cagliari entrerà nella casa di Aldo Scardella
per perquisirla e il giovane verrà interrogato. Anche se il 24enne riuscirà a
fornire subito un alibi e non verranno riscontrate tracce sul passamontagna,
nessuno crederà all'innocenza di Aldo, che verrà quindi trasportato nel
penitenziario di Oristano. Eppure il capo d'accusa citerà la presenza di indizi
di colpevolezza sufficienti a poterlo indicare come responsabile dell'omicidio
Pinna e anche a rinchiuderlo in isolamento forzato per dieci giorni. Il motivo è
da ricondurre a quegli indizi, scrive Il Giornale, che anche se non dimostrano
con certezza la colpevolezza di Scardella, sono sufficienti per le autorità per
metterlo sotto pressione. Un tentativo di farlo crollare tramite torture morali
che in seguito alla sua morte verrà messo al vaglio del Parlamento italiano.
Solo dieci anni dopo il suicidio di Aldo si riuscirà a scoprire i colpevoli
dell'omicidio Pinna, Walter Camba e Adriano Peddio, grazie a un collaboratore di
giustizia.
Enzo Tortora si occupò del caso. Il suicidio
di Aldo Scardella ha messo l'accento su tanti punti interrogativi. Le lacune sul
modus operandi della Procura di Cagliari sono state sottolineate da diverse
interrogazioni parlamentari richieste dai cittadini italiani, con cui si sono
messi in luce i diversi errori. A partire dal fatto che la famiglia di Aldo è
stata informata del carcere in cui si trovava rinchiuso solo diversi giorni dopo
il suo arresto. Senza considerare, ricorda Il Giornale, che al ragazzo è stato
impedito non solo di avere un contatto con la propria famiglia, ma anche con il
difensore. L'avvocato tra l'altro non è riuscito a parlare con lo studente
cagliaritano nemmeno nei mesi successivi al suo arresto, mentre la famiglia lo
incontrerà 3 volte in tutto. Aldo Scardella tuttavia non è mai stato
dimenticato, soprattutto da chi si è ritrovato a condividere con il 24enne,
seppur a distanza di tanti anni, lo stesso crudele destino. Rimane nella memoria
il desiderio di Enzo Tortora infatti di voler deporre dei fiori sulla tomba del
giovane. E non solo, perché per uno scherzo del destino anche il collaboratore
di giustizia Antonio Fanni, che dodici anni dopo la tragedia ha scagionato
Scardella da ogni accusa, si ucciderà nel carcere di Spoleto. Il pregiudicato
era conosciuto come membro della banda Is Mirrionis, ricorda Repubblica, una
gang che negli anni Ottanta ha messo in ginocchio Cagliari a causa di furti,
rapine, attentati e omicidi.
Sono Innocente su Rai3: casi del 22
aprile 2018, scrive Debora Marighetti su Notizie
tv, Rai, Rai3. Stasera, domenica 22 aprile 2018, alle 21.20 circa su Rai3
tornerà Sono Innocente, il programma condotto dal giornalista Alberto Matano che
racconta storie di errori giudiziari, di innocenti condannati ingiustamente,
detenuti e poi scarcerati e risarciti dallo Stato. Si tratta della terza puntata
stagionale.
Si inizierà con la storia di Maria Vittoria Pichi.
Ha 27 anni e lavora come dipendente in una farmacia quando, il 17 dicembre del
1981, a Verona, un commando delle Brigate Rosse rapisce il generale della Nato
James Lee Dozier. In poche ore la notizia fa il giro del mondo. La risposta
delle forze dell’ordine è immediata. Perquisizioni e posti di blocco si
alternano senza sosta in ogni angolo della città. A 10 giorni dal rapimento
vengono arrestati alcuni giovani: tra loro c’è anche Maria Vittoria che, in quel
periodo, fa parte di un movimento studentesco. Con il sequestro lei non ha
niente a che fare eppure, prima di dimostrarlo, dovrà trascorrere quasi tre mesi
nel carcere della Giudecca a Venezia.
La seconda storia parla di casi giudiziari che
hanno avuto una grande risonanza mediatica. In particolare in studio con Alberto
Matano ci sarà Patrick Lumumba, accusato del delitto di Meredith Kercher.
Arrivato a Perugia per studiare all’Università per Stranieri, conosce una
ragazza polacca con la quale mette su famiglia. Abbandona gli studi e apre un
piccolo locale frequentato particolarmente da studenti. Conosce Meredith Kercher
e Amanda Knox perché lavorano nel suo pub. E’ probabilmente questa la ragione
del suo coinvolgimento in uno dei casi di cronaca nera più clamorosi della
nostra storia recente: Lumumba viene accusato da Amanda Knox di avere ucciso
Meredith. Trascorre due settimane in carcere prima di essere scagionato e prima
di vedere Amanda condannata per calunnia. Adesso Patrick vive in Polonia.
L’ultima testimonianza vede protagonista Alberto
Ogaristi. A Casal di Principe, nel 2002, è in atto una vera e propria guerra di
camorra. A febbraio avviene un omicidio per il quale è condannato un ragazzo del
posto di 25 anni, Alberto. Viene identificato da un testimone ma lui, con il
fatto di sangue, non c’entra nulla. In quel momento si trovava alla festa di
compleanno della nipote. Nessuno gli crede e, dopo vari processi,
viene condannato all’ergastolo. Ma la famiglia non si arrende; i suoi parenti si
attivano e riescono a scoprire la verità grazie alla testimonianza di un
camorrista che aveva partecipato realmente all’omicidio. Le sue parole
scagionano Alberto che, dopo un tormentato processo di revisione, viene assolto
per non aver commesso il fatto.
SONO INNOCENTE. MARIA VITTORIA PICHI.
Maria Vittoria Pichi. Arrestata per il sequestro
di James Lee Dozier: 100 giorni in prigione (Sono Innocente). Il 28 dicembre
1981 Maria Vittoria Pichi viene arrestata nell’ambito delle indagini sul
sequestro del generale americano James Lee Dozier, scrive il 22 aprile 2018
Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". La storia di Maria Vittoria Pichi, una
farmacista delle Marche, inizia nel dicembre del 1981. È in questa data che i
Carabinieri arrestano la giovane con l'accusa di sequestro di persona e
terrorismo. Un racconto drammatico che la protagonista di quest'incubo
ripercorre nel suo libro autobiografico “Come una lama”, edizione Italic. Il suo
caso verrà approfondito invece nella puntata di Sono Innocente di questa sera,
domenica 22 aprile 2018, grazie alla ricostruzione con i documenti storici di
quanto avvenuto in quei giorni. Maria Vittoria Pichi verrà rinchiusa dietro le
sbarre per oltre cento giorni, per un crimine che la vedrà alla fine innocente.
La sua unica colpevolezza all'epoca sembra il suo interesse politico e una serie
di coincidenze che hanno come sfondo gli anni di piombo italiani. Sono anni
difficili, in cui la pressione esterna è tale che l'attenzione di autorità e
giustizia sembra concentrarsi più sul trovare dei colpevoli ad ogni costo,
scrive la Pichi, piuttosto che a dimostrare tramite prove certe che le accuse
sono fondate. E sarà proprio quella giovane farmacista, che in quel momento
viveva in un paesino distante da Padova pochi km, a finire in una ragnatela da
cui sarà difficile uscire.
Il sequestro di James Lee Dozier Arrestata,
condannata e innocente. Maria Vittoria Pichi ha vissuto un vero incubo a partire
dal 28 dicembre del 1991, ritrovando alla fine se stessa e scoprendo il suo
inedito lato da scrittrice proprio grazie agli eventi che ha vissuto. Le
indagini delle autorità sul suo conto iniziano per via del sequestro di James
Lee Dozier, un generale americano. Le Brigate Rosse si prenderanno subito il
merito dell'azione, soprattutto perché il rapimento dell'ufficiale rappresenta
un evento importante che riguarda non solo lo Stato italiano, ma anche l'America
e persino la NATO. Le pressioni dall'esterno diventano sempre più forti proprio
per le origini del Generale. L'America preme e l'Italia inizia a organizzare
retate e perquisizioni di massa negli ambienti politici frequentati dai membri
della sinistra estrema. In tutto questo si ritroverà coinvolta Maria Vittoria
Pichi, che verrà tratta in arresto al fianco del compagno Paolo. Riuscirà a
raccontare quanto le è successo, sottolinea Senigallia Notizie, solo 27 anni
dopo quei terribili giorni. Il pretesto del suo arresto sembra riconducibile
alla presenza di alcuni volantini di organizzazioni para-terroristiche che
verranno trovate nell'auto della coppia. Materiale che a detta della Pichi erano
facilmente reperibili e distribuiti in tutte le assemblee della sua fazione
politica. E la loro diffusione non implicava necessariamente far parte delle
Brigate Rosse, motivo per cui sia Maria Vittoria che Paolo verranno prosciolti
in seguito da ogni accusa.
Maria Vittoria Pichi, cento giorni in carcere.
Anche se Maria Vittoria Pichi verrà considerata innocente agli occhi della
giustizia, dopo 100 giorni di carcere ingiusto, il suo paese d'origine la vedrà
per lungo tempo come una terrorista. E ancora di più come una raccomandata. L'ex
farmacista verrà additata infatti come una finta innocente dai suoi compaesani,
per via del presunto intervento del padre. Per Senigallia la Pichi rimarrà
sempre una terrorista, sottolinea in un'intervista al giornale locale,
soprattutto perché i titoloni altisonanti con cui è stato trattato il suo
arresto colpiranno duramente la popolazione. Di contro, nessuno sembrerà
ricordare i successivi, quelli che riguarderanno la sua assoluzione piena. Ed è
anche il motivo per cui Maria Vittoria ha voluto scrivere il suo libro Come una
lama, per ricordare ciò che è stato dimenticato dalla popolazione e per dire la
sua in merito a quanto accaduto. Le accuse dirette alla donna coinvolgeranno
tuttavia anche la famiglia, dato che i genitori rimarranno a vivere a Senigallia
senza curarsi di ciò che stava avvenendo. E immancabilmente vivranno sulla loro
pelle l'onta attribuita alla figlia, che riuscirà a togliersi di dosso solo
grazie alla propria coscienza. Anche Maria Vittoria del resto è dovuta ritornare
nella sua Senigallia a distanza di tanto tempo, molto dopo quei fatti degli anni
Ottanta. Ed è lì che vive ancora, dove per molti rimane "la terrorista".
SONO INNOCENTE. PATRIK LUMUNBA.
Patrick Lumumba. Il congolese ingiustamente
accusato e incastrato da Amanda Knox (Sono Innocente). Nella puntata di questa
sera di "Sono Innocente" si parlerà del delitto di Meredith Kercher, con la
testimonianza di Patrick Lumumba che fu ingiustamente accusato, scrive il 22
aprile 2018 Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". La vita di Patrick
Lumumba verrà segnata in modo inesorabile dal delitto di Meredith Kercher. La
studentessa 22enne di Londra viene uccisa nel novembre del 2007 in circostanze
che appaiono subito oscure. Al centro delle indagini verranno messi subito tre
nomi e non solo quello di Lumumba: Amanda Knox e Raffaele Sollecito. La prima è
la coinquilina della vittima, il secondo il ragazzo che Amanda frequenta in quel
periodo. E sarà proprio la ragazza a fare il nome di Lumumba dopo diverse
pressioni da parte delle autorità. Il caso di Patrick Lumumba verrà trattato
nella puntata di Sono Innocente di oggi, domenica 22 aprile 2018, in onda su Rai
3. Qual è il collegamento fra l'uomo e la ragazza di Seattle, oltre che di
entrambi con Meredith Kercher? Amanda Knox all'epoca dei fatti lavora come
barista nel bar gestito dall'uomo e lo indicherà in tempo record come
responsabile del delitto di Meredith. Accuse infondate che le comporteranno una
condanna a tre anni per calunnia nei suoi confronti. In un'intervista a La
Zanzara, il programma di David Parenzo e Giuseppe Cruciani su Radio24, Lumumba
si è dichiarato addolorato della successiva assoluzione della Knox, sicuro che
sia in realtà colpevole dell'omicidio della coinquilina: "Sono sicuro che Amanda
sa chi ha ucciso la povera Meredith, deve sapere cosa è successo. Sono
convinto". Il congolese del resto non ha mai creduto al fatto che la ragazza lo
avesse accusato solo per lo stress vissuto durante i molteplici interrogatori.
Soprattutto alla luce dei dissapori che i due hanno sempre vissuto durante il
loro rapporto di lavoro e che avevano spinto Lumumba a pensare di licenziare la
ragazza poco prima dell'orrenda tragedia.
L’accusa di Amanda Knox. Patrick Lumumba verrà
accusato dell'omicidio di Meredith Kercher e finirà in carcere per le accuse di
una delle sospettate. Alla sua assoluzione verrà risarcito con 8 mila euro per
ingiusta detenzione, un trattamento non equo ai suoi occhi. E non solo per
quanto riguarda Amanda Knox, colei che lo farà finire in carcere e che volerà
nella madre patria America subito dopo l'assoluzione. Anche per quanto riguarda
il trattamento che il congolese sente di aver ricevuto dallo Stato italiano. A
suo dire la Knox sarebbe inoltre a conoscenza di chi ha davvero compiuto il
delitto e sarebbe così abile nel recitare da essere riuscita a farsi beffe
persino delle autorità. Come ricorda Il Corriere della Sera, l'omicidio di
Meredith verrà attribuito alla fine solo a Rudy Guede, unico dei tre imputati a
rimanere dietro le sbarre e a subire la condanna. La Knox e Raffaele Sollecito
verranno invece assolti in via definitiva nel corso degli anni successivi.
All'epoca dei fatti Lumumba ha solo 37 anni e conosce bene sia la vittima che
Amanda Knox. Sarà quest'ultima a indicare il suo nome agli inquirenti,
strappandolo alla famiglia. Il congolese trascorrerà infatti due settimane
dietro le sbarre prima di essere assolto da ogni accusa. E non per merito della
Knox, che intanto non ritratterà mai le sue parole. A dimostrare l'innocenza di
Patrick sarà un professore svizzero che testimonierà in suo favore.
Patrick Lumumba assolto. Il nome di Patrick
Lumumba verrà sempre associato all'omicidio di Meredith Kercher, la ragazza di
22 anni che lavorava saltuariamente nel suo bar. Anche in seguito al
proscioglimento dalle accuse, il nome del congolese verrà usato spesso negli
articoli di stampa a livello internazionale. Il delitto della ragazza americana
coinvolge alla fine tre Paesi: il Congo, patria di Lumumba, l'America, che ha
dato i natali ad Amanda Knox, amica e coinquilina di Meredith, e l'Italia grazie
a Raffaele Sollecito. Non sarà infatti solo le dinamiche orrende con cui verrà
compiuto l'omicidio di Meredith ad attirare l'attenzione della stampa
internazionale, ma le origini dei tanti volti associati alla vicenda. Ed il nome
di Lumumba verrà estratto dal cilindro dei ricordi anche in seguito alla
distribuzione del documentario di Amanda Knox distribuito nel 2016 grazie alla
piattaforma Netflix. Una carrellata dei fatti visti dal punto di vista di quella
che è stata a tutti gli effetti una delle principali indiziate della tragedia.
La tesi della ragazza americana negli anni è rimasta la stessa: lei e Sollecito
hanno trovato il cadavere di Meredith solo dopo essere rientrati
nell'appartamento che la vittima condivideva con altre tre ragazze. Come ricorda
il giornale Bustle, Amanda farà leva su un messaggio inviato in risposta a
Lumumba per dimostrare di averlo visto in seguito all'omicidio. Sarà materiale
di una delle ritrattazioni successive della Knox, che a suo dire sarebbe
costretta a parlare di un falso ricordo che la vedeva al fianco del congolese
nell'appartamento della Kercher la notte del delitto.
SONO INNOCENTE. ALBERTO OGARISTI.
Alberto Ogaristi. Assolto dopo la latitanza e 5
anni in carcere per un delitto non commesso (Sono Innocente). Nella puntata di
questa sera di Sono Innocente si parlerà di Alberto Ogaristi, operaio di Casal
di Principe arrestato e condannato all'ergastolo per un delitto che non aveva
commesso, scrive il 22 aprile 2018 Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario".
L'arresto di Alberto Ogaristi, avvenuto nel settembre del 2015, ha dato la
possibilità alla stampa di additarlo come uno degli ultimi latitanti dei
casalesi. Il clan mafioso lo avrebbe visto come uno dei fedelissimi della
famiglia Schiavone, ma le autorità erano decise ad acciuffarlo anche per un
altro motivo. Ogaristi viene infatti accusato di essere il responsabile
dell'omicidio di Antonio Amato, uno degli affiliati della famiglia Tavoletta. Un
testimone presente sulla scena del crimine punterà il dito contro l'uomo e
spingerà le forze dell'ordine a considerarlo l'unico responsabile, per via della
guerra innescata fra il clan della vittima e la famiglia Bidonetti, di cui fa
parte l'accusato. Il caso di Alberto Ogaristi verrà trattato nella puntata
di Sono Innocente di oggi, domenica 22 aprile 2018, in onda su Rai 3. Diverso
tempo dopo l'arresto di Ogaristi, mentre prende piede il suo incubo personale,
un pentito inizia a indicare Luigi Grassia come il vero responsabile del delitto
Amato. Le sue parole tuttavia non verranno prese in considerazione dai giudici,
nemmeno quando alla prima rivelazione, scrive il Corriere del Mezzogiorno, si
aggiungeranno le parole di altri due pentiti, Oreste Spagnuolo e Emilio Di
Caterino. La Corte d'Appello di Roma indicherà infatti nel verdetto che la
revisione del processo non può avere luogo, dato che le dichiarazioni dei
pentiti sono da considerarsi inattendibili.
La latitanza di Alberto Ogaristi. Il caso
di Alberto Ogaristi inizia 18 febbraio del 2002, quando Antonio Amato viene
ucciso nell'ambito della faida di camorra a Villa Literno. Tutto ruota attorno a
un testimone che indica Ogaristi come il killer del mafioso. Il testimone è un
uomo di origini albanesi legato alla vittima in quanto cognato, fidanzato della
sorella di Amato. Ogaristi verrà subito portato in Caserma per un interrogatorio
ed anche se informerà subito le forze dell'ordine di essere innocente, fornendo
anche un alibi, la fidanzata dell'epoca non conferma le sue parole per un motivo
oscuro. Tempo dopo la ragazza avrà modo di ritrattare tutto in tribunale e
Ogaristi verrà rilasciato, ma il suo destino è nelle mani del testimone e del
pm. Quest'ultimo infatti richiederà in Appello che il verdetto di assoluzione si
trasformi in ergastolo per via della parentela dell'accusato con uno dei boss
del clan dei Casalesi. Ogaristi tuttavia decide di non finire in carcere e
diventa latitante, mentre le autorità iniziano la sua caccia, fino ad
acciuffarlo nel luglio del 2007. Come scrive Il Corriere del Mezzogiorno,
famiglia e conoscenti faranno petizioni e manifestazioni, ma cadranno tutte nel
vuoto. L'uomo verrà condannato in ergastolo per omicidio volontario grazie ad
una sentenza della Cassazione. In questo scenario va però tenuto in
considerazione un altro particolare. Nello stesso periodo di tempo il testimone
che lo ha indicato come assassino sparirà nel nulla. Il riconoscimento del
latitante quindi verrà collegato solo alla sua foto segnaletica.
L’assoluzione dopo cinque anni di carcere da
innocente. Quattro anni di carcere prima che la verità inizi a emergere. Alberto
Ogaristi dovrà attendere ben di più per ritrovare la sua libertà. Nel 2008, il
pentito Massimo Iovine decide di raccontare la verità sul delitto di Antonio
Amato e indica come veri responsabili Gaetano Ziello, Luigi Grassia e Luigi
Guida, tre che verranno incarcerati nel giro di poco tempo grazie ai riscontri
di Vincenzo Caputo, all'epoca gip di Napoli. L'identificazione dei colpevoli
avrebbe dovuto di conseguenza permettere ad Ogaristi di ritornare libero, ma non
sarà così. Dovrà attendere in tutto 12 anni di accuse perché la Corte d'Appello
di Firenze, scrive Il Mattino, lo assolva dalle accuse. Il più grande rammarico
del muratore di Casal di Principe sarà di dimostrare la propria innocenza solo
in seguito alla morte del padre, a cui dedicherà la sua assoluzione. Il suo nome
tuttavia rimarrà impresso nella stampa italiana come il latitante che è riuscito
a sfuggire all'operazione “Spartacus reset” dell'Antimafia e associato in modo
indelebile al clan Schiavone di Casal di Principe. La sua colpa, a quanto
sembra, è principalmente quella di aver vissuto in quella Gomorra fatta di lotte
e faide intestine, non solo fra mafia e Stato ma anche fra le famiglie stesse, i
clan locali.
SONO INNOCENTE. SAVERIO DE SARIO.
Saverio De Sario. Assolto dopo essere
stato condannato per abusi sui figli (Sono Innocente).
Il caso di Saverio De Sario verrà ripercorso nella puntata di
Sono Innocente di domenica 29 aprile 2018, in onda su Rai 3 e condotta da
Alberto Matano, scrive il 29 aprile 2018 Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario".
Poco più di un anno fa, Saverio De Sario è riuscito finalmente a rivedere la
luce dopo un incubo durato 11 anni. Quattro dei quali trascorsi ingiustamente in
carcere con una pesante accusa: aver violentato i due figli di 5 e 11 anni e una
nipotina. Un'etichetta pesante da digerire, un'infamia che lo ha portato non
solo a perdere la libertà per le denunce degli stessi ragazzini, ma a dover
combattere per diversi gradi di giudizio prima di essere riconosciuto come
innocente. Quanto accaduto a Saverio De Sario verrà ripercorso nella puntata
di Sono Innocente di oggi, domenica 29 aprile 2018, a partire da quell'accusa
che diventerà un marchio a fuoco fino alla ritrovata libertà grazie agli stessi
figli che, una volta adulti, hanno scagionato il genitore. De Sario infatti
viene accusato di violenza su minore e condannato per aver abusato i due
ragazzini a dieci anni di carcere. Una sentenza diventata definitiva nel 2015 e
poi rivista grazie alla Corte d'Appello di Perugia, in seguito a due richieste,
una delle quali andata a vuoto. A permettere a Saverio di rivedere la luce del
sole e uscire dal suo incubo personale saranno proprio le testimonianze dei
figli Gabriele e Michele, scrive La Repubblica, che confermeranno come in realtà
quella falsa confessione sia stata strappata loro dalla madre.
Il rapporto con i figli. Saverio De Sario e i
figli avevano perso ogni speranza di poter ottenere finalmente giustizia. La
lotta dell'uomo contro l'accusa di violenza sui figli è stata infatti condivisa
con i due ragazzi, oggi più che adulti, e che all'epoca dei fatti erano solo dei
bambini. I fatti risalgono al 2001, quando il matrimonio fra De Sario e la
moglie si inasprisce a causa dell'affidamento dei due ragazzi. Qualche anno più
tardi è la moglie Angela ad aprire quella che sarà l'odissea dell'uomo,
riuscendo nel frattempo a ottenere l'affidamento dei due figli in via esclusiva.
Una verità emersa già otto anni più tardi grazie a un memoriale del figlio
maggiore, Gabriele, ampiamente ignorato dagli educatori della comunità di
Brescia a cui era stato affidato. In quello scritto emerge una nuova versione
dei fatti: sarebbe stata Angela, come riporta una ricostruzione de La Vita in
Diretta, a spingere i due figli ad accusare ingiustamente il padre. Il tutto per
un motivo di gelosie e vendette dovute alla separazione in corso. Eppure tutto
questo non impedirà a De Sario di ritrovarsi in carcere per due volte, in una
realtà disagiata e ostile. Nelle notti nascoste in carcere, sottolinea
nell'intervista, è riuscito a rimanere in piedi solo grazie alla consapevolezza
di essere innocente e alla certezza che la verità sarebbe presto emersa. Senza
dimenticare il sostegno dei due figli, che lo hanno supportato con tutte le loro
forze. Gabriele all'epoca era già consapevole che la madre cercasse di
manipolare lui ed il fratello in ogni modo, ma non riusciva comunque a dire la
verità. Non era solo una violenza psicologica, ha riferito, ma anche fisica: la
donna infatti avrebbe picchiato i figli per costringerli a portare avanti le
false accuse.
Le responsabilità della moglie di Saverio De
Sario. Anche se i figli hanno contribuito a farlo finire in carcere, Saverio De
Sario non ha mai avuto alcun risentimento nei confronti di Gabriele e Michele.
Fin dalla prima incarcerazione, era sicuro che le accuse che i due ragazzini gli
avevano mosso erano dovute all'influenza di una terza persona. Anzi, durante i
primi anni di penitenziario De Sario ha cercato comunque di inviare dei regali
ai figli, senza mai riuscirci per via del regime carcerario ristretto. Anche se
i due figli hanno ritrattato tutto, la versione dell'ex moglie di De Sario è
sempre stata diversa. Gabriele nel memoriale depositato agli atti e utile alla
scarcerazione del padre, parla anche di come la madre Angela avrebbe abbandonato
entrambi i figli. Come ha sottolineato a La Vita in Diretta, il figlio Gabriele
in particolare sarebbe stato testimone dei grandi problemi che erano presenti
nel matrimonio dei genitori. I due ragazzi avrebbero cercato poi di dimostrare
l'innocenza del padre solo per il forte senso di colpa provato per averlo fatto
incarcerare. Gabriele invece non crede che potrà mai perdonare la madre per
quello che è successo, anche se sia lui che il fratello Michele hanno deciso di
guardare avanti e di lasciarsi tutto alle spalle. Secondo il minore dei De Sario
l'errore deve invece essere esteso anche alle autorità che non hanno indagato a
fondo sulle accuse ed hanno accettato la denuncia senza alcun tipo di
approfondimento.
SONO INNOCENTE. FILIPPO LA MANTIA.
Filippo La Mantia. Sei mesi
all'Ucciardone per errore: da fotografo a chef (Sono Innocente).
Lo chef Filippo La Mantia è stato sei mesi nel carcere dell'Ucciardone di
Palermo. Entrato come fotoreporter, è uscito come cuoco. La sua vicenda
giudiziaria nella puntata di Sono Innocente, scrive il 29 aprile 2018 Morgan K.
Barraco su "Il Sussidiario". Il nome di Filippo La Mantia, oggi uno degli chef
più rinomati d'Italia, è strettamente collegato con Ninni Cassarà. Il
vicequestore ucciso da Cosa Nostra nell'agosto del 1985 è stato raggiunto
infatti da una raffica di mitra mentre si trovava di sui gradini di casa, la
stessa che era stata affittata tempo prima al cuoco. Per questo, in quanto
ultimo a risultare inquilino dell'appartamento, La Mantia è stato tradotto in
carcere a Palermo, dove ha vissuto sei mesi prima di dimostrare la propria
innocenza. La storia di Filippo La Mantia verrà raccontata nella puntata di Sono
Innocente di oggi, domenica 29 aprile 2018, ripercorrendo i difficili mesi
vissuti dal giovane che all'epoca svolgeva la professione di reporter.
L'esperienza in carcere, sottolinea lo chef a Il Corriere della Sera, gli ha
permesso alla fine di scoprire la passione per la cucina. È infatti in carcere
che inizia a destreggiarsi fra i fornelli, cucinando per 11 detenuti con cui
condivideva una cella dell'Ucciardone, il penitenziario di Palermo. È forse
l'unico modo per il futuro cuoco di rimanere ancorato a quell'infanzia fatta di
profumi e sapori di libertà e di affetti. In quel momento La Mantia inizia a
sperare ogni giorno di poter dimostrare di essere innocente, soprattutto perché
la casa da cui sono partiti i colpi diretti a Cassarà l'aveva abbandonata
diversi mesi prima della tragedia.
Filippo La Mantia: da fotografo a chef. Filippo La
Mantia riuscirà alla fine a dimostrare di essere estraneo alla morte di Ninni
Cassarà, ma dietro quelle sbarre non finirà solo il giovane 25enne siciliano. Si
chiuderà in qualche modo anche la professione che in quattro anni gli hanno
permesso di diventare uno dei fotografi più apprezzati di Palermo. La Mantia
ricorda bene quel giorno, l'entrata in carcere, le porte del penitenziario che
si chiudono dietro di lui e la sicurezza di aver perso anche il suo futuro
professionale. È in quel momento che realizza tutto, anche di poter contare solo
sui propri sogni. E non solo per quanto riguarda la libertà da ritrovare, ma
anche quella passione che presto gli permetterà di diventare famoso come chef
italiano. Il provvedimento di Giovanni Falcone lo rende di nuovo un uomo libero
sei mesi dopo il suo arresto, ricorda in un'intervista a Il Corriere della Sera,
ma occorreranno molti anni prima di riuscire a ingranare davvero come cuoco. Un
sogno diventato realtà grazie al trasferimento a Roma, a una dura gavetta e
infine all'apertura del suo primo ristorante, avvenuto quando aveva 54 anni,
nella cornice di Milano. Un piccolo passo prima della replica del successo,
grazie all'apertura di un nuovo locale e alla scalata come oste e cuoco
italiano. Di certo non ha mai ambito a riconoscimenti e stelle, confida, ma a
realizzare quell'unico obbiettivo che gli ha permesso di rimettersi in pista ed
a trasformare un ostacolo in una grande opportunità.
Lo chef che cucina senza aglio e cipolla. In
carcere per un errore, Filippo La Mantia non è riuscito solo a lasciarsi alle
spalle quei brutti mesi che ha trascorso dietro le sbarre dell'Ucciardone di
Palermo. E non ha solo trasformato quest'esperienza nel suo futuro successo come
oste cuoco, come ama definirsi. Anche nella vita privata La Mantia è riuscito a
realizzarsi a tutto tondo, grazie al supporto della compagna Chiara Maci e alla
nascita del loro primo figlio. In realtà il successo del palermitano avviene
molto prima, quando appena ventenne è uno dei fotoreporter più apprezzati in
Sicilia. È stato infatti uno dei primi a raggiungere la scena del crimine in cui
è stato ucciso il Generale Dalla Chiesa, ricorda Vanity Fair. Eppure basterà un
solo dettaglio perché La Mantia venga etichettato come un affiliato della mafia,
per via di quell'appartamento coinvolto nella morte del vicequestore Ninni
Cassarà. Una casa che lo chef aveva lasciato otto mesi prima, trasferendosi poi
a Mondello. Di quel periodo però non ricorda solo il dolore, la sofferenza, ma
anche la famiglia e la tradizione. Due elementi che ha cercato di infondere nei
piatti che proponeva ai detenuti, soprattutto grazie all'assenza di aglio e
cipolla. Due prodotti che non ama e che ha deciso di togliere del tutto dalle
proprie creazioni, sicuro che ogni cuoco che si rispetti debba adeguarsi al
gusto delle persone e non viceversa. Facendo questa piccola modifica ha scoperto
infatti che tante altre persone non sopportano quei due particolari ingredienti
e che molti accettano la loro presenza nei piatti solo perché piegati al volere
dello chef.
SONO INNOCENTE. FULVIO PASSANANTI.
Fulvio Passananti. Scambiato per il
ladro, nove mesi in carcere (Sono Innocente). Il caso
di Fulvio Passananti, scambiato per il responsabile di una rapina all'Oro Trade
di Chirignago, scrive il 29 aprile 2018 Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario".
Il caso di Fulvio Passananti rientra fra gli errori giudiziari del nostro Paese
ed inizia nel 2011, quando l'uomo viene accusato di rapina ai danni dell'Oro
Trade di Chirignago, in provincia di Venezia, e di sequestro di persona. In quei
momenti infatti avrebbe rinchiuso una commessa del contro/vendo oro per due
minuti all'interno di un bagno. La ricostruzione dei fatti risale al 19 gennaio
di quell'anno ed il volto di Passananti verrà associato a quello del ladro
grazie alla testimonianza dell'addetta alle vendite. Quanto accaduto a Fulvio
Passananti verrà ripercorso nella puntata di Sono Innocente di oggi, domenica 29
aprile 2018, a partire dall'alibi che l'uomo esibirà nell'immediato alla pm
Carlotta Franceschini. Come riporta La Nuova Venezia, il presunto ladro infatti
riferirà subito che al momento della rapina si trovava a 15 km di distanza dal
negozio, per sostenere un colloquio in un paese vicino. Una distanza che
tuttavia agli occhi degli inquirenti avrebbe potuto comunque compiere per poter
mettere in atto il crimine. Ma nella storia di Passananti c'è molto di più: la
stessa testimone, poche ore dopo il riconoscimento dell'uomo grazie alla foto
segnaletica, avrebbe riferito agli investigatori di essersi sbagliata.
Un'affermazione che verrà però ascoltata diversi mesi più tardi, nove per
l'esattezza, quando l'imputato verrà considerato innocente e rilasciato per
ingiusta detenzione.
La testimonianza della commessa. Il nome di Fulvio
Passananti non è di certo sconosciuto alle autorità quando la commessa di un
compro/vendo oro della provincia di Venezia riconoscerà nella sua foto l'uomo
che ha rapinato il punto vendita. È la donna l'unica testimone di quanto
avvenuto in quei momenti, in quel gennaio del 2011, quando un uomo irrompe nel
negozio e la spinge contro il muro, intimandole di consegnargli l'incasso prima
di rinchiuderla dentro al bagno del locale. Durante la denuncia, la donna
riconoscerà Passananti grazie alle foto segnaletiche: l'uomo infatti ha alle
spalle diversi precedenti alle spalle. Alcuni specifici, come sottolinea Il
Corriere del Veneto. Eppure alcune ore dopo la donna rivede il vero rapinatore
all'esterno del negozio e riferirà agli inquirenti di non essere più sicura del
riconoscimento precedente, ma non verrà ascoltata. Anche per questo la Procura
di Venezia deciderà alla fine di aprire un fascicolo per indagare meglio su
quanto avvenuto, mentre il tribunale dichiarerà Passananti come innocente. Una
decisione contraria a quanto proposto dal pm Carlotta Franceschetti, che avrebbe
invece richiesto l'assoluzione per insufficienza di prove. La testimonianza
della commessa si rivelerà alla fine sufficiente per i giudici per dimostrare
l'estraneità dell'uomo ai fatti, così come la ricostruzione dell'avvocato
difensore. Il legale infatti ha dimostrato durante l'udienza che pochi minuti
prima della rapina il suo cliente si trovava a diversi km di distanza dalla
scena del crimine, in una località che aveva raggiunto in bicicletta. Per questo
non avrebbe potuto percorrere in un così breve lasso di tempo la distanza
necessaria per raggiungere il negozio rapinato.
La famiglia di Fulvio Passananti. La storia di
Fulvio Passananti inizia a Napoli, nel quartiere Vomero, dove viveva con i
genitori e i fratelli più grandi. Sono diversi i punti cruciali che lo
porteranno a seguire poi le cattive amicizie e a percorrere una strada buia che
lo spingeranno poi verso l'arresto, anche se come innocente. Appena 18enne perde
infatti la madre in un incidente stradale e l'evento spacca la famiglia,
provocando dolore nel padre e nei fratelli. "Erano conosciuti come i
fidanzatini", dice Passananti a Siamo Noi, il programma di Tv2000, per indicare
quanto la coppia fosse legata e innamorata. Alla morte del padre, l'uomo decide
di trasferirsi in Veneto, in una provincia in cui cercherà di rifarsi una vita e
allontanarsi dal passato, dai reati penali che gli erano già stati imputati. Il
giorno della rapina di Chirignago, vicino Mestre, Passananti ricorda di essersi
sentito isolato e di aver iniziato a capire che cosa era successo grazie agli
articoli dei giornali. Verrà infatti accusato di aver rapinato un negozio del
paese e di aver sequestrato una commessa. Trascorrerà nove mesi in carcere,
lasciando a casa tre figli, di cui solo uno maggiorenne. L'evento non travolgerà
quindi solo il diretto accusato, ma anche i ragazzi che pagheranno sia in
termini economici che morali. I figli infatti saranno costretti ad affrontare
numerosi viaggi da Napoli, luogo di residenza, fino a Venezia, dove il padre
viene incarcerato. Passananti però riuscirà a vedere per la prima volta la
famiglia solo dopo alcuni mesi di detenzione, a causa di un rallentamento
burocratico.
SONO INNOCENTE. VITO GAMBERALE.
Vito Gamberale. Le ingiuste accuse di
concussione e il racconto della figlia Chiara (Io sono innocente).
Vito Gamberale, le ingiuste accuse di concussione e il racconto della figlia
Chiara su Rai Tre. La storia dell'uomo arrestato e infine assolto dopo anni,
scrive il 6 maggio Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". Arrestato e in
carcere, poi agli arresti domiciliari e infine assolto: le accuse contro Vito
Gamberale, all'epoca amministratore delegato della Sip, riguardavano alcuni
favori richiesti ad una società fornitrice della compagnia telefonica italiana.
Il suo arresto avviene nell'ottobre del '93, quando Gamberale viene trasportato
nel carcere di Poggioreale, in provincia di Napoli, dove trascorrerà 16 giorni.
Il caso di Vito Gamberale verrà approfondito da Sono Innocente nella puntata di
questa sera, domenica 6 maggio 2018, a partire dai dettagli dell'accusa. Secondo
le indagini, l'amministratore delegato della Sip aveva ridotto le commesse della
Ipm, società fornitrice, per via di quattro assunzioni non andate a buon fine e
raccomandate da Giulio Di Donato, all'epoca vice segretario del Psi. L'arresto
di Gamberale precede tuttavia l'interrogatorio di Paolo De Feo, il titolare
dell'Ipm che confermerà un'ora dopo le accuse contro il manager. A questo si
aggiunge anche il fatto che Carmine Meloro, un testimone contro il manager,
ammetterà alcuni giorni dopo ai legali dell'accusato di aver dichiarato il falso
solo per ottenere la libertà. Negli anni successivi, ricorda La Repubblica, si
era ventilata persino l'idea di realizzare una fiction sull'arresto di
Gamberale. Un'ipotesi ostacolata da Giantomaso de Matteis, deciso a rimanere
chiuso nel silenzio, e persino da don Luigi Ciotti. Secondo il prete, da sempre
vicino agli oppressi, la Rai avrebbe rischiato di banalizzare con il prodotto
tutta la vicenda accaduta al manager.
VITO GAMBERALE E L'INGIUSTA DETENZIONE. 290
milioni delle vecchie lire per Vito Gamberale e l'ingiusta detenzione per
l'accusa di concussione. Un risarcimento salato per lo Stato Italiano, che ha
dovuto riconoscere l'innocenza di un uomo che ad oggi è considerato uno dei big
dell'economia italiana. Negli anni successivi alla vicenda giudiziaria infatti,
Gamberale diventerà una figura centrale in Telecom Italia, poi in Autostrade Spa
ed infine anche nel settore delle energie rinnovabili. Una sfida continua che
inizia anche quel giorno in cui si ritrova agli arresti per accuse che
attirarono anche l'attenzione di Oscar Luigi Scalfaro. In quei giorni di
carcere, riferisce don Ciotti, ha cercato personalmente di incontrare Gamberale,
ma la visita gli venne negata. La richiesta era stata mossa da alcuni amici del
sacerdote nel Natale del '93, come racconta a La Repubblica, per permettere al
manager di poter raccontare la propria verità. L'incontro fra don Ciotti e
Gamberale invece avverrà solo in seguito alla scarcerazione dell'uomo, così come
con la figlia Chiara, che non ha mai smesso di supportare il genitore e di
inviargli lettere piene di dubbi e di speranza.
IL RACCONTO DELL'EX AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA
SIP E DELLA FIGLIA CHIARA. La storia di Vito Gamberale verrà raccontata a Io
sono Innocente dalla viva voce dell'ex amministratore delegato della Sip e della
figlia Chiara. Un pilastro della famiglia dell'uomo, duramente colpita per
quanto avvenuto negli anni Novanta. Chiara Gamberale, oggi scrittrice e
conduttrice, ha confidato alle pagine del suo Una vita sottile, il primo romanzo
scritto nel '99, tutto il dolore provato in quei giorni. Le conseguenze
dell'arresto del padre si ripercuoteranno infatti sulla figlia 16enne, quasi
cancellata da una fragilità che ha cercato di sconfiggere con la forza della
determinazione. Vito Gamberale e la figlia Chiara si ritrovano così a vivere la
stessa sofferenza sotto due punti di vista. Per il primo l'arresto rappresenta
un'ingiustizia da combattere, mentre per la figlia si tratta di confrontarsi con
lo spettro della bulimia e dell'anoressia. Sul punto di uccidersi, quanto
vissuto in quei giorni la accompagnerà per tutta la vita. In occasione della
diffusione del film dal titolo omonimo al romanzo e diretto da Gianfranco
Albano, per Chiara Gamberale è stato impossibile non rievocare quei momenti e
soffrire per quel punto di rottura, quel cambiamento che l'ha portata poi a
riconciliarsi con se stessa. Anche per Gamberale l'impatto con il film è stato
forte, come racconta a La Repubblica, soprattutto nel ricordare quanto sia
difficile difendersi quando si è innocenti.
SONO INNOCENTE. CARMINE BELLI.
Omicidio Mollicone, i cinque depistaggi
che hanno "incastrato" Carmine Belli. Il carrozziere
che, in un'intervista a Today.it si definisce 'l'unico str.... di Arce', secondo
le attuali indagini, sarebbe stato volutamente scelto da chi, colpevole della
morte di Serena, ha compromesso e confuso il vero quadro investigativo Omicidio
Mollicone, i cinque depistaggi che hanno "incastrato" Carmine Belli, scrive
Angela Nicoletti il 5 novembre 2018 su Frosinone today. Se Carmine Belli avesse
visto una foto recente di Serena Mollicone (come questa che pubblichiamo qui in
alto ndr) avrebbe evitato dolore, sofferenza e soprattutto l'infamante arresto
con l'accusa di aver assassinato la diciottenne di Arce. Ecco, il primo,
incredibile, assurdo depistaggio del quale il carrozziere di Rocca d'Arce
resterà vittima, sarà proprio la foto della studentessa liceale. Perché i
volantini affissi in tutta la provincia di Frosinone e nelle ore immediate la
sparizione di Serena, mostreranno un'immagine della ragazza diversa e
soprattutto non recente. Belli, una volta appreso dalla sparizione di una
giovane donna e una volta vista la foto del volantino quel giorno di giugno di
17 anni fa, dedusse di aver incontrato Serena e da cittadino onesto decise di
informare gli investigatori. Per l'uomo, come lui stesso dichiara,
'sarà l'inizio della fine...'
Atti e foto "dimenticate". Non solo aver scambiato
una persona per un'altra porterà Belli sulla strada del carcere. Ma anche le
dichiarazioni, si scoprirà poi mai rilasciate, della proprietaria del bar 'Le
Pocchietelle' situato lungo la Statale Valle del Liri ed a poche centinaia di
metri dal luogo dove la diciottenne di Arce viene trovata morta. Per anni si è
creduto che la barista avesse riferito ai carabinieri di 'aver visto Carmine
Belli con Serena Mollicone nel piazzale antistante il locale'. In realtà la
stessa Stefania Bianchi dichiarò sin dai primi interrogatori di non aver visto
la giovane scomparsa insieme al carrozziere ma una donna a lei conosciuta e
residente a Monte San Giovanni Campano simile per aspetto e abiti a Serena.
Qualcuno, volutamente, non prese in considerazione le dichiarazioni della
Bianchi e preferì percorrere la strada dell'assurdo.
I tanti interrogatori. Carmine Belli, nei giorni
successivi al ritrovamento di Serena Mollicone, verrà interrogato dal
maresciallo Mottola ben 18 volte. Nessuno pensò mai, però, di mostrare al
carrozziere una fotografia recente della ragazza uccisa. Al carrozziere viene
mostrata solo e sempre quella del manifestino dove Serena portava capelli lunghi
e ricci ed era più rotonda nei lineamenti del viso. Facendo questo elementare
confronto, la vita di Belli sarebbe rimasta quella di sempre e non avrebbe
trascorso il resto dei suoi anni a doversi giustificare per una colpa non
commessa. Ma chi voleva confondere gli inquirenti e la magistratura ancor prima
di Belli, ha provato a gettare 'ombre' sul padre della povera Serena che
verrà interrogato per ore. Addirittura prelevato dalla chiesa dove si stavano
svolgendo i funerali della ragazza e trattenuto in caserma.
Gli oggetti fantasma. La droga trovata nei
cassetti di casa. Il telefono cellulare della ragazzina che scompare e appare.
Tutti segni di un chiaro intento di voler confondere le acque di una vicenda che
ha dell'incredibile e che ora sembra essere arrivata alle battute finali. Cinque
gli indagati, l'ex comandante della stazione dei Carabinieri, la moglie, il
figlio - accusati di omicidio volontario ed occulatamento di cadavere - e due
carabinieri all'epoca in servizio ad Arce che - ritenuti coinvolti con posizioni
minori compresa l'istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi -, entro
breve, potrebbero correre il rischio di finire sotto processo.
Carmine Belli. Vittima della giustizia,
non un mostro: chi ha ucciso Serena Mollicone? (Io sono Innocente).
Carmine Belli, una vittima della giustizia e non un mostro. Chi ha ucciso Serena
Mollicone? La trasmissione ripercorre i passi con la ricostruzione dell'accusa,
scrive il 6 maggio Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". 17 mesi di carcere
prima che Carmine Belli venisse scagionato dall'accusa di aver ucciso Serena
Mollicone. Una pagina tragica della cronaca italiana che ferma il tempo a quanto
accaduto nel giugno del 2001. A differenza dei sospetti dei familiari, le
indagini degli inquirenti si concentrano ad un certo punto sulla figura del
carrozziere di Rocca D'Arce, in provincia di Frosinone, per via della mancanza
di un alibi che confermasse dove si trovava quella mattina in cui Serena è stata
vista entrare nella Caserma di Arce e non uscirne mai più viva. Sono Innocente
ripercorrerà la vicenda giudiziaria di Carmine Belli, assolto da ogni accusa
grazie al verdetto definitivo della Cassazione, come ricorda La Repubblica,
nella puntata di oggi, domenica 6 maggio 2018. Un verdetto che non ha convinto
il padre della vittima, Guglielmo Mollicone, sempre più convinto invece della
sua colpevolezza. Nel corso del processo, ai suoi occhi Belli avrebbe persino
lasciato intendere di aver avuto nei complici. Ed in questo quadro si affianca
la richiesta dell'accusa che il carrozziere venisse condannato a 23 anni di
detenzione, soprattutto per via di quel famoso bigliettino di proprietà di
Serena che è stato ritrovato nell'officina dell'uomo. Un foglietto in cui la
ragazza aveva segnato la data e l'orario dell'appuntamento con il dentista.
LA RICOSTRUZIONE DELL'ACCUSA A CARMINE BELLI.
La ricostruzione dell'accusa che ha permesso l'incarcerazione di Carmine Belli
inizia dall'abitudine di Serena Mollicone di spostarsi grazie all'autostop.
Sarebbe in questa occasione che la mattina del giugno del 2001 avrebbe
incontrato la ragazza, nell'Isola Liri. Secondo l'accusa il carrozziere avrebbe
inoltre fatto delle avances alla ragazza ed al suo rifiuto avrebbe reagito
colpendola sul volto con un oggetto. Solo in un secondo momento l'uomo avrebbe
ultimato il delitto e si sarebbe sbarazzato del corpo, lasciandolo ormai privo
di vita nel boschetto di Anitrella. Una tesi inesistente agli occhi dei legali
di Belli, che fin dalle accuse che sono state mosse al loro assistito, hanno
evidenziato come non ci fossero prove che confermassero la sua colpevolezza. Una
visione che corrisponde con l'assenza di tracce della vittima nell'auto del
carrozziere, così come le impronte del Belli sul corpo della ragazza e sui
vestiti. A complicare la posizione dell'uomo era stata all'epoca la decisione
dell'ex socio di ritirare la propria deposizione. Come ricorda La Repubblica,
Pierpaolo Tomaselli aveva infatti inizialmente confermato l'alibi di Belli,
indicandolo all'interno dell'officina nell'arco di tempo in cui Serena veniva
uccisa.
UNA VITTIMA DELLA GIUSTIZIA, NON UN MOSTRO. Una
vittima della giustizia e non un mostro. Si è definito così Carmine Belli in
seguito al rilascio atteso per 17 mesi, trascorsi in carcere con l'accusa di
essere l'assassino di Serena Mollicone. Il caso della giovane di Arce ha preso
nuovo vigore negli ultimi tempi grazie alla determinazione del padre della
vittima di non fermarsi e di volere giustizia per la morte della 18enne. Gli
inquirenti infatti hanno abbandonato la pista di Belli seguendone un'altra più
importante, che accende i riflettori sui Carabinieri presenti nella Caserma di
Arce quel triste giorno. Si parla dell'ex Comandante Mottola, del figlio e della
moglie, così come di altri due Carabinieri che erano in servizio quel giorno.
Anche se il carrozziere è stato assolto, la sua preoccupazione è stata invece
cercare di riabilitarsi agli occhi dell'opinione pubblica. Come rivelato a
Storie Vere, Belli spera che siano proprio le nuove indagini ad annullare
qualsiasi dubbio ancora vivo nella comunità in cui vive. Del giorno del suo
arresto, avvenuto nel febbraio del 2003, il carrozziere ricorda la
consapevolezza di aver intuito di essere diventato il capro espiatorio per il
delitto di Serena Mollicone. I primi sei mesi di carcere sono stati
particolarmente duri per Belli, guardato a vista dalle guardie del
penitenziario. Solo in seguito la direttrice gli avrebbe offerto un lavoro
all'interno della struttura.
Delitto di Arce, la perizia del Ris
conferma: "Serena Mollicone uccisa nella caserma dei carabinieri".
I militari hanno analizzato i frammenti di legno recuperati nel corso della
nuova autopsia sul nastro adesivo con cui erano stati bloccati mani e piedi
della diciottenne uccisa nel 2001, scrive Clemente Pistilli il 27 settembre 2018
su "La Repubblica". Serena Mollicone è stata uccisa all'interno della caserma
dei carabinieri di Arce. Al principale sospetto dei magistrati di Cassino,
impegnati a distanza di 17 anni dall'omicidio a far luce sulla morte della
ragazza, è arrivata ora la conferma dai carabinieri del Ris. Gli investigatori
in camice bianco hanno ultimato la perizia sui frammenti di legno recuperati,
nel corso della nuova autopsia effettuata sulla salma della vittima, sul nastro
adesivo con cui erano stati bloccati mani e piedi della diciottenne e si sono
convinti che quel materiale provenisse dai locali appunto della caserma. Il 1
giugno 2001 Serena Mollicone, 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, uscì di
casa per recarsi all'ospedale di Isola Liri e nel primo pomeriggio, rientrata
nel suo paese, sparì. Il corpo della giovane studentessa venne trovato due
giorni dopo da alcuni volontari della Protezione civile in un boschetto di
Anitrella, frazione del vicino Monte San Giovanni Campano, con un sacchetto di
plastica sulla testa, e le mani e i piedi legati. Venne presto indagato un
carrozziere di Rocca d'Arce, con cui la diciottenne si sospettò avesse un
appuntamento, Carmine Belli, ma l’uomo venne prosciolto in via definitiva ed è
ora tra quanti invocano giustizia per Serena. Nel 2008 poi si verificò un altro
episodio misterioso, il suicidio del carabiniere Santino Tuzi, che era tra i
militari presenti in caserma il giorno della scomparsa della 18enne. Un dramma
che ha portato gli investigatori a intensificare le nuove indagini intanto
aperte per cercare di scoprire i colpevoli dell’omicidio. In Procura a Cassino
si sono man mano convinti che la giovane sia stata picchiata a morte, dopo un
violento litigio, all'interno della caserma dell'Arma di Arce, dove si era
recata forse per denunciare strani traffici in paese, che sia stata portata
agonizzante nel boschetto di Anitrella e che, scoperto che respirava ancora, sia
stata soffocata. Un omicidio a cui avrebbe fatto seguito una serie di
depistaggi. Sono stati così indagati, con le accuse di omicidio volontario e
occultamento di cadavere, l'ex comandante della stazione di Arce, il maresciallo
Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna, il luogotenente Vincenzo
Quatrale per concorso morale nell’omicidio e per istigazione al suicidio del
brigadiere Tuzi, e l'appuntato Francesco Suprano per favoreggiamento. Le
indagini dei carabinieri di Frosinone, consegnata anche la perizia dei Ris,
appaiono ormai concluse e a breve il sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo
dovrebbe tirare le somme. Forse l'ora della verità su uno dei peggiori cold case
italiani è giunta.
SONO INNOCENTE. PIETRO MELIS.
Pietro Melis. 18 anni di vita rubata per
il rapimento di Vanna Licheri mai commesso (Io sono innocente).
Pietro Paolo Melis, 18 anni di vita rubata per il rapimento di Vanna Licheri mai
commesso. Su Rai Tre si ripercorrono le tappe di questa storia che ha
dell'assurdo, scrive il 6 maggio Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". Per 18
anni Pietro Paolo Melis è stato considerato il responsabile del sequestro
di Vanna Licheri, la possidente di Abbasanta rapita in Sardegna nel 1995 e mai
più tornata a casa. Il ruolo di Melis per gli inquirenti è chiaro: era lui la
mente del sequestro e per questo la richiesta dell'accusa era di 30 anni di
carcere. Pietro Paolo Melis verrà invece scarcerato nel luglio del 2016 con
formula piena e la sua vicenda processuale verrà raccontata a Sono Innocente
nella puntata di oggi, domenica 6 maggio 2018. Al centro della scarcerazione
immediata richiesta dalla Corte d'Appello di Perugia la contestazione dei
consulenti di parte riguardo alla perizia fonica che incastrava Melis. In
un'intercettazione ambientale, la voce di un uomo collegato al rapimento della
Licheri era stata riconosciuta come quella dell'imputato. Una tesi smontata dai
legali dell'uomo, uscito dal carcere a 54 anni d'età, grazie all'uso di software
particolari. Come ricorda la Nuova Sardegna, la morte di Vanna Licheri sarebbe
avvenuta a pochi mesi dal suo sequestro, nell'ottobre del '95. E' in questo mese
infatti che i rapitori hanno interrotto ogni contatto con i familiari della
donna.
PIETRO MELIS, 18 ANNI DI VITA RUBATA. Pietro Paolo
Melis non potrà più riavere quei 18 anni trascorsi in carcere con l'accusa
ingiusta di aver organizzato il rapimento di Vanna Licheri. Nonostante la
durezza dell'esperienza in penitenziario, l'uomo non ha mai perso la speranza di
poter dimostrare finalmente la propria innocenza, anche se ogni giorno trascorso
dietro le sbarre è apparso sempre più lungo di quanto effettivamente fosse. In
un'intervista a Quotidiano, Melis ha sottolineato di essere felice della
solidarietà e affetto ricevuti da conoscenti e amici in seguito al suo rilascio.
Non si aspettava di poter contare ancora su tante persone. Così come non può
dimenticare come l'arresto lo abbia privato di un momento importante della sua
vita e carriera, dato che in quel periodo stava realizzando dei passi
significativi a livello economico e familiare. Gli è stato impedito di creare
quella famiglia che sognava da tempo, un sogno spezzato che non ha potuto più
inseguire una volta libero. Studia e cura della propria salute sono stati i
salvavita di Melis, che ha cercato di dedicare tutto se stesso all'esercizio
fisico ed a diplomarsi in tessitura. La speranza invece non l'ha mai persa,
anche nei momenti più bui. Anche di fronte alle condanne, una delusione molto
forte che è riuscito a affrontare grazie al sostegno della sorella Rita e degli
avvocati Maria Antonietta Salis e Alessandro Ricci. Sono loro ad aver lottato al
suo fianco per tanti anni perché la verità potesse emergere.
ARRESTATO PER IL RAPIMENTO DI VANNA LICHERI.
Allevatore della provincia di Nuoro, Pietro Paolo Melis aveva 38 anni quando il
dicembre del '98 viene arrestato con l'accusa di essere l'ideatore del rapimento
di Vanna Licheri. La donna era scomparsa da Abbasanta, in provincia di Oristano,
nel maggio del '95 ed in seguito considerata morta anche se il suo corpo non
venne mai ritrovato. Melis non è stato l'unico a finire dietro le sbarre per il
rapimento Licheri: la condanna ha colpito anche Giovanni Gaddone, così come per
il fratello Sebastiano Gaddone e Tonino Congiu, questi ultimi due considerati i
custodi della donna rapita e Salvatore Carta. Uniti nella condanna così come
nella revisione del processo, ricorda La Nuova Sardegna: anche Gaddoni avrebbe
potuto ottenere la libertà in seguito alla scarcerazione di Melis, evento che
tuttavia non è avvenuto. Melis invece è riuscito a dimostrare di non aver mai
conosciuto Vanna Licheri, come affermato fin dall'inizio della sua vicenda
giudiziaria. Così come conosceva solo di vista Gaddone, colui che nel settembre
del '95 avrebbe avuto quella conversazione in auto che avrebbe incastrato
l'allevatore. In un'intervista a Panorama, l'uomo racconta come prima
dell'arresto avesse già ricevuto un avviso di garanzia per il rapimento della
donna e di aver pensato allora che avrebbe potuto chiarire tutto in
Commissariato nell'arco di qualche ora.
Sono innocente. Anticipazioni
13 maggio 2018: Alberto Matano incontra i protagonisti della scorsa stagione.
Ultimo appuntamento con Sei Innocente: Alberto Matano conduce una puntata
speciale incontrando sei protagonisti della scorsa edizione e ripercorrendo la
loro storia, scrive il 13 maggio 2018 Stella Di Benedetto su "Il Sussidiario".
Oggi, domenica 13 maggio, a partire dalle 21.25 su Raitre, Alberto
Matano conduce l’ultimo appuntamento con “Sono innocente”, il programma che
racconta i momenti drammatici vissuti da chi, da innocente, si ritrova ad essere
accusato di un reato che non ha mai commesso. In alcuni casi, dopo anni
trascorsi in carcere, le vittime della legge riescono a riconquistare la libertà
e a riprendersi la propria vita. In altri casi, invece, le vicende si concludono
nel peggiore dei modi. Quella di questa sera sarà una puntata speciale. Alberto
Matano incontra sei protagonisti della scorsa edizione con cui ripercorrerà i
momenti drammatici della loro vicenda svelando quello che è successo nel corso
dell’ultimo anno. Nell’ultima puntata di Sono Innocente, il conduttore Alberto
Matano incontra Giuseppe Gulotta, accusato dell’omicidio di due carabinieri nel
1976 ad Alcamo in provincia di Trapani. Dopo aver trascorso, da innocente, 22
anni in carcere, ha riacquistato la libertà nel 2012 ottenendo un risarcimento
da 6 milioni di euro. Maria Andò, nel 2007, è stata accusata di aver partecipato
ad una rapina insieme ad un ragazzo e di aver ridotto in fin di vita un tassista
di Catania. All’epoca aveva solo 22 anni ed era una studentessa e ha trascorso
in carcere ben nove anni. Alberto Matano, inoltre, incontra Diego Olivieri,
Corrado Di Giovanni, Lucia Fiumberti e Francesco Raiola, anche loro vittime di
una ingiusta detenzione.
SONO INNOCENTE. GIUSEPPE GULOTTA.
Giuseppe Gulotta. 22 anni
in carcere per un tragico errore: a che serve ora il risarcimento?
(Sono Innocente). Giuseppe Gulotta, il muratore di Firenze è stato in carcere
per 22 anni con l'accusa ingiusta di aver ucciso due Carabinieri. Un
risarcimento record e una vita incrinata (Sono Innocente), scrive il 13 maggio
2018 Morgan K. Barraco su "Il Sussiadiario". 6 milioni e mezzo di euro per
risarcire Giuseppe Gulotta, il muratore della provincia di Firenze che è stato
detenuto per 22 anni con l'ingiusta accusa di aver ucciso due Carabinieri. Era
il 1976 quando l'uomo viene costretto a firmare una confessione in cui ammette
il duplice delitto. Una tortura che gli è costata alla fine 33 anni di accuse e
l'etichetta di assassino, oltre che a tutta la sua giovinezza e parte della vita
adulta. La storia di Giuseppe Gulotta verrà raccontata nella puntata di oggi,
domenica 13 maggio 2018, da Sono Innocente, il programma di Alberto Matano sugli
errori giudiziari del nostro Paese. Ed è proprio di questo che si tratta, un
clamoroso errore, uno degli episodi più bui per la Giustizia italiana. Il nome
di Gulotta viene associato alla morte di Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo,
avvenuta in provincia di Trapani a metà degli anni Settanta, come ricorda nel
suo libro Alkamar, scritto a due mani con il giornalista Nicola Biondo. Sono
anni importanti per la storia del nostro Paese, in cui il clima di paura e
violenza vede la Sicilia impegnata in un forte contrasto fra Stato e
criminalità. La decisione del colonnello Giuseppe Russo è di ottenere giustizia
per i due militari uccisi, anche a costo di torture, finte esecuzioni, pestaggi
e molto altro ancora. La macchina da guerra delle autorità si fermerà infine
solo quando Giuseppe Gulotta verrà indicato come colpevole, ma non quella di
Cosa Nostra, che un anno dopo a quegli eventi, metterà fine alla vita di Russo.
UN PERIODO PARTICOLARE NON
SOLO PER IL CARCERE. La vita di Giuseppe Gulotta non finisce solo nel vortice
del carcere, in anni in cui lo Stato e la mafia sono divisi da confini sottili.
Un periodo in cui perdono la vita importanti icone dell'Antimafia, come il
giornalista Mario Francese e molti altri ancora, ma anche in cui i segreti di
Stato nascondono eventi che non devono trapelare e sfuggire al clima di silenzio
che avvolge la Sicilia. Ed è in questo quadro che Peppino Impastato perde la
vita, mentre il Colonnello Russo muove importanti squadroni per torturare chi
potrebbe essere in possesso di importanti informazioni. Fra questi c'è anche
Giuseppe Gulotta, un ragazzo all'epoca appena 18enne e che non riuscirà a
contrastare le torture, le accuse. Come stabilirà la Cassazione diversi decenni
dopo, ricorda Il Fatto Quotidiano, le azioni dei Carabinieri non produrranno
solo una catena di errori giudiziari, ma vedranno alcuni elementi dell'Arma
inventare prove, nascondere altri indizi importanti agli occhi dei giudici. Ed a
farne le spese sarà chi, come Gulotta, non avrà i mezzi per smacchiare il
proprio nome da accuse così pesanti.
LA STRAGE DI ALCAMO: MARINA E
I SUOI COLPEVOLI. La strage di Alcamo Marina vede un crescendo di sospetti che
porteranno alla fine all'arresto e la reclusione di Giuseppe Gulotta, al fianco
di altri giovani del luogo. Inizialmente si pensa ad un intervento delle Brigate
Rosse, sempre più acerbe in quegli anni e forse intenzionate per molti motivi ad
uccidere i due Carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta. A farne le spese
alla fine saranno Gulotta, Giuseppe Vesco, Vincenzo Ferrantelli, Gaetano
Santangelo e Giovanni Mandalà. Solo quest'ultimo e Gulotta tuttavia verranno
condannati all'ergastolo, nonostante ritratteranno la propria confessione subito
dopo. Per parlare di errore giudiziario per il caso Gulotta, sottolinea Oggi, si
dovrà però attendere che l'ex brigadiere Renato Olino ammetta che le confessioni
sono state estorte grazie a torture che prevedono annegamento simulato,
elettroshock e molto altro ancora. Ed anche in quel momento l'allora 18enne sarà
fra i pochi a ritrovarsi per decenni dietro le sbarre, visto che Santangelo e
Ferrantelli emigreranno in Brasile prima della sentenza definitiva, mentre
Mandalà si toglierà la vita in circostanze misteriose nel '98. E forse la beffa
non finisce nemmeno quando finalmente le porte del carcere si aprono e Gulotta
ritrova quella libertà perduta. La richiesta del difensore, l'avvocato Pardo
Cellini, di ottenere 65 milioni di euro per la detenzione ingiusta del suo
cliente, verrà accettata solo in minima parte. 6,5 milioni di euro per chi ha
perso gran parte della sua vita pur essendo innocente.
Ventuno anni
all'ergastolo, era innocente. "Chi mi ridarà la mia vita perduta?".
Giuseppe Gulotta aveva 18 anni quando venne prelevato e portato nella caserma
dei carabinieri di Alcamo come sospettato dell'omicidio di due militari
dell'Arma. Venne picchiato e seviziato per ore finché non confessò quello che
non aveva fatto. Poi ritrattò invano. Il processo nel '90 con la condanna a
vita. Nel 2007, con il pentimento di uno dei carabinieri che parteciparono
all'interrogatorio, il nuovo processo e, oggi, la sentenza: "Non è colpevole. Lo
Stato deve restituirgli libertà e dignità". Dopo 21 anni, 2 mesi, 15 giorni e
sette ore di carcere, Giuseppe Gulotta, adesso cinquantenne, ha ottenuto
giustizia e dignità. Alle ore 17,35 di oggi la Corte d'Appello di Reggio
Calabria dove si è celebrato il processo di revisione, ha pronunciato la
sentenza. Giuseppe Gulotta è innocente, e da oggi non è più un ergastolano, non
è l'assassino che il 26 gennaio del 1976 avrebbe ucciso, assieme ad altri
complici, due carabinieri, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, in un attentato
alla caserma di Alcamo Marina, un paese al confine tra le province di Palermo e
Trapani. "Gulotta non c'entra nulla; abbiamo il dovere di proscioglierlo da ogni
accusa e restituirgli la dignità che la giustizia gli ha indebitamente tolto" ha
detto oggi la pubblica accusa prima che la corte si riunisse in camera di
consiglio per emettere una sentenza di assoluzione che Giuseppe Gulotta
attendeva da troppo tempo. Da quando, 35 anni fa, appena diciottenne, fu
arrestato, condotto in carcere e, più tardi, dopo la durissima trafila dei
diversi gradi processuali, condannato all'ergastolo definitivamente. E con lui
gli altri tre suoi presunti complici: due sono ancora latitanti in Brasile; il
terzo, Giuseppe Vesco, si suicidò in carcere qualche anno dopo il suo arresto.
Ad accusare Gulotta della strage fu appunto Giuseppe Vesco, considerato il capo
della banda, suicidatosi - in circostanze non del tutto chiare - nelle carceri
di ''San Giuliano'' a Trapani, nell'ottobre del 1976. A provocare la revisione
del processo che si è finalmente concluso oggi con l'assoluzione di Gulotta,
sono state le dichiarazioni, molto tardive, di un ex ufficiale dei carabinieri
Renato Olino che nel 2007 raccontò che le confessioni di Gulotta e degli altri
erano state ottenute a seguito di terribili torture da parte dei carabinieri.
Olino, che si era dimesso dal'Arma proprio in seguito alla vicenda di Alcamo,
non aveva retto al rimorso e aveva deciso di dire la verità. Gli altri
carabinieri, oggi quasi tutti molto anziani, hanno fatto qualche ammissione o si
sono rifiutati di rispondere. Ma la giustizia ha trovato elementi sufficienti
per il processo di revisione e per questa assoluzione che, inevitabilmente,
dovrebbe aprire la strada a un congruo risarcimento per gli imputati. Anche per
gli altri due condannati, Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo, fuggiti
all'estero prima che la condanna diventasse esecutiva, ci sarà adesso la
revisione. La notte del 27 Gennaio di quell'anno Carmine Apuzzo (19 anni) e
l'appuntato Salvatore Falcetta, due militari dell'Arma, furono trucidati da
alcuni uomini che avevano fatto irruzione nella piccola caserma di Alcamo
Marina. L'attacco suscitò ovviamente forte impressione in Sicilia e in tutta
Italia. Si puntò sulla pista politica e finirono nel mirino delle indagini
alcuni giovani di sinistra. Pochi giorni dopo venne fermato un giovane alcamese,
Giuseppe Vesco, trovato in possesso di una pistola in dotazione ai carabinieri.
La sua casa venne perquisita e saltò fuori anche l'arma utilizzata per il
delitto. Il giovane, però, si dichiarò estraneo ai fatti affermando soltanto che
aveva avuto il compito di consegnare delle armi. In seguito alle pressioni dei
carabinieri, Giuseppe Vesco cambiò rapidamente la sua versione: condusse gli
inquirenti al luogo in cui erano conservati gli indumenti e gli effetti
personali dei due agenti uccisi (in una stalla di proprietà di Giovanni Mandalà,
un bottaio di Partinico), dichiarò di aver fatto parte del commando che aveva
fatto irruzione nella casermetta e fece il nome dei suoi tre complici: Gulotta,
Ferrantelli e Santangelo. Dopo poco tempo Vesco ritrattò tutto e dichiarò che
quanto da lui affermato era stato ottenuto in seguito di terribili torture.
Nelle sue lettere dal carcere San Giuliano di Trapani descrive minuziosamente il
comportamento dei carabinieri e come erano state estorte le confessioni dei
fermati. Ma pochi giorni prima di essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti,
venne trovato impiccato nella sua cella, con una corda legata alle grate della
finestra, cosa resa abbastanza difficile dal fatto che a Vesco era stata
amputata una mano a causa di un incidente. E proprio a questa vicenda si legano
le confessioni del pentito Vincenzo Calcara, che lascia intravedere una verità
fino ad ora soltanto accennata, ma resa più concreta anche da alcune rivelazioni
in cui si attesta una collaborazione tra mafia e Stato. Calcara avrebbe
affermato che gli venne intimato di lasciare da solo in cella Giuseppe Vesco e
che lo stesso venne ucciso da un mafioso aiutato da due guardie carcerarie.
Anche quanto affermato dal pentito Peppe Ferro libera i quattro dalle gravi
accuse: "Li ho conosciuti in carcere quei ragazzi arrestati... Erano solamente
delle vittime... pensavamo che era una cosa dei carabinieri, che fosse qualcosa
di qualche servizio segreto". Dopo la chiamata di correità di Vesco, Giuseppe
Gulotta fu arrestato e massacrato di botte per una notte intera. La mattina,
dopo i calci, i pugni, le pistole puntate alla tempia, i colpi ai genitali e le
bevute di acqua salata, avrebbe confessato qualunque cosa e firmò un documento
in cui affermava di aver partecipato all'attacco alla caserma. Il giorno dopo,
davanti al procuratore, Gulotta ritrattò tutto e provò a spiegare quello che gli
era successo. Non venne mai creduto, neanche al processo che, nel 1990 lo
condannò in via definitiva all'ergastolo. Poi, nel 2007, la confessione di Olino
e la revisione chiesta e ottenuta dal suo avvocato Salvatore Lauria. Oggi
l'assoluzione. Ma Giuseppe Gulotta ha trascorso gran parte della sua vita in
carcere. Durante un breve periodo di soggiorno si è sposato con la donna che lo
ha sempre "protetto" e che gli ha dato un figlio. Adesso, completamente libero,
andrà a vivere a Certaldo, in Toscana, dove, da quando è in semilibertà, fa il
muratore. "Sono felice di essere stato riconosciuto finalmente innocente. Ma chi
potrà mai farmi riavere la gioventù che ho passato in carcere, chi potrà mai
darmi quegli anni che ho perduto senza potere crescere mio figlio?".
Gulotta, 21 anni all'ergastolo da innocente.
"Ho sempre sostenuto di non avere colpe". Giuseppe
Gulotta è stato condannato all'ergastolo per l'uccisione di due militari ad
Alcamo, nel 1976. Ha pagato questo reato con la propria libertà. Dal 1990 è in
carcere. Negli ultimi mesi del 2007, un ex brigadiere dell'Arma dei Carabinieri,
Renato Olino, membro del nucleo anti-terrorismo di Napoli, che partecipò allora
alle indagini, ha raccontato la sua verità: "Confessò perché lo torturammo".
Assolto dopo aver trascorso ventidue anni di carcere. Giuseppe Gulotta è stato
scarcerato dopo la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che l’ha
ritenuto estraneo alla strage alla casermetta di Alcamo Marina, in Sicilia,
avvenuta il 26 gennaio del 1976. «Aspettavo questo momento da 36 anni» ha detto
Gulotta. L’uomo era stato accusato ingiustamente di essere l’autore della strage
dove morirono due carabinieri diciottenni, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta.
La vicenda di Giuseppe Gullotta è articolata da
una serie di processi. Il primo capitolo l’aveva scritto la Corte d’Assise di
Trapani che aveva assolto l’imputato. La Corte d’Assise di Palermo però, ribaltò
il verdetto e lo condannò all’ergastolo. I legali ricorsero in Cassazione che
annullò quella condanna e trasferì gli atti nuovamente a Palermo, ad altra
sezione. Nuova condanna all’ergastolo per Gulotta. Stessa decisione presero
successivamente le Corti d’Appello di Caltanissetta e Catania, investite da
altri rinvii trasmessi dalla Cassazione. Nel 1990 la sentenza è divenuta
definitiva.
L’imputato non si è mai arreso. I suoi difensori
Baldassarre Lauria e Pardo Cellini hanno cercato e trovato nuovi elementi per
far riaprire il caso. Una prima istanza di revisione del processo presentata a
Messina fu annullata. I legali si rivolsero ancora una volta in Cassazione che
ha accolto la revisione inviando gli atti alla Corte d’Appello di Reggio
Calabria. Al processo i giudici reggini hanno raccolto nuove testimonianze, tra
cui quella dell’ex brigadiere Renato Olino, all’epoca in servizio al reparto
antiterroristico di Napoli che si occupò dell’inchiesta sulla strage. Il
brigadiere ha fatto alcune ammissioni: in particolare ha riferito che ci furono
dei «metodi persuasivi eccessivi» per far «cantare» un giovane Giuseppe Vesco,
che finì con accusare Gulotta. Il pentito Vincenzo Calcara, poi, sentito in
videoconferenza ha dichiarato di aver appreso in carcere dell’estraneità alla
strage di Gulotta. Nella sua requisitoria il procuratore generale Danilo Riva ha
chiesto l’assoluzione dell’imputato. «Spero che anche per le famiglie dei due
carabinieri sia fatta giustizia» ha detto Gulotta, avvicinato dai giornalisti
dopo la sentenza.
Ventuno anni all'ergastolo, era innocente.
"Chi mi ridarà la mia vita perduta?".Giuseppe
Gulotta aveva 18 anni quando venne prelevato e portato nella caserma dei
carabinieri di Alcamo come sospettato dell'omicidio di due militari dell'Arma.
Venne picchiato e seviziato per ore finché non confessò quello che non aveva
fatto. Poi ritrattò invano. Il processo nel '90 con la condanna a vita. Nel
2007, con il pentimento di uno dei carabinieri che parteciparono
all'interrogatorio, il nuovo processo e, oggi, la sentenza: "Non è colpevole. Lo
Stato deve restituirgli libertà e dignità". Dopo 21 anni, 2 mesi, 15 giorni e
sette ore di carcere, Giuseppe Gulotta, adesso cinquantenne, ha ottenuto
giustizia e dignità. Alle ore 17,35 di oggi la Corte d'Appello di Reggio
Calabria dove si è celebrato il processo di revisione, ha pronunciato la
sentenza. Giuseppe Gulotta è innocente, e da oggi non è più un ergastolano, non
è l'assassino che il 26 gennaio del 1976 avrebbe ucciso, assieme ad altri
complici, due carabinieri, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, in un attentato
alla caserma di Alcamo Marina, un paese al confine tra le province di Palermo e
Trapani.
"Gulotta non c'entra nulla; abbiamo il dovere di
proscioglierlo da ogni accusa e restituirgli la dignità che la giustizia gli ha
indebitamente tolto" ha detto oggi la pubblica accusa prima che la corte si
riunisse in camera di consiglio per emettere una sentenza di assoluzione che
Giuseppe Gulotta attendeva da troppo tempo. Da quando, 35 anni fa, appena
diciottenne, fu arrestato, condotto in carcere e, più tardi, dopo la durissima
trafila dei diversi gradi processuali, condannato all'ergastolo definitivamente.
E con lui gli altri tre suoi presunti complici: due sono ancora latitanti in
Brasile; il terzo, Giuseppe Vesco, si suicidò in carcere qualche anno dopo il
suo arresto.
Ad accusare Gulotta della strage fu appunto
Giuseppe Vesco, considerato il capo della banda, suicidatosi - in circostanze
non del tutto chiare - nelle carceri di ''San Giuliano'' a Trapani, nell'ottobre
del 1976. A provocare la revisione del processo che si è finalmente concluso
oggi con l'assoluzione di Gulotta, sono state le dichiarazioni, molto tardive,
di un ex ufficiale dei carabinieri Renato Olino che nel 2007 raccontò che le
confessioni di Gulotta e degli altri erano state ottenute a seguito di terribili
torture da parte dei carabinieri. Olino, che si era dimesso dal'Arma proprio in
seguito alla vicenda di Alcamo, non aveva retto al rimorso e aveva deciso di
dire la verità. Gli altri carabinieri, oggi quasi tutti molto anziani, hanno
fatto qualche ammissione o si sono rifiutati di rispondere. Ma la giustizia ha
trovato elementi sufficienti per il processo di revisione e per questa
assoluzione che, inevitabilmente, dovrebbe aprire la strada a un congruo
risarcimento per gli imputati. Anche per gli altri due condannati, Vincenzo
Ferrantelli e Gaetano Santangelo, fuggiti all'estero prima che la condanna
diventasse esecutiva, ci sarà adesso la revisione.
La notte del 27 Gennaio di quell'anno Carmine
Apuzzo (19 anni) e l'appuntato Salvatore Falcetta, due militari dell'Arma,
furono trucidati da alcuni uomini che avevano fatto irruzione nella piccola
caserma di Alcamo Marina. L'attacco suscitò ovviamente forte impressione in
Sicilia e in tutta Italia. Si puntò sulla pista politica e finirono nel mirino
delle indagini alcuni giovani di sinistra. Pochi giorni dopo venne fermato un
giovane alcamese, Giuseppe Vesco, trovato in possesso di una pistola in
dotazione ai carabinieri. La sua casa venne perquisita e saltò fuori anche
l'arma utilizzata per il delitto. Il giovane, però, si dichiarò estraneo ai
fatti affermando soltanto che aveva avuto il compito di consegnare delle armi.
In seguito alle pressioni dei carabinieri, Giuseppe Vesco cambiò rapidamente la
sua versione: condusse gli inquirenti al luogo in cui erano conservati gli
indumenti e gli effetti personali dei due agenti uccisi (in una stalla di
proprietà di Giovanni Mandalà, un bottaio di Partinico), dichiarò di aver fatto
parte del commando che aveva fatto irruzione nella casermetta e fece il nome dei
suoi tre complici: Gulotta, Ferrantelli e Santangelo.
Dopo poco tempo Vesco ritrattò tutto e dichiarò
che quanto da lui affermato era stato ottenuto in seguito di terribili torture.
Nelle sue lettere dal carcere San Giuliano di Trapani descrive minuziosamente il
comportamento dei carabinieri e come erano state estorte le confessioni dei
fermati. Ma pochi giorni prima di essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti,
venne trovato impiccato nella sua cella, con una corda legata alle grate della
finestra, cosa resa abbastanza difficile dal fatto che a Vesco era stata
amputata una mano a causa di un incidente. E proprio a questa vicenda si legano
le confessioni del pentito Vincenzo Calcara, che lascia intravedere una verità
fino ad ora soltanto accennata, ma resa più concreta anche da alcune rivelazioni
in cui si attesta una collaborazione tra mafia e Stato. Calcara avrebbe
affermato che gli venne intimato di lasciare da solo in cella Giuseppe Vesco e
che lo stesso venne ucciso da un mafioso aiutato da due guardie carcerarie.
Anche quanto affermato dal pentito Peppe Ferro libera i quattro dalle gravi
accuse: "Li ho conosciuti in carcere quei ragazzi arrestati... Erano solamente
delle vittime... pensavamo che era una cosa dei carabinieri, che fosse qualcosa
di qualche servizio segreto".
Dopo la chiamata di correità di Vesco, Giuseppe
Gulotta fu arrestato e massacrato di botte per una notte intera. La mattina,
dopo i calci, i pugni, le pistole puntate alla tempia, i colpi ai genitali e le
bevute di acqua salata, avrebbe confessato qualunque cosa e firmò un documento
in cui affermava di aver partecipato all'attacco alla caserma. Il giorno dopo,
davanti al procuratore, Gulotta ritrattò tutto e provò a spiegare quello che gli
era successo. Non venne mai creduto, neanche al processo che, nel 1990 lo
condannò in via definitiva all'ergastolo. Poi, nel 2007, la confessione di Olino
e la revisione chiesta e ottenuta dal suo avvocato Salvatore Lauria. Oggi
l'assoluzione. Ma Giuseppe Gulotta ha trascorso gran parte della sua vita in
carcere. Durante un breve periodo di soggiorno si è sposato con la donna che lo
ha sempre "protetto" e che gli ha dato un figlio. Adesso, completamente libero,
andrà a vivere a Certaldo, in Toscana, dove, da quando è in semilibertà, fa il
muratore. "Sono felice di essere stato riconosciuto finalmente innocente. Ma chi
potrà mai farmi riavere la gioventù che ho passato in carcere, chi potrà mai
darmi quegli anni che ho perduto senza potere crescere mio figlio?". spettavo
questo momento da 36 anni".
Giuseppe Gulotta, accusato ingiustamente di
essere l'autore del duplice omicidio dei carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore
Falcetta, avvenuto nella casermetta di Alcamo Marina il 27 gennaio 1976, lascia
da uomo libero il tribunale di Reggio Calabria dove dopo esattamente 36 anni dal
giorno del suo arresto (21 gli anni trascorsi in cella) è stato dichiarato
innocente. Un nuovo macroscopico caso di malagiustizia.
"Non ce l'ho con i carabinieri" - Alla lettura
della sentenza, al termine del processo di revisione che si è svolto a Reggio
Calabria, Gulotta è scoppiato in lacrime, insieme alla sua famiglia. Accanto a
lui c'erano gli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini che lo hanno
assistito durante l'iter giudiziario. "Spero - ha dichiarato l'uomo parlando con
i giornalisti - che anche per le famiglie dei due carabinieri venga fatta
giustizia. Non ce l’ho con i carabinieri - ha precisato - solo alcuni di loro
hanno sbagliato in quel momento". "Fatta giustizia
giusta" - Giuseppe Gulotta, nonostante la
complessa vicenda giudiziaria che lo ha portato a subire nove processi più il
procedimento di revisione, non ha smesso di credere nella giustizia. "Bisogna
credere sempre alla giustizia. Oggi è stata fatta una giustizia giusta", ha però
aggiunto. Un ultimo pensiero va all’ex brigadiere Renato Olino, che con le sue
dichiarazioni ha permesso la riapertura del processo: "Dovrei ringraziarlo
perché mi ha permesso di dimostrare la mia innocenza però non riesco a non
pensare che anche lui ha fatto parte di quel sistema".
La vicenda - Il 26 gennaio 1976 furono trucidati
i carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo. Ad accusare Gulotta della
strage fu Giuseppe Vesco, considerato il capo della banda, suicidatosi nelle
carceri di San Giuliano a Trapani, nell'ottobre del 1976 (era stato arrestato a
febbraio). Gulotta, in carcere per 21 anni, dal 2007 godeva del regime di
semilibertà nel carcere di San Gimignano (Siena). Venne arrestato il 12 febbraio
1976 dai militari dell'Arma dopo la presunta confessione di Vesco. Nel 2008 la
procura di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di
sequestro di persona e lesioni aggravate alcuni carabinieri, oggi in pensione,
che nel 1976 presero parte agli interrogatori degli accusati della strage di
Alcamo Marina: il reato contestato agli agenti è quello di tortura nei confronti
degli interrogati.
Venti anni in
galera: Gulotta è innocente.
Le rivelazioni
di un carabiniere: "Confessò perché lo torturammo". Giuseppe Gulotta è in
carcere dal ’90 per l'uccisione di due militari ad Alcamo, avvenuta nel 1976:
"Ho sempre detto delle sevizie. Nessuno mi ha mai creduto".
Era poco
più che maggiorenne, Giuseppe Gulotta siciliano di Alcamo Marina (Trapani),
quando iniziò il suo lungo calvario,
che attraverso nove processi lo ha portato dietro le sbarre con l’accusa di
duplice omicidio per la strage di Alcamo Marina del gennaio 1976. Condannato
all’ergastolo per aver ucciso — in concorso con due complici tuttora latitanti —
due carabinieri trucidati in caserma. Condannato ma innocente. Reo confesso, ma
sotto tortura. L’ha gridata, la sua innocenza, attraverso 14 anni e 9 processi.
Ma inutilmente: l’ergastolo lo sta scontando dal ’90, nel carcere di Ranza di
San Gimignano (Siena). Una speranza si è accesa nell’autunno del 2007,
quando Renato Olino, brigadiere in congedo dei carabinieri del Nucleo
antiterrorismo, che indagò sul duplice omicidio, rivelò al sostituto procuratore
di Trapani che la confessione di Gulotta, effettivamente, fu estorta con la
violenza. Ci sono voluti tre anni di battaglie legali per ottenere la revisione
del processo. Oggi, a distanza di 34 anni dai fatti, la testimonianza di Olino,
sarà ascoltata dai giudici della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria
(cui è stato affidato il nuovo processo).
Gulotta,
che adesso ha 53 anni, in tutto questo tempo si è sempre professato innocente.
Per la sua buona condotta gli è stato concesso anche il regime di semilibertà:
di giorno lavora come muratore a Poggibonsi, quando smonta raggiunge a Certaldo
la sua compagna Michela (dalla quale ha avuto anche un figlio, William di 22
anni), ma a mezzanotte è costretto a tornare in cella.
«Il mio
calvario — racconta — cominciò quel maledetto giorno di molti anni fa quando
insieme ad altri due giovani alcamesi fummo sospettati di aver ucciso
l’appuntato Salvatore Falcetta
e il militare
Carmine Apuzzo che dormivano in caserma. Gli inquirenti che facevano parte di un
commando antiterrorismo di Napoli, mandato apposta per indagare sul caso, ci
arrestarono e ci sottoposero ad un terribile interrogatorio dove ci torturarono
per farci confessare». I tre giovani, tra l’altro accusati dalla testimonianza
di Giuseppe Vesco, un alcamense psicolabile, conosciuto con il nomignolo di
«Peppe ‘u pazzu», davanti al magistrato ritrattarono tutto, ma nessuno li
credette più. Tutti colpevoli, tutti condannati all’ergastolo. L’unico, però,
che ha conosciuto il carcere è stato Gulotta, perché gli altri si sono dati alla
latitanza in Brasile, da dove hanno chiesto inutilmente la grazia.
A distanza
di anni, però, Renato Olino è pronto a raccontare ai giudici gli sconcertanti
retroscena sui metodi utilizzati durante l’interrogatorio
di molti anni fa. Rivelazioni che l’ex carabiniere aveva già fatto al sostituto
procuratore di Trapani nel 2007 e che hanno permesso agli avvocati, Baldassarre
Lauria e Pardo Cellini, di chiedere alla Cassazione la revisione del processo a
carico di Gulotta.
Giuseppe
Gulotta, condannato per la strage della casermetta di Alcamo Marina del 27
Gennaio 1976, in cui furono uccisi barbaramente nel sonno i due militari Carmine
Apuzzo e Salvatore Falcetta, e furono rubate, dopo la strage, armi, munizioni e
divise.
La svolta sulle
indagini avvenne il 13 febbraio. A un posto di blocco fu fermato un giovane
alcamese, Giuseppe Vesco, su una Fiat 127 verde con una targa di cartone
“Trapani 121”. Questi aveva in mano una pistola (si pensa che fosse scarica dato
che il giovane aveva un arto amputato) e dopo una perquisizione ne venne trovata
una seconda. Era una Beretta in dotazione ai carabinieri, probabilmente rubata
durante l’omicidio della casermetta. Dopo una perquisizione a casa del ragazzo e
attente analisi si dimostrò che Vesco era in possesso dell’arma del delitto. Fu
dunque interrogato dai carabinieri ma questi negò in modo deciso la sua
partecipazione all’agguato dicendo che doveva solo consegnare le armi a
qualcuno. Dopo aver negato in tutti i modi la sua partecipazione alla strage
improvvisamente il fermato Vesco cambiò versione.
Vesco fece
ritrovare armi e divise in una stalla di proprietà di Giovanni Mandalà, un
bottaio di Partinico. Vesco confessò di aver partecipato alla strage insieme ad
altri tre ragazzi: Gaetano Santangelo, Giuseppe Gulotta e Vincenzo Ferrantelli.
I tre ragazzi alcamesi più il partinicese Mandalà furono tutti tratti in arresto
per omicidio e costretti a confessare firmando un verbale di riconoscimento di
colpevolezza. La versione accertata dei fatti fu la seguente: Giovanni Mandalà,
il bottaio di trentotto anni di Partinico, avrebbe forzato la porta della
caserma con la fiamma ossidrica e a sparare invece sarebbero stati Giuseppe
Gulotta e Gaetano Santangelo, due giovani alcamesi di diciannove e diciassette
anni, mentre Vincenzo Ferrantelli, uno studente di sedici anni di Alcamo,
avrebbe solo messo a soqquadro le stanze.
30 anni dopo, il
colpo di scena. Negli ultimi mesi del 2007, un ex brigadiere dell’Arma dei
Carabinieri, Renato Olino, membro del nucleo anti-terrorismo di Napoli, che
partecipò allora alle indagini, ha spiegato come si sono svolti veramente i
fatti. Dopo 32 anni dall’accaduto l’ex brigadiere Olino ha affermato chiaramente
che sia a Vesco che agli altri ragazzi accusati, le confessioni furono estorte
con violenza. Vennero messi nelle loro bocche imbuti e versati al loro interno
grossi quantitativi di acqua e sale. Gli accusati furono anche picchiati e venne
usato anche un “telefono da campo” in grado di produrre scariche elettriche per
torturare ulteriormente i fermati. Giuseppe Vesco però aveva dichiarato già nel
1976, dopo aver firmato la sua colpevolezza, di essere stato torturato. Dopo
qualche mese da quel tragico gennaio 1976 Vesco aveva provato anche a scagionare
i presunti complici, purtroppo senza riuscirci. Ma il 26 ottobre del 1976, pochi
giorni prima di essere ascoltato dagli inquirenti: Giuseppe Vesco, nonostante
avesse un arto imputato, viene ritrovato impiccato alle sbarre della finestra
della sua cella. Gli accusati da Vesco, anche loro torturati, subiscono
un’odissea di condanne dopo un iter giudiziario complicato. Ergastolo per il
bottaio Giovanni Mandalà, che avrebbe aperto la porta della caserma con la
fiamma ossidrica e custodito le armi, ergastolo a Giuseppe Gulotta, che avrebbe
sparato, 20 anni a Gaetano Santangelo, che avrebbe sparato anche lui ma allora
minorenne, e 20 anni anche a Vincenzo Ferrantelli, che ha rubato armi e divise
anche lui minorenne. Mandalà è deceduto di morte naturale dopo essersi fatto
diversi anni di carcere, Santangelo e Ferrantelli, tra un appello e l’altro, si
sono rifugiati in un paese del Sudamerica che non ha accordi di estradizione con
l’Italia.
Il brigadiere
Olino s’è presentato spontaneamente nel 2008 davanti al procuratore capo della
Procura di Trapani e ha rivelato che furono mandati in galera degli innocenti.
Gulotta ha chiesto e ottenuto la revisione del processo. Un collaboratore di
giustizia, Leonardo Messina, della famiglia di San Cataldo di Caltanisetta,
soltanto recentemente ha illustrato un’altra verità: quando era in carcere a
Trapani venne a sapere da altri mafiosi di Alcamo che la strage della casermetta
era stato un errore. Era stato stabilito di affidarla ad alcuni affiliati della
famiglia di Alcamo ma poi era stato deciso di che non si sarebbe fatta più. Il
contro-ordine purtroppo era arrivato troppo tardi e la mafia aveva ugualmente
eseguito l’operazione. Perché la mafia doveva eseguire tale strage? Perché Cosa
Nostra aveva pianificato una serie di attacchi allo Stato: era stata decisa una
vera e propria strategia della tensione. Probabilmente accordi segreti tra mafia
e servizi segreti deviati. Un altro mafioso della famiglia di Alcamo, Giuseppe
Ferro, conferma che la strage della casermetta non fu eseguita da quei giovani
accusati e che la mafia questo lo sapeva bene.
Oggi dopo le
rivelazioni di Renato Olino, i magistrati indagano ancora e sono tornati sulle
tracce di GLADIO. La presenza di Gladio è documentata a Trapani negli anni 90
(con l’esistenza del misterioso Centro Scorpione) ma le indagini sulla
casermetta inducono a ritenere che questa a Trapani ci fosse già da molto tempo
prima.
Il 26 gennaio
1976 Apuzzo e Falcetta avrebbero fermato un furgone. Danno l’alt, vogliono
vedere cosa trasporta. La scoperta è incredibile: ci sono tantissime casse piene
di armi e gladiatori della sede trapanese di Gladio. Tutti vengono portati nella
casermetta per il verbale ma Apuzzo e Falcetta vengono uccisi. Un poliziotto del
trapanese ha riferito recentemente alla magistratura che una fonte sicura gli
riferì nel 1993 la vera storia della strage della casermetta: Il furgone fermato
portava armi di Gladio, nella casermetta fu organizzata una messa in scena,
forse i carabinieri furono portati altrove e poi riportati morti all’interno
della caserma. Dagli armadi probabilmente sparì anche qualcos’altro. E per
questo furono uccisi perché non venisse svelata «Gladio» che per vent’anni
ancora sarebbe rimasta segreta, ma forse anche per non far svelare
qualcos’altro… Le rivelazioni dell’ex brigadiere Olino hanno portato sotto
inchiesta i componenti di quel gruppo: Elio Di Bona, Giovanni Provenzano,
Giuseppe Scibilia, Fiorino Pignatella. Chiamati a rispondere davanti al pm
nonostante la conclamata prescrizione si sono avvalsi della facoltà di non
rispondere. Da loro nessuna conferma ma neanche alcuna smentita.
SONO INNOCENTE. MARIA ANDO’.
Maria Andò. Accusata di
rapina e tentato omicidio: a salvarla dei testimoni...
(Sono Innocente). Maria Andò, i testimoni furono decisivi nel salvarla dal
carcere con l'accusa ingiusta per la 22enne di rapina e tentato omicidio. Un
incubo difficile da superare. (Sono Innocente), scrive il 13 maggio 2018 Morgan
K. Barraco su "Il Sussidiario". Maria Andò non potrà mai dimenticare quel giorno
del febbraio 2008, quando i Carabinieri si presentano alla porta della
palermitana 22enne e l'arrestano con l'accusa di rapina e tentato omicidio. Un
mercoledì come tanti forse, ma non per quella ragazza che ha appena superato la
maggiore età e che di certo non si aspetta di ritrovarsi in una cella del
carcere Pagliarelli. Maria Andò è già stata ospite di Sono Innocente, il
programma che ritornerà oggi, domenica 13 maggio 2018, con una nuova puntata. A
distanza di dieci anni da quei nove giorni che trascorrerà in carcere, la donna
ha ancora ben chiaro nella mente come abbia avuto bisogno di 24 ore di tempo
prima di realizzare che cosa fosse successo. 'Quelle poche volte che riesci a
prendere sonno, il risveglio è terribile', riferisce nella sua intervista,
perché è proprio in quel momento che si intuisce come l'incubo sia in realtà una
realtà da cui non si può sfuggire. Anche se alcuni giorni dopo la ragazza verrà
scagionata dalle accuse, Maria non riuscirà mai a ritornare quella di un tempo.
All'interno del penitenziario è finita una persona diversa da quella che poi è
stata liberata, perché 'una volta entrata in contatto con quel mondo, non ne
esci più'. Uno scambio di persona. Sarà questo il vero motivo che spingerà Maria
Andò dietro le sbarre, sei mesi dopo una rapina avvenuta a Catania ai danni di
un tassista che rischierà la propria vita. In seguito all'arresto dell'allora
22enne, le autorità riescono a stabilire che in realtà la ragazza è innocente e
che a picchiare e derubare il tassista sono in realtà due senzatetto che la
vittima conosceva bene. La Andò tuttavia finirà in carcere e in custodia
cautelare a causa di quella sim telefonica che la sorella aveva regalato al
fidanzato della palermitana, oltre ad una descrizione. L'autrice
dell'aggressione fatta al tassista verrà infatti identificata come Maria Andò,
nonostante le somiglianze siano davvero esigue, solo il taglio di capelli come
ricorderà in seguito la siciliana a Sono Innocente. E la sua fortuna alla fine
sono state le testimonianze a suo favore, sottolinea Meridiano News, quella
dello zio che era andata a trovare nei momenti in cui a diversi km di distanza
avveniva la rapina, una collega dell'università e persino la madre a cui aveva
fatto visita quello stesso pomeriggio.
MARIA ANDO', I TESTIMONI LA
SALVANO DALL'INCARCERAZIONE. Saranno i testimoni a salvare Maria
Andò dall'incarcerazione ingiusta e dalle accuse da cui verrà prosciolta nel
2009, a distanza di quasi due anni dalla rapina che le è stata attribuita. La
palermitana alla fine è stata scagionata anche dalla confessione dei due giovani
che hanno quasi ucciso il tassista rapinato, lo stesso che li aveva preso a
cuore ed a cui ogni tanto dava qualcosa da mangiare. Le indagini alla fine
proseguiranno anche mentre la Andò si trova in carcere, sottolinea Il Corriere
della Sera, riuscendo alla fine a risalire ad una minorenne senzatetto. E ciò
che la palermitana invece non riesce ancora a spiegarsi, oltre allo scambio di
persona, è come mai sia stata oggetto di misura cautelare nonostante la rapina
fosse avvenuta sei mesi prima del suo arresto. Un arco di tempo in cui avrebbe
potuto fuggire, nascondersi e non di certo rimanere nella sua Palermo. Ed a
questo si aggiunge anche l'incredulità di aver dovuto pagare come innocente,
nonostante fosse incensurata, mentre chi ha promosso un errore giudiziario di
quello stampo non abbia dovuto invece pagare per il proprio errore.
UN INCUBO DAL PESO INDICIBILE.
Maria Andò entra subito sotto shock quella mattina in cui, aprendo la porta, si
ritrova di fronte i Carabinieri. Segue un incubo dal peso indicibile, a causa
delle accuse di aver rapinato e quasi ucciso un autista di Catania. La ragazza è
incredula di fronte a questo evento, specialmente perché non si è mai sposata da
Palermo e non capisce come possano associarla ad un crimine simile. Nello stesso
giorno viene inoltre arrestato il ragazzo che in coppia con lei avrebbe commesso
lo stesso reato, ma che dirà solo giorni più tardi di aver in realtà collaborato
con una minorenne senzatetto. A dirigere gli investigatori verso Maria Andò,
ricorda La Repubblica, è una sim card che la sorella Federica aveva regalato due
anni prima al fidanzato della palermitana, mentre svolgeva il servizio militare
a Catania. In quel periodo, il giovane deve evidentemente aver contattato
l'autista, dato che quel numero di telefono verrà ricavato dai tabulati
telefonici della vittima di rapina. Ed anche se Maria non assomigliava in tanti
punti alla ragazza descritta dal tassista aggredito, i Carabinieri riusciranno
ad individuare una vecchia fototessera in cui la sospettata assomiglia vagamente
alla rapinatrice. A nulla servirà, ricorda il padre Carlo Andò, che le autorità
verifichino che la ragazza è una studentessa regolare di Giurisprudenza e non
una clochard, come l'aveva già indicata il tassista.
SONO INNOCENTE. DIEGO OLIVIERI.
Diego Olivieri. In carcere,
isolato, in condizioni precarie: 5 anni per essere scagionato! (Sono Innocente).
Diego Olivieri, cinque anni da attendere per la giustizia. L'accusa ingiusta di
narcotraffico e un incubo iniziato nell'ottobre del 2007 alle 4 di mattino.
(Sono Innocente), scrive il 13 maggio 2018 Morgan K. Barraco su "Il
Sussidiario". Diego Olivieri ha dovuto attendere cinque anni prima di essere
riconosciuto come innocente dall'accusa di narcotraffico. Un incubo iniziato
nell'ottobre del 2007, attorno alle 4 del mattino: è questo l'orario che i
Carabinieri di Arzignano, in provincia di Vicenza, scelgono per arrestare il
mediatore di pellame. Una famiglia quasi perfetta, una casa creata con la fatica
di una vita, una barca per coltivare la sua passione per il mare e figli a
dargli tante soddisfazioni. Tutto svanito nel giro di pochi minuti, quando il
commerciante diventa da rispettabile ad ex cittadino modello. Il caso di Diego
Olivieri verrà raccontato a Sono Innocente nella puntata di oggi, domenica 13
maggio 2018, a partire da quei tragici momenti. Attimi in cui viene accusato di
riciclaggio, narcotraffico, associazione mafiosa e insider trading, come ricorda
Il Corriere del Veneto. Minuti che diventano ore e un fiume di domande a cui non
sa rispondere, come riferirà in seguito alla stampa. A peggiorare la situazione
la sua impossibilità a trovare risposte alle domande sempre più incalzanti e che
lo spingono a rimanere in silenzio, figurando così persino omertoso. Il tutto si
conclude con il trasporto a Rebibbia, dove trascorrerà quattro mesi, e poi al
San Pio X per via di quell'accusa fatta da un pentito, che lo indica come il
principale attivista in fatto di droga. Un'attività che tra l'altro riuscirebbe
a gestire grazie alla facciata di vendita di pellame, in cui nasconderebbe della
droga. Per Olivieri, che su consiglio di un amico deciderà infine di fingere con
gli altri detenuti che le accuse siano fondate, solo per riuscire ad evitare
altri guai.
DIEGO OLIVERI, IL CARCERE NEL
CARCERE. Il carcere nel carcere è la sezione a cui viene destinato Diego
Olivieri in seguito al suo arresto, un settore angusto, fatto di sporcizia e
poca illuminazione. Una situazione indescrivibile in cui al neo detenuto è
possibile solo usufruire di quelle due ore d'aria concesse al giorno,
nell'impossibilità di usare la palestra o gli altri luoghi comuni. Solo 4 ore al
mese per le visite dei familiari e urla continue, che a volte indicano solo la
protesta dei carcerati, altri invece precedono quei tentativi di suicidio che
'sono all'ordine del giorno', come sottolinea a Il Corriere della Sera. Diego
Olivieri verrà considerato parte integrante del narcotraffico, l'ultimo anello
che lo collegherebbe a Nick Rizzuto e Vito Don, per cinque anni in tutto e tre
processi durissimi da sostenere. Solo allora i giudici si pronunceranno con un
verdetto favorevole, sicuri che sia innocente perché il fatto non sussiste, ma
nel frattempo il commerciante ha già vissuto un anno dietro le sbarre. Obbligato
a rimettersi in piedi a 65 anni, età che aveva al momento del rilascio, e con
l'obbiettivo di usare i soldi di risarcimento per ingiusta detenzione per
realizzare un ospedale in Tanzania. Ed oggi che il suo incubo è finalmente
finito, può affermare con certezza che l'indulto possa essere utile solo se
associato ad una totale rivoluzione del sistema carcerario. Fatto di
rieducazione e lavoro perché "anche il criminale più incallito può essere
recuperato".
OGGI A ME, DOMANI A CHI? Lo
scorso aprile Diego Olivieri ha presentato nella provincia di Cosenza il suo
Oggi a me domani a chi?, il libro in cui racconta nei dettagli l'esperienza
vissuta in carcere fra il 2007 ed il 2008. Un appuntamento previsto nel
programma di Aprile d'autore, una rassegna organizzata con il patrocinio del
Comune di Diamante. Un'avventura inverosimile quella del commerciante di
pellame, accusato ingiustamente di essere colluso con la mafia e di sfruttare
l'azienda per promuovere attività di narcotraffico e riciclaggio, come ricorda
Cosenza Post. Un'accusa gravissima, che ha spinto Olivieri a vivere
un'esperienza ancora più traumatica, dato il sospetto di affiliazione con i
vertici della mafia. Per questo, per le misure di sicurezza, verrà rinchiuso in
isolamento per diversi mesi. La libertà gli verrà restituita solo un anno dopo
il giorno del suo arresto, con una sentenza che la Cassazione dichiarerà
irrevocabile. Ed ora che quella pagina di vita è stata girata per fare spazio ad
una nuova esistenza, Diego Olivieri non dimentica il passato e si è attivato per
mantenere la promessa di aiutare la popolazione grazie ad un'associazione di
solidarietà. Futuro per tutti è infatti la Onlus che lo vede come presidente e
che ha finanziato lo scorso aprile la spedizione di letti, materassi, mobilio,
ventilatori, divise sanitarie, macchine per la fisioterapia e molti altri
strumenti utili per migliorare l'esistenza dei ragazzi del Ghana, per una catena
di solidarietà a cui si sono uniti anche diversi istituti pubblici e privati del
Trevigiano, come ricorda Treviso Today.
SONO INNOCENTE. CORRADO DI GIOVANNI.
Corrado Di Giovanni.
Tradimento dell'amico e tentato omicidio: per due bugie perde la libertà (Sono
innocente). Corrado Di Giovanni, il tradimento di un amico e una colpa non
commessa. Una tragica storia fatta di bugie e di una scoperta incredibile una
volta finito in carcere. (Sono innocente), scrive il 13 maggio 2018 Morgan K.
Barraco su "Il Sussidiario". La libertà è il prezzo che dovrà pagare Corrado Di
Giovanni per una colpa che non ha commesso. Il rappresentante di vernici di 49
anni, residente a Rivarotta di Pasiano, verrà infatti accusato di essere un
rapinatore. Un'impronta pesante che lo porterà in poco tempo non solo in
carcere, ma anche a perdere il posto di lavoro che con tanta fatica è riuscito a
portare avanti con successo. Di Giovanni è considerato una delle punte di
diamante dell'azienda per il Nord Est, dove riesce ad ottenere contratti con
diversi clienti importanti e benestanti. Corrado Di Giovanni ripercorrerà la
propria storia grazie alla puntata di Sono Innocente di oggi, domenica 13 maggio
2018, a distanza di un anno dal suo primo racconto al programma di Alberto
Matano. Nelle parole del rappresentante i ricordi di quella bella vita
conquistata con successo e fatica e la successiva distruzione, dovuta all'accusa
di essere la talpa di una banda di rapinatori che hanno preso di mira le ville
di alcuni suoi clienti. Siamo nel 2012, ricorda il programma di Rai 3, quando
l'industriale Graziano Zucchetto di Pramaggiore viene rapinato da un gruppo di
malviventi. Una rapina sanguinosa, come sottolinea l'imprenditore a Il
Gazzettino, in cui rischia di perdere la vita e da cui riesce a salvarsi solo
grazie ad un evento fortuito. La pistola si inceppa e Zucchetto riesce a
salvarsi dalla furia dei tre albanesi che lo prendono a calci e pugni. Solo in
seguito le indagini condurranno fino a due italiani, di cui uno verrà
identificato come Di Giovanni, il migliore amico della vittima.
CORRADO DI GIOVANNI, IL
TRADIMENTO DI UN AMICO. Tradito da un amico: sarà questo che penserà di Corrado
Di Giovanni l'industriale Graziano Zucchetto. Quest'ultimo viene infatti
rapinato da un gruppo di criminali e non immagina che nei giorni successivi, gli
inquirenti si concentreranno su quel rappresentante di vernici della provincia
di Venezia con cui ha stretto da anni un forte legame di amicizia. In quei
giorni infatti, Zucchetto non viene informato dello sviluppo delle indagini e
scoprirà solo in seguito dell'arresto di Di Giovanni, un evento che lo lascia
nel totale stupore. 'Agghiacciante', sottolinea all'epoca a Il Gazzettino, 'una
persona che consideravamo di famiglia'. Non sarà tuttavia solo la rapina a
Zucchetto a provocare l'arresto ingiusto di Corrado Di Giovanni, ma anche una
serie di colpi ai danni di diversi dei suoi clienti più importanti. Al momento
dell'incontro con gli investigatori, il rappresentante conferma infatti di
conoscere tutti i nomi che gli vengono elencati senza che gli venga spiegato che
cosa sta succedendo, mentre i Carabinieri perquisiscono la sua abitazione,
setacciano ogni punto, scattano diverse foto. Per Zucchetto invece in seguito
non ci saranno dubbi sulla colpevolezza dell'amico, visto che i rapinatori erano
a conoscenza di troppi particolari. Sapevano infatti che la cassaforte si trova
in un locale isolato dal cemento armato, come riferisce alla stampa la moglie
della vittima, Barbara. Ed è anche per quel particolare che la donna non si
accorge in quei momenti di quanto sta avvenendo al piano di sotto né che il
marito rischia di perdere la vita.
UNA TRAGICA VERITÀ SCOPERTA IN
CARCERE. Corrado Di Giovanni impiegherà diversi giorni prima di realizzare
quanto siano pesanti le accuse che gli sono state mosse per errore. Il suo nome
infatti verrà indicato come capo di una banda di rapinatori, di cui fa parte
anche il cugino Massimo Di Giovanni e tre uomini di origini albanesi, ma il
diretto interessato lo scoprirà solo una volta rinchiuso in carcere. A
compromettere la posizione di Di Giovanni sono i rapporti di lavoro intrecciati
con le vittime, fra cui l'amico Graziano Zucchetto, con cui ha cercato per
diversi giorni di mettersi in contatto inutilmente. Come ha raccontato a Sono
Innocente, in quegli attimi Di Corrado è sicuro che verrà scarcerato nel giro di
poche ore, al limite giorni, e sarà invece il suo difensore a renderlo
consapevole che le accuse sono davvero tragiche. Dalla rapina al furto fino al
tentato omicidio. Per Di Corrado si tratta di una vera e propria doccia fredda e
continuerà ad essere così anche nei 14 mesi che trascorrerà in custodia
cautelare, a cui si aggiungerà un altro mese agli arresti domiciliari. Solo al
processo di primo grado, il rappresentante verrà assolto dalle accuse e la
conferma arriverà in Appello nel 2014. Solo in seguito Zucchetto deciderà di
parlare a favore dell'amico di un tempo, sottolineando che in realtà il
rappresentante è stato nella sua villa due volte in tutto e non molte volte come
indicato dagli investigatori nel fascicolo d'accusa. Ed a nulla invece sono
servite le testimonianze dei rapinatori, che durante l'interrogatorio
affermeranno più volte di non aver mai conosciuto, visto o sentito parlare di Di
Giovanni. E infine la beffa: il risarcimento di 516 mila euro richiesti dal
difensore dell'ex rappresentante, ormai senza lavoro come il figlio, non è mai
stato accordato dallo Stato. Ed è per questo, riporta Il Gazzettino, che Di
Giovanni ha presentato ricorso a Roma per riuscire finalmente ad ottenere ciò
che è suo di diritto.
SONO INNOCENTE. LUCIA FIUMBERTI.
Lucia Fiumberti. A 28 anni
usata e incastrata dai suoi superiori della Provincia di Lodi (Sono Innocente).
Lucia
Fiumberti, la donna nel 2007 finì in carcere perché usata dai suoi superiori
come capro espiatorio di un crimine che non aveva effettivamente commesso. (Sono
Innocente), scrive il 13 maggio 2018 Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". Sono
trascorsi 11 anni da quel marzo del 2007 che ha spinto Lucia Fiumberti dietro le
sbarre. Di origine comasca ed ex dipendente della provincia di Lodi, la donna
verrà ritenuta responsabile a causa delle accuse dei suoi superiori, che
decidono di usarla come capro espiatorio. In quei giorni, l'allora 28enne si
trovava in ferie dal lavoro e non sospetta che le verrà attribuita dai dirigenti
della Provincia una firma che concede l'autorizzazione ad una conceria di
rinviare una bonifica da cromo piuttosto costosa. Il caso di Lucia Fiumberti
verrà ricordato dal conduttore Alberto Matano all'interno della puntata di Sono
Innocente di oggi, domenica 13 maggio 2018. La donna non sa quanto quelle
meritate ferie le costeranno la reclusione in carcere per 22 giorni, accuse che
rientreranno in un'indagine che la Procura sta facendo su una concessione
promossa dalla Provincia di Lodi per cui lavora. Anche se il castello di carte
costruito ad arte dai superiori di Lucia verrà demolito in breve tempo, il
carcere rimarrà un'esperienza traumatica per la sua giovane vita e provocherà il
cambio radicale di settore professionale. Ad oggi, ricorda Il Giorno, Lucia ha
infatti messo da parte la laurea con lode ottenuta in Tecnologia farmaceutiche
per proseguire la sua carriera nella provincia di Como, in qualità di estetista.
Un lavoro che ha deciso di intraprendere subito dopo il licenziamento senza
preavviso che ha posto fine al suo lavoro di consulente ambientale per la
Provincia di Lodi. E quanto è accaduto, l'errore giudiziario di cui è rimasta
vittima, continua ad essere il motore che la spinge a raccontare la sua storia
senza sosta. Un riscatto conquistato con fatica e sudore, un calvario che è
stato raccontato anche dal regista Francesco Del Grosso nel suo film
documentario Non voltarti indietro, così come nel libro che ha scritto grazie
all'editore Albatros nel 2010, dal titolo Fuori e dentro.
LUCIA FIUMBERTI, QUEL VOLTO
PIENO DI CANDORE
Persino il Carabiniere che
l'ha arrestata non ha potuto fare a meno di notare il candore sul volto di Lucia
Fiumberti. Quasi 28 anni che avrebbe compiuto pochi giorni dopo il suo arresto
ed una pesante accusa che grava già sulle sue spalle. La consulente ambientale
viene infatti indicata come la responsabile di una firma finita nell'inchiesta
delle autorità ai danni della Provincia di Lodi per cui lavora. E' il 2007
quando Lucia si ritrova di fronte sette Carabinieri alle 4 del mattino, pronti a
prelevarla per portarla nel carcere di San Vittore. Un incubo che durerà 22
giorni di detenzione, chiusa in una cella e accusata di aver falsificato una
firma importante. Due dirigenti della Provincia a cui fa capo hanno infatti
negato la propria responsabilità, preferendo scaricare ogni colpa su quella
giovane che collabora con loro da cinque anni. E la storia di Lucia Fiumberti
non finisce quando viene finalmente dichiarata innocente perché, come ricorda
Unione Sarda, sarà destinata a rivivere tutto quando Claudio Samarati, il suo
principale accusatore, riuscirà quasi a sfuggire alle sue responsabilità grazie
alla prescrizione.
Per questo che Lucia decide di
scrivere ai giornali italiani, convoca Le Iene perché non si dimentichi quanto
ha dovuto vivere e soprattutto il colpevole non riesca a farla franca,
regalandole un'ingiustizia all'interno di un errore giudiziario. Di quel giorno
in cui è finita in manette, virtuali grazie alla decisione di un Carabiniere di
lasciarle libere le mani, Lucia ricorda ogni particolare. Da quel sonno che la
vede al fianco del compagno alle 4 del mattino fino al brutale risveglio in cui
impiega diversi minuti prima di capire che cosa stia accadendo. Il primo
pensiero è che si tratti di un errore, mentre scandaglia con la mente qualsiasi
tipo di errore possa aver compiuto. La realtà dei fatti le verrà spiegata solo
al suo arrivo in caserma, quando le verrà finalmente riferito perché è stata
accusata.
SONO INNOCENTE. FRANCESCO RAIOLA.
Francesco Raiola. Arrestato
per traffico di stupefacenti: stesso calvario di Enzo Tortora (Sono Innocente).
Francesco Raiola, arrestato ingiustamente per traffico di stupefacenti il suo
caso somiglia moltissimo a quello che colpì diversi anni prima il giornalista
Enzo Tortora. (Sono Innocente), scrive il 13 maggio 2018 Morgan K. Barraco su
"Il Sussidiario". Quanto accaduto a Francesco Raiola è stato considerato negli
anni come il nuovo caso Tortora, per via dell'assurdità con cui è stato accusato
ed ha dovuto pagare con il carcere e con la vita per un errore che non ha mai
commesso. Il soldato Raiola, come viene indicato nel 2011, quando dovrà scontare
21 giorni di carcere per l'accusa di ricettazione e traffico di stupefacenti.
Sono Innocente ripercorrerà la storia di Francesco Ragiola grazie alla puntata
che andrà in onda questa sera, domenica 11 maggio 2018, partendo da quel
fatidico giorno. Perché è lì che il militare subisce un calvario che lo spingerà
a stare 4 giorni in cella di isolamento presso il penitenziario di Santa Maria
Capua Vetere, ritrovando la libertà solo due settimane più tardi e dimostrando
la propria innocenza dopo 4 mesi di arresti domiciliari. Ed anche se verrà
scagionato dalle accuse, perderà la possibilità di rientrare in servizio, un
reintegro in cui verrà affiancato anche al Movimento 5 Stelle. Il partito
produrrà infatti atti parlamentari per ottenere dei risultati concreti,
riuscendo a far inserire un articolo nel Decreto legge che prevede la
riammissione per tutte le vittime di errori giudiziari.
FRANCESCO RAIOLA E I PUNTI IN
COMUNE COL CASO ENZO TORTORA. Il caso di Francesco Raiola ha fin troppi punti in
comune con l'errore giudiziario che ha colpito il giornalista Enzo Tortora. A
partire dalle calunnie fabbricate ad arte per produrre le accuse che porteranno
il militare dietro le sbarre, fino alle intercettazioni che per la procura di
Torre Annunziata indicano con chiarezza la sua attività di trafficante di droga.
Il militare infatti, come racconta a Il Giornale, parla di kg di mozzarelle che
per gli inquirenti si trasformeranno in un preciso quantitativo di droga. Raiola
finisce così all'interno dell'inchiesta Alieno ed infine nel carcere per quasi
un mese, un incubo da cui riuscirà a fuggire solo quando il giudice di Nocera
Inferiore eredità il caso dalla procura di Torre Annunziata e si accorge
dell'errore commesso. Il militare non verrà così portato fino al processo, ma
rimarrà l'onta delle accuse, almeno per quanto riguarda la sua carriera militare
ormai distrutta. Ed ancora. Con Tortora ci sarà in comune anche quel pm che
nell'85 vedrà il presentatore al pari di un mercante di morte e che individuerà
in Raiola un chiaro criminale. Diego Marmo non sarà solo cruciale nella vita di
entrambi gli innocenti, ma rimarrà anche impresso nella memoria della vedova
Tortora. Francesca Scopelliti riferirà infatti in un'intervista a Mary
Tagliazucchi, di ricordare con chiarezza le bretelle rosse del pm, i toni
esasperati.
L'ACCUSA PER TRAFFICO DI
STUPEFACENTI. Francesco Raiola riuscirà a dimostrare la propria innocenza dopo
essere stato accusato di traffico di stupefacenti e ricettazione di droga. Non
riuscirà però a riavere quel lavoro di militare che aveva ottenuto con tanti
sacrifici, una porta che rimarrà chiusa a lungo anche di fronte alla conferma
che le accuse che gli sono state rivolte sono in realtà un errore giudiziario.
Ed è per questo che Raiola non si arrende e decide di rivolgersi persino al
Presidente della Repubblica per riuscire a cancellare anche quella conseguenza
dell'arresto promosso dal pm Diego Marmo, lo stesso che arrestò diversi decenni
prima Enzo Tortora. Il sogno che il militare ha coltivato per una vita,
riuscendo a realizzarlo grazie ad un concorso per entrare nell'Esercito
italiano, si infrangerà infatti quel giorno in cui i Carabinieri decideranno di
arrestarlo. Nella puntata di Sono Innocente in cui ha raccontato la sua storia
per la prima volta, il militare ripercorre ogni istante della notte del suo
arresto. E' il Maresciallo superiore ad informarlo della presenza dei
Carabinieri, ma in quel momento Raiola pensa che sia successo in realtà qualcosa
ai familiari. Solo dopo, con in mano 'un faldone di 1200 pagine', inizierà a
realizzare che non si tratta di una tragedia avvenuta alla famiglia oppure uno
scambio di persona come penserà inizialmente. Lo stesso faldone servirà nella
Caserma di Barletta per informarlo dei diversi punti presi in esame nel corso
delle indagini di Castellamare di Stabia, in particolar modo le telefonate
intercorse fra Raiola ed un vecchio amico. Si tratta di un uomo che conosceva da
diverso tempo e con cui poco prima aveva riallacciato i rapporti, non sapendo
che le autorità erano già sulle sue tracce con il sospetto di spaccio di droga.
SONO INNOCENTE. GUIDO BERTOLASO.
Bertolaso è innocente,
chiedetegli scusa: assolto dopo 8 anni di gogna.
Condannati Anemone e l'ex Provveditore Balducci. Per gli appalti super Guido
"assolto perché il fatto non sussiste", scrive Augusto Parboni su "Iltempo.it"
il 9 Febbraio 2018. «È una corruzione 2.0». Così l’hanno considerata gli
stessi magistrati che hanno chiesto e, in parte, ottenuto, la condanna di chi è
stato coinvolto nell’inchiesta G8 della Maddalena. A uscire invece indenne dal
processo, l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso «perché il fatto
non sussiste». Ma non finisce qui. Nel verdetto dei giudici dell’ottava sezione
del tribunale di Roma ci sono state anche prescrizioni del reato. Insomma,
quella di ieri è stata una sentenza che ha fatto luce su un presunto sistema
corruttivo che ha coinvolto personaggi politici e istituzionali, che a
differenza delle posizioni processuali, hanno ottenuto decisioni differenti. I
giudici hanno emesso quattro condanne e una dozzina tra assoluzioni e
prescrizioni nel processo romano legato agli appalti del G8 della Maddalena.
Riabilitato dopo il fango:
Bertolaso assolto per il G8.
Completamente scagionato
"perché il fatto non sussiste". Ma il processo distrusse la Protezione civile,
scrive Patricia Tagliaferri, Venerdì 09/02/2018, su "Il Giornale". Lui, l'uomo
delle emergenze, colui che accorreva dove c'era pericolo e risolveva i problemi,
ha dovuto convivere per otto anni con l'accusa di essere un corrotto, uno che
favoriva gli amici imprenditori negli appalti, talvolta anche solo per un
massaggio a luci rosse. Nulla di tutto ciò è mai accaduto. Solo fango. Un
calvario contro il quale Guido Bertolaso, un medico prima di essere funzionario
di Stato, ha combattuto per la sua dignità e per quella della Protezione civile
che ha guidato tanti anni e che dopo di lui non è stata più la stessa. Fino a
ieri, quando il Tribunale di Roma lo ha completamente riabilitato assolvendolo
con formula piena, «perché il fatto non sussiste», nonostante la Procura di Roma
avesse sollecitato la richiesta di prescrizione. «Questo vale come una doppia
assoluzione - ha commentato su Facebook - grazie alla mia famiglia e a chi mi è
stato vicino in questi anni. Sono innocente, come ho sempre detto. Ora lo hanno
dichiarato anche i giudici». L'ex capo della Protezione civile, dunque, non
faceva parte della cosiddetta «cricca», per usare le parole del gip Rosario
Lupo, composta da un gruppo di imprenditori e pezzi delle istituzioni, che
operava «in un sistema gelatinoso» ed era capace di condizionare i maggiori
appalti degli ultimi anni, dai Mondiali di nuoto a Roma del 2009 al G8 della
Maddalena (poi trasferito a L'Aquila), fino alle celebrazioni per i 150 anni
dell'Unità d'Italia. La seconda assoluzione per lui, dopo quella per l'accusa di
omicidio colposo nel processo Grandi Rischi bis per il terremoto del 2009.
Bertolaso l'ha festeggiata creando un gruppo WhatsApp chiamato «assolto», che
ieri in poche ore ha raccolto centinaia di messaggi, congratulazioni e attestati
di stima da parte di amici, parenti e collaboratori. «Questa assoluzione
certifica che questo processo non doveva neanche cominciare, resta il rammarico
che si sono dovuti attendere otto lunghi anni nel corso dei quali si è messa
fuori campo una persona che certamente costituisce una risorsa per il Paese», ha
commentato il suo avvocato, Filippo Dinacci. Oltre a quella di Bertolaso ci sono
state una decina di assoluzioni e prescrizioni, ma anche quattro condanne per
associazione a delinquere per i capi della «cricca»: sei anni e sei mesi per
l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci, sei
anni per il costruttore romano Diego Anemone, quattro anni e sei mesi per l'ex
provveditore opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis e quattro anni per
l'ex generale della Finanza Francesco Pittorru. L'inchiesta è nata alla Procura
di Firenze, dalle indagini sulla costruzione della nuova Scuola Marescialli, e
poi è stata trasferita prima a Perugia e poi a Roma per competenza. Secondo i
magistrati c'erano Balducci ed Anemone, ai quali veniva contestata la corruzione
e l'associazione a delinquere, al centro del gruppo che con favori e denaro si
aggiudicava gare milionarie. «Una sorta di corruzione 2.0», aveva detto il pm
nella requisitoria parlando di una rete fatta di «rapporti illeciti con soggetti
di alto profilo istituzionale». Ma non tutto l'impianto accusatorio ha retto.
Anche l'ex commissario straordinario ai Mondiali di nuoto Claudio Rinaldi e l'ex
funzionaria alla presidenza del Consiglio Maria Pia Forleo sono stati assolti.
Prescritta invece la posizione di Daniele Anemone, fratello di Diego.
«Soddisfatti» anche gli avvocati di Rinaldi, Nicola Madia e Livia Lo Turco.
Bertolaso assolto dopo anni
di sofferenze, perché Mattarella non gli telefona? Mattarella chiami Bertolaso,
scrive Pietro Mancini su Affari Italiani Venerdì 9 febbraio 2018. Perchè Sergio
Mattarella, 76 anni, che è anche Presidente del Consiglio della Magistratura,
non invia un telegramma, o non telefona a Guido Bertolaso, ieri assolto da ogni
accusa, dopo aver lavorato, con correttezza ed efficienza, in situazioni
drammatiche, per il nostro Paese? E perché qualche giornale, de'lotta dura e
de'Procura, non chiede scusa all'ex responsabile all'ex Capo della Protezione
civile, dopo averne sporcato l'immagine, presentandolo come un funzionario
corrotto, che prediligeva messaggi hot, nel circolo sportivo del costruttore
Anemone, stangato dal tribunale di Roma, insieme a don Angelo Balducci (sei anni
e mezzo all'ex presidente delle Opere pubbliche)?
SONO INNOCENTE. ANTONIO CARIDI.
“Non è mafioso”: Caridi scarcerato dopo
20 mesi di galera. L’ex senatore è libero per mancanza
di indizi, scrive Simona Musco il 27 Marzo 2018 su "Il Dubbio". L’ex senatore
Antonio Caridi, dopo 20 mesi in cella, è di nuovo un uomo libero. Lo ha deciso
ieri il tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che ha annullato la custodia
cautelare riqualificando l’accusa di associazione mafiosa in concorso esterno.
La vicenda era tornata al tribunale della libertà dopo due annullamenti da parte
della Cassazione, che aveva censurato le motivazioni con le quali era stato
confermato il carcere per il politico, coinvolto nell’inchiesta
“Mammasantissima”, poi unificata assieme ad altri procedimenti nel maxi processo
“Gotha”, per il quale è stato rinviato a giudizio. Per Caridi il Senato aveva
votato l’arresto ad agosto 2016, con 154 senatori favorevoli, 110 contrari e 12
astenuti. Un voto preceduto da ampie polemiche e scontri, nonché dalla
dichiarazione d’innocenza dello stesso Caridi, che aveva condensato su due
pagine il proprio pensiero. «Io sono e mi dichiaro innocente e sono sicuro che
questo mi verrà riconosciuto in sede giudiziaria», aveva affermato poco prima di
lasciare l’aula alla volta di Rebibbia. Non aveva convinto dunque i suoi
colleghi, persuasi invece dalla tesi della Dda di Reggio Calabria, secondo cui
il senatore in quota Gal sarebbe stato al servizio della cosiddetta cupola
grigia, una struttura riservata e invisibile – al cui vertice ci sarebbero l’ex
deputato Paolo Romeo, l’ex sottosegretario regionale Alberto Sarra, l’avvocato
Giorgio De Stefano ( condannato a 20 anni in abbreviato) e il funzionario
Francesco Chirico ( che è stato assolto) -, capace di interloquire
«drammaticamente» con la ‘ ndrangheta, «per consentire l’attuazione del
programma criminoso anche negli ambiti strategici della politica, dell’economia
e delle istituzioni». Caridi, dunque, sarebbe stato «soggetto strumentale
rispetto alle finalità» della cupola, che ne avrebbe sfruttato la carriera
politica sin dal 1997, quando si candidò comunali di Reggio Calabria, potendo
contare sul sostegno del clan De Stefano per almeno 13 anni. E, una volta
eletto, avrebbe operato «in modo stabile, continuativo e consapevole» a favore
del gruppo criminale, facendo confluire ingenti risorse pubbliche su
imprenditori “amici”. Ma tali accuse sono state ridimensionate ieri dal Riesame,
che ha ritenuto insussistente l’ipotesi dell’appartenenza alla cupola, facendo
venire meno le esigenze cautelari. La discussione era iniziata il 20 marzo ed è
terminata ieri, dopo l’analisi di migliaia di pagine di atti prodotti dalla
Procura. «È stata un’udienza lunghissima, approfondita – ha spiegato
al Dubbio l’avvocato Valerio Spigarelli, suo difensore insieme al collega Carlo
Morace -, che ha avuto come esito la restituzione della libertà a chi non doveva
evidentemente esserne privato. Su tutto il resto interloquiremo nelle dovute
sedi, ma l’ipotesi per cui è stato arrestato, in questo momento, non trova
conferma. Siamo soddisfatti – ha aggiunto -. Questo processo si doveva svolgere
senza la carcerazione di Caridi. Ci riserviamo ogni ulteriore commento a quando
leggeremo la motivazione, annunciando che anche per ciò che residua faremo
comunque ricorso per Cassazione. La cosa fondamentale per noi è che ora sia
libero». La Cassazione nei mesi scorsi aveva chiesto al Riesame di ricostruire
le questioni di «gravità indiziaria», «la condotta in concreto» di Caridi, la
sua rilevanza penale e la corretta qualificazione giuridica, anche in termini di
esigenze cautelari. Diverse le censure mosse dalla Suprema Corte, soprattutto
sul ruolo di Caridi nella presunta associazione segreta (la cui esistenza è
stata certificata dalla sentenza in abbreviato), ritenuto poco chiaro, a partire
dai rapporti del politico reggino con il fulcro di tale cupola, Paolo Romeo.
L’ipotesi secondo cui sarebbe stato a tempo indeterminato un esecutore del
programma della struttura segreta, avevano obiettato i giudici, «non trova
nessun riscontro in atti sul piano della gravità indiziaria». E ad eccezione di
una conversazione intercettata nel 2014, su questioni relative alla costituzione
della città metropolitana di Reggio Calabria, non è stato indicato nessun altro
contatto tra Romeo e l’ex senatore da cui evincere «un collegamento fra la
carriera politica di Caridi e la prospettata struttura segreta».
Il caso Caridi e quei senatori senza
coscienza. Il Parlamento diede l’ok all’arresto del
senatore, ora si scopre che non c’è uno straccio di indizio, scrive Piero
Sansonetti il 27 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Antonio Caridi è stato scarcerato.
Il tribunale della libertà ha accertato che non è né il capo della mafia, né uno
dei capi (come era stato ipotizzato al momento della prima richiesta di arresto)
e neppure un docile strumento della cosiddetta “Cupola grigia” (come fu
ipotizzato in un secondo tempo, visto che l’ipotesi che fosse il boss dei boss
appariva un po’ comica). Il tribunale della libertà ha preso questa decisione
dopo che la Cassazione, per ben due volte di seguito, gli aveva fatto notare
che, lette e rilette le carte, non era saltato fuori neppure un indizio piccolo
piccolo che suffragasse l’ipotesi di Caridi mafioso. Avendo accettato l’ipotesi
della Cassazione che l’accusa non reggeva, il tribunale ha deciso di scarcerare
Caridi e di accontentarsi di un’accusa più modesta: concorso esterno. Come sta
la coscienza di quei senatori che hanno fatto arrestare Caridi? Diciamo che il
capo della mafia comunque non faceva parte della mafia… E così ha potuto
scarcerarlo. E scarcerandolo ha ammesso che Antonio Caridi, senatore della
Repubblica fino a una settimana fa (e ora non più perché la sua condizione di
detenuto gli ha impedito, di fatto, di presentarsi a nuove elezioni) è stato
tenuto in prigione ingiustamente per venti mesi. Se adesso parlo di sopruso, di
grandissima ingiustizia, di persecuzione, qualcuno mi dirà che cerco sempre lo
spunto polemico? E cioè mi farà capire che in fondo tenere in prigione un
senatore per venti mesi, senza avere un indizio in mano, sulla base di una
accusa palesemente cervellotica (come questo giornale, solo soletto, sostiene
esattamente da 20 mesi) non è una cosa scandalosa, fa parte della routine di una
giustizia perfettibile ma comunque funzionante? Penso che qualcuno me lo dirà. E
mi dirà che se Caridi non è più accusato di associazione mafiosa, comunque è
accusato di concorso esterno, che è un reato grave. Già, infatti questa sentenza
del tribunale della libertà – che giunge con un ritardo mostruoso e in nessun
modo giustificabile visto che circa un anno fa la Cassazione dichiarò
incomprensibile l’arresto di Caridi – sembra piuttosto ipocrita. Di fronte
all’evidenza dei fatti, messa sul tavolo dalla Corte di Cassazione (e cioè
l’assenza di indizi di colpevolezza) il tribunale della libertà, per non
sbugiardare in modo clamoroso la Procura, ha deciso di derubricare l’accusa.
Come dire: vabbé, non ci sono indizi di nessun tipo sui rapporti di Caridi con
la “Cupola”, né su iniziative parlamentari che lui ha preso a favore della
“Cupola”, né su favori che le ha fatto, né tantomeno su favori che ha ricevuto,
e quindi, evidentemente non è mafioso; però, almeno un po’ di concorso esterno
può restare in piedi… Sarebbe come se di fronte all’evidenza che il tal dei tali
non ha commesso un omicidio, si dicesse: beh, però almeno lo avrà ferito…
Lasciamo stare questo capitolo, sul quale la Cassazione dovrà pronunciarsi per
la terza volta ( poi dicono che la macchina della giustizia si intasa…).
Restiamo ai fatti di oggi. Possiamo tranquillamente affermare tre cose. La prima
è che la Procura ha fatto arrestare una persona senza indizi. E che questa
persona era un senatore. E che è abbastanza probabile che la Procura lo abbia
fatto arrestare proprio perché era un senatore. La seconda è che il Senato della
Repubblica, di fronte a una richiesta di arresto senza indizi, non si è
domandato il perchè ma ha piegato la testa dinnanzi al volere dei giudici. Su
che base la maggioranza dei senatori ha deciso che c’erano indizi sufficienti
per dare il via libero alla carcerazione del loro collega? C’è uno solo dei
senatori che 20 mesi fa votarono per l’arresto e sostennero che gli indizi erano
sufficienti, che oggi saprebbe elencarmi quali erano questi indizi sufficienti?
Cosa provano ora i senatori che mandano in carcere il senatore Caridi, e
provocarono i venti mesi di detenzione, cosa provano di fronte alla notizia che
fu un errore? La terza cosa chiarissima è che i giornali e le Tv e i talk show e
la rete e tutto quanto vi piace definire con il termine “informazione”, tutto
questo “circo” è del tutto inutile quando si parla di giustizia. Perché quando
si parla di giustizia i giornali dicono una sola cosa: evviva il Pm. Non c’è
stato un giornale (salvo il nostro) che in questi mesi si sia occupato del
caso-Caridi, non c’è stato un singolo giornale o una singola Tv che abbia
sollevato il problema della assenza di indizi contro di lui e della follia della
concessione, da parte del senato, del mandato di arresto. Qualcuno sarà chiamato
a rispondere di questo atteggiamento arrogante e immorale? Da parte
dell’informazione, da parte di moltissimi senatori, da parte di alcuni
magistrati? Beh, di tutte le domande che ho posto, quest’ultima è l’unica alla
quale ho una risposta sicura: no, nessuno.
SONO INNOCENTE. HASHI OMAR HASSAN.
Caso Alpi, 3 milioni di risarcimento ad
Hassan per errore giudiziario, scrive Damiano
Aliprandi il 31 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Riconosciuto un risarcimento di oltre
3 milioni di euro per i 17 anni scontati da innocente. È quanto è stato disposto
in favore di Hashi Omar Hassan, il somalo che ha scontato, da innocente, quasi
17 anni di carcere per gli omicidi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Hassan,
poi è stato assolto in un processo di revisione. La notizia, anticipata da Chi
l’ha visto? – trasmissione che fece riaprire il caso -, è stata poi confermata
all’Ansa dall’avvocato Antonio Moriconi, uno dei legali di Hassan. La Corte di
Appello di Perugia, che il 19 ottobre 2016 aveva assolto Hashi Omar Hassan
dall’accusa di aver ucciso nel marzo 1994 a Mogadiscio la giornalista Ilaria
Alpi e l’operatore Miran Hrovatin, gli ha riconosciuto un risarcimento di
3.181.500 euro per 6.363 giorni scaturiti da un errore giudiziario. Cinquecento
euro per ogni giorno trascorso in carcere da innocente. Unico condannato (26
anni di reclusione) per l’omicidio della giornalista del Tg3, Ilaria Alpi e
dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuta a Mogadisco il 20 marzo del 1994, è
stato scagionato nel 2016 e rimesso in libertà dalla Corte di Perugia che ha
accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Dario Razzi. «Se è vero
che Hassan è stato condannato dobbiamo avere anche il coraggio di ammettere che
possa essere innocente», aveva detto il magistrato. Convinta dell’innocenza di
Hassan si è sempre detta la famiglia di Ilaria Alpi. Teste chiave del processo a
suo carico era stato un altro somalo, Ahmed Ali Rage, detto Jelle, il quale però
prima alla trasmissione “Chi l’ha visto”, andata in onda il 18 febbraio 2015,
aveva ritrattato le sue accuse. In particolare sostenendo di non aver «detto a
nessuno» che Hassan «faceva parte del commando» autore del duplice delitto e
«nemmeno che è stato lui a uccidere». Spiegando di averlo collocato sull’auto
degli assassini solo «per dare credibilità» al racconto, costruito su
particolari raccolti da chi vide l’agguato. «L’ho fatto solo per andarmene via
dal Paese», aveva ribadito. Rimane però senza colpevole l’agguato che costò la
vita a Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin. Sul caso si sono alternati
negli anni ben cinque magistrati e tre procuratori. Eppure, nessuno è riuscito a
porre fine ai troppi evidenti depistaggi che hanno caratterizzato questa
vicenda. L’unica certezza è che a pagarne ingiustamente le spese è stato il
somalo Omar Hassan. Nel 2000 venne arrestato e inserito nel circuito E. I. V.
(elevato indice di vigilanza) sezione “protetti”, riserva d’appello a soggetti
che temono per la propria incolumità personale. Nel 2009 venne poi assegnato nel
circuito “Media Sicurezza” riservato ai detenuti comuni e trasferito presso la
sezione “protetti” del carcere di Padova. Presso tale sede non si verificarono
criticità e dal 30.04.2013 ha iniziato a fruire di regolari permessi premio
concessi dalla locale magistratura di sorveglianza; in data 19.04.2015 è stato
scarcerato per affidamento in prova al servizio sociale. Nessuno potrà ridargli
i 17 anni di vita rubati, ma almeno ha avuto il giusto risarcimento per l’errore
giudiziario. È necessario distinguere il risarcimento per l’ingiusta detenzione
da quello per l’errore giudiziario. Nel primo caso si fa riferimento alla
detenzione subita in via preventiva prima dello svolgimento del processo e
quindi prima della condanna eventuale, mentre nel secondo si presuppone invece
una condanna a cui sia stata data esecuzione e un successivo giudizio di
revisione del processo in base a nuove prove o alla dimostrazione che la
condanna è stata pronunciata in conseguenza della falsità in atti.
SONO INNOCENTE. MARIA GRAZIA MODENA.
Distrutta dalle accuse e trattata come
una criminale: l'odissea giudiziaria della cardiologa.
Maria Grazia Modena era Primario al Policlinico modenese dove aveva costruito un
reparto di ricerca d'eccellenza. Poi le accuse infamanti. E i processi, scrive
la Redazione di Tiscali il 28 gennaio 2018. La sua vicenda ha non pochi punti in
comune con quella di Ilaria Capua, la virologa intervistata da TiscaliNews che
fu accusata di voler diffondere virus e far scoppiare contagi in Italia per poi
guadagnare con i vaccini che metteva a punto. E che in seguito è stata
completamente scagionata dalle accuse. Sono stati sei anni infernali, quelli
vissuti da Maria Grazia Modena, all'epoca dei fatti primario di Cardiologia del
Policlinico di Modena. Accusata di essere alla testa di un gruppo di "camici
sporchi" con cui secondo la accusa commetteva alcuni fra i più gravi
reati: associazione a delinquere, truffa al sistema sanitario, corruzione, abuso
d’ufficio, sperimentazioni illecite. Arrestata nel 2012 mentre gli elicotteri
volavano su casa sua, neanche fosse un pericoloso boss della mafia. E solo
qualche giorno fa assolta da tutte le accuse, anche quella di falso, dopo la
sentenza della Cassazione.
"Resta la sconfitta morale". Secondo Maria Grazia
Modena, che tuttora attende di essere reintegrata al Policlinico di Modena e che
le si tolga la radiazione dall'Ordine dei Medici, quella contro di lei è stata
una sentenza politica, con un quadro accusatorio montato per farla fuori. Come
lei stessa ha raccontato in una intervista a Modena Today: "Se penso ai denari
pubblici che, a partire dal costo degli elicotteri che hanno circondato casa mia
e degli altri otto medici arrestati quell’indimenticabile 9 novembre del 2012
fino a tutte le spese occorse in questo accanimento processuale, hanno pesato
sulle tasche dei cittadini, mi assale un grande dispiacere. Perché se quei
denari, così sprecati, fossero stati investiti nella sanità pubblica, avrebbero
sicuramente apportato a Modena un ulteriore salto di qualità. Questo è stato un
processo politico, non penale. E questa è stata, da un lato, la mia salvezza
perché sapevo che contro avevo i poteri forti. Davanti a un nemico titanico ho
trovato quella forza che, altrimenti, probabilmente, non avrei avuto per portare
avanti una battaglia nella quale non solo si ristabilisse la mia dignità di
professionista e donna ma, soprattutto, quella dei pazienti e dei medici che
hanno pagato con me. Alcuni di questi erano all’inizio della loro carriera e,
questo processo, ha distrutto le loro vite. Altri si sono visti emarginati solo
perché hanno continuato a credere in me. Resta la sconfitta morale".
Come sopravvivere. La dottoressa Modena e Ilaria
Capua si sono sentite proprio poco prima della pronuncia della Cassazione che ha
completamente riabilitato la cardiologa: "Non le ho risposto perché attendevo la
sentenza, ora lo farò. Lei schifata se n'e andata negli Usa, io voglio
riprendermi il mio ruolo a Modena, in Italia" ha detto al Corriere della Sera.
Era diventata potente e stimata: "Sì lo ammetto volevo creare una cardiologia
d’eccellenza e ci sono riuscita. Ho dato la vita per il lavoro, uscivo alle 6
tornavo alle 9 di sera, niente figli per scelta". Ed ecco le accuse infamanti, i
processi, gli arresti domiciliari, i titoli sui "camici sporchi" a tutta stampa.
Ad aiutarla a sopravvivere a tanto sfascio, il marito già in pensione e
costretto a rimettersi in pensione per mantenere la famiglia dopo la radiazione
della moglie. E le cure del cagnolino Manhattan". La dottoressa Modena ha
ripreso a insegnare, ma vuole tornare in ospedale, come primario, e riprendere
le sue ricerche con i collaboratori fidati.
La Cassazione la assolve: il processo era
“sperimentale”…, scrive Valentina Stella il 23 gennaio
2018 su "Il Dubbio". Sono le 5 e 18 dell’alba di sabato mattina quando mi giunge
questo messaggio: “Ho vinto su tutti i fronti!!! È finito per sempre un incubo.
Adesso vado a dormire!!”: a scrivermi è Maria Grazia Modena, professoressa di
Cardiologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, già Presidente della
Società Italiana di Cardiologia, che non ha smesso di combattere per dimostrare
la sua innocenza, come vi avevamo già raccontato qualche mese sul Dubbio. Adesso
che il suo camice è definitivamente pulito ha voglia di dirlo a tutti, a poche
ore dalla sentenza della Cassazione che l’ha assolta da tutte le accuse
dell’inchiesta che nel novembre 2012 la portò agli arresti domiciliari, dopo un
arresto spettacolare con elicotteri in volo, e che riguardava le presunte
sperimentazioni abusive sui pazienti inconsapevoli che, secondo l’accusa del pm
Marco Niccolini, sarebbero avvenute nel reparto di cardiologia del Policlinico
modenese. Venerdì notte intorno all’una e trenta è arrivato il giudizio da Roma:
la sentenza annulla senza rinvio la disposizione di condanna per i reati di
falso, che era l’unica condanna che era rimasta alla dottoressa Modena e
dichiara inammissibili i ricorsi contro l’assoluzione in Appello per i reati di
associazione a delinquere, corruzione, truffa ai danni dell’ospedale e abuso
d’ufficio, del procuratore generale di Bologna e delle parti civili ossia
Azienda ospedaliera, Regione Emilia Romagna e Associazione Amici del Cuore
condannandoli alle spese processuali. «Adesso posso dire di credere nella
magistratura giusta – racconta al Dubbio la professoressa – leale, fatta di
giuristi veri. Ho vissuto sei anni di panico, però alla fine ho ottenuto piena
giustizia, essendo stata assolta per tutto, grazie anche ai miei straordinari
avvocati». Oggi la professoressa Modena è completamente libera di riprendere in
mano la sua vita e forse di tornare a fare il primario. «Proprio oggi (ndr ieri)
mi è arrivato il messaggio del Rettore dell’Università di Modena per cui la mia
assoluzione è “motivo di grande soddisfazione e restituisce forza e credibilità
all’ambiente universitario della Medicina modenese”».
Il procuratore capo di Modena Lucia Musti – il
magistrato che tra l’altro è stato ascoltato nei mesi scorsi dalla prima
commissione del Csm sui casi Cpl Concordia e Consip che sulla decisione dei
supremi giudici ha detto: “La Cassazione non dichiara le persone innocenti o
colpevoli. È un provvedimento che ha solo dichiarato inammissibile il ricorso
del procuratore generale di Bologna. Rispettiamo tutte le pronunce, ma il nostro
lavoro sperimentale di indagine è stato valido. È stata fatta una ‘ indagine
sperimentale’, unica, al punto tale che lo stesso tipo di indagine è stata anche
esportata all’estero perché è stata oggetto di studio in altri ordinamenti di
altri Stati’. Il professore Luigi Stortoni, difensore con il collega
Massimiliano Iovino della professoressa Modena, commenta: «Non è vero che la
Cassazione non decide chi è innocente o colpevole. La Cassazione decide se le
sentenze sono state fatte correttamente e in contrario le corregge. Nel caso
della professoressa Modena la Cassazione ha dichiarato addirittura inammissibili
i ricorsi della Procura Generale di Bologna, quindi ciò ha confermato la
correttezza della sentenza di assoluzione arrivata in Appello e ha cassato senza
rinvio la sentenza per quello che concerne la condanna per i falsi. Quando la
Cassazione cassa senza rinvio significa che assolve. Quindi come hanno
dimostrato tre giudici della Corte d’Appello e cinque giudici della Cassazione
questa ipotesi accusatoria, questa grande inchiesta sul malaffare, è stata tutta
una montatura».
La giustizia, secondo la dottoressa Musti, si
amministra anche a colpi di ‘ esperimenti’: lei cosa pensa?
«Le
dichiarazioni della Musti sono sconcertanti, io sono sbigottito prima come
penalista e poi come cittadino e difensore. Esse sovvertono tutti i principi e
tutti i valori del diritto e del processo penale che sono la presunzione di
innocenza, il fatto che si possa punire qualcuno quando vi è la prova che abbia
commesso un reato, che il diritto penale debba essere certo come dice la nostra
Costituzione e la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. È terribile che un
processo sia stato preceduto da una ‘ indagine sperimentale’: la sperimentazione
del diritto penale è un assurdo, si applica la regola che già esiste, non si
fanno tentativi sperimentali. La Musti è come se dicesse ‘ abbiamo provato ad
applicare un diritto penale che non c’era prima’ ma allora i principi di
certezza e di retroattività del diritto penale vanno a farsi benedire! È come
dire che si fanno ‘ esperimenti penali’ in corpore vili: sperimentazioni
pericolose e inammissibili in un ordinamento costituzionale che garantisce la
libertà personale. Rischiamo di diventare delle cavie nelle mani delle Procure.
Il mio timore è che la Musti stia confessando con candida ingenuità che si può
sperimentare sulla pelle dei cittadini».
La Musti poi prosegue dicendo che quel loro
tipo di indagine sperimentale è stato esportato all’estero.
«Spero che non
sia così, quale immagine daremmo mai dell’operato dei nostri pubblici ministeri?»
Tutta una anomalia fin dall’inizio dunque?
«Nella fase
delle indagini, si è verificata, da parte del pm Niccolini e dell’allora capo
Zincani, una situazione paradossale contraria a tutte le regole e a tutti i
principi. L’imputato deve essere messo nelle condizioni di sapere di cosa è
accusato per potersi difendere. Invece in questo processo, nella fase delle
indagini, gli indagati che, leggendo i giornali, venivano a sapere di un
procedimento in atto, andavano ripetutamente a bussare alla porta della Procura
per chiedere conferme e non veniva detto loro nulla. Addirittura quando chiesero
un certificato sui carichi pendenti nei loro confronti fu risposto negativamente
facendo un falso. E questo noi l’abbiamo denunciato. E mentre non si diceva
nulla a chi aveva diritto ad essere informato sulla propria posizione, sui
giornali e in tv si sbandieravano confusamente notizie false. Il dottor Zincani
fece una serie di dichiarazioni alimentando una gogna mediatica inqualificabile».
SONO INNOCENTE. GIUSEPPE MELZI.
L’avv. antimafia arrestato per mafia: 10
anni per scagionarlo, scrive Valentina Stella il 17
gennaio 2018 su "Il Dubbio". La vicenda giudiziaria di Giuseppe Melzi, che fu
il legale dei risparmiatori del crack ambrosiano e del fallimento Sindona. Nel
2008 venne accusato di riciclaggio per i clan. L’avvocato Giuseppe Melzi venne
arrestato a Milano, dinanzi il suo studio, l’8 febbraio 2008 insieme ad altre 8
persone a seguito di una indagine dei Ros dei Carabinieri di Milano, denominata
“Dirty Money” (ex Tre Torri), avviata nel lontano 2001. Era accusato di
“riciclaggio e agevolazione mafiosa”: secondo l’accusa aveva riciclato e
reimpiegato capitali, attraverso un giro di società fittizie tra Svizzera e
Italia, per un valore di circa 80 milioni di euro che erano il prodotto dei
traffici illeciti della cosca della ‘ndrangheta Ferrazzo di Mesoraca (Crotone).
L’avvocato Melzi ha scontato 291 giorni di custodia cautelare (89 in carcere e
202 a domicilio, quasi 10 mesi), e subìto la sospensione dall’attività
professionale per 1.159 giorni ( 3 anni e 2 mesi). Nel 2009 la Procura chiese il
rinvio a giudizio per gli imputati, ma il gup Paolo Ielo trasmise il
procedimento a Cagliari per competenza territoriale. Melzi da allora sostiene di
non aver avuto più aggiornamenti sulla sua vicenda giudiziaria. Il 4 aprile 2016
il procuratore capo di Cagliari, Gilberto Ganassi, e il sostituto Guido Piani
chiedono al gip Mauro Grandesso Silvestri l’archiviazione di tutti gli indagati.
Il 5 maggio giunge l’archiviazione ma nulla viene notificato all’avvocato Melzi
che ne è venuto a conoscenza solo qualche giorno fa tramite un collega sardo.
L’avvocato Giuseppe Melzi, che ha difeso i risparmiatori vittime del crack
Ambrosiano e del fallimento della banca di Sindona, venne accusato nel 2008 di
riciclaggio per i clan della ‘ ndrangheta. Vita privata e professionale
rovinate. A dieci anni da quelle accuse il procedimento viene archiviato e non
gli viene neanche comunicato.
Il primo febbraio 2008 inizia il suo calvario
giudiziario.
«È stato uno
“tsunami”. Non riuscivo neppure a realizzare che il provvedimento cautelare e le
ipotesi accusatorie riguardassero me e non unicamente soggetti che richiedevano
la mia assistenza professionale. Non sapevo nulla della maggior parte dei fatti
esposti nell’ordinanza di 279 pagine che mi veniva notificata. Conoscevo solo
alcuni degli altri indagati e non ero mai stato interrogato dal Pm».
Lei ha subìto ingiustamente 291 giorni di
custodia cautelare.
«Nel carcere si
perde la propria identità: una devastazione completa, che tronca improvvisamente
la vita di relazione, gli impegni, gli interessi, la manifestazione degli
affetti; in definitiva la propria realtà esistenziale».
Lei è passato da paladino dei piccoli
risparmiatori ad imputato con l’aggravante della finalità mafiosa.
«La mia
attività professionale è sempre stata in difesa delle vittime della criminalità
economico- finanziaria. Sono stato l’unico che ha denunciato pubblicamente che
il mandante dell’assassinio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli era Sindona, mentre
l’Ordine degli Avvocati di Milano non partecipò ai funerali e mi interrogò sulla
fonte delle mie affermazioni. Nessuno deve essere considerato “intoccabile”, ma
l’identità e la storia personale e professionale di ogni cittadino non possono
essere ignorate e calpestate, in base a ipotesi, “teoremi” accusatori infondati
e strumentali di magistrati, territorialmente incompetenti e non solo.
Purtroppo, “intoccabili” appaiono i giudici che non si confrontano con gli
indagati e con i loro difensori, non rispettano le procedure e, in definitiva,
non rispondono delle loro decisioni, né subiscono controlli e sanzioni».
Lei scrive “dell’irrisarcibile pregiudizio”
subìto dal comportamento dei magistrati milanesi: cosa intende?
«Il
“pregiudizio”, i danni subiti dalla mia persona, dalla mia famiglia, dalla mia
attività sono incalcolabili e, appunto, irrisarcibili».
Sulla stampa lei è stato definito “la mente
finanziaria e legale dell’organizzazione criminale” e anche il “deus ex machina
della cosca Ferrazzo’.
«Il “processo
mediatico” è stato non meno devastante. La stampa deve diffondere le notizie, ma
non può prescindere da una verifica critica di ogni comportamento, anche di
quello dei giudici. Nessuno allora ha proposto riserve, o dubbi sulle
incredibili e folli accuse rivoltemi. Solo l’allora Assessore al Comune di
Milano, On. le Tiziana Maiolo (che conoscevo appena) ha avuto la civiltà di
scrivere sul proprio blog: “E se l’avvocato Melzi fosse innocente?… La storia
non cambia, basta una informazione di garanzia, o un arresto per essere già
colpevoli”».
Come è possibile che non ha mai ricevuto
informazione dell’archiviazione?
«L’art. 409 c.
p. p. prevede la notifica dell’archiviazione non solo alle eventuali parti lese,
ma agli indagati che hanno subito un provvedimento cautelare. L’omissione della
Cancelleria nel tardare la notifica del decreto di archiviazione è rimediabile e
davvero, “veniale”, rispetto alla “mortale” gravità dell’errore e dell’abuso
compiuto dai giudici che hanno malamente indagato dal 2001 al 2009, raccogliendo
“la massa enorme di dati e di elementi” definitivamente inconcludenti».
Che giudizio complessivo dà di questa sua
vicenda?
«Il giudizio
complessivo riguarda il “sistema giustizia”: non si tratta solo di denunciare
pubblicamente la “malagiustizia” che colpisce persone innocenti, ma di ottenere
la modifica di un sistema che esercita poteri assoluti e purtroppo
“irresponsabili”. Non a caso il “potere giudiziario” è stato definito una
“casta”: i giudici non rispondono mai delle loro decisioni e non sono sottoposti
a reali controlli. Quelli del C. S. M. (politicizzato all’eccesso), in realtà,
sono inesistenti, o marginali: l’autoreferenzialità è assoluta. In 46 anni di
professione non ho mai avuto la fortuna di incontrare un giudice che ha
riconosciuto e modificato un proprio errato convincimento, neppure a seguito
della smentita dei propri “teoremi”, ovviamente, confidando sulla sostanziale
impunità. Di fronte ad un “sistema chiuso” e che si auto- seleziona in base solo
ai risultati di un concorso e autogiustifica definitivamente i propri adepti
(per l’intera vita professionale fino alla pensione), è indispensabile una
modifica radicale. Perché non rendere elettiva anche la nomina dei giudici?
Dovranno almeno rispondere periodicamente del loro operato, come i componenti
gli Ordini Legislativo ed Esecutivo, caposaldi della nostra Costituzione?»
Nessuno pagherà i danni,
scrive Piero Sansonetti il 9 gennaio 2018 su "Il Dubbio". Anche il processo-
Finmeccanica si è concluso con un flop. Ci sono voluti quasi cinque anni per
arrivare alla conclusione che lo scandalo non c’era. Non è stata trovata nessuna
traccia delle tangenti. Come del resto avevano già detto i giudici di primo
grado, quasi tre anni fa, ma non erano stati ascoltati. I manager ora sono
scagionati e possono riprendere a testa alta la loro attività. Anche se i danni
che ha ricevuto la loro carriera ormai sono irreparabili. Anche se il trauma
subìto quel giorno che arrivarono i carabinieri a casa e li trascinarono in
prigione, la foto di fronte e di profilo, gli oggetti personali consegnati al
piantone, e poi i tre mesi passati in cella, beh, tutto questo è impossibile da
dimenticare. E anche da risarcire. Lo scandalo Finmeccanica non c’era Chi
pagherà i danni (ingentissimi)? Lo scandalo non c’era. Non è la prima volta che
succede. Cito a mente, senza neanche sforzarmi troppo e senza consultare gli
archivi: lo scandalo tempa Rossa, che alimentò tutti i grandi giornali un paio
d’anni fa, e che costrinse alla dimissioni una ministra, e che permise alla
stampa di frugare in modo osceno nella sua vita privata, e di sbatterla in
piazza con ferocia e un po’ di perversione, beh, lo scandalo Tempa Rossa si è
concluso con un’archiviazione generale. Non esisteva: zero. Nessuno ha pagato.
Lo scandalo di Sesto San Giovanni, che travolse il braccio destro di Bersani,
Filippo Penati, figura emergente della sinistra italiana, beh, anche quello è
finito in una bolla di sapone. Penati, invece, ha pagato. L’ha pagata cara. Oggi
nemmeno più pensa alla lontana all’ipotesi di tornare a far politica. Un po’ non
gli interessa più, un po’ forse ha paura, ha imparato sulla sua pelle che se un
Pm ti punta ha il potere di fare di te quel che vuole, di sbranarti, e poi
magari lasciarti sul selciato, vivo, ma distrutto e terrorizzato. Vogliamo
parlare di Vasco Errani, ex presidente della Regione Emilia, anche lui travolto
da uno scandalo, accusato di favoritismi e corruzione, costretto a uscire dalla
politica per molti mesi, poi assolto? Errani non s’è dato per vinto, in qualche
modo ha ripreso a lottare a a far politica, ma certo ripartendo da una posizione
molto, molto svantaggiata rispetto alla posizione che aveva raggiunto prima che
una Procura si interessasse a lui. Fermiamoci qui, sennò diventiamo noiosi (e
tralasciamo i settanta processi a Berlusconi andati a vuoto). Appena appena
citiamo il caso Consip, che non è ancora concluso ma si è già sgonfiato come un
palloncino di plastica. Il caso Consip è stato ancora più clamoroso, forse.
Perché è stata una inchiesta realizzata in collaborazione da Pm e giornalisti,
che si sono scambiati volentieri i ruoli, e che hanno passo passo accompagnato
con la copertura e il cannoneggiamento della “marina”, cioè dei giornali,
l’attività sul terreno dei magistrati, la quale però – si è poi scoperto – era
parecchio farlocca perché basata su informative dei carabinieri falsificate. Lì
poi il candidato “vittima” – che si è salvato solo perché a un certo punto è
intervenuta la Procura di Roma è ha scoperto che a Napoli stavano taroccando –
era una preda parecchio appetitosa: il capo del partito di maggioranza e premier
uscente. Torniamo al punto di partenza. Lo scandalo Finmeccanica ha avuto molte
conseguenze: il cambio quasi totale del management di Finmeccanica, la rovina
personale di alcune carriere, una perdita consistente economica e di prestigio
per l’industria italiana. Difficile quantificare tutto questo, ma stiamo
parlando probabilmente di miliardi. Naturalmente nessuno sostiene che se sono in
ballo i miliardi è bene che la magistratura si tenga fuori. E’ chiaro che se ci
sono indizi seri di un reato grave, la magistratura deve intervenire, senza
opportunismi e senza guardare in faccia a nessuno. Il problema è che negli
ultimi tempi si hanno pochissime notizie di inchieste che hanno portato alla
condanna. Lo scarto tra il clamore, talvolta drammatico, provocato dall’apertura
delle inchieste sui politici o nelle grande aziende e i risultati delle
inchieste è uno scarto gigantesco. Sarebbe forse il caso di ragionarci. E di
vedere se non è il caso di portare qualche correttivo. Non solo per rendere più
giusto il funzionamento della nostra società, e più salde le garanzie di
giustizia dei cittadini, ma anche per la credibilità della magistratura. La
quale credibilità, se in questi vent’anni non fosse stata sostenuta con
incredibile utilizzo di mezzi, da quasi tutto il fronte dell’informazione, oggi
probabilmente sarebbe a livelli ancor più bassi da quelli raggiunti dalla
politica. Il fatto è che finché chiunque può in allegria procedere in inchieste,
anche in assenza di prove, e può costruire su queste inchieste il proprio
successo mediatico, e se poi va tutto a carte quarantotto non succede niente, e
chi ha avviato l’inchiesta non solo non paga in “euro” ( come succede a quasi
tutti gli altri professionisti), ma neppure in carriera, in possibilità di
avanzamento e di successo, voi capite che è difficile frenare la “pulsione”
irrefrenabile ad aprire sempre nuove inchieste sui “Grandi Imputati”. E
addirittura, succede, come nel caso Finmeccanica, che se il tribunale assolve,
c’è una Procura che non si arrende, perché ha un’idea di uso personale della
macchina della giustizia – non è in grado di interpretare l’interesse generale –
e ricorre in appello sulla base di nulla. Ecco, di fronte a questa situazione
dovrebbe essere interesse in primo luogo della magistratura ragionare,
impegnarsi e trovare dei correttivi. Perché il rischio è che l’idea di
onnipotenza, dominante in alcuni magistrati, mandi a scatafascio tutta la
macchina della giustizia, a partire dalla magistratura.
SONO INNOCENTI. GIUSEPPE ORSI E BRUNO
SPAGNOLINI.
Scandalo Finmeccanica, altro flop: tutti
assolti, scrive Simona Musco il 9 gennaio 2018 su "Il
Dubbio". L’ex presidente Orsi e l’ex ad Spagnolini erano innocenti. «Non vi è
prova sufficiente» della corruzione messa in atto dagli ex vertici di
Finmeccanica per assicurarsi la vendita di 12 elicotteri all’India. Lo hanno
stabilito ieri i giudici della terza sezione della corte d’appello di Milano,
presieduta da Piero Gamacchio, che hanno assolto Giuseppe Orsi, ex presidente di
Finmeccanica (ora Leonardo) e Bruno Spagnolini, ex amministratore delegato della
controllata Agusta Westland, nel corso dell’appello bis del processo. Orsi e
Spagnolini erano accusati di corruzione internazionale e false fatturazioni per
il presunto pagamento di una tangente a pubblici ufficiali indiani, che in
cambio avrebbero assicurato loro una commessa da 556 milioni di euro. In primo
grado, Orsi e Spagnolini erano stati assolti dal tribunale di Busto Arsizio
dall’accusa di corruzione e condannati solo per le false fatture. Il processo
d’appello aveva invece ribaltato la sentenza, con la condanna dei due manager
per entrambi i reati: Orsi a 4 anni e 6 mesi e Spagnolini a 4 anni, con in
aggiunta la confisca per equivalente dell’importo di sette milioni e mezzo di
euro. «Non vi è prova sufficiente» della corruzione messa in atto dagli ex
vertici di Finmeccanica per assicurarsi la vendita di 12 elicotteri all’India.
Lo hanno stabilito ieri i giudici della terza sezione della corte d’appello di
Milano, presieduta da Piero Gamacchio, che hanno assolto Giuseppe Orsi, ex
presidente di Finmeccanica (ora Leonardo) e Bruno Spagnolini, ex amministratore
delegato della controllata Agusta Westland, nel corso dell’appello bis del
processo. Orsi e Spagnolini erano accusati di corruzione internazionale e false
fatturazioni per il presunto pagamento di una tangente a pubblici ufficiali
indiani, che in cambio avrebbero assicurato loro una commessa da 556 milioni di
euro. In primo grado, Orsi e Spagnolini erano stati assolti dal tribunale di
Busto Arsizio dall’accusa di corruzione e condannati solo per le false fatture.
Il processo d’appello aveva invece ribaltato la sentenza, con la condanna dei
due manager per entrambi i reati: Orsi a 4 anni e 6 mesi e Spagnolini a 4 anni,
con in aggiunta la confisca per equivalente dell’importo di sette milioni e
mezzo di euro. Una decisione che, a fine 2016, i giudici della Suprema Corte
avevano nuovamente ribaltato, disponendo un nuovo processo davanti ad una
differente sezione della corte d’appello di Milano e contestando ai giudici di
secondo grado di non aver rinnovato l’assunzione delle prove dichiarative
Secondo la Cassazione, dunque, Orsi e Spagnolini sarebbero stati condannati
semplicemente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni rilasciate dai testimoni nel processo di primo grado. Una
situazione che determina «un vizio della motivazione della sentenza», si legge
nell’annullamento della prima sentenza di secondo grado. Il processo era dunque
tornato in appello, dove il pg Gemma Gualdi, che ha sostenuto l’accusa assieme
al collega Gianluigi Fontana, aveva ribadito la necessità di confermare le
condanne già inflitte, tenendo conto però della prescrizione dell’accusa di
false fatture per il 2008. Secondo l’accusa, ci sarebbe stata «un’imponente mole
di prove documentali sul giro di denari» finalizzati alla corruzione delle
autorità indiane. Prove che, secondo le difese sono state invece travisate,
senza riuscire nemmeno, ha affermato l’avvocato Ennio Amodio, difensore di Orsi,
a «stabilire la data dell’accordo corruttivo e quali sarebbero stati i denari
arrivati al maresciallo Tyagi». Il processo d’appello bis si era aperto con la
novità della costituzione di parte civile del Governo indiano e l’ammissione di
nuovi atti chiesti dalla Procura generale e dal Ministero della Difesa indiano,
tra i quali le procedure del bando di gara che, secondo l’accusa, sarebbe stato
truccato a favore della società ita- liana. Ma i giudici hanno accolto la
richiesta di assoluzione avanzata dai legali degli imputati, non ravvisando
prove del passaggio di denaro utilizzato per la corruzione. Un’assoluzione
tardiva «con tutto il danno che hanno fatto all’azienda, quello che hanno fatto
a noi è il meno», ha commentato Bruno Spagnolini dopo la lettura della sentenza.
Una decisione che «chiude una vicenda che doveva, fin dalle prime battute,
essere chiara anche agli investigatori: non esiste alcun accordo corruttivo, non
vi è prova alcuna che il denaro sia pervenuto a Tyagi, né si è mai dimostrato
che i funzionari indiani abbiano in qualche modo interferito nella gara – ha
commentato Amodio -. Si riafferma così che quella fornitura altro non è stata se
non la manifestazione di un successo dell’industria elicotteristica italiana che
aveva offerto all’India una delle sue macchine di maggiore efficienza, tanto da
essere acquisita anche dall’amministrazione statunitense per i viaggi del
presidente Obama». Orsi e Spagnolini furono arrestati nel febbraio 2013 e
scarcerati a maggio dello stesso anno. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbe-
ro corrisposto somme di denaro non esattamente quantificate al maresciallo Sashi
Tyagi, capo di Stato maggiore dell’Indian Air Force dal 2004 al 2007, per
compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, con lo scopo di favorire la
Agusta Westland nella gara per l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura al
Governo indiano di 12 elicotteri Vvip. Orsi avrebbe incaricato Guido Ralph
Haschke, amministratore e socio di Gadit S. A. e di Gordian Services s. a. r.
I., e Christian Michel, titolare della Global Service Trade Commerce della
Global service Fze, di condurre la trattativa in India. Haschke, assieme al suo
socio Carlo Gerosa, per il tramite dei fratelli Juli Tyagi, Docsa Tyagi e
Sandeep Tyagi, cugini del Maresciallo Tyagi, sarebbero intervenuti sul bando
facendolo modificare in senso favorevole ad Agusta Westland, ottenendo così la
riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri e consentendo alla
società di partecipare alla gara e, quindi, di vincerla. Orsi e Spagnolini
avrebbero corrisposto inizialmente ad Haschke e Gerosa la somma di 400mila euro
attraverso un contratto di consulenza, concludendo in seguito contratti di
ingegneria con le società Ids India e Ids Tunisia, allo scopo di coprire
l’intero pagamento, nell’ambito di una operazione commerciale nella quale erano
vietati compensi per mediazioni. In primo grado, però, il tribunale di Busto
Arsizio aveva stabilito che dal processo non erano emersi riscontri all’accusa
di corruzione e che le prove consentivano di inquadrare la vicenda anche
attraverso una ricostruzione alternativa e lecita. Non c’era, infatti, prova
dell’accordo corruttivo con il pubblico ufficiale straniero, essendo il primo
incontro tra Orsi ed Haschke successivo alla decisione favorevole alla Agusta
Westland, e non c’era prova neppure della adozione, da parte del pubblico
ufficiale straniero, dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, essendo stata
deliberata in precedenza e da altri la riduzione della quota operativa di volo
richiesta per gli elicotteri. Nessun riscontro nemmeno del passaggio di denaro,
in quanto la ricostruzione dei flussi finanziari non aveva consentito di
riscontrare pagamenti diretti a favore del maresciallo Tyagi. I primi giudici di
appello avevano deciso però di condannare i due imputati senza ascoltare
nuovamente i testimoni, semplicemente valutando diversamente le prove. Decisione
che, dopo la Cassazione, è stata bocciata anche dai colleghi di Milano: le prove
di quella corruzione, se mai c’è stata, non sono mai state trovate.
SONO INNOCENTE. ANGELO
MASSARO.
Sono innocente. Angelo
Massaro.
Taranto. Il Foro dell’ingiustizia. Angelo Massaro, 20 anni di carcere da
innocente in folta compagnia. Non erano colpevoli, chiedono 12 mln di euro.
Giovanni Pedone, Massimiliano Caforio, Francesco Aiello e Cosimo Bello,
condannati per la cosiddetta «strage della barberia» di Taranto, sono tornati in
libertà dopo 7 anni di detenzione e vogliono un risarcimento. Domenico Morrone,
15 anni di carcere da innocente, risarcito con 4,5 milioni di euro. E poi ci
sono le condanne dubbie in presenza di confessioni verificate, e ciononostante
non credute: Faiuolo, Orlandi, Nardelli, Tinelli, Montemurro, Donvito per i
delitti di Sebai, il killer delle vecchiette. Cosima Serrano e Sabrina Misseri
per il delitto di Michele Misseri, il killer di Avetrana.
La storia di Angelo
Massaro, che ha passato 20 anni in prigione per una parola fraintesa.
L’incredibile odissea dell’uomo di 51 anni che è stato condannato a 30 anni per
un delitto mai commesso. È stato scarcerato con revisione del processo, scrive
Carlo Vulpio il 24 febbraio 2017 su "Il Corriere della Sera". Sua moglie
Patrizia festeggia oggi (ieri, ndr) il compleanno, 43 anni, ventuno dei quali
trascorsi ad aspettarlo, a crescere i loro due figli, Raffaele e Antonio, e a
peregrinare da un carcere all’altro: Foggia, Carinola, Rossano Calabro, Melfi e
infine Catanzaro. Lui, Angelo Massaro, 51 anni, di Fragagnano, Taranto, è appena
uscito dal carcere di via Tre Fontane e ha trovato lì Patrizia, che lo ha
abbracciato e in silenzio lo ha aiutato a caricare le sue poche cose su una
station wagon molto usata. È già sera, ci allontaniamo da quei muri ostili,
scegliamo un posto più defilato per parlare e finalmente lo troviamo nella sala
del biliardo di un bar della frazione di Santa Maria, a Catanzaro Lido.
Sappiamo, lo ha scritto il Quotidiano di Lecce, che Angelo Massaro, condannato
ingiustamente per un omicidio mai commesso, quello di Lorenzo Fersurella,
ammazzato a San Giorgio Jonico il 10 ottobre 1995, dopo ventuno anni di galera è
stato riconosciuto innocente grazie alla revisione del processo, in cui hanno
fermamente creduto i suoi avvocati, Salvatore Maggio e Salvatore Staiano. Ma non
sappiamo che già un’altra volta Massaro è stato vittima di un altro clamoroso
errore giudiziario, perché ritenuto l’autore di un altro omicidio, quello di
Fernando Panico, avvenuto a Taranto nel 1991. Anche allora, Massaro fu
arrestato, condannato a 21 anni, incarcerato per un anno e poi giudicato
definitivamente innocente e risarcito dallo Stato con 10 milioni di lire. «Non
pensavo che quattro anni dopo avrei vissuto lo stesso incubo — dice Angelo
Massaro — per una intercettazione telefonica in cui dicevo a mia moglie, in
dialetto, “tengo stu muert”, cioè “ho questo morto, questo peso morto”, un
Bobcat che trasportavo nel carrello agganciato all’auto e che dovevo lasciare
prima di andare a prendere mio figlio per accompagnarlo a scuola». Massaro era
intercettato per fatti di droga — che lo stavano rovinando, perché la assumeva e
poi l’ha anche spacciata —, ma paradossalmente proprio questa vicenda,
conclusasi con la sua condanna definitiva a 10 anni, lo ha salvato dalla seconda
ingiusta condanna per omicidio. «Ho sbagliato ed era giusto che pagassi, ma se
non ci fosse stato il processo per spaccio di droga, dal quale abbiamo tratto
gli elementi che mi hanno scagionato dall’accusa di omicidio, oggi per tutti io
sarei un assassino». Certo, adesso Massaro chiederà il risarcimento per ingiusta
detenzione, come fece undici anni fa, sempre a Taranto, Domenico Morrone, 15
anni di galera per un duplice omicidio mai commesso e poi riconosciuto innocente
e risarcito con 4,5 milioni di euro, forse la cifra record per questo tipo di
performance della giustizia italiana. «Ma nessun risarcimento mi ridarà i miei
anni perduti — dice lui — e mi consolerà delle afflizioni patite. Non ho visto i
miei figli per sette anni consecutivi, dal 2008 al 2015. Ho condiviso celle
minuscole con detenuti ammalati di Aids, tubercolosi, epatite C, senza che
nessuno mi avesse avvertito. Mi sono stati negati i permessi più semplici, come
quelli per il battesimo e la prima comunione dei miei bambini. E ora anche la
beffa finale. Appena avremo finito di parlare, devo presentarmi in Questura
perché mi hanno anche imposto la sorveglianza speciale. È questo il carcere che
rieduca? Dalla galera, esce carico di odio anche un cagnolino docile». Massaro
in carcere si è diplomato da geometra e si è poi iscritto a Giurisprudenza,
facoltà in cui ha già superato cinque esami con voti alti. «Studiare mi è
servito tanto — dice —, ma sono stati lo yoga, la meditazione e lo sport a non
farmi impazzire, a farmi chiudere un capitolo della mia vita sbagliata e a
sopravvivere alla persecuzione giudiziaria, che non auguro a nessuno».
Condannato per una parola
fraintesa viene assolto dopo 20 anni di carcere. L’incredibile odissea di Angelo
Massaro, 51 anni, scarcerato con revisione del processo. Pena di 30 anni per un
delitto mai commesso. Il suo avvocato: «E’ ancora sotto choc», scrive Michele
Pennetti su “Il Corriere della Sera” il 23 febbraio 2017. «Ho sentito Angelo
stamattina, appena uscito dal carcere di Catanzaro. Era ancora sotto choc, come
se fosse in preda a una piccola crisi di panico. Comprensibile, dopo 21 anni
passati ingiustamente in cella». Parola di Salvatore Maggio, l’avvocato
tarantino che ha portato avanti (e vinto) la battaglia di Angelo Massaro, 51enne
di Fragagnano, Comune a una quindicina di chilometri di Taranto, assolto dalla
Corte d’Appello di Catanzaro «per non aver commesso il fatto» dall’omicidio di
Lorenzo Fersurella, ucciso nell’ottobre del 1995, e dal reato di occultamento di
cadavere. L’uomo era stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione
(per cumulo di pene). Poi, però, la Corte di Cassazione aveva accolto la
richiesta di revisione del processo avanzata proprio dall’avvocato Salvatore
Maggio. La storia di Angelo Massaro, arrestato sulla base di una intercettazione
telefonica e di una dichiarazione di un collaboratore di giustizia che sosteneva
di aver appreso da altri del presunto coinvolgimento dell’uomo nel delitto, era
stata oggetto anche di una interrogazione parlamentare dei Radicali. Massaro,
arrestato il 15 maggio 1996, è stato in carcere a Foggia, Carinola (Caserta),
Taranto, Melfi e Catanzaro. Nei 20 anni di detenzione è stato spesso lontano
dalla residenza di famiglia e quindi dalla moglie e dai due figli. Dal carcere
Massaro ha scritto lettere di sensibilizzazione al blog “urladalsilenzio”, al
ministero della Giustizia, al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
all’associazione `Antigone´ e all’associazione “Bambini senza sbarre”. Il
difensore di Massaro è riuscito a dimostrare che il suo assistito si trovava in
una località diversa da quella dalla quale scomparve la vittima, depositando
atti, testimonianze e le intercettazioni di un altro procedimento giudiziario.
Nel 2011 Massaro era stato assolto dall’accusa di un altro omicidio avvenuto nel
1991. Ora il legale presenterà domanda di risarcimento per ingiusta detenzione.
Massaro è stato scarcerato dopo la sentenza, ma non ha ancora raggiunto la sua
famiglia. Il legale ha dimostrato che Massaro era stato condannato per una
parola equivocata. «A una settimana dall’omicidio, colloquiando con la moglie -
spiega l’avvocato - aveva detto, in dialetto, “tengo stu muert”, ma in realtà
voleva intendere "muers", cioè un materiale ingombrante attaccata al gancio di
un autovettura e che stava trainando. Poi ho trovato un certificato da cui
risultava che il mio assistito si trovava al Sert quando sparì Fersurella.
Insomma, tutta una serie di elementi che non erano stati presi in
considerazione. Sono contento per essere riuscito a dimostrare l’innocenza di
una persona ed è una grande soddisfazione per lui, per la sua famiglia e per
quello che è stato fatto».
Taranto, venti anni in
carcere per un omicidio mai commesso.
L'uomo fu ritenuto responsabile del delitto di Lorenzo Fersurella avvenuto a
Fragagnano, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno il 23 Febbraio 2017. Assolto per
non aver commesso il fatto. Ieri mattina è finito un incubo lungo 20 anni per
per il 51enne di Fragagnano, Angelo Massaro, assolto dalla corte d’appello di
Catanzaro, così come sollecitato dall’avvocato Salvatore Maggio dall’accusa di
aver ucciso Lorenzo Fersurella (morto il 22 ottobre del 1995), reato costato una
condanna definitiva a 24 anni di reclusione per Angelo Massaro, 20 dei quali
scontati ingiustamente, come ora si può serenamente affermare. L'uomo, arrestato
il 15 maggio 1996, è stato in carcere a Foggia, Carinola (Caserta), Taranto,
Melfi e Catanzaro. Il caso è giunto all’attenzione della corte d’appello di
Catanzaro a seguito dell’istanza di revisione del processo presentata
dall’avvocato Maggio, istanza che in un primo momento era stata rigettata dalla
corte d’appello di Potenza che l’aveva giudicata inammissibile. L’avvocato
Maggio aveva così proposto il ricorso in Cassazione e la Suprema Corte così ha
inviato gli atti a Catanzaro. Massaro fu condannato a 24 anni di reclusione
sulla base di una intercettazione telefonica e di una dichiarazione di un
collaboratore di giustizia che sostenne di aver saputo da altri del
coinvolgimento del Massaro nel delitto. L’avvocato Maggio ha invece
documentalmente provato che l’imputato si trovava in una località diversa da
quella dalla quale scomparve Fersurella (Manduria invece che Fragagnano),
portando a sostegno della tesi dell’innocenza di Massaro anche alcune
testimonianze e le intercettazioni del procedimento «Ceramiche» nel quale l’uomo
si professa più volte innocente. Per Massaro oltre all’assoluzione è scattata
contestualmente anche la scarcerazione. L’uomo, nel 2011, sempre difeso
dall’avvocato Maggio, era già stato assolto, per non aver commesso il fatto,
dall’accusa di omicidio di Fernando Panico, il corriere della droga ucciso nel
marzo del ’91. A oltre cinque anni di distanza dalla sentenza di primo grado,
che il 1° dicembre del 2005 lo condannò a 21 anni di reclusione, per Massaro era
arrivata l’assoluzione in appello. Ora l’avvocato Maggio valuterà tutta la
documentazione processuale per inoltrare domanda di risarcimento per ingiusta
detenzione. Nei 20 anni di detenzione è stato spesso lontano dalla residenza
famigliare e quindi dalla moglie e dai due figli. Dal carcere ha scritto lettere
di sensibilizzazione al blog «urladalsilenzio», al ministero della Giustizia, al
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, all’associazione Antigone e
all’associazione Bambini senza sbarre. «Finalmente è emersa una verità, che poi
è sempre la verità processuale che vorremmo tutti coincidesse con quella vera.
Posso dire con amarezza che c'è una persona che non ha commesso il grave reato
per il quale era stato condannato e che solo dopo 21 anni lascia le patrie
galere. La giustizia è fatta da uomini e come tali possono sbagliare tutti.
Faceva i colloqui - dice Maggio - con i familiari ogni 15 giorni. Penso che
tornerà a Fragagnano. I suoi figli ora sono maggiorenni. Quando fu arrestato il
secondogenito aveva appena 45 giorni. Questa è una storia molto particolare».
Lo arrestarono il 15 maggio
1996, aveva 30 anni. Un pentito, testimone "de relato" (riferiva cioè
informazioni apprese da altri), lo accusava dell’omicidio di Lorenzo Fersurella,
ucciso con colpi di pistola nel Tarantino per contrasti nell’ambito dello
spaccio di sostanze stupefacenti facendo sparire il corpo. Una parola
pronunciata in dialetto durante un colloquio con la moglie, che venne
equivocata, convinse gli inquirenti della sua colpevolezza. Ma dopo quasi 21
anni di carcere Angelo Massaro, 51 anni di Fragagnano (Taranto), è stato assolto
nel processo di revisione dalla Corte d’Appello di Catanzaro e scarcerato. E’
stato così ribaltato l’esito della sentenza definitiva che lo condannava a 24
anni di reclusione (diventati 30 per cumulo di pena comprensivo di una condanna
a 11 anni per associazione finalizzata allo spaccio di droga) per un omicidio
mai commesso. Angelo Massaro è tornato in libertà ieri, ma non ha raggiunto
subito la sua famiglia nel paese di origine. «Si sente un pò spaesato. Non è
facile - ha riferito l'avv. Salvatore Maggio, che ha difeso l’imputato con il
collega Salvatore Staiano - vedere dopo 21 anni sempre in una cella le macchine,
il bar, la strada. Il mondo è cambiato. Gli gira la testa, ha paura. Faceva i
colloqui con i famigliari ogni 15 giorni. I suoi figli ora sono maggiorenni.
Quando fu arrestato il secondogenito aveva appena 45 giorni». Non appena uscito
dal carcere, secondo quanto riferito dai suoi legali, Massaro ha detto: «Sono
felice, ma nulla potrà bilanciare le sofferenze che ho patito in questi
vent'anni». «Adesso - ha detto Angelo Massaro, mentre, a Catanzaro, sbrigava le
ultime questioni prima di tornare in Puglia - voglio giustizia. Se qualcuno ha
sbagliato voglio che paghi». «Lotterò - ha aggiunto - perché ciò che è successo
a me non capiti a nessun altro». Massaro, negli anni di detenzione, si è
diplomato e si è anche iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Catanzaro sostenendo 5 esami nell’ultimo anno grazie ad alcuni permessi
premio per buona condotta. Lezioni che gli sono servite dal momento che
l’istanza di revisione del processo che ha portato poi alla sua assoluzione è
stata curata anche da lui. La vicenda di Angelo Massaro era stata oggetto anche
di una interrogazione parlamentare dei Radicali. Nel 2011 fu assolto dall’accusa
di aver commesso un altro omicidio dopo l'annullamento con rinvio da parte della
Cassazione. Anche in quella occasione era stato chiamato in causa da un pentito.
L'uomo è stato detenuto a Foggia, Carinola (Caserta), Taranto, Melfi e
Catanzaro, quasi sempre lontano dalla sua residenza famigliare. In uno dei testi
inviati al blog "urladalsilenzio", Massaro (che avrebbe finito di scontare la
pena il 20 aprile del 2022) ha scritto: «Lo Stato ci ha tolto da tempo la
'famosa palla al piede', ma in una detenzione come la mia che è disumana, che so
i miei figli stare male a causa dei miei errori commessi in una vita sbagliata e
che lo Stato mi impedisce di incontrare, quella 'palla' mi è stata posta
nell’anima». Nel processo di revisione, i legali del 51enne sono riusciti a
dimostrare che il suo assistito si trovava a colloquio con una assistente
sociale in una località diversa da quella dalla quale scomparve Lorenzo
Fersurella e ha contestato l’interpretazione di una intercettazione telefonica.
«Ad una settimana dall’omicidio, parlando con la moglie - ha spiegato l’avvocato
Maggio - Massaro aveva detto, in dialetto, "tengo stu muert", ma in realtà
voleva intendere "muers", cioè un materiale ingombrante attaccato al gancio di
un’autovettura e che stava trainando. Finalmente è emersa una verità, che poi è
sempre la verità processuale che vorremmo tutti coincidesse con quella vera. Lui
non è uno stinco di santo, ha i suoi trascorsi. Ma posso dire con amarezza che
c'è una persona che non ha commesso il grave reato per il quale era stato
condannato e che lascia le patrie galere solo dopo 21 anni, dieci in più di
quanti ne avrebbe dovuti scontare in seguito alla condanna per droga. La
giustizia - ha osservato il penalista - è comunque fatta da uomini e, come tali,
possono sbagliare tutti». (di Giacomo Rizzo, ANSA) 23 Febbraio 2017.
Vent’anni dopo la condanna
emessa dalla Corte d’assise di Taranto, il cinquantunenne Angelo Massaro è stato
assolto dall’accusa di aver ucciso, il 10 ottobre 1995, Lorenzo Fersurella,
scrive Lino Campicelli su "Il Quotidiano di Puglia”. «Per uno sgarro nell’ambito
delle questioni di droga», fu la motivazione che sopravvisse alla causa di
secondo grado con conferma in Cassazione. Per rendere giustizia all’imputato
originario di Fragagnano, che ha passato tutti questi anni in carcere, è stata
però necessaria un’altra pronuncia della Corte di Cassazione che nel 2015,
accogliendo i rilievi mossi dall’avvocato Salvatore Maggio, prese una decisione
non consueta: disse “sì” alla revisione del processo. Il placet era giunto agli
inizi del maggio di quell’anno, dopo che l’avvocato Maggio aveva avviato la
richiesta di revisione del processo, basata sull’esito di indagini difensive con
le quali aveva puntato a scagionare l’imputato che era dietro alle sbarre.
Quella richiesta di revisione, per la cronaca, era già stata bocciata dalla
Corte d’appello di Potenza che l’aveva bollata come inammissibile. Contro quel
verdetto, però, l’avvocato Maggio aveva proposto ricorso in Cassazione. E la
decisione finale aveva premiato la sua tenacia. E quella dello stesso Massaro
che sin dal primo grado di giudizio, regolato da una sentenza emessa nel
novembre 1997, aveva gridato la sua assoluta estraneità all’omicidio. Nella
circostanza, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto
dall’avvocato tarantino, aveva rimesso gli atti relativi alla richiesta di
revisione ad altra sezione della Corte di appello. E il processo era sfociato
all’esame della Corte d’appello di Catanzaro che, appunto, ha mandato assolto
l’imputato per non aver commesso il fatto. Lorenzo Fersurella fu trovato privo
di vita in una cava alla periferia di San Giorgio Jonico, dopo la denuncia di
scomparsa presentata dal padre della vittima. Il giovane sangiorgese era stato
ucciso a colpi di pistola. I primi accertamenti avevano acceso i riflettori
sulla posizione di Massaro, del quale Fersurella era amico. Massaro, proprio in
ragione di quella amicizia vantata con la vittima, aveva da subito preso le
distanze da ogni responsabilità. Una intercettazione, il cui senso era stato
evidentemente equivocato, aveva indotto gli inquirenti a pigiare l’acceleratore
sulla sua presunta responsabilità. Nella intercettazione, l’uomo diceva alla
moglie che avrebbe tardato a rientrare perché aveva “qualcosa” da portare. Il
termine qualcosa, in realtà, aveva avuto una esplicitazione dialettale, il cui
senso cambiava a seconda della consonante finale. Per gli inquirenti, Massaro
doveva portare un “muert”: cioè il corpo privo di vita di Fersurella da far
sparire. Per Massaro, al contrario, quel qualcosa era un ““muers” che in
dialetto tarantino sta ad indicare un oggetto, un materiale particolarmente
ingombrante. Infatti, nessuno volle credere che l’uomo si stava riferendo a un
macchinario in panne. In aggiunta a quella interpretazione, però, a segnare la
sua fine giudiziaria, nel processo di primo grado, spuntò la dichiarazione di un
pentito secondo il quale «negli ambienti della malavita si diceva che ad
uccidere Fersurella fosse stato Massaro per motivi di droga». Massaro, il cui
difensore originario aveva rinunciato all’esame di alcuni testimoni che
avrebbero potuto scagionarlo, fu condannato. E quella condanna a 24 anni Massaro
se la trascinò sino a sentenza definitiva. Successivamente, però, grazie a
quelle testimonianze reintrodotte agli atti, a una perizia che chiarì il senso
del termine intercettato, cioè “muers” e non “muert”, e grazie soprattutto a un
documento scovato negli archivi da cui emerse che Massaro, nelle ore in cui
Fersurella fu ucciso, era nel Sert di Manduria per problemi personali, la
Cassazione rilevò la valenza e la necessità di una revisione del processo.
Chiusa ieri con l’assoluzione dopo vent’anni passati in carcere.
Angelo Massaro in cella per 21 anni da
innocente, scrive Simona Musco il 25 Febbraio 2017, su
"Il Dubbio". Angelo Massaro, 51 anni, ha passato la sua giovinezza a scontare
una condanna per aver ammazzato il suo amico, Lorenzo Fersurella, ucciso il 22
ottobre 1995 in Puglia. Ventuno anni in carcere sui 24 inflitti dalla giustizia,
dopo i quali è stato riconosciuto innocente. «Sono stato sequestrato dallo Stato
italiano per un reato mai commesso». Angelo Massaro parla con il Dubbio dopo 21
anni passati in cella, cercando di farsi ascoltare ma ci hanno messo la metà
degli anni che ha per dargli ragione. Oggi, a 51 anni, ha il resto della sua
vita davanti. Ma la sua giovinezza l’ha passata a scontare una condanna per aver
ammazzato il suo amico, Lorenzo Fersurella, ucciso il 22 ottobre 1995 in Puglia.
Ventuno anni in carcere sui 24 inflitti dalla giustizia, dopo i quali è stato
riconosciuto innocente. Il giorno dopo il processo di revisione celebrato a
Catanzaro, Massaro racconta i suoi anni in cella, arrestato per una telefonata
male interpretata dagli inquirenti. «Sette giorni dopo la scomparsa del mio
amico ho telefonato a mia moglie, dicendole di preparare il bambino per portarlo
all’asilo. Ho detto questa frase: «Faccio tardi, sto portando u muers» –
racconta al Dubbio -. Portavo dietro alla mia auto una piccola pala meccanica
per fare dei lavori edili per mio padre. Questa frase l’ho detta davanti ad
un’altra persona ma nessuno l’ha mai sentita». E nessuno, quel giorno, verifica
cosa effettivamente Massaro stia trasportando. Fosse stato lui, avrebbero potuto
beccarlo con le mani nel sacco. Invece prima di interrogarlo passano quattro
mesi. «Mi chiesero se ero mai stato a San Marzano, senza spiegarmi perché»,
dice. L’arresto scatta sette mesi dopo quella telefonata. «Era il 16 maggio
1996. Mi stavano arrestando per aver ammazzato una persona che consideravo un
fratello, l’uomo che aveva battezzato il mio figlio più grande, che avrebbe
dovuto battezzare anche il piccolo, il mio compare d’anello – racconta -. Sono
stato privato dell’affetto dei miei figli, della possibilità di vederli
sorridere, piangere, di una carezza. Ero incredulo ma avevo fiducia. Pensavo:
ora ascolteranno la telefonata e capiranno». Invece prima che qualcuno capisca
l’equivoco ci vuole molto tempo. Più la vicenda va avanti, più diventa grossa.
«Come potevano pensare che qualcuno trasportasse un cadavere sette giorni dopo
un omicidio alle 8.30 del mattino? Perché non mi hanno sentito subito? Avrei
potuto di- mostrare tutta la verità subito». Nessuna risposta a queste domande.
Massaro rimane fiducioso anche nel corso del processo. Al punto che la difesa
rinuncia ad ascoltare testimoni, sapendo che nessuna prova può dimostrare la sua
colpevolezza. «I testimoni dell’accusa non hanno dato elementi utili», spiega
infatti. All’improvviso, però, l’accusa tira fuori un pentito. «Ci siamo opposti
ma non è servito – racconta Massaro -. Il collaboratore ha soltanto detto che
secondo lui avrei potuto ucciderlo io il mio amico, tutto qua. Può bastare
questo? Non credo». Per tre gradi di giudizio, invece, è bastato. In appello i
legali chiedono una nuova perizia sulla telefonata e l’audizione di altri
testimoni, «ma ci è stato negato». E non serve nemmeno la testimonianza dei
carabinieri di Roma, che hanno spiegato come il tono di voce, nella telefonata,
fosse tranquillo e come quella parola incriminata – “muers” – possa avere
diverse interpretazioni. Nemmeno le sentenze hanno chiarito cosa sia accaduto
quel lontano giorno di ottobre, quando Fersurella venne ucciso. «Lo stesso
procuratore generale di Catanzaro ha criticato la sentenza, definendola piena
zeppa di errori», racconta. Il carcere. «Ho vissuto 21 anni di incredulità e
rabbia. Non ho mai accettato questa condanna, tremendamente ingiusta. Ho sempre
lottato, studiato sui codici e due anni fa mi sono iscritto a giurisprudenza a
Catanzaro. Mi ha portato avanti la rabbia, la sete di giustizia e verità»,
racconta ora come un fiume in piena. Quelli in carcere sono stati anni di abusi
di potere e violazione dei diritti umani. «Il ministero della Giustizia mi ha
sempre considerato pericoloso e fatto girare per molte carceri. Mi hanno
ritenuto insofferente nei confronti delle regole penitenziarie». E per sette
anni, dal 2008 al 2015, non ha potuto vedere i suoi figli. «Il tribunale aveva
certificato il loro stato di depressione causato dalla lontananza del padre da
casa. Nonostante il magistrato di sorveglianza di Catanzaro abbia richiesto il
trasferimento a Taranto, vicino ai miei figli – denuncia -, il Dap si è
completamente disinteressato». Le condizioni di vita dietro le sbarre sono state
a volte intollerabili. In cella, ad esempio, mancava l’acqua «e mi lavavo con
quella delle bottiglie, che ero io a comprare. E cosa è successo? Mi hanno
punito con l’isolamento per lo spreco d’acqua. Questa è solo una parte delle
cose subite. Ho visto gente perbene ma anche tanta violenza». La vita
fuori. Angelo Massaro oggi è nella sua casa. Spaesato, felice e arrabbiato al
tempo stesso. E vuole capire, vuole sapere perché sono stati commessi degli
errori. «Non do la colpa a nessuno, chiedo solo che vengano fatti degli
accertamenti, perché privare della libertà una persona a 29 anni è crudele e in
uno stato di diritto è immorale», dice. E invita a riflettere sullo stato della
giustizia in Italia, alla luce anche dei numerosi processi di revisione partiti
negli ultimi anni, sintomo di un sistema da rivedere. «Chi sbaglia è giusto che
paghi ma un giudice prima di condannare una persona e privarla della vita e dei
sui affetti deve chiedersi se lo fa oltre ogni ragionevole dubbio – evidenzia -.
Non provo rancore, voglio solo capire se questo errore poteva essere evitato».
Tornare a casa è stato strano, dice. Un’emozione che richiederebbe parole nuove.
Anche perché alla gioia di rivedere la moglie – che all’epoca aveva solo 22 anni
– e i suoi due figli, il più piccolo dei quali era nato soltanto da 45 giorni,
aumenta la sua frustrazione. «Perché ho fatto questi 21 anni di carcere?», si
chiede quasi ad intervalli regolari. Perché, ripete, è il carcere ciò che non
riesce ad accettare, «ma la condanna per un crimine così efferato – ha concluso
-. Non potevo sopportare che mi si accusasse della morte di un mio amico, non
volevo che la mia famiglia venisse additata. Ho lottato, non mi sono mai arreso.
Ma spesso mi chiedo: se fosse capitato a qualcuno meno forte di me e si fosse
ammazzato, chi avrebbe reso giustizia per lui?».
Taranto, la moglie dell'uomo assolto dopo
vent'anni: "Così ho atteso Angelo in carcere per errore".
Patrizia Massaro aveva 22 anni quando nel 1996 il marito fu arrestato con
l'accusa di omicidio, per un'intercettazione interpretata male. Ora è tornato in
libertà: "Ha trovato un altro mondo", scrive Vittorio Ricapito il 25 febbraio
2017 su "La Repubblica". Angelo Massaro è ancora spaesato, sta imparando a usare
lo smartphone. Entrò in carcere che aveva trent'anni, lasciando fuori l'Italia
del 1996, quella di Romano Prodi premier, del Milan di George Weah, della Terra
dei cachi di Elio e le storie tese per uscirne 21 anni dopo catapultato nell'era
dei social network. Fu condannato a 24 anni per l'omicidio di un suo caro amico
soltanto per la cattiva interpretazione di una frase dialettale intercettata al
telefono. Diceva alla moglie che portava un "muers", un carico ingombrante
attaccato all'auto. Gli investigatori pensarono si trattasse di un "muert", cioè
del cadavere. Una maledetta consonante cambiò il senso della frase e della sua
vita. La revisione dopo vent'anni in cella: non è lui il killer. Ieri per Angelo
Massaro il primo risveglio tra le braccia di sua moglie Patrizia, che in tutti
questi anni non lo ha mai abbandonato. E poi l'abbraccio con i figli Antonio e
Raffaele. Quando fu arrestato avevano due anni e mezzo l'uno e 45 giorni
l'altro. Ora sono adulti e lavorano.
Patrizia, ricorda la telefonata intercettata
che è costata la condanna a suo marito?
"Non ho fatto che pensarci per vent'anni. Io capii
cosa voleva dire Angelo e non replicai, ma per vent'anni mi sono detta che se
solo avessi pensato per un attimo che la frase poteva essere ascoltata da altri
e fraintesa gli avrei detto di chiarire, di precisare a cosa si riferiva e forse
gli avrei evitato a lui la condanna e a noi tante sofferenze. Avevo soltanto 22
anni quando fu arrestato mio marito. Ero una ragazzina inesperta e concordai con
gli avvocati di non parlare in aula. Durante il processo di revisione a
Catanzaro il procuratore generale mi ha rimproverata per questo errore e ha
voluto riascoltare la telefonata".
Suo marito aveva anche un alibi?
"Lorenzo Fersurella è stato nostro compare di
nozze, ha battezzato il mio primo figlio, uscivamo insieme e veniva spesso a
casa nostra. Il 10 ottobre passò a cercare Angelo e poi sparì. In serata
accompagnai mio marito al Sert di Manduria e dopo andammo a una festa in
famiglia. Ricostruendo questi movimenti i giudici hanno deciso che mio marito è
innocente, ma ci sono voluti 21 anni. Angelo fu arrestato otto mesi dopo
l'omicidio. Era il 15 maggio del 1996, due giorni dopo il nostro terzo
anniversario di nozze. Ricordo la camera di consiglio del processo di primo
grado: nel silenzio del tribunale mi sembrò anche di sentire un giudice che non
se la sentiva di condannare solo perché un pentito aveva sentito dire, ma non
andò così".
Dopo la sentenza definitiva suo marito le
chiese di rifarsi una vita.
"Lo fece con una lettera dal carcere. Lo andai
subito a trovare e gli dissi che non si doveva neanche permettere di pensare una
cosa del genere. Credevo nella sua innocenza e avremmo affrontato insieme la
battaglia".
Certo è stata lunga. Ci sono stati momenti
difficili?
"La maggior parte. Lui era in carcere da
innocente. Non ebbe il permesso neanche per partecipare al funerale del fratello
morto in un incidente due anni fa. Io dovevo affrontare la vita di una donna
sola con due bambini piccoli in un paese in cui ero guardata come la moglie di
un assassino. Sono arrivata a fare quattro o cinque lavori in contemporanea per
sostenere le spese legali".
Come si è comportata con i suoi figli?
"Li ho mandati a scuola lontano da Fragagnano,
perché non volevo che fossero additati come i figli del killer. Finché ho potuto
ho cercato di nascondergli la realtà, durante le visite dicevo loro che il
carcere era il posto di lavoro del papà. Poi hanno iniziato a leggere e capire.
Erano alle elementari e poco prima di Natale dissi la verità. Spiegai che il
papà era accusato di una cosa brutta, ma che era innocente. Crescere senza un
padre non è stato facile. Gli scrivevano sognando di andare al mare insieme al
suo ritorno. Anche Angelo ci scriveva tante lettere".
Dopo vent'anni arriva la revisione del
processo.
"Il giorno prima è stato il mio compleanno. Non
potevo ricevere regalo più bello, anche se abbiamo dovuto aspettare vent'anni.
Subito dopo la sentenza Angelo è scoppiato a piangere dicendo che finalmente
l'incubo era finito. Poi siamo andati per la prima volta a pranzo fuori, come
due fidanzatini, in un ristorante suggerito dalle guardie carcerarie".
E ora?
"Ora facendo la spesa in paese ho visto sguardi
diversi. Possiamo tornare a vivere. Non chiedo altro che invecchiare con mio
marito".
SONO INNOCENTE. ANNA MARIA
MANNA.
Un altro caso trattato è stato quello di
Anna Maria Manna avvenuto in Puglia, scrive "Il
Corriere del Giorno" il 5 febbraio 2017. Nel 1999 il paese di Palagiano
(Taranto) venne sconvolto da un’inchiesta giudiziaria: dei bambini di una scuola
elementare confessarono alle proprie maestre di aver partecipato a dei festini a
sfondo sessuale con degli adulti. Nell’inchiesta venne coinvolta anche Anna
Maria Manna, una giovane trentenne, perché, sebbene confusamente, viene
riconosciuta tra le foto mostrate dagli investigatori. La Manna passò 15 giorni
in carcere, prima a Torino, dove si trovava per un concorso pubblico proprio in
uno dei giorni in cui era svolto uno dei “festini”, poi trasferita a Taranto.
Viene additata come una pedofila, emarginata e minacciata. “Non so assolutamente
perchè sono finita nell’inchiesta ha dichiarato la Manna. Il suo legale Antonio
Orlando ha evidenziato gli errori “In un passaggio viene chiesto ad un bambino
se avesse toccato la donna e dove. Il bambino risponde: sul naso”. Ma nelle
trascrizioni compare ben altro: “davanti”. Il difensore della Manna ha trovato
molte altre incongruenze con le trascrizioni. Solo un bambino sostiene di aver
visto la Manna fare l’amore con un uomo. “Mi accusarono di essere in una di
queste feste. Mentre io ero a Torino. Ma questo non bastò agli inquirenti.
Grazie all’incidente probatorio, richiesto dal suo legale, si riuscì a provare
la sua innocenza. Infatti i bambini non la riconoscono. E’ la fine di un
incubo. Ma chi ha pagato per questo errore giudiziario? Solo la povera Anna
Maria. Che è stata risarcita dallo Stato con 63mila euro. La sua storia venne
trattata anche in un precedente programma della RAI “Presunto colpevole”.
Guardando gli abusi e follie giudiziarie del magistrato che ha ordinato per ben
4 volte la carcerazione del povero Lattanzi, abbiamo pensato alla richiesta di
arresti del nostro Direttore formulata da due pubblici ministeri dalla Procura
di Taranto sulla base del nulla (rigettata dal Gip del Tribunale ), entrambe
evidentemente a caccia di protagonismo mediatico (soltanto ?), le quali adesso
dovranno rispondere del loro operato dinnanzi alle Magistrature ed Autorità
competenti, ci viene spontaneo chiedersi: ma è questa la “giustizia” di cui
parla l’ ANM – Associazione Nazionale Magistrati ? Quando avremo anche in Italia
una “giustizia giusta”, e soprattutto quando i magistrati saranno chiamati a
rispondere dei loro abusi, omissioni e soprusi. Nei Paesi civili tutto questo
non accade…
SONO INNOCENTE. CLAUDIO RIBELLI.
La storia di Claudio Ribelli a Rai3, il
giovane di Sinnai accusato ingiustamente di rapina a “Sono Innocente”.
La storia di Claudio Ribelli a Rai2, il giovane di Sinnai innocente e accusato
ingiustamente di rapina ai danni di una donna. Claudio Ribelli è stato il
protagonista della puntata di sabato sera della trasmissione “Sono Innocente”
andata in onda, scrive il 12 marzo 2017 La Redazione di Vistanet. La storia di
Claudio Ribelli a Rai2, il giovane di Sinnai innocente e accusato ingiustamente
di rapina ai danni di una donna. Claudio Ribelli è stato il protagonista della
puntata di sabato sera della trasmissione “Sono Innocente” andata in onda su
Rai3 e condotta da Alberto Matano. Un anno di carcere (sei dentro e sei ai
domiciliari) per un reato mai commesso. Ha vissuto un incubo Claudio, operaio
che sette anni fa era stato ingiustamente reso colpevole di un crimine mai
commesso. Ribelli era stato accusato di aver rapinato una donna e di aver
puntato un coltello alla gola del suo bambino. Chiamato in causa dai carabinieri
del suo paese, Claudio dopo alcune titubanze da parte della donna era stato
indicato come esecutore della rapina. «Prima dell’arresto avevo chiesto alle
forze dell’ordine di confrontare le mie impronte digitali con quelle trovate sul
posto. Mi ero reso disponibile a qualsiasi tipo di controllo, anche a quello del
Dna. Mi risposero che non erano tenuti a farlo. Ho poi scoperto di essere finito
in prigione soltanto perché quella mattina al bar avevo offerto un caffè alla
persona che ha confessato il reato, mentre facevo una serie di commissioni tra
l’orto di casa e il paese». Il 19 ottobre 2010 due uomini erano entrati a casa
della donna fingendo di essere dei tecnici comunali. Uno di questi, Pierpaolo
Atzeni, aveva confessato il reato. A scagionare Claudio un video realizzato
dalla telecamera di una vicina stazione di servizio: qui è ripreso Atzeni,
l’autore della rapina, in compagnia di un altro giovane che non era sicuramente
Claudio Ribelli. La prova decisiva per la fine di un incubo. Un incubo che ha
lasciato strascichi seri, comunque. Terapie, un’invalidità e molti pensieri. Una
nota lieta: Claudio è un ragazzo per bene e non si è buttato giù. Ha conservato
la voglia di vivere, lavora il suo orto e ha un amore, sua moglie, che gli vuole
bene.
Sinnai, dopo un anno da innocente in
carcere per Claudio Ribelli 91mila euro di risarcimento,
scrive Radio Fusion. E' stato un anno da Incubo per Claudio Ribelli, l'operaio
di Sinnai finito sotto accusa per rapina. Ha dovuto scontare sei mesi a
Buoncammino e altri sei ai domiciliari, è stato scagionato grazie ad un video è
riuscito ad ottenere un giusto risarcimento. Nel novembre 2012 è stato assolto
dal giudice per le udienze preliminari per non aver commesso il fatto, e il Gup
ha di sposto nuove indagini a carico di un'altra persona. Ma in attesa della
sentenza lui ha scontato un anno di carcere con l'accusa gravissima di aver
puntato un coltello alla gola di un bambino, per rapinare la mamma di 100 euro e
una catenina d'oro. Claudio Ribelli, 28 anni, operaio edile di Sinnai, sarà
risarcito dal suo "un incubo durato un anno". La Corte d'appello di Cagliari ha
stabilito che lo Stato riconosca al ragazzo «91.082 euro» vista «l'ingiusta»
privazione della libertà personale patita. "Prima dell'arresto avevo supplicato
le forze dell'ordine di confrontare le mie impronte digitali con quelle trovate
sul posto, mi risposero che non erano tenuti a farlo" - racconta Ribelli «Quando
ero stato portato in caserma il giorno della rapina, non conoscevo il motivo. Ma
non ero stato arrestato perché la signora aveva detto: Non è lui. Poi, dopo un
mese aveva cambiato versione, così mi sono ritrovato in carcere da innocente,
soltanto perché quella mattina al bar avevo offerto un caffè alla persona che ha
confessato il reato. Essere risarcito mi sembra il minimo" Secondo l'accusa, il
19 ottobre 2010, due persone erano entrate a casa della donna fingendosi tecnici
comunali per rapinarla. Uno di questi era Pierpaolo Atzeni, 34enne di Sinnai, ll
quale aveva confessato ed era stato condannato in appello a cinque anni e 4
mesi. Ma il complice non era di certo Ribelli. Non lo dice soltanto la sentenza.
C'è anche un video ripreso da una telecamera di una stazione di servizio che lo
scagiona: si vede Atzeni in auto, pochi secondi dopo la rapina. con un ragazzo.
E questo non era Claudio Ribelli. La detenzione «ingiusta» ha provocato
«conseguenze familiari e personali», un «evidente clamore mediatico», l'offesa
«alla reputazione» (è «ancora giovane»), la «lesione al patrimonio personale e
morale».
SONO INNOCENTE. ANTONIO LATTANZI.
Ex assessore di Martinsicuro arrestato 4
volte:”Stavo per mollare…” (Sono innocente, 4 febbraio
2017). Antonio Lattanzi: a Sono innocente, su Rai Tre, la storia dell’ex
assessore all’urbanistica di Martinsicuro arrestato ingiustamente per 4 volte.
L’esperienza in carcere e il risarcimento, scrive il 04.02.2017 "Il
Sussidiario". Antonio Lattanzi è il protagonista dell’errore giudiziario che
verrà raccontato questa sera nel programma di Alberto Matano, Sono Innocente, su
Rai Tre. L’ex assessore all’urbanistica del comune di Martinsicuro, all’epoca
dell’assoluzione venne intervistato da Il Tempo, al quale non nascose come
l’esperienza dietro le sbarre lo stesse portando quasi a mollare la presa:”Nei
colloqui in carcere con mia moglie, davanti allo stillicidio delle diverse
ordinanze, sentivamo di doverci aggrappare a qualcosa. E così abbiamo deciso che
quando sarei uscito, finito quell’incubo, avremmo fatto un figlio. Da quel
dramma è nata una nuova vita, che ci ha permesso di andare avanti”. L’unico
aspetto positivo di una storia che avrebbe piegato chiunque, al netto di un
risarcimento di 55mila euro che non può ripagare neanche in minima parte la
sofferenza provata in questi anni. Questa sera a Sono Innocente, su Rai Tre, si
parla dell’odissea giudiziaria di Antonio Lattanzi, ex assessore all’urbanistica
del comune di Martinsicuro, in provincia di Teramo, finito in carcere 4 volte
ingiustamente. L’incubo per Lattanzi ha inizio nel 2001, quando un’indagine
della Procura di Teramo per una questione di tangenti all’interno dell’ente
porta all’arresto di Pierluigi Lunghi, funzionario dell’ufficio urbanistica che
nel 2004 patteggia una condanna a 2 anni di reclusione. Ed è proprio Lunghi,
accusato di concussione, a chiamare in correità Lattanzi e Giulio Cesare Maté,
allora capo della Polizia Municipale di Martinsicuro (poi assolto al pari
dell’ex assessore). Lattanzi in particolare è chiamato a rispondere di
concussione e abuso d’ufficio. Per lui le porte del carcere si aprono, purtroppo
per la prima volta, il 22 gennaio del 2002. Una sentenza del Tribunale del
Riesame lo riporta alla libertà, ma questa condizione dura poco: per altre tre
volte Lattanzi esce e rientra in carcere su richiesta della Procura,
trascorrendo in tutto 83 giorni di galera da innocente. La fine dell’incubo si
intravede nel 2006, quando il Tribunale di Teramo lo assolve: una sentenza
confermata successivamente in tutti i gradi di giudizio al termine di un iter
giudiziario durato in tutto 10 anni. Un caso di errori giudiziari perfetto per
il programma Sono Innocente.
SONO INNOCENTE. JOAN HARDUGACI.
Joan Hardugaci. Arrestato per
aggressione: vittima di uno scambio di persona (Sono
Innocente, 18 marzo 2017). Joan Hardugaci, il romeno arrestato nel 2009 per la
rapina ad una 77enne della provincia di Empoli e vittima di uno scambio di
persona (Sono Innocente, 18 marzo 2017), scrive il 18.03.2017 La Redazione de
Il Sussuadiario. Si potrebbe riassumere così la storia di Joan Hardugaci, un
uomo di origini romene, arrestato nel 2009 a Montelupo, in provincia di Empoli,
perché indicato come l’aggressore di un’anziana. Una rapina brutale, da cui ha
preso subito le distanze, ma che lo hanno portato dietro le sbarre per oltre un
mese. Per le tre settimane successive, Joan Hardugaci ha dovuto presentarsi in
Caserma per apporre la propria firma di presenza. Questa sera, sabato 18 marzo
2017, Sono Innocente racconterà il suo caso all’interno di una nuova inchiesta
sulle vittime degli errori giudiziari del nostro Paese. Secondo le indagini
dell’epoca degli inquirenti, Joan Hardugaci ha aiutato Gheorghe Sorin, un
connazionale, a rapinare la 77enne Maria Mostardini. L’anziana viene legata con
delle stringhe e messa a tacere grazie ad un cuscino sulla bocca. Come
sottolinea La Nazione, la rapina appare subito strana agli occhi degli
investigatori, dato che i ladri erano in possesso delle chiavi di casa della
vittima. Le indagini degli inquirenti risalgono subito a Joan Herdugaci. Per le
autorità è lui che assieme ad altri tre connazionali, di origine romena, si è
introdotto nella casa di Maria Mostardini e l’ha derubata. Il collegamento
avviene grazie all’arresto di Subtirelu, individuato in base alle conoscenza
della badante della vittima. Nonostante in tribunale Maria Mostardini non si
mostra sicura dell’identificazione di Herdugaci, quest’ultimo viene interessato
da una custodia cautelare. Più tardi, perderà anche il posto di lavoro. Si parla
infatti di una percentuale di appena del 50%: questo era quanto consentiva alla
vittima di dire con certezza che fra i rapinatori vi fose anche Joan Herdugaci.
Sei anni più tardi, il romeno è stato dichiarato innocente e i giudici hanno
valutato la detenzione ingiusta in un risarcimento di 253 euro per ogni giorno
trascorso dietro le sbarre e quelli vissuti in provvedimenti restrittivo.
Aggiunto alla perdita di lavoro, l’indennizzo è stato di circa 16 mila euro.
SONO INNOCENTE. VITTORIO LUIGI COLITTI.
Vittorio Luigi Colitti. Quattordici mesi
in carcere per omicidio e danni irreparabili. Assolto
nel 2012 (Sono innocente, 25 febbraio 2017). Vittorio Luigi Colitti: quattordici
mesi in carcere per omicidio e danni irreparabili. Assolto nel 2012, gli è stato
negato il risarcimento di 500mila euro (Sono innocente, 25 febbraio 2017),
scrive il 25.02.2017 La Redazione de Il Sussidiario. Non aveva nemmeno diciotto
anni quando è stato arrestato Vittorio Luigi Colitti: l’accusa era di aver
ucciso, insieme al nonno, Giuseppe Basile, un consigliere dell’Italia dei
Valori. L’omicidio era avvenuto davanti casa del politico a Ugento, in provincia
di Lecce, la notte tra il 14 e il 15 giugno 2008. Unica testimone una bambina:
testimonianza poi giudicata inattendibile in fase di processo. Vittorio Luigi
Colitti ha passato nel carcere di Bari quattordici mesi: quattordici mesi in cui
ha riportato gravi danni fisici e morali e che gli sono costati, secondo un
accertamento fatto dai consulenti dopo il rilascio, “un disturbo post traumatico
da stress di grado severo, attualmente in fase cronica, e con sopraggiunti
attacchi di panico senza agorafobia, con un danno biologico residuo pari al 35
per cento”. Gli viene però negato il risarcimento da parte dello Stato.
L’impianto accusatorio di Vittorio Luigi Colitti, si basava su una presunta
faida tra vicini, cosa che poi è stata smentita in fase di processo. Il ragazzo
è stato assolto prima nel 2010 dal Tribunale per i minorenni per non aver
commesso in fatto, e anche dalla Corte di appello nel 2012. Una vicenda che, pur
se ormai finita, ha lasciato dei segni indelebili nella vita e nel fisico di
Vittorio Luigi Colitti: vista la giovane età all’epoca dell’arresto, il ragazzo
è rimasto traumatizzato dall’accaduto, e ancora oggi deve fare i conti con i
danni causategli dall’ingiusta detenzione. Gli avvocati di Colitti avevano fatto
richiesta di risarcimento allo Stato per 500mila euro: richiesta che gli è stata
negata dalla Corte d’Appello perché avrebbe mentito sull’ora in cui si trovava a
casa ma, secondo la motivazione presentata dai legali in Cassazione, “il ragazzo
mentì solo all’inizio chiarendo poi subito dopo l’interrogatorio di garanzia
l’esatto orario di rientro in casa la notte in cui fu ucciso il povero Basile
spiegando le ragioni del mendacio iniziale dettato solo dalla paura di essere
coinvolto in una terribile vicenda giudiziaria.
Ugento: Vittorio Luigi Colitti, minorenne
accusato e in carcere per un omicidio mai commesso.
L'assassinio di Giuseppe Basile, a metà giugno 2008. Se ne parla a "Sono
innocente", scrive il 25 febbraio 2017Noi Notizie. La puntata di stasera del
programma “Sono innocente” (Raitre) descrive due casi. Quello di Gerardo De
Sapio, ad esempio: avellinese investigatore integerrimo, si fece un anno di
carcere perché sospettato di legami con la camorra. Nel 2009 venne completamente
riabilitato. C’è poi un caso pugliese, quello di Vittorio Luigi Colitti: in
galera a diciotto anni per un omicidio mai commesso. Dopo la vicenda di Angelo
Massaro di Fragagnano, alla ribalta in questi giorni (21 anni di carcere per un
clamorosissimo quanto gravissimo errore giudiziario) ecco un altro caso
sbagliato dall’amministrazione della giustizia. Di seguito il comunicato dello
Sportello dei diritti: Vittorio Luigi Colitti ha trascorso oltre quattordici
mesi presso l’istituto penale minorile di Bari per un omicidio che non ha mai
commesso. Infatti, ancora minorenne, è stato accusato (in concorso con il nonno
Vittorio) dell’omicidio di Giuseppe Basile, consigliere dell’Italia dei Valori,
assassinato davanti alla sua abitazione a Ugento – in provincia di Lecce – la
notte tra il 14 e il 15 giugno del 2008. Il giovane è stato assolto per ben due
volte. La sentenza è diventata definitiva e irrevocabile il 28 maggio 2013. Una
vicenda che ha segnato per sempre la vita del giovane e della sua famiglia.
Vittorio, un ragazzo come tanti, ha visto sgretolarsi nei mesi i suoi affetti,
gli studi, il lavoro e i legami più cari. Ha sviluppato, come accertato dai
consulenti, “un disturbo post traumatico da stress di grado severo, attualmente
in fase cronica, e con sopraggiunti attacchi di panico, con un danno biologico
residuo pari al 35%”.
Omicidio Basile, sette anni di misteri e
omertà in un delitto ancora senza colpevoli. Sono
trascorsi oltre duemila giorni da quell'afosa notte in cui Peppino Basile fu
massacrato con oltre venti coltellate. Non sono bastati tre processi a far
emergere la verità. Appello del comitato civico "Io conto" affinché non si
dimentichi la storia del consigliere comunale ucciso, scrive Andrea Morrone il
14 giugno 2015 su Lecce Prima. Ci sono vicende destinate a segnare per sempre la
storia di una comunità, a raccontarne difetti e debolezze, paure e omertà.
Quella dell’omicidio di Giuseppe Basile, il consigliere dell’Italia dei
Valori assassinato a Ugento la notte tra il 14 e il 15 giugno del 2008, è
divenuta prima un’inchiesta e poi un processo che, come spesso accade, ha
proiettato sul palcoscenico di un’aula di Tribunale, la storia, i vizi e le
virtù di un’intera collettività. Sono trascorsi ormai sei anni da quella notte
d’inizio estate, era da poco passata l’una, in cui Peppino Basile fu massacrato
con oltre venti coltellate. Da allora la macchina investigativa e quella della
giustizia hanno lavorato incessantemente alla ricerca di una verità che dopo
oltre duemila giorni da quel brutale omicidio appare ancora lontana. Piste
alternative, criminalità, vendette, rancori, tradimenti e sospetti hanno tinto
ancor più di giallo un delitto misterioso. Non sono bastati tre processi, tutti
conclusi con un verdetto di assoluzione, a fare luce sul delitto. Un’intera
famiglia è stata travolta da una vicenda giudiziaria in cui, lo dicono sentenze
(di cui una già definitiva), no avevano colpe. L’omicidio Basile ricalca alla
perfezione il più classico dei copioni di quella provincia addormentata, dove il
delitto sembra la più semplice delle cose. Quelle coltellate e quel sangue
rimangono, però, una ferita aperta nella voglia di giustizia e verità di tanta
altra gente che non vuole dimenticare. A distanza di sette lunghi anni da quella
brutale uccisione, il comitato civico "Io conto" definisce tutto ciò che è stato
fatto una “farsa”. “Una farsa - si legge nel comunicato – è stato l’intervento
sulla “scena del crimine”, dove chiunque vi ha potuto accedere senza ostacoli e
passeggiarvi dentro (basti vedere le immagini di repertorio dei telegiornali
delle primissime ore che seguirono il fatto); una farsa sono stati gli appelli
al silenzio per “non disturbare le indagini”; a nessuno è venuto in mente di
bloccare la raccolta dei rifiuti per la ricerca dell’arma del delitto; molto
breve ci è sembrato il tempo passato tra l’omicidio, le indagini autoptiche ed
il funerale, il tutto nell’arcodi 52 ore circa, come se si volesse mettere
subito un velo sulla vicenda. Chi ha spronato a parlare ha pagato di persona con
minacce, insulti e accuse”. “Le indagini sottolineano gli esponenti di Io Conto
– , durate ben 17 mesi e mezzo, hanno avuto come risultato l’arresto ed il
processo a due vicini di casa con il movente dei “futili motivi”, assolti dopo
quasi 5 anni per non avere commesso il fatto. Ed eccoci qui a chiederci ancora
se mai sapremo perché, e per volontà di chi, è stato ucciso Peppino Basile, che
amava spesso dire nei suoi comizi, in modi forse teatrali e coloriti, “…un
sogno…il mio sogno… che questa terra cresca. Sarei pronto anche al sacrificio
della mia vita pur di vedere crescere la mia terra, non per me ma per i nostri
figli…”, oppure “…in Ugento non esiste la mafia … c’è il Sistema….”. Sarà stato
un caso che dopo poco tempo spararono alla sua macchina e che lui parcheggiò in
piazza, crivellata di colpi, come per dire a tutti “vedete che ho ragione!”. “Il
momento storico in cui è avvenuto l’atroce delitto, può tranquillamente fare
pensare ad intromissioni non gradite a sistemi affaristici locali e non, di cui
purtroppo solo lui era a conoscenza, considerato l’agire solitario in cui si era
trincerato e in cui noi tutti l’avevamo relegato”. Questo il pensiero del
comitato civico. La morte di Peppino Basile, il muratore divenuto politico, metà
Masaniello e metà Don Chisciotte, uomo dalle mille battaglie, osteggiato e
spesso deriso, è sembrata quasi un peso fastidioso per la comunità ugentina e
non solo. Quello sull’omicidio di Peppino Basile è diventato, udienza dopo
udienza, molto più di un processo. Un viaggio attraverso il substrato sociale di
un Sud profondo e pieno di contraddizioni, in cui la verità sembra cambiar forma
in ogni istante. Un viaggio alla scoperta della vita di un piccolo paese del
basso Salento, pieno di silenzi e verità sospese a metà. Non sono bastati due
processi, centinaia di ore di dibattimento e decine di testimonianze per
squarciare il velo di silenzi e omertà che da subito è calato sull’omicidio. Un
processo che si è trasformato nel viaggio a ritroso dentro il ventre di un
Salento arcaico e di una terra che Sciascia avrebbe descritto proprio come la
sua Sicilia. Vittorio Luigi Colitti, il ragazzo accusato, in concorso con il
nonno, dell’omicidio, è stato assolto in via definitiva. Quel ragazzone dalla
faccia buona, travolto da una storia sembrata molto più grande di lui, ha subito
il lungo calvario di due processi e undici lunghissimi mesi di detenzione prima
di vedere riconosciuta la propria innocenza, grazie agli avvocati Francesca
Conte e Roberto Bray (saranno i giudici ora a stabilire l’eventuale
risarcimento). Il nonno, invece, è stato assolto in primo grado, in un processo
pieno di dubbi e poche certezze. Rimangono, infatti, molti lati oscuri attorno
alla ricostruzione fatta dall’accusa. Innanzitutto sul movente, quello dei
contrasti vicini, apparso subito fragile e che non ha mai avuto riscontri. Così
come la ricostruzione dell’omicidio e il ruolo dei presunti assassini, che
continuano ad apparire piuttosto complessi. Labile e poco credibile anche la
figura della presunta baby testimone del delitto, già smentita dai giudici. Al
di là di ogni sentenza e ogni verdetto, restano le verità nascoste di chi ha
visto e ha taciuto, di chi pur sapendo non ha parlato, di chi ancora considera
la legge come una rete fastidiosa in cui è troppo facile e scomodo rimanere
impigliati. Quelle sulla morte di Basile, comunque, sono state indagini
difficili e piene di ostacoli, che hanno cercato a fatica di squarciare il velo
di ostilità e reticenze. Perché quella tra il 14 e il 15 giugno 2008 è una calda
notte di giugno, afosa (proprio come quella appena trascorsa), in cui nessuno
sente le urla disperate della vittima (letteralmente squartato), il cui corpo
giace in mezzo alla strada, ben illuminato da un lampione. Una notte tragica in
cui nessuno, però, sembra aver visto nulla. È questa una delle peculiarità di
questa vicenda, avvolta da una fitta cortina di omertà e silenzi, che nemmeno
gli inquirenti sono riusciti a diradare. “Ci troviamo dinanzi a un’omertà senza
precedenti – ha detto il pubblico ministero Simona Filoni nel processo di primo
grado a Colitti junior –, in un luogo dove tutti sanno e nessuno parla, pensando
che forse è giusto così. In questo modo è come se Peppino fosse stato ucciso due
volte: la prima dai suoi assassini, la seconda dai suoi concittadini”. Quelle
coltellate e quel sangue rimangono, però, una ferita aperta nella voglia di
giustizia e verità di tanta altra gente che non vuole dimenticare. Già, perché
come ha scritto Voltaire: “Ai vivi dobbiamo rispetto, ai morti solo la verità”.
In attesa che la giustizia concluda il suo percorso tortuoso, rimane il
terribile sospetto che gli assassini di Basile siano liberi e impuniti e che
quello del politico amato dalla gente comune sia stato un delitto molto più
complesso di quello che si è immaginato. Peppino, forse, ha pagato a caro prezzo
le sue battaglie e la voglia di non fare mai un passo indietro.
SONO INNOCENTE. VITTORIO RAFFAELE GALLO.
Prosciolto dopo 13 anni: non era il
basista della Banda degli Onesti (Sono Innocente).
Vittorio Raffaele Gallo, condannato per essere il basista della Banda degli
Onesti, la gang di rapinatori che nel ’96 effettuò diversi illeciti (Sono
Innocente), scrive il 24.06.2017 Morgan K. Barraco su "Il Sussidiario". Dopo
diversi anni di onorato servizio alle Poste romane, Vittorio Raffaele Gallo
viene condannato a 6 anni di carcere con l’accusa di essere il basista di una
banda di rapinatori. Siamo nel novembre del 2004, quando il dipendente
dell’ufficio postale Bravetta viene condannato come membro di quella che verrà
chiamata la Banda degli Onesti. Nonostante l’accusa e relativa pena, Vittorio
Raffaele Gallo viene prosciolto da ogni accusa alcuni mesi più tardi, dopo
cinque mesi trascorsi in carcere e sette mesi che lo vedono agli arresti
domiciliari. La sua storia verrà raccontata all’interno della puntata di Sono
Innocente di questa sera, sabato 24 giugno 2017. I guai con la giustizia per
Vittorio Raffaele Gallo non finiscono tuttavia con l’assoluzione. Nel 2013 la
Corte dei Conti ha infatti condannato l’ex dipendente delle Poste ad un
risarcimento di oltre 557 mila euro per danno erariale, una cifra pari al
bottino sottratto dalla Banda degli Onesti nel 1996. La storia di Vittorio
Raffaele Gallo sembra costellata da ingiustizie. Non solo la condanna per essere
il presunto basista della Banda degli Onesti, a cui vennero attribuite due
rapine nella Capitale, ma anche per via di tutto quello che ha perso a causa di
quella pesante sentenza. Com’è facile immaginare, la condanna porta Gallo a
perdere il lavoro alle Poste, che svolgeva da diversi anni. E non solo, perché
nel 2004, quando i cancelli del carcere si chiudono dietro l’ex dipendente
postale, la moglie decide di lasciarlo e di vietargli di rientrare in casa.
Costretto quindi a condurre una vita fatta di stenti, Vittorio Raffaele Gallo
può destreggiarsi solo fra lavoretti saltuari ed una pensione sociale
accordatagli per via della dialisi, che lo rende un invalido del 100%. Una spada
di Damocle che inizia tutta quel giorno, quando un gruppo di rapinatori entra
nell’ufficio delle Poste in cui lavora Gallo. Siamo nel 1996 e Vittorio Raffaele
Gallo lavora da diversi anni alle Poste di Roma. Un impiego sicuro, che svolge
con passione e professionalità. Tutto cambia quando dalle porte dell’ufficio
entra quella che in seguito verrà conosciuta come la Banda degli Onesti, un
gruppo di rapinatori che decreterà la condanna al processo del dipendente
postale e di altre tre persone. Apprezzato dai collegi per via del suo ruolo di
sindacalista, Gallo non è l’unico che finisce nel mirino degli inquirenti. Al
suo fianco ci sono infatti il 59enne Franco Fuschini, a cui verranno attribuite
altre rapine effettuate a Bologna, il 42enne Giorgio mariotti ed un autista del
trasporto pubblico di Livorno, Bruno Del Moro. Ricevono tutti una condanna in
primo grado di giudizio fra i 4 ed i 6 anni. Come sottolinea Errori Giudiziari,
per nessuno dei quattro ci sono prove sufficienti a stabilirne la colpevolezza e
i sospetti si basano su intercettazioni particolari, prive della perizia fonica
e quindi successivamente considerate irrilevanti.
SONO INNOCENTE. MICHELE TEDESCO.
Imprenditore rovinato dai pentiti: lo
accusarono di essere uno spacciatore (Sono innocente).
Michele Tedesco: l’imprenditore nel luglio del 1997 venne arrestato
ingiustamente con l’accusa di acquisto, possesso, vendita e distribuzione di
sostanze stupefacenti (Sono Innocente), scrive l'11.03.2017 La Redazione de Il
Sussidiario. Michele Tedesco, imprenditore di Gravina di Puglia, è il
protagonista di Sono innocente, il programma in onda stasera su Rai Tre.
L’errore giudiziario che coinvolge Michele ha inizio nel luglio del 1997, quando
Michele viene tratto in arresto nella sua abitazione dai carabinieri di
Altamura, che lo ammanettano e lo confinano in una cella d’isolamento del
carcere di Bari. I reati contestati a Tedesco, incredulo fin dall’arrivo dei
carabinieri nella propria residenza, come riportato da aivm.it, sono
“l’acquisto, il possesso, la vendita e la distribuzione di diverse sostanze
stupefacenti, quali eroina, cocaina e hashish, sia in campo nazionale che
internazionale”. In poche parole, Michele Tedesco viene accusato di essere uno
spacciatore. Fin dai primi colloqui con il Gip, l’imprenditore dichiara la
propria estraneità ai fatti e si dichiara innocente, ma passa un mese prima che
gli vengano concessi gli arresti domiciliari. Questo provvedimento resta in
vigore per 4 mesi, ma Tedesco è chiamato comunque a non allontanarsi dal proprio
luogo di residenza con l’obbligo di firma giornaliera. La vicenda vede la
propria conclusione, con l’assoluzione piena di Michele Tedesco, soltanto il 14
febbraio del 1998: ad incastrarlo furono le false accuse di alcuni pentiti.
Il Caso Di Michele Tedesco: Malagiustizia
O Errore Giudiziario? Scrive Elisa il 13 Marzo 2013 su
AIVM. L’esito: errore giudiziario o malagiustizia? All’udienza preliminare
tenutasi il 14 Febbraio 1998, il GUP Dott.ssa Daniela Rinaldi dispose l’invio a
giudizio di Michele Tedesco innanzi alla Corte di Assise di Bari. Durante il
processo di primo grado la posizione di Tedesco venne a mano a mano chiarita
fino a quando, a distanza di ben 9 anni dall’arresto, su richiesta avanzata
dallo stesso P.M. Dr. Elisabetta Pugliese, la Corte di Assise adotta
una sentenza di assoluzione dell’imputato con ampia formula di merito (allegato
3). Nonostante le sofferenze subite durante l’ingiusta prigionia e nonostante la
sentenza che lo dichiara estraneo ai fatti, Michele Tedesco continua a pagare
ancora oggi le conseguenze di un gravissimo errore giudiziario. Il caso di
Michele Tedesco: vittima di un errore giudiziario che gli ha stravolto la vita.
Michele Tedesco (Gravina di Puglia), all’epoca dei fatti imprenditore
regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Bari, nato ad Altamura 41 anni
fa, è stato vittima di un terribile errore giudiziario che ha completamente
stravolto la sua vita. Era il 18 Luglio 1997 quando alle cinque del mattino i
Carabinieri della Caserma di Altamura bussavano alla sua porta di casa per
notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal GIP
Dott. Antonio Diella su richiesta del P.M. Dr. Leonardo Rinella. I reati di cui
veniva accusato, nell’ambito del procedimento penale n. 53/95 R.G.N.R. Procura
della Repubblica di Bari – DDA -, erano l’acquisto, il possesso, la vendita e la
distribuzione di diverse sostanze stupefacenti, quali eroina, cocaina e hashish,
sia in campo nazionale che internazionale. Il capo d’imputazione così recitava:
“dei reati di cui all’art. 73 c. I, V,e VI, art. 74 c. I, III, V, art. 80 c. I
lett. A) e c. II dpr 309/90 per avere, associandosi fra loro e con altre persone
in associazioni distinte ma spesso fra loro di volta in volta collegate,
acquistato, detenuto, venduto, ceduto e distribuito e, comunque, procurato ad
altri sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina ed hashish nei luoghi e nei
tempi di cui al capo A), sia in campo nazionale che in campo internazionale”.
“In Gravina in Puglia ed altre città limitrofe fino alla data della presente
richiesta (08 marzo 1997).” Senza rendersi conto di quello che stava accadendo,
Michele Tedesco venne portato in caserma per redigere i primi atti e quindi
venne condotto presso il carcere di Bari, dove, dopo il disbrigo di tutte le
formalità di ingresso di un detenuto, venne messo in una cella di
isolamento. Durante i successivi interrogatori di garanzia Michele Tedesco
rispose alle domande che il GIP gli pose non senza dichiarare ripetutamente la
propria innocenza e la propria estraneità ai fatti di cui veniva accusato. In
data 1° Agosto 1997 il GIP modificò la misura cautelare in custodia cautelare
domiciliare (allegato 1) e così Michele Tedesco poté ritornare nella sua
abitazione dove vi rimase per 4 mesi, fino al 13 Novembre 1997. Nonostante la
revoca degli arresti domiciliari, Michele Tedesco ricevette il divieto di
allontanarsi dal luogo di residenza con l’obbligo di firma giornaliera, fino al
23 Dicembre 1999 (allegato 2), presso la Caserma dei Carabinieri.
SONO INNOCENTE. ROBERTO GIANNONI.
Di Roberto Giannoni, febbraio 2003 su “Ristretti”.
Roberto Giannoni è stato al centro di una terribile vicenda giudiziaria che ha
sconvolto la sua vita e distrutto la sua famiglia. Bancario, direttore della
filiale di Sassetta della Cassa di Risparmio di Livorno, viene arrestato il 10
giugno 1992 dagli uomini della DIA di Firenze con l’accusa di associazione a
delinquere di stampo mafioso, usura, concorso in usura, estorsioni, riciclaggio,
traffico di stupefacenti ed armi. Tutto si regge sulle dichiarazioni rilasciate
da due collaboratori di giustizia. Gli vengono negati gli arresti domiciliari,
resta in carcere per 12 mesi, di cui 10 sotto il regime del 41 bis in custodia
cautelare. Viene assolto su richiesta della stessa procura al termine di un
processo durato quasi quattro anni ed una vicenda durata sei anni sei mesi sei
giorni. Nel frattempo ha perso il posto di lavoro, il padre è morto di
crepacuore un mese prima dell’inizio del processo, la madre un mese dopo la
sentenza, sfinita dall’angoscia. Su questa vicenda ha scritto un libro, Hotel
Sollicciano - 12 mesi in una suite dello Stato a mezza pensione. Quella che
segue è una testimonianza che Roberto Giannoni ci ha mandato, contattandoci
attraverso il nostro sito. È difficile da spiegare, da capire, da far credere
come un click possa cambiarti per sempre la vita. È quello delle manette che ti
scattano ai polsi alle 4,15 di mattina nel bel mezzo di una vita passata a
lavorare sodo e seriamente, prima di quel momento non si può immaginare cosa
possa essere l’arresto, cosa significa perdere la libertà, non essere più
padrone di te stesso. Oggi paragono le parole del mio avvocato che dopo aver
parlato con i poliziotti mi disse: "Roberto, ti arrestano", alle parole che i
medici mi dissero pochi istanti prima che mio padre e mia madre morissero:
"Roberto, stanno per morire". Non sapevo cosa fosse la morte e fino a quando
vedevo il respiro non riuscivo a capire, a spiegarmi come una persona potesse
morire, così fino a quando non ho sentito quel click non sapevo cosa fosse un
arresto. Ma soprattutto non ci credi: non credi che una persona a te cara possa
andarsene per sempre e finché vedi un respiro speri che non muoia mai, e così
fino a che non senti il click non credi che a te innocente possano toglierti la
libertà
Dopo quel click ho lasciato la mia casa con i miei
genitori atterriti e smarriti in mezzo al corridoio, un’immagine che rimarrà per
sempre nella mia mente. Sconcerto e disperazione è stata la prima sensazione.
Una vita distrutta in pochi minuti. Portato via sottobraccio dai poliziotti, il
"mio mondo" è scomparso. Sono stato fatto salire su di un’auto ed ho iniziato un
lungo viaggio, che mi ha portato ad attraversare due mondi nuovi. Non vedevo più
nulla intorno a me, lo sguardo si perdeva nel vuoto, non focalizzavo più,
sentivo le voci ma non vedevo le persone, una folle corsa a sirena spiegata fino
ad arrivare in Procura, quindi "spinto" senza poter ragionare, rendermi conto di
dove mi trovavo, interrogato per ore ed ore e poi di nuovo via di corsa sempre a
sirene spiegate, fino ad arrivare al carcere, e qui con un lugubre rumore si è
spalancato il grande cancello e sono entrato nel tunnel della carcerazione. Sono
entrato come per incanto in un mondo che non conoscevo ma che è sempre esistito,
ed in quel momento così disperato il detenuto che mi ha accolto era la persona
che più capiva il mio dolore, perché chi soffre dietro quelle sbarre può capire
veramente la sofferenza di uno che sta entrandoci. La sorpresa di aver trovato
nel compagno di cella un’umanità semplice, povera ma sincera, non riusciva a
togliermi il trauma della limitazione di spazio, dover dividere una cella di 12
mq. con un’altra persona con la quale non c’era nessuna affinità. Lo scandire
concitato dei tempi e delle cose che si devono fare in veloce sequenza, con ogni
giornata sempre identica alle precedenti, mi facevano arrivare rapidamente al
momento in cui spegnevano la luce e rimanevo al buio con la disperazione che si
faceva più grande. Parlavo, ascoltavo gli altri detenuti, ognuno di loro aveva
una parola buona quando con il pianto cercavo di alleviare un po’ la sofferenza,
rispondevo loro con dei cenni, annuivo accettando i loro consigli, ma dentro di
me ero con il pensiero lontano da loro, da quel mondo, vivevo ora dopo ora
pensando di tornare nel mondo che avevo lasciato, era lì che io ero sempre con
la testa. Dopo pochi mesi sono stato trasferito sotto il regime del 41 bis, la
massima restrizione carceraria, il carcere duro, quello dei mafiosi. Mi giravo
intorno, assente con la mente, ma ero sempre in compagnia di un pensiero che non
mi lasciava mai, la testa mi scoppiava, sentivo solo vuoto ed abbandono. Il
passo delle guardie ed il tintinnio ferreo delle chiavi riuscivano a distrarmi
un momento ed era come mi fermassi sull’orlo del precipizio: quel suono di
chiavi era la voce che mi urlava l’istante prima di gettarmi nel vuoto. L’urlo
del silenzio era assordante, più mi tappavo le orecchie e più si faceva forte.
C’era il conforto della fede con il cappellano del carcere che aveva sempre una
parola di aiuto per tutti, c’erano i medici, psicologi, psichiatri, assistenti
sociali, persone civili che ti portavano negli incontri un pezzo di quel mondo
che ricordavo ed al quale mi avevano ingiustamente strappato, ma io mi sentivo
ed ero innocente e mi ritrovavo in un luogo dove si espiano le condanne, ed
allora davanti a queste persone, ognuna delle quali svolgendo il suo lavoro
cercava di aiutarmi, io mi sentivo in difficoltà, provavo disagio, vergogna,
sarei tanto voluto sparire. Il tempo scorre rapido, può sembrare strano, sei
spinto continuamente dalla conta del mattino fino alla sera quando ti chiudono
il blindato, ma anche perché speri di correre incontro al processo e per un
innocente l’assoluzione dovrebbe essere sicura, ma i dubbi, le angosce, il
perverso evolversi della vicenda, ti mette tutto in discussione e ti pone
terribili interrogativi. Passi le ore, abbarbicato al cancello con la faccia
spiaccicata alle sbarre per avere un campo visivo maggiore.
L’angoscia di affrontare un processo con il
terrore di non riuscire a dimostrare la mia innocenza. Sotto il regime del 41
bis, due colloqui al mese con i miei genitori, biancheria ridotta
all’essenziale, pantaloni senza cintura, due ore sole di aria al giorno, nessuna
possibilità di cucinare, a gomito e branda con i boss, quelli veri. Lì, mi
sembrava di rivivere il film "Il Padrino". All’inizio nessuno di questi signori
mi rivolgeva parola, poi piano, piano vengo avvicinato, mi si chiede il nome, la
professione e perché mi trovo lì. Declinate le mie generalità dico: associazione
a delinquere di stampo mafioso. Qualcuno mi guarda con sospetto, altri accennano
un sorriso, un vecchio boss mi guarda dall’alto in basso e sentenzia: voi siete
un coglione, altro che un mafioso. Questa sezione mi vedrà ospite per 10 mesi,
per tutto questo periodo godrò delle gentilezze dei miei scomodi vicini di casa,
ma non riesco, non mi è possibile sentirmi un inquilino di quei palazzi. Ed è
arrivato dopo 365 giorni il giorno della scarcerazione. L’euforia di tornare
libero è durata poco, quando la guardia mi ha comunicato che ero libero ho
esultato, preparato in fretta le poche cose che avevo, salutato fugacemente gli
altri detenuti e dentro di me ho pensato: sono libero, ritorno, finalmente, nel
mio "mondo". Ma dopo l’abbraccio con i familiari e gli amici che erano ad
attendermi, fatti alcuni passi mi sono fermato ed un pensiero mi ha subito
assalito la mente: stavo entrando in un mondo del quale sentivo di non fare più
parte. L’angoscia di affrontare un processo con il terrore di non riuscire a
dimostrare la mia innocenza unito al fatto di incontrare persone, anche
conoscenti, nelle quali leggere velatamente una forma di dubbio, avere la
sensazione che chi ti parla non vede l’ora di finire la conversazione, bussare a
tantissime porte e accorgerti che, con una scusa banale, tutti ti negano un
lavoro, tutto ciò rafforzava in me la convinzione di essere in un mondo che non
conoscevo, che non era più quello che avevo lasciato e per il quale avevo
trascorso il mio tempo con il desiderio di ritornarci. Ora, libero, volevo
fuggire da quel mondo e quando al mattino uscivo di casa, evitavo le strade del
centro cercando di incontrare meno persone possibile, mi sentivo un oggetto
misterioso motivo di curiosità. È il momento in cui scopri gli amici veri,
quelli che non hanno aspettato l’assoluzione per credere in me e darmi il loro
affetto, ed è così che comincia a maturare verso questo mondo un rapporto dove
la fiducia non è più totale. Questo sentimento infatti non passa più per il
cuore, ma attraverso le valutazioni più fredde e razionali della mente. Finivo
per rifugiarmi nel retrobottega di tre amici, lì mi sentivo più tranquillo,
ritrovavo un pizzico di serenità e speranza ed anche un po’ di quel mondo che
avevo lasciato. Dopo aver ascoltato la sentenza che decretava l’ assoluzione, il
mio pensiero è corso subito alla memoria di mio padre ed a mia madre che stava
morendo in ospedale colpita da un tumore sconosciuto, ma anche ad Aldo, Carlo e
Leoluca, i tre amici che mi accoglievano nel loro retro bottega aiutandomi
infinitamente. In quel momento ho capito che forse avevo abusato della loro
grande disponibilità e fraterna amicizia, mettendoli con la mia presenza in
difficoltà, ed ero contento per loro della mia assoluzione che li gratificava,
ma chissà quanta amarezza e dispiacere avrei dato loro se colpito anche solo da
una piccola condanna. Continuavo comunque ad avere la sensazione che tutti mi
guardassero, e camminavo a testa china evitando gli sguardi anche di chi non
conoscevo, era un rigetto istintivo verso quel mondo dal quale mi sentivo
abbandonato, tradito proprio da quei valori sociali e morali nei quali avevo
sempre creduto.
ROBERTO GIANNONI. Il banchiere di
Livorno, 12 mesi di calvario ingiustificato (Sono
Innocente, 4 marzo 2017). Roberto Giannoni, l’ex banchiere di Livorno condannato
a 12 mesi di carcere per presunta associazione a delinquere ed in seguito
scagionato (Sono Innocente, 4 marzo 2017), scrive il 04.03.2017 La Redazione de
"Il Sussidiario". Molteplici i casi di ingiustizia giudiziaria, che spesso
portano i protagonisti a vivere un calvario fatto di calunnie e accuse, oltre ad
una detenzione ingiusta. Uno dei casi più eclatanti è senza dubbio Roberto
Giannoni, il direttore di banca di Livorno che nel giugno del 1992 è stato
arrestato per divere accuse. Fra queste usssura, estorsione e affiliazione a
organizzazioni criminali di stampo mafioso. Quattro anni di processo ed un anno
in tero di detenzione: questa la pena scontata da Giovanni Giannoni, che ha
dovuto ripartire da zero una volta conclusa l’inchiesta sul suo conto.
L’indagine che ha gravato sul banchiere e sulla sua famiglia è scattata grazie
alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, che lo hanno portato a 2
mesi di carcere e 10 di custodia cautelare. Questa sera, sabato 4 marzo 2017,
Sono Innocente affronterà la vicenda nella sua puntata, in onda su Rai 3. Di
tutto quello che ha vissuto, sottolinea La Nazione, Roberto Giannoni ha parlato
a lungo all’interno del suo libro “Hotel Sollicciano – 12 mesi in una suite
dello Stato a mezza pensione”, con cui affronta stati d’animo e pensieri che lo
hanno attraversato in quel periodo. Una volta conclusa la vicenda giudiziaria,
Giannoni ha ingranato nuovamente, ricucendo gli strappi della propria vita.
L’anno scorso è stato inolte ricevuto da papa Francesco, in occasione del
Giubileo della Misericordia. Nel momento in cui Roberto Giannoni finisce in
carcere, al suo fianco, simbolicamente, si trova tutta la sua famiglia.
L’arresto, soprattutto alla luce dell’innocenza del banchiere livornese, gli
vale subito la perdita del lavoro ed il tracollo emotivo. Il padre invece, a cui
era molto legato, è deceduto un mese prima del processo, mentre la madre un mese
dopo la sentenza di proscioglimento. “Sfinita dall’angoscia”, sottolinea in
un’intervista recente a Il Tirreno, ma nonostante tutto, Roberto Giannoni è
riuscito a risalire la china, aiutando tanti carcerati al meglio delle proprie
possibilità. Allo stesso modo, durante la sua permanenza in carcere si era
offerto di aiutare gli altri detenuti a fare i conti e scrivere lettere, dato
che la maggior parte è analfabeta. Una possibilità per sopravvivere all’interno
di una realtà difficile ed in cui fortunatamente è riuscito a ritagliarsi uno
spazio di rispetto e solidarietà.
SONO INNOCENTE. SANDRA MALTINTI.
Quando a cambiarci è un’ingiustizia,
Sandra Maltinti. Libri: Quando a cambiarci è
un’ingiustizia, Sandra Maltinti. In carcere ingiustamente: la storia di Sandra
Maltinti. Intervista a cura di Cinzia Ficco
Pubblicato lunedì 23 Nov 2009 in Libri su "Voglio Vivere Così". Due mesi e mezzo
di carcere subito ingiustamente. Tanta sofferenza. Fango gettato sulla sua
professionalità ed una dignità su cui c’è ancora qualcuno che sputa veleno.
Dall’incubo si sta riprendendo, grazie all’amore della sua famiglia che non l’ha
mai abbandonata in “quell’universo di donne urlanti”. Tanti i ricordi e i
rimpianti. E’ la storia di Sandra Maltinti, architetto, residente ad Empoli, che
ha trascorso settantadue giorni nel carcere di Sollicciano senza avere alcuna
colpa. E’ stata arrestata con l’accusa di reati contro la pubblica
amministrazione a Portoferraio. Maltinti aveva lavorato per diverse
amministrazioni comunali come dirigente dei settori di assetto del territorio.
Arrestata il primo giugno del 2004, è stata protagonista di Elbopoli. Da questa
esperienza ha tratto un libro “L’Isola che non c’è” (Società editrice
fiorentina). “Novanta pagine per non dimenticare – spiega- e mettere a nudo le
illusioni e i miti ingannevoli sul mondo che sopravvive dentro le mura del
carcere, quel mondo parallelo che da fuori è proibito vedere e immaginare”.
Dunque, architetto, una brutta storia.Come è
cambiata la sua vita? E’ difficile rialzarsi?
«Quando non hai
più niente ad un tratto scopri quali sono le cose più importanti della vita: la
famiglia , gli amici, quelli veri che sanno fin dall’inizio che non può essere
vero. Il mio libro è dedicato a loro. Sì, a quelli che non ci hanno mai creduto».
E il suo lavoro?
«Ah, quello è
perso. Non riesco più a trovare una pubblica amministrazione e un sindaco che
credano veramente che era una balla. Se uno è stato in galera - dicono - una
ragione ci sarà pure stata».
Cos’è il carcere vissuto da un innocente?
«La galera è un
universo di donne urlanti. Ma le loro voci giungono silenziose nel mondo che non
le può sentire, che ignora la loro esistenza: dura, giorno dopo giorno».
Anche lei ha provato ad urlare?
«Sì, ma ho
aspettato settantadue giorni perché la mi voce oltrepassasse la cortina
impermeabile del carcere . Io ci sono riuscita. Ma poverette quelle che non
hanno un bagaglio di cultura, forza e soldi. Dopo il carcere ingoiate in
quell’inferno che ti porta di nuovo indietro. Il mio pensiero va spesso a loro».
Ci racconta in poche battute cosa è successo?
«Tutto è nato
da un presunto abuso edilizio , una denuncia di inizio di attività redatta da un
tecnico. Ci voleva la concessione, dice il consulente della Pubblico Ministero,
o almeno un’autorizzazione comunale. Forse il consulente non era aggiornato sul
fatto che la legge non prevedeva più l’autorizzazione , e le modifiche interne
agli edifici erano soggette A Denuncia di Inizio di Autorità, come era stato
fatto».
Strano questo errore dovuto ad ignoranza!
«Anche se una
ragione in realtà non c’era dominavano pressapochismo e smania di notorietà.
Tutta la mia storia e altre sono state pubblicate in un libro di un giornalista
di sinistra che ha ricostruito i fatti secondo la sua logica».
La stampa ha dato un prezioso contributo!
«Eh sì, si veda
il sito camminando.org di questo giornalista per capire quanto la stampa uccida
piu che la spada».
Perché tanta cattiveria?
«La minoranza
non ci dava pace, vedeva che il comune cominciava a funzionare e faceva di tutto
per mettersi di traverso nei consigli comunali, sui giornali, denunce alla
magistratura. Di tutto. Il motivo era che non si poteva permettere ad una giunta
di destra di fare di più e meglio di una di sinistra con la Provincia e la
Regione che remavano contro. Sempre la politica, anche quando non c’entra niente».
E ora? Ha avuto giustizia, anche se con
ritardo!
«Ripenso spesso
al tempo della galera con nostalgia».
Davvero?
«Non perché
abbia voglia di riviverlo, giammai, ma perché l’amicizia con le mie compagne di
cella e di tutte le donne senza voce è stata veramente toccante. Vorrei fare di
più per loro, per quelle che non possono difendersi e non hanno un bagaglio di
cultura e forza come il mio. Parlo anche di possibilità economiche. Il carcere
annienta, non serve a riabilitarti».
Perché dice questo?
«Una delle due
compagne di cella quando è uscita non aveva da mangiare e dopo tre giorni si è
dovuta prostituire. Poi tutto torna inevitabilmente come prima se non c’è
nessuno che ti aiuta».
Sandra Maltinti, una dirigente in piedi,
scrive il 19 febbraio 2017 Eticapa. Sandra Maltinti, classe 1955 (vedi
curriculum), non é una dirigente pubblica sugli altari delle cronache nazionali
e di lei sapremmo poco se la sua vita professionale non fosse stata
caratterizzata da due eventi contrastati e drammatici, il primo dei quali
(una reclusione nell’anno 2004 per un fatto mai commesso) rischiò di piegare la
sua stessa vita. Una trasmissione di ieri sera su RAI 3 (vedi podcast) ha
rievocato la sua storia: laureata in architettura, vincitrice di un concorso
pubblico, divenne Direttrice dell’Ufficio tecnico del Comune di Portoferraio
(isola d’Elba) e, in questa veste, predispose il piano urbanistico comunale. Un
esposto anonimo pervenuto alla Magistratura (nonché una furibonda campagna di
stampa contro il sindaco dell’epoca) innescò un’indagine per presunto
favoreggiamento e voto di scambio: l’indagine portò al suo arresto nel giugno
2004 – vedi qui articolo dell’epoca – per associazione a delinquere (gridò ai
due figli, quando vennero ad arrestarla all’alba, “non vi vergognate perché io
non ho fatto niente“) e a una successiva detenzione durata 70 giorni e terminata
a motivo di una gravissima crisi depressiva accertata a livello medio-legale.
Insieme a lei erano state arrestate 5 persone, fra le quali il Sindaco di
Portoferraio, 71 anni, che morì poco tempo dopo essere stato rilasciato dal
carcere. Nel luglio 2008 tutti gli imputati furono assolti “perché il fatto non
sussiste”: il dibattimento aveva dimostrato che il castello di accuse era basato
sulle maldicenze e ipotesi accusatorie espresse da oppositori politici di
giunta, mai prima verificate con altre, opposte testimonianze. L’Architetto
Maltinti ha ieri raccontato di essere stata remunerata per l’ingiusta detenzione
con 30.000 euro, ma ciò non basta: dovette combattere (vedi qui sua conferenza
stampa) per ottenere le retribuzioni arretrate che le erano dovute dal Comune di
Portoferraio. E’ sempre bello rispondere che “sì, é giusto!” impegnarsi per uno
Stato che non ti riconosce quell’onore che ci richiede l’articolo 54 della Carta
costituzionale. Tuttavia, il tema della coerenza con i principi etici di un
dirigente pubblico si è riproposto nella storia professionale di Sandra
Maltinti circa 6 mesi fa, quando, dopo essere risorta a una nuova “vita”
professionale come direttore generale del Comune di Livorno nominata nell 2014
dal sindaco Filippo Nogarin, é stata licenziata in tronco dallo stesso sindaco.
Lungi dal voler entrare in aspetti politico/partitici di questa vicenda e
premettendo che la figura del direttore generale dei comuni è prevista come
incarico di capo della struttura amministrativa – di fiducia del vertice
politico, mette conto, comunque, di citare alcuni passi della nota che
l’Architetto Maltinti ha inviato al sindaco lo scorso giugno 2016: “se un
Dirigente pone a un atto un parere negativo, non è perché non è d’accordo con
l’atto o esercita la propria opinione politica, ma è perché l’atto contrasta con
le leggi in vigore, infatti si chiama: parere tecnico di legittimità“….”I
Dirigenti sono tenuti per legge a TUTELARE l’azione dell’Ente, e sottoscrivere
solo atti legittimi e ne rispondono personalmente“…..”Il Sindaco, gli Assessori
ed anche alcuni membri del Consiglio Comunale mostrano di non aver capito la
distinzione prevista dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali, ndr) tra indirizzo
politico e gestione amministrativa e tendono a prendere decisioni operative e
pretendere che i dirigenti appongano a valle delle loro scelte, il loro parere,
sovrapponendosi di fatto all’azione dirigenziale” “alcuni assessori e
consiglieri comunali, “per realizzare le loro personali iniziative, pongono in
essere indebite ingerenze, rivolgendosi direttamente agli impiegati più
accondiscendenti, che, molto spesso, non riferiscono ai Dirigenti preposti, con
conseguenti sovrapposizioni, malintesi e disservizi”. A quelle affermazioni
il sindaco Nogarin ha prontamente risposto argomentando che “il comportamento
tenuto dal direttore rappresenta un fatto di una gravità tanto rilevante da
giustificare la revoca dell’incarico e il recesso dell’amministrazione dal
contratto di lavoro“….”il direttore ha lanciato accuse gravissime nei confronti
dell’amministrazione, accusando me, la giunta e i consiglieri di gravi ingerenze
nei confronti della macchina amministrativa. Tutto questo senza però fare alcun
riferimento a fatti specifici o procedimenti utili ad accertare la veridicità di
quanto riportato”…. “Se davvero avesse avuto a cuore il buon funzionamento della
macchina amministrativa, avrebbe dovuto chiedere un confronto con il
sottoscritto. Così non è stato. Ha preferito lanciare pubblicamente le sue
accuse”- vedi qui meglio. Questa seconda vicenda della storia professionale di
Sandra Maltitnti, certo meno drammatica della prima, testimonia però della
stessa posizione di debolezza della dirigenza pubblica, una sorta di anello
debole in una catena di poteri pubblici che possono scaricare tensioni e
responsabilità utilizzando il dirigente come una sorta di “parafulmine”
istituzionale. il principio di separazione fra poteri di indirizzo
politico-amministrativo e potere di gestione è ancora molto, molto lontano dal
concretizzarsi nella realtà, proprio in quelle Amministrazioni che maggiormente
necessiterebbero dell’assoluta neutralità e autonomia della macchina
amministrativa. Continua a regnare, piuttosto, non la separazione, ma una
completa incomunicabilità nei comportamenti, nel linguaggio e nell’orientamento
operativo fra i due “ambiti”, politico e burocratico.
Sei
condanne e 2 assoluzioni per Elbopoli. Dopo sei ore di camera di consiglio,
nell’aula del tribunale di Genova entra il collegio con la sentenza di Elbopoli,
una delle bufere giudiziarie che si è abbattuta sull’Elba in quella calda estate
del 2003 e che ha coinvolto un giudice, alti rappresentanti delle istituzioni,
imprenditori. A distanza di oltre 6 anni
dalla bufera giudiziaria i giudici (presidente Dagnino, a latere Lepri e
Panicucci) hanno accolto la ricostruzione dell’accusa sostenuta dal pm Paola
Calleri anche se le condanne sono state inferiori rispetto alle richieste del
pubblico ministero e due imputati sono stati assolti. Quando i giudici leggono
la sentenza in aula c’è un solo imputato: Giuseppe Pesce, ex prefetto di Isernia
e all’epoca dello scandalo commissario prefettizio di Rio Marina. L’ex capo dei
gip livornesi Germano Lamberti - che era in aula prima che il collegio si
ritirasse - è stato condannato a 3 anni per corruzione in atti giudiziari e
assolto invece dall’accusa di peculato e dalla corruzione con gli imprenditori.
Un anno e
4 mesi a Vincenzo Gallitto, ex prefetto di Livorno, per favoreggiamento in
corruzione e 8 mesi per peculato; due anni e 2 mesi per corruzione per Giuseppe
Pesce che ha annunciato che andrà in appello ritenendosi estraneo alle accuse
("Voglio essere assolto e non mi basta la prescrizione", ha detto); 3 anni e 4
mesi per gli imprenditori pistoiesi Franco Giusti e Fiorello Filippi condannati
per un solo episodio corruttivo che fa riferimento alla Costa dei Barbari;
un anno e 8 mesi per abuso di ufficio e falso a Gabriele Mazzarri, ex
responsabile dell’edilizia privata del Comune di Marciana.
Al centro
delle indagini della Finanza partite da una segnalazione del Corpo Forestale due
complessi edilizi: il centro servizi di Procchio nel Comune di Marciana e la
ristrutturazione della Costa dei Barbari, un’ex discoteca a Cavo nel Comune di
Rio Marina. Per gli inquirenti intorno a
quei due complessi, sui quali lavorano Giusti e Filippi, si sarebbero scatenati
interessi di vario tipo. L’allora prefetto Gallitto avrebbe fatto da
intermediario tra i costruttori Giusti e Filippi, il progettista Coppetelli ed
il giudice Lamberti perché quest’ultimo rigettasse la richiesta di sequestro
preventivo del Centro Servizi. In cambio, per l’accusa, il giudice avrebbe avuto
a prezzo di favore 2 case a Cavo e una a Procchio. Appartamenti a prezzo di
favore, per l’accusa, anche per Gallitto e Pesce che da commissario aveva
nominato consulente all’edilizia privata del Comune Coppetelli che era il
progettista della ristrutturazione di Cavo.
A Genova
c’erano alcuni familiari delle vittime del Moby Prince. "Avrei voluto guardarlo
in faccia. Ho accolto questa condanna con rabbia",
ha detto Loris Rispoli, presidente dell’Associazione 140,
parlando di Lamberti che era presidente del Tribunale al processo che mandò
tutti assolti. "La condanna in atti giudiziari del giudice Lamberti apre scenari
anche sulla tragedia del Moby, scenari che la Procura di Livorno non potrà non
considerare".
Un buco nero che si spalanca davanti a una delle
vicende giudiziarie più controverse della storia italiana. Non si sono fatte
attendere le reazioni dei familiari delle vittime della tragedia del Moby
Prince, il traghetto che andò a fuoco dopo uno scontro con la petroliera
dell'Agip Abruzzo, dramma nel quale la sera del 10 aprile 1991 persero la vita
140 persone di cui molti sardi, dopo la condanna dell'ex capo dei Gip del
tribunale di Livorno durante il processo per la tragedia.
Il presidente della prima sezione penale del
tribunale di Genova, Giuseppe d’Agnino, dopo oltre sei ore di camera di
consiglio, aveva letto la sentenza di condanna per sei degli otto imputati nel
procedimento riguardante vari scandali immobiliari nell’Isola d’Elba: tra questi
c'è anche l’ex capo dei Gip di Livorno, Germano Lamberti, presidente del
Collegio giudicante nel processo sul disastro della Moby Prince, in cui furono
assolti tutti gli imputati perché «il fatto non sussiste».
La sentenza verrà però parzialmente riformata in
appello: la terza sezione penale di Firenze dichiarò il non doversi procedere
per intervenuta prescrizione del reato. Secondo le accuse, Lamberti, in concorso
con altri due imputati, avrebbe ottenuto appartamenti in un residence di lusso
in cambio di agevolazioni per la realizzazione di un centro servizi nel comune
di Marciana. Secondo il pm, inoltre, il giudice Lamberti non sequestrò
volutamente un cantiere irregolare.
Tra il pubblico, al processo nei confronti di
Lamberti, erano presenti alcuni familiari delle vittime della Moby Prince. «La
sentenza del tribunale di Genova che ha condannato per corruzione il Presidente
del Collegio giudicante del processo Moby Prince amareggia ed inquieta». Sono le
prime parole di Angelo Chessa, presidente dell’associazione “10 aprile”, che
raccoglie alcuni familiari delle vittime morte nel 1991 nel traghetto che entrò
in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno,
nel commento dell’esito del processo genovese nel quale l’ex giudice Germano
Lamberti era imputato per una vicenda diversa.
«Abbiamo - ha aggiunto Chessa - aspramente
contestato il modo in cui il processo fu condotto e la sentenza successivamente
emessa dal tribunale di Livorno. Ciò ci porta a tornare indietro con la mente e
non siamo sereni».
Sono stati svolti due processi sulla tragedia
della Moby Prince, dai quali non è emersa nessuna responsabilità precisa: la
tragedia è quindi ufficialmente ascritta alla distrazione che sarebbe regnata a
bordo del traghetto (si parlò a lungo anche del fatto che sia il personale di
bordo sia i soccorritori sarebbero stato distolti dalle loro mansioni da
un'importante partita di calcio che si stava svolgendo quella sera).
MAI DIRE ELBOPOLI.
La corte d'appello di Genova ha inflitto 4 anni e
4 mesi di reclusione all'ex prefetto di Livorno Vincenzo Gallitto e 4 anni e 9
mesi all'ex capo dei gip livornesi Germano Lamberti al processo d'appello per la
vicenda di "Elbopoli" che aveva coinvolto otto persone, imputate a vario titolo
di corruzione, peculato e favoreggiamento. E' stato invece assolto, ma solo per
prescrizione dei reati l'ex prefetto di Isernia Giuseppe Pesce, già vice di
Gallitto a Livorno. In particolare, secondo l'accusa Lamberti, Pesce e Gallitto
avrebbero ottenuto appartamenti in un residence di lusso in cambio di
agevolazioni per la realizzazione di un centro servizi nel comune di Marciana. I
giudici, che sono rimasti in camera di consiglio per oltre quattro ore, hanno
condannato a tre anni e sei mesi l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del
comune di Marciana (Livorno), Gabriele Mazzarri, a cinque anni ciascuno gli
imprenditori edili pistoiesi Franco Giusti e Fiorello Filippi, a due anni
l'immobiliarista Francesco Sinisgallo ed a un anno e sei mesi a Luigi Logi,
nella sua qualità di sindaco di Marciana. Sinisgallo e Logi hanno beneficiato
della sospensione condizionale della pena. Il processo di appello per
"Elbopoli", gli scandali edilizi dell'isola d'Elba la cui pentola fu
scoperchiata da Legambiente con un dossier sulla piccola isola di Cerboli, si è
chiuso a Genova con una brutta sorpresa per quasi tutti gli imputati. Infatti le
pene sono state aumentate rispetto alla prima istanza, con l'esclusione dell'ex
vice prefetto dell'Elba dell'epoca (e poi prefetto di Isernia), ma solo per
prescrizione dei reati, mentre gli è stata confermata l'assoluzione per il
peculato. E' andata peggio agli altri imputati eccellenti: la Corte di appello
di Genova ha inflitto 4 anni e 4 mesi di reclusione all'ex prefetto di Livorno
Vincenzo Gallitto (2 anni in primo grado); 4 anni e 9 mesi all'ex capo dei Gip
livornesi Germano Lamberti (3 anni in primo grado). La sentenza riguarda affari
e scambi di favori edilizi che coinvolgono due complessi elbani l'ex discoteca
"Costa dei Barbari" nella frazione di Cavo, Comune di Rio Marina (tornata al
centro delle polemiche con il nuovo Regolamento urbanistico) da trasformare in
appartamenti sul mare e il cosiddetto "ecomostro di Procchio" rimasto uno
scheletro di cemento a pochi metri dal mare della frazione del Comune di
Marciana e per il quale gli ambientalisti chiedono la demolizione. I giudici
genovesi hanno condannato a 3 anni e 6 mesi l'ex responsabile dell'ufficio
tecnico del comune di Marciana Gabriele Mazzarri (1 anno e 8 mesi in primo grado
e Mazzarri aveva già ricevuto una condanna per un'altra vicenda edilizia) e a 5
anni ciascuno gli imprenditori edili pistoiesi Franco Giusti e Fiorello Filippi
(3 anni e 4 mesi in primo grado), che risultano ancora i proprietari
dell'isolotto di Cerboli dopo innumerevoli tentativi di vendita. 2 anni la
condanna per l'immobiliarista Francesco Sinisgallo e 1 anno e 6 mesi per Luigi
Logi (che si è sempre detto estraneo alla vicenda), l'ex sindaco di Marciana
eletto in una lista civica sostenuta dal centro-sinistra, entrambi erano stati
assolti in primo grado e hanno beneficiato della sospensione condizionale della
pena.
Un’assoluzione e cinque prescrizioni. Teletirreno
ha dato notizia così della conclusione di un’altra vicenda giudiziaria elbana.
Una vicenda che suscitò grande impressione. Quella dei lavori alla piazza della
Chiesa di Marciana Marina. Sette persone furono arrestate all’alba del primo
maggio del 2004. Si parlò e si scrisse di un appalto "ammaestrato”. Sei anni
dopo, all'esito del processo, il geometra portoferraiese Boris Gasparri è stato
assolto perché risultato estraneo alle problematiche riguardanti il profilo del
contratto d’appalto al centro del procedimento. Il giudice ha ritenuto di non
dover procedere, per avvenuta prescrizione, anche nei confronti degli
imprenditori Camillo Caldarera, Salvatore Pezzotta e Fiorenzo Batignani, e
dell'archietto Lionello Balestrini, allora direttore dei lavori. Purtroppo non
ha avuto il tempo di assistere alla conclusione della vicenda che l’aveva
coinvolto l’architetto Luca Tantini. L’ex tecnico comunale di Marciana Marina,
infatti, nei primi giorni di dicembre del 2005 è morto, a soli 56 anni, ucciso
da un male improvviso e inesorabile. Una fine drammatica. La moglie e le figlie,
in una lettera toccante piena di un dolore ancora incredulo pubblicata da
Giovanni Muti nel suo “Affari e politica. Il caso è chiuso!”, hanno scritto di
quanti sono “stati travolti, insultati, umiliati nel pubblico e nel privato,
tanto colpiti che ne è risultata persa, non solo la serenità, la professione, la
famiglia ma anche la vita”.
Ha pagato con la vita Tantini, come Giovanni
Ageno. Entrambi travolti da quella che allora fu chiamata Elbopoli. Una serie di
casi giudiziari fra loro legati solo da una lettura “politica”. Quella che
voleva l’Elba - così alcuni dissero e scrissero – in preda “all’istinto
predatorio”, all’“emergenza legalità”, a “intrecci pericolosi”, alla “perversa
spirale del malaffare”. Coloro che furono coinvolti nel caso “Affari e
politica”, politici e imprenditori, furono assolti perché il fatto non sussiste,
perché la stessa pubblica accusa riconobbe la totale insussistenza delle accuse
più gravi e infamanti, che allora furono addotte per giustificare il carcere, e
misure restrittive lunghe e pesanti. A sei-sette anni da quelle vicende, dopo
l’ennesima assoluzione, sarebbe giusto forse domandarsi cosa resta di quella
“Elbopoli”. Qual è il bilancio giudiziario di quei casi, e quale il bilancio
politico. E, se la storia insegna davvero qualcosa, sarebbe giusto chiedersi
perché tutto ciò è successo, e come si può impedire che accada di nuovo.
Il fatto non sussiste un’altra volta. Un’altra
assoluzione, doppia. Ma mentre ci rallegriamo per le ultime sentenze di
proscioglimento che hanno riguardato l’ex vicesindaco di Campo, Enrico Graziani,
non possiamo non rilevare che il suo non è un caso isolato, anzi è solo l’ultimo
di una lunga serie. E riteniamo che l’Elba non possa più eludere una riflessione
politica su cosa è stato e su quali effetti ha prodotto il giustizialismo, anche
all’isola.
Molti anni sono passati, dai primi drammatici
casi. Si coniò allora la parola Elbopoli, per marchiare l’isola con l’ombra di
un sospetto: quello di un malaffare diffuso e generalizzato. Amministratori,
professionisti, politici e imprenditori sono stati indagati o arrestati, sono
rimasti in carcere per settimane e mesi. Hanno pagato un prezzo alto, hanno
visto compromessa la serenità, la salute, a volte la loro vita. Le loro famiglie
sono state distrutte o sottoposte a prove durissime. E a distanza di anni di
quelle accuse, di quei teoremi non è rimasto niente. Fatti che non sussistono,
accuse che non hanno retto alla prova del processo, anzi a volte sono state
ritirate o derubricate dai magistrati incaricati della pubblica accusa.
“Presunto colpevole”, la Rai racconta il caso
Ageno. In onda alle 23,25 del 7 maggio 2012 la puntata del programma Tg 2
condotto da Fabio Bonini dedicato alla vicenda del 2004. Fra gli intervistati
Nicola Ageno, Tiziano Nocentini, Sandra Maltinti, Alberto Fratti Paolo Chillè.
Ancora riflettori accesi sul caso giudiziario che
nel giugno 2004 sconvolse Portoferraio e l’Isola d’Elba. Il programma del TG2
“Presunto colpevole”, condotto da Fabio Massimo Bonini, in onda domani alle 23 e
25, ripercorrerà la vicenda di Giovanni Ageno, sindaco di Portoferraio dal 1999
al 2004. Un fatto giudiziario che sconvolse Portoferraio, quello degli arresti
del sindaco e di suo figlio Nicola, oltre che dell’assessore Alberto Fratti, del
capo dell’ufficio tecnico Sandra Maltinti e degli imprenditori Tiziano Nocentini
e Marco Regano. L'operazione fu condotta a una settimana dalle elezioni
amministrative, ed evidentemente è ancora visto dalla stampa nazionale come
esempio eclatante di errore giudiziario, anche per la maniera in cui si è
conclusa la vicenda: l’ex sindaco morì dopo alcuni mesi dal suo arresto, gli
imputati, dopo essere stati accusati di vari reati, tra cui l’associazione a
delinquere e il voto di scambio, per un’intricata ipotesi di affari e
urbanistica poi rivelatasi infondata anche agli occhi del pm, furono assolti
“perché il fatto non sussiste” con la sentenza di primo grado arrivata nel 2008.
Il programma Rai, che ogni settimana affronta i casi italiani di
“malagiustizia”, ricostruisce la vicenda, dall’avvio delle indagini nel 2003
fino a quando - nel 2009 - la Procura di Livorno decise di non ricorrere in
Appello facendo così calare il sipario sul caso. Per ricostruire il caso sono
stati intervistati l’architetto Sandra Maltinti, l’ex assessore Alberto Fratti e
il giornalista Paolo Chillè di Teleelba.
"AFFARI E POLITICA, IL FATTO NON SUSSISTE". E’
uscito il libro inchiesta di Giovanni Muti su una delle pagine più nere della
storia elbana: il calvario di coloro che furono arrestati nel 2004 e dopo anni
scagionati da ogni accusa. Cosa successe in quei giorni?
Riaprire le ferite. Scrivere altre pagine di una
storia che finalmente poteva essere chiusa con quella sentenza di assoluzione
“perché il fatto non sussiste”. Ma scrivere altre pagine e riaprire le ferite
forse è inevitabile, per una questione di rispetto: della verità e della
dignità. Per questo è uscito nelle librerie “Affari e politica a Portoferraio –
Il fatto non sussiste” (ed. Forte Inglese). Un’inchiesta di Giovanni Muti che
ripercorre una delle pagine più nere della storia elbana recente. Politici,
imprenditori, tecnici, uomini, donne, mariti: arrestati all’alba come criminali
comuni; spesso come tali trattati. Si scrisse di un “violento comitato d’affari”
e di una “perversa spirale di malaffare”. Ingiustamente, si è visto molto tempo
dopo, quando è stata lo stesso pm a smontare la gran parte delle accuse. E il
giudice il resto. Allora però il caso era appetibile, come pochi: c’era il
sindaco di Giovanni Ageno, medico di famiglia stimato, due lauree, colto,
elegante, che in modo sorprendente aveva conquistato il Comune praticamente da
solo, lui e gli uomini della sua lista civica. E da solo fu lasciato. Lo ricorda
impietosamente Muti: a difendere pubblicamente la sua onorabilità solo pochi
politici: Francesco Bosi, Pino Lucchesi, Elba 2000. Con Ageno fu arrestato un
assessore, Alberto Fratti. E l'architetto Sandra Maltinti. E ancora il maggiore
imprenditore dell’isola, Tiziano Nocentini e il suo stretto collaboratore Marco
Regano. E altri ancora. Voto di scambio, associazione a delinquere finalizzata
alla corruzione e alla concussione, abuso d’ufficio: l’accusa era terribile, e
arrivava a pochi giorni dalle elezioni. Il libro è uscito a pochi giorni dalle
stesse elezioni Comunali, Provinciali ed Europee, questa inchiesta di Giovanni
Muti: “Non è un caso – spiega l’autore – qualcuno me lo ha fatto notare e mi
sono posto il problema se non fosse necessario un distacco maggiore. Invece no,
perché il distacco non è possibile, e questo è anche un atto riparatore”. “Ci
sono stati drammi incredibili, e danni collaterali. E’ successo qualcosa di
molto grave in quei giorni, Io speravo che dopo l’assoluzione la stampa locale
desse il giusto risalto all’esito della vicenda, come lo aveva dato agli
arresti, e invece non è stato così. Si sono defilati. Non tutti, ma molti”.
Tutti sanno come finì: Ageno fu eletto consigliere, tornò in Consiglio per
dimettersi, ma non era più lui. Il suo calvario finì pochi mesi dopo. È morto
per un infarto nel febbraio 2005. Prima di poter leggere quelle sentenze di
completa assoluzione. Nel libro c’è anche la vicenda dell’architetto Luca
Tantini, e la testimonianza toccante della moglie. Con un lavoro di archivio
giornalistico meticoloso, Muti ricostruisce quelle vicende, e le inserisce in un
contesto politico e storico ben preciso. Teletirreno ha intervistato Nocentini,
Fratti e Regano (la loro testimonianza è nel video pubblicato insieme a questo
articolo). “Io stavo male – ricorda Fratti – ma non per me, per chi era fuori.
Io pensavo ai miei cari”. “Spero che questo libro - ha detto Regano – possa far
capire davvero cosa è successo, cosa abbiamo passato e cosa ci hanno cucito
addosso”. “Certe cose non si dimenticano – ha detto ai microfoni di Teletirreno
Tiziano Nocentini – noi stiamo valutando come muoverci. Pochi ormai hanno dei
dubbi su questa vicenda. Spero che leggendo capiranno cosa ci ha portato”.
“L’ISOLA CHE NON C’E’” è il libro di Sandra
Maltinti. «Male non fare, paura non avere». Un assioma che accompagna le
certezze di ognuno di noi. Fino a quando un evento imprevedibile, accaduto
contro ogni logica evidente, arriva a sconvolgere tutto. In questo romanzo
autobiografico, Sandra Maltinti racconta i settantadue giorni trascorsi,
innocente, nel carcere di Sollicciano. Una denuncia aperta sul senso della
giustizia. Un atto dovuto, alle compagne di cella e a sé stessa: per non
dimenticare, per mettere a nudo le illusioni e i miti ingannevoli sul mondo che
sopravvive dentro le mura del carcere, quel mondo parallelo che da fuori è
proibito vedere, e immaginare. «Male non fare, paura non avere». Un assioma che
accompagna le certezze di ognuno di noi. Fino a quando un evento imprevedibile,
accaduto contro ogni logica evidente, arriva a sconvolgere tutto. Nel romanzo
autobiografico L’isola che non c’è Sandra Maltinti racconta i settantadue giorni
trascorsi, innocente, nel carcere di Sollicciano. Una denuncia aperta sul senso
della giustizia. Un atto dovuto, alle compagne di cella e a sé stessa: per non
dimenticare. La ricerca del proprio io, disperso e distrutto dagli avvenimenti,
all’interno di un mondo diverso, un universo dove vivere e lottare per
settantadue lunghi giorni, con persone tanto diverse, con loro, le recluse, così
diverse da lei e da quello che era il suo mondo. Il carcere, un grido ruggente
all’interno di un racconto struggente, un “altrove” reale, che vive intorno e
dentro di noi, dimenticato da tutti. Tutta l’Italia ha parlato di lei: è la
protagonista di “ELBOPOLI”. Una lunga carriera di architetto, con piani
regolatori ed opere realizzate. È stata a capo di diversi comuni come dirigente
dei settori di assetto del territorio ed al comune di Portoferraio, fino al suo
arresto, il 1 giugno 2004. “ già signora dell’urbanistica portoferraiese,
potente consulente del Sindaco e di fatto a capo di questo settore nella
cittadina elbana”, travolta dall’azione della Magistratura avvenuta a pochi
giorni dalle elezioni amministrative a Portoferraio, con il Sindaco arrestato in
veste di candidato. Racconta nel suo primo romanzo la sua esperienza, la sua
verità, senza veli. Una lunga carriera di architetto, con piani regolatori e
opere realizzate. È stata a capo di diversi comuni come dirigente dei settori di
assetto del territorio e al comune di Portoferraio, fino al suo arresto,
avvenuto il primo di giugno del 2004. Nel romanzo autobiografico L’isola che non
c’è Sandra Maltinti racconta i settantadue giorni trascorsi, innocente, nel
carcere di Sollicciano. Una denuncia aperta sul senso della giustizia. Un atto
dovuto, alle compagne di cella e a sé stessa: per non dimenticare. Già signora
dell’urbanistica portoferraiese, potente consulente del Sindaco e di fatto a
capo di questo settore nella cittadina elbana, viene travolta dall’azione della
magistratura avvenuta a pochi giorni dalle elezioni amministrative a
Portoferraio, con il Sindaco arrestato in veste di candidato. Racconta nel suo
primo romanzo la sua esperienza, la sua verità, senza veli. «Male non fare,
paura non avere». Un assioma che accompagna le certezze di ognuno di noi. Fino a
quando un evento imprevedibile, accaduto contro ogni logica evidente, arriva a
sconvolgere tutto. In questo romanzo autobiografico, Sandra Maltinti racconta i
settantadue giorni trascorsi, innocente, nel carcere di Sollicciano. Una
denuncia aperta sul senso della giustizia. Un atto dovuto, alle compagne di
cella e a sé stessa: per non dimenticare, per mettere a nudo le illusioni e i
miti ingannevoli sul mondo che sopravvive dentro le mura del carcere, quel mondo
parallelo che da fuori è proibito vedere, e immaginare. Sandra Maltinti fu
condotta in carcere, dove le furono prese le impronte digitali, gesto che l’ha
marchiata. Accusata di reati verso la pubblica amministrazione e con 14 capi di
imputazione nei suoi confronti, ha trascorso 72 giorni dietro le sbarre e si è
vista negare per tre volte gli arresti domiciliari “perché sostenevano fossi
socialmente pericolosa”, ha affermato in una intervista. Dopo quattro anni di
processo è stata completamente assolta. “Non per non aver commesso il fatto, ma
perché il reato non c’era”, ha spiegato. «Non basta essere innocenti – continua
l’ex dirigente del Comune di Portoferraio – è difficile assumere una ex
galeotta. Dopo aver presentato 22 domande sono ancora senza lavoro. Se sei stato
in carcere sei marchiato a vita». Il processo oltre all’architetto Maltinti vide
coinvolte altre persone, tra cui l’ex sindaco del comune dell’Elba Giovanni
Ageno, deceduto per infarto pochi mesi dopo la scarcerazione. Due mesi e mezzo
di carcere subito ingiustamente. Tanta sofferenza. Fango gettato sulla sua
professionalità ed una dignità su cui c’è ancora qualcuno che sputa veleno.
Dall’incubo si sta riprendendo, grazie all’amore della sua famiglia che non l’ha
mai abbandonata in “quell’universo di donne urlanti”.
Tanti i ricordi e i rimpianti. E’ la storia di
Sandra Maltinti, architetto, residente ad Empoli, che ha trascorso settantadue
giorni nel carcere di Sollicciano senza avere alcuna colpa. E’ stata arrestata
con l’accusa di reati contro la pubblica amministrazione a Portoferraio.
Maltinti aveva lavorato per diverse amministrazioni comunali come dirigente dei
settori di assetto del territorio. Arrestata il primo giugno del 2004, è stata
protagonista di Elbopoli. Da questa esperienza ha tratto un libro “L’Isola che
non c’è” (Società editrice fiorentina). “Novanta pagine per non dimenticare –
spiega- e mettere a nudo le illusioni e i miti ingannevoli sul mondo che
sopravvive dentro le mura del carcere, quel mondo parallelo che da fuori è
proibito vedere e immaginare”. L’autrice del libro è stata intervistata da
Cinzia Ficco.
Dunque, architetto, una brutta storia. Come è
cambiata la sua vita? E’ difficile rialzarsi?
Quando non hai più niente ad un tratto scopri
quali sono le cose più importanti della vita: la famiglia , gli amici, quelli
veri che sanno fin dall’inizio che non può essere vero. Il mio libro è dedicato
a loro. Sì, a quelli che non ci hanno mai creduto.
E il suo lavoro?
Ah, quello è perso. Non riesco più a trovare una
pubblica amministrazione e un sindaco che credano veramente che era una balla.
Se uno è stato in galera- dicono- una ragione ci sarà pure stata.
Cos’è il carcere vissuto da un innocente?
La galera è un universo di donne urlanti. Ma le
loro voci giungono silenziose nel mondo che non le può sentire, che ignora la
loro esistenza: dura, giorno dopo giorno.
Anche lei ha provato ad urlare?
Sì, ma ho aspettato settantadue giorni perché la
mi voce oltrepassasse la cortina impermeabile del carcere . Io ci sono riuscita.
Ma poverette quelle che non hanno un bagaglio di cultura, forza e soldi. Dopo il
carcere ingoiate in quell’inferno che ti porta di nuovo indietro. Il mio
pensiero va spesso a loro.
Ci racconta in poche battute cosa è successo?
Tutto è nato da un presunto abuso edilizio , una
denuncia di inizio di attività redatta da un tecnico. Ci voleva la concessione,
dice il consulente della Pubblico Ministero, o almeno un’autorizzazione
comunale. Forse il consulente non era aggiornato sul fatto che la legge non
prevedeva più l’autorizzazione , e le modifiche interne agli edifici erano
soggette A Denuncia di Inizio di Autorità, come era stato fatto.
Strano questo errore dovuto ad ignoranza!
Anche se una ragione in realtà non c’era
dominavano pressapochismo e smania di notorietà. Tutta la mia storia e altre
sono state pubblicate in un libro di un giornalista di sinistra che ha
ricostruito i fatti secondo la sua logica.
La stampa ha dato un prezioso contributo!
Eh sì, si veda il di questo giornalista per capire
quanto la stampa uccida più che la spada.
Perché tanta cattiveria?
La minoranza non ci dava pace, vedeva che il
comune cominciava a funzionare e faceva di tutto per mettersi di traverso nei
consigli comunali, sui giornali, denunce alla magistratura. Di tutto. Il motivo
era che non si poteva permettere ad una giunta di destra di fare di più e meglio
di una di sinistra con la Provincia e la Regione che remavano contro. Sempre la
politica, anche quando non c’entra niente.
E ora? Ha avuto giustizia, anche se con ritardo!
Ripenso spesso al tempo della galera con
nostalgia.
Davvero?
Non perché abbia voglia di riviverlo, giammai, ma
perché l’amicizia con le mie compagne di cella e di tutte le donne senza voce è
stata veramente toccante. Vorrei fare di più per loro, per quelle che non
possono difendersi e non hanno un bagaglio di cultura e forza come il mio. Parlo
anche di possibilità economiche. Il carcere annienta, non serve a riabilitarti.
Perché dice questo?
Una delle due compagne di cella quando è uscita
non aveva da mangiare e dopo tre giorni si è dovuta prostituire. Poi tutto torna
inevitabilmente come prima se non c’è nessuno che ti aiuta.
Sandra Maltinti, architetto, parla della sua
esperienza in carcere. “La galera è un universo di donne urlanti, ma le loro
voci giungono silenziose nel mondo, che non le può sentire, che ignora la loro
esistenza: dura, giorno dopo giorno''. Anche lei ha provato ad urlare, e,
soprattutto, ad invocare giustizia. Ma ha dovuto aspettare settantadue giorni
perché la sua voce oltrepassasse il mondo impermeabile della galera. Alla fine,
con i suoi mezzi, ci è riuscita. Ma poverette quelle che, come lei stessa dice,
non hanno un bagaglio di cultura, forza e soldi. Dopo il carcere ingoiate in
quell’inferno che ti porta di nuovo dentro. La testimonianza è di Sandra
Maltinti, architetto, residente ad Empoli che, per errore, ha trascorso due mesi
e mezzo nel carcere di Sollicciano. E’ stata arrestata con l’accusa di reati
contro la pubblica amministrazione a Portoferraio. Da questa esperienza è venuto
fuori un libro: “L’Isola che non c’è'' (Società editrice Fiorentina), che
rappresenta “un atto dovuto alle compagne di cella- spiega Maltinti- e a se
stessa''. Novanta pagine per non dimenticare e “per mettere a nudo le illusioni
e i miti ingannevoli sul mondo che sopravvive dentro le mura del carcere, quel
mondo parallelo che da fuori è proibito vedere e immaginare''.
Ma perché questo titolo? “L'isola che non c'è'-
chiarisce- è il carcere, un altrove così vicino, ma nello stesso tempo lontano
anni luce dal mondo normale, dove vigono altre leggi. Ma è anche l'isola d'Elba,
un mondo a parte''. Maltinti ha lavorato per diverse amministrazioni comunali
come dirigente dei settori di assetto del territorio. Arrestata il primo giugno
del 2004, è stata protagonista di Elbopoli. “E tutto- scrive a pagina 54- per un
presunto abuso edilizio…una denuncia di inizio di attività redatta da un
tecnico…ci voleva la concessione, dice il consulente del Pubblico Ministero , o
almeno un’autorizzazione comunale. Forse il consulente non era aggiornato sul
fatto che la legge non prevedeva più l’autorizzazione, era stata abrogata e le
modifiche interne agli edifici erano soggette a Denuncia di Inizio di Autorità,
come era stato fatto''. Dunque, ingiustizia e sofferenza derivate da sciatteria,
ignoranza? Anche se una ragione in realtà non c'era- replica Maltinti-
dominavano solo pressappochismo e smania di notorietà! (il fine giustifica i
mezzi!). Tutta la mia storia (e altre) sono state pubblicate in un libro che è
uscito in questi giorni all'Elba di un giornalista (di sinistra) che ha
ricostruito la vicenda dagli articoli di giornale. E’ sul sito camminando.org.
Ritengo che sia significativo come la stampa uccida più che la spada.
L’esperienza in carcere l’ha cambiata, ma di certo non le ha tolto la voglia di
rialzarsi e riprovare. Anche se non è semplice. Quando non hai più niente-
spiega- ad un tratto scopri quali sono le cose più importanti della vita: la
famiglia, gli amici, quelli veri che sanno fin da principio che non può essere
vero... il mio libro è dedicato a loro... a quelli che non ci hanno creduto. Il
mio lavoro è perso. Non riesco più a trovare una pubblica amministrazione e un
sindaco che credano veramente che era una balla, se uno è stato in galera una
ragione ci sarà pur stata, dicono''. Ma solo errori e sciatteria? O c’è stato
dell’altro? “La minoranza- scrive a pagine 51 del libro- non ci dava pace,
vedeva che il comune cominciava a funzionare e faceva di tutto per mettersi di
traverso…nei consigli comunali, sui giornali, denunce alla magistrature…di
tutto…il motivo era che non si poteva permettere ad una giunta di destra di fare
di più e meglio di una sinistra ..con la Provincia e la Regione che remavano
contro…sempre la politica, anche quando non c’entra niente…E ora, quali saranno
i suoi impegni? La politica? L'amministratore non l'ho mai fatto, anche se ho
vissuto per più di venti anni nelle amministrazioni pubbliche, è solo un salto
di barricata''. Conclude: “Ripenso al tempo della galera con nostalgia, non
perché abbia voglia di riviverlo, giammai!, ma perché l'amicizia con le mie
compagne di cella e di tutte le donne senza voce è stata veramente toccante.
Vorrei fare di più per loro, per quelle che non possono difendersi e non hanno
un bagaglio di cultura e di forza come il mio...(vorrei aggiungere possibilità
economiche). Il carcere annienta, non serve a riabilitarsi. Una delle due
compagne di cella quando è uscita non aveva da mangiare e dopo tre giorni si è
dovuta prostituire. Poi tutto torna inevitabilmente come prima se non c'è
nessuno che ti aiuta.
SONO INNOCENTE. GAETANO MURANA.
"Nell'inferno del carcere di Pianosa
capii perché Scarantino mi accusava". Parla Gaetano
Murana, in cella dal 18 luglio 1994 fino a quarantotto ore fa. "A Voghera ho
lasciato l'infinita tristezza per una falsa verità che non mi apparteneva e una
pentola con il sugo di carne fatto con le mie mani", scrive Romina Marceca il 29
ottobre 2011. Dal 18 luglio 1994 e fino a quarantotto ore fa è stato uno degli
ergastolani accusati della strage di via d'Amelio. Ha attraversato l'inferno di
Pianosa, che lui chiama la discoteca perché "si ballava dalla mattina alla sera
per le sevizie", è rimasto in isolamento al 41 bis, ha perso il suo lavoro al
Comune come spazzino, portando addosso il marchio di essere uno dei mafiosi che
ha preparato l'attentato al giudice Borsellino. Gaetano Murana, scarcerato con
altri cinque, compie 54 anni il 4 novembre: il suo primo compleanno da uomo
libero dopo 18 anni in cella. Si racconta nella sua prima intervista. Ha il viso
scavato, adesso porta gli occhiali e ha le mani gonfie e rosse di chi ha
maneggiato tanti detersivi per tirare a lucido le troppe celle in cui ha
vissuto. Al polso l'unico "souvenir" che gli ricorda gli anni trascorsi in
galera: un orologio Swatch di plastica, l'unico ammesso.
Da dove cominciamo signor Murana, dall'inizio o
dalla fine?
"La conclusione dei miei giorni in carcere è
assolutamente la parte più bella. A Voghera ho lasciato l'infinita tristezza per
una falsa verità che non mi apparteneva e una pentola con il sugo di carne fatto
con le mie mani, che, senza offesa, è uno dei migliori che si siano mai
assaggiati nelle celle italiane. E io di carceri ne ho girate ben 8 in diciotto
anni. È andata così: stavo arriminannu il sugo per non farlo appigghiare quando
un agente è entrato nella mia cella di Voghera. Mi ha portato in infermeria dal
capoposto che mi ha chiesto quale fosse la mia residenza. Lì ho capito e mentre
già piangevo è stato il capoposto a dirmi: "Lei è liberante". A quel punto i
miei compagni mi hanno aiutato a fare le valigie. Anche loro piangevano. I
vestiti, le scarpe, le tute da lavoro li ho donati ai più bisognosi. Quando la
porta carraia si è chiusa alle mie spalle ho cominciato a tremare. Mi sono
guardato attorno, ero confuso. Mi sono seduto su un gradino e ho cominciato a
piangere tutte le mie lacrime".
Andiamo indietro di 18 anni, al giorno
dell'arresto. Come andò?
"Ancora ci penso e in certi momenti sorrido
amaramente. Bisogna partire dal giorno prima per capire. Era il 17 luglio. Stavo
guardando la finale Italia-Brasile del campionato mondiale di calcio Usa 94,
abbracciato a mia moglie. Eravamo sposini. Mio figlio, Giuseppe, era nato un
anno e un mese prima. Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo l'annuncio
che ha cambiato la mia vita. Il giornalista del tg diceva che un nuovo
collaboratore di giustizia, Vincenzo Scarantino, stava raccontando fatti e
misfatti sulla strage di via d'Amelio. Non dimenticherò mai la sua foto in
televisione. È rimasta impressa nella mia memoria per tutti questi anni
maledetti. Conosco Scarantino, abitava a 50 metri da casa mia. La mattina
seguente sono stato arrestato mentre andavo al lavoro. Con la mia auto avevo
fatto un'infrazione. Un'auto civetta mi ha subito bloccato. Credevo di ricevere
una multa. I poliziotti mi dissero che avrei perso tre minuti. Ebbene, questi
tre minuti sono durati 206 interminabili mesi e una manciata di ore. Quando alla
squadra mobile mi hanno consegnato l'ordine di cattura per strage, ero
stupefatto. Ho chiesto perché. I poliziotti mi hanno risposto: "Questo è un
regalo che ci ha fatto Scarantino"".
Lei è stato accusato di avere "bonificato e
sorvegliato" il luogo dell'attentato a Borsellino. Ed è finito al 41 bis, il
carcere duro. Come ha resistito?
"Pianosa è quello che ha lasciato nella mia anima
le ferite più profonde. Dopo l'arresto mi hanno portato nella sezione Agrippa,
quella riaperta proprio per il 41 bis. Botte e sevizie, come hanno denunciato
alcuni detenuti, erano all'ordine del giorno. Sono stato costretto a fare
flessioni nudo per 3 anni, a subire violenza con l'uso del metal detector sui
genitali. Ma non dimenticherò nemmeno i profilattici dentro alle minestre, il
peperoncino nelle bevande, le sbarre battute a tutte le ore per tenerci svegli.
Il 17 luglio del 1997 sono stato l'ultimo a lasciare Pianosa. Ma anche
Caltanissetta è stato un altro posto da dimenticare. Mi rendo conto, adesso, che
negli anni a tutte quelle botte mi ero quasi abituato".
Nel "Borsellino I" lei è stato assolto, e dal 2002
al 2005 è tornato in libertà. In appello poi è stato condannato all'ergastolo,
pena confermata in Cassazione. Libertà a parte, cos'altro ha perduto in questi
anni?
"La crescita di mio figlio: l'ho rivisto e l'ho
potuto toccare dopo i primi 5 anni di carcere. È stato un supplizio. Poi ho
perso i migliori anni di matrimonio. Ero un ragazzo, adesso mi sento stanco e
vecchio. Ho perso una sorella, morta di tumore e che non ho potuto salutare. E
ho perso il lavoro. Adesso pretendo di nuovo il mio impiego al Comune.
Credo mi spetti, no?".
C'è stato qualcosa di buono, nonostante tutto,
nella sua lunga carcerazione?
"Nel 2009, finalmente, dopo una lunga battaglia
con l'avvocato Rosalba Di Gregorio, ho ottenuto la revoca del carcere duro. Ho
potuto riprendere gli studi. Mi sono iscritto a ragioneria: andrò al terzo anno
. Poi ho approfondito la mia fede. Ho letto e riletto i libri su San Francesco.
Sono diventato anche un uomo più riflessivo e vorrei dedicarmi al volontariato".
Qual è il primo desiderio esaudito da uomo libero?
"Mi sono fatto preparare un piatto di pasta con le
sarde, la mia preferita".
Se avesse Scarantino davanti cosa gli direbbe?
"Nulla, lo saluterei. È una vittima come me. Credo
che le sue false dichiarazioni sono il frutto dei terribili anni a Pianosa.
Vorrei solo chiedergli una cosa: "Chi ti ha detto di fare il mio nome?"
Gaetano Murana ha 44
anni e ha trascorso un terzo della propria vita dietro le sbarre per le accuse
di Vincenzo Scarantino, che lo indicava tra gli esecutori della strage di via
D'Amelio. La nuova verità sul 19 luglio 1992 lo ha portato fuori dalla cella:
"Un'esperienza che non dimenticherò mai".
"Diciotto anni da
incubo in carcere. Ero giovane ora sono un vecchio".
Il racconto di Gaetano Murana, 54 anni, un terzo della propria vita trascorsa
dietro le sbarre con l'accusa di essere tra i responsabili della strage di via
D'Amelio. Una detenzione dura, in regime di 41bis: "Non dimenticherò mai le
violenze e le umiliazioni subite. Ho perso i migliori anni del mio matrimonio".
E chiede: "Ora almeno ridatemi un lavoro". L'ultimo "errore giudiziario"
della giustizia italiana, riconosciuto nell'ottobre scorso dalla Procura
Generale di Caltanissetta, riguarda gli ex imputati della Strage di via D'Amelio
del luglio del 1992. Tra di essi, c'è Gaetano Murana, 54 anni, che ne ha
trascorsi 18 in cella, in regime di carcere duro (il cosiddetto "41 bis"
previsto per i mafiosi). Quando, nell'ottobre scorso, ha saputo nel carcere di
Voghera dov'era rinchiuso che era diventato un "liberante" (cioè scarcerato in
attesa della revisione del processo che, fra alcuni anni, lo dichiarerà
definitivamente innocente) ha pianto per ore ed ore. Con il "Venerdì di
Repubblica" ha accettato di rievocare la sua odissea e l'inizio di quei 18 anni
trascorsi in carcere, senza colpa. "Non smetto di pensarci e, in certi momenti,
riesco persino a sorridere, ma con amarezza. Per capire, bisogna partire dal
giorno precedente il mio arresto. Era il 17 luglio 1994 e stavo guardando in tv
la finale di Italia-Brasile dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti,
abbracciato a mia moglie. Ci eravamo sposati da poco. Mio figlio, Giuseppe, era
nato un anno e un mese prima. Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo,
giunse la notizia che ha cambiato la mia vita. Il giornalista del telegiornale
disse che un nuovo collaboratore di giustizia, Vincenzo Scarantino, stava
raccontando fatti e misfatti sulla strage di via d'Amelio. Non dimenticherò mai
la sua foto in televisione. È rimasta impressa nella mia memoria per tutti
questi anni maledetti. La mattina seguente sono stato catturato mentre andavo al
lavoro. Con la mia auto avevo fatto un'infrazione. Un'auto civetta mi ha subito
bloccato. Credevo di ricevere una multa. I poliziotti mi dissero che avrei perso
tre minuti. Ebbene, questi tre minuti sono durati 206 interminabili mesi e una
manciata di ore. Quando alla squadra mobile mi hanno consegnato l'ordine di
cattura per strage, ero stupefatto. Ho chiesto perché. I poliziotti mi hanno
risposto: "Questo è un regalo che ci ha fatto Scarantino (il falso pentito,
anche lui scarcerato, che lo aveva accusato ingiustamente)"". E gran parte di
questa ingiusta detenzione per un errore giudiziario incredibile, Murana l'ha
trascorsa in uno dei carceri più duri d'Italia. "Pianosa, il luogo che ha
lasciato nella mia anima le ferite più profonde. Dopo l'arresto mi hanno portato
nella sezione Agrippa, quella riaperta proprio per il 41 bis. Botte e sevizie,
come hanno denunciato alcuni detenuti, erano all'ordine del giorno. Sono stato
costretto a fare flessioni nudo per 3 anni, a subire violenza con l'uso del
metal detector sui genitali. Ma non dimenticherò nemmeno i profilattici gettati
nella minestra, il peperoncino nelle bevande, le sbarre battute a tutte le ore
per tenerci svegli. Il 17 luglio del 1997 sono stato l'ultimo a lasciare
Pianosa. Ma anche Caltanissetta è stato un altro posto da dimenticare. Mi rendo
conto solo adesso, che negli anni, a tutte quelle botte mi ero quasi abituato.
La sofferenza maggiore è stata la crescita di mio figlio. L'ho rivisto e l'ho
potuto abbracciare solo dopo i primi 5 anni di carcere. È stato un supplizio.
Così, ho anche perso i migliori anni di matrimonio. Ero un ragazzo, adesso mi
sento stanco e vecchio. Ho perso una sorella, morta di tumore e che non ho
potuto rivedere. E non ho più un lavoro: adesso pretendo di nuovo il mio impiego
in Comune". Murana, in realtà, quel lavoro non c'è l'ha ancora ricevuto e meno
che mai il risarcimento per l'errore che gli ha rubato 18 anni di vita.
Bisognerà infatti attendere che si concluda il processo di revisione: in primo
grado, in appello e, infine, in Cassazione. Quanti anni dovranno ancora passare?
Strage Borsellino, i boss accusati da
Scarantino chiedono i danni allo Stato. Cosimo
Vernengo, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana, Gaetano Scotto e Natale Gambino
si sono costituiti parte civile nell’udienza preliminare del processo al
questore Mario Bo, agli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, cioè i
poliziotti che secondo la procura di Caltanissetta hanno diretto le false
dichiarazioni di Scarantino: per questo motivo sono accusati di calunnia, scrive
"Il Fatto Quotidiano" il 29 agosto 2018. Un milione di euro come provvisionale,
cioè l’anticipo sul risarcimento complessivo. I boss accusati dal falso
pentito Vincenzo Scarantino di essere colpevoli della strage di via
d’Amelio chiedono i danni allo Stato. Cosimo Vernengo, Giuseppe La
Mattina, Gaetano Murana, Gaetano Scotto e Natale Gambino si sono costituiti
parte civile nell’udienza preliminare del processo al questore Mario Bo, agli
ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, cioè i poliziotti che secondo la
procura di Caltanissetta hanno diretto le false dichiarazioni di Scarantino: per
questo motivo sono accusati di calunnia. Il procedimento – come racconta
l’edizione palermitana di Repubblica – comincerà il 20 settembre prossimo al
tribunale nisseno e i boss anche citato come “responsabili civili” la presidenza
del consiglio e il ministero dell’Interno: istanza accolta dal gip Francesco
Lauricella. “L’udienza preliminare che si celebrerà è un primo importante
passaggio ma come dice la sentenza del Borsellino quater, dietro Scarantino non
c’è stato un mero errore giudiziario, bisogna piuttosto scoprire le ragioni del
depistaggi”, dice a Repubblica l’avvocata Rosalba Di Gregorio, che insieme ai
colleghi Giuseppe Scozzola e Giuseppe D’Acquì rappresenta le parti civili “La
presenza del responsabile civile è un atto dovuto da parte di chi ritiene di
aver subito un danno. Ma anche un atto dovuto da parte delle istituzioni che
devono tutelare i propri uomini”, controreplica l’avvocato Nino Caleca, legale
di Mario Bo, indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto
l’archiviazione. Bo avrebbe “diretto” le operazioni di condizionamento del falso
pentito Scarantino, mentre Mattei e Ribaudo – che ne curavano la sicurezza – i
pm contestano di averlo imbeccato “studiando” insieme a lui le dichiarazioni che
avrebbe dovuto rendere nel primo dei processi sulla strage per
evitargli incongruenze e di averlo indotto a non ritrattare le menzogne già
affermate. Non tutte le persone condannate sulla base delle dichiarazioni di
Scarantino e poi assolte nel processo di revisione si sono costituite parte
civile. Sono rimaste fuori dal processo, infatti, Salvatore Profeta e Giuseppe
Urso: sono entrambi nuovamente finiti in carcere per fatti di mafia. Quello
contro i poliziotti è solo l’ultimo troncono d’indagine di una storia
giudiziaria infinita. Nell’aprile del 2017 la corte d’assise di Caltanissetta,
presieduta da Antonio Balsamo, fa condannò all’ergastolo i boss Salvo
Madonia e Vittorio Tutino, imputati di strage e a 10 anni i “falsi pentiti”
Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. I giudici
dichiararono estinto per prescrizione il reato contestato a Scarantino pure lui
imputato di calunnia. Resta ancora oscuro, però, almeno il movente del
depistaggio. Solo due anni fa i pm sostennero di non avere elementi idonei per
sostenere il giudizio a carico di Bo e di due altri funzionari Salvo La Barbera
e Vincenzo Ricciardi e il caso venne chiuso. Dopo l’archiviazione le indagini,
però, sono ripartite e si sono arricchite di nuove dichiarazioni di Scarantino e
della moglie. Entrambi hanno raccontato le pressioni e le violenze subite dal
falso pentito da parte dei poliziotti che pretendevano confermasse le loro
versioni. Nel nuovo fascicolo è finita anche parte dell’attività
istruttoria svolta nel corso dell’ultimo processo per la strage in cui Bo venne
sentito come teste non potendosi più avvalere, dopo la archiviazione della sua
posizione, della facoltà di non rispondere. Nelle motivazioni del quarto
processo per la strage Borsellino i giudici della corte d’Assise hanno scritto
che quello sulla strage di via d’Amelio è stato “uno dei più gravi
depistaggi della storia giudiziaria italiana”. “È lecito interrogarsi
sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello
Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico
riferimento ad alcuni elementi”, scrive la corte quando parla di “soggetti
inseriti nei suoi apparati” che indussero Scarantino a rendere false
dichiarazioni. Ma quali erano le finalità di uno dei più clamoroso depistaggi
della storia giudiziaria del Paese? si chiedono i giudici. La corte tenta di
avanzare delle ipotesi: come la copertura della presenza di fonti rimaste
occulte, “che viene evidenziata – scrivono i magistrati – dalla trasmissione ai
finti collaboratori di giustizia di informazioni estranee al loro patrimonio
conoscitivo ed in seguito rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà”, e,
sospetto ancor più inquietante, “l’occultamento della responsabilità di altri
soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra Cosa
Nostra e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l’opera del
magistrato”.
Via d’Amelio, Fiammetta Borsellino a
Salvini: "Incredibile che il Viminale non sia parte civile al processo su
depistaggio". La figlia del magistrato ucciso il 19
luglio del 1992 fa notare come il ministero dell'Interno non si sia costituito
al processo ai tre poliziotti accusati di calunnia aggravata: "Il ministro non
dovrebbe avere bisogno del mio appello per capire che si dovrebbero prendere
delle posizioni chiare e precise anche nei confronti di dipendenti dello Stato",
scrive "Il Fatto Quotidiano" il 2 ottobre 2018. Il ministero dell’Interno non si
è costituito parte civile al processo per il depistaggio delle prime indagini
sulla strage di via d’Amelio. E a farlo a notare a Matteo Salvini è
direttamente Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso il 19 luglio del
1992. “Ritengo assolutamente incredibile che il Viminale non sia parte civile di
questo processo. Una cosa che ha rilevato anche lo stesso pubblico ministero è
che questi funzionari dello Stato non solo hanno anche fatto delle carriere, ma
attualmente ricoprono comunque il loro posto di lavoro”, ha detto la
figlia Paolo Borsellino, a ‘Uno nessuno 100Milan’ in onda su Radio 24. Venerdì
scorso il giudice per l’udienza preliminare, Graziella Luparello, ha rinviato a
giudizio per calunnia aggravata tre poliziotti: Mario Bo, Michele
Ribaudo e Fabrizio Mattei. “Il ministro Salvini – continua Fiammetta Borsellino
– non dovrebbe avere bisogno del mio appello per capire che si dovrebbero
prendere delle posizioni chiare e precise anche nei confronti di dipendenti
dello Stato, perché non ci possono essere dipendenti di serie A o di serie B. Io
penso, e tutti noi lo sappiamo, che chiunque sbaglia in questo ordinamento è
oggetto comunque di provvedimenti, anche di sospensione, e in questo caso
secondo me sarebbe lecita una cosa del genere”. Per l’accusa i poliziotti – Bo
era stato già indagato e archiviato – avrebbero confezionato una verità di
comodo sulla fase preparatoria dell’attentato e costretto il falso pentito
Vincenzo Scarantino a fare nomi e cognomi di persone innocenti. Un piano
dal movente non definito, con un regista ormai morto: l‘ex capo della task force
investigativa Arnaldo La Barbera, comprimari come Bo e “esecutori” come Ribaudo
e Mattei. Un piano costato la condanna all’ergastolo a sette innocenti
scagionati, una volta smascherate le menzogne, dal processo di revisione che si
è celebrato e consluo a Catania il 13 luglio 2017. La svolta nell’inchiesta
della Procura di Caltanissetta, che dopo anni di inchieste e grazie alle
rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza, è riuscita ad individuare i veri
artefici della fase preparatoria della strage, era arrivata a ridosso dal
deposito della sentenza emessa nel corso dell’ultimo processo per l’eccidio di
Via D’Amelio e le cui motivazioni sono state depositate il 1 luglio scorso. Nel
provvedimento di chiusura indagine, sette pagine, la procura nissena aveva
ricostruito il presunto ruolo di Bo, Mattei e Ribaudo nel depistaggio. Bo, prima
che Scarantino mostrasse la volontà di collaborare con la giustizia, seguita poi
da mille ritrattazioni, gli avrebbe suggerito, anche mostrando le foto dei
personaggi da accusare, cosa riferire all’autorità giudiziaria. E avrebbe fatto
pressioni imbeccando Scarantino in modo che riconoscesse alcuni indagati,
istruendolo sulla verità da fornire e facendogli superare le contraddizioni con
le versioni rese da altri due pentiti: Salvatore Candura e Francesco
Andriotta. Un piano che, nonostante la palese inattendibilità di Scarantino
protagonista di mille ritrattazioni anche in sedi giudiziarie, aveva retto fino
alla Cassazione e aveva portato alla condanna ingiusta al carcere a vita di
Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe
La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso. Poi tutti scagionati. A Mattei e
Ribaudo che curavano la sicurezza di Scarantino dopo il falso pentimento i pm
contestano di averlo imbeccato “studiando” insieme a lui le dichiarazioni che
avrebbe dovuto rendere nel primo dei processi sulla strage per
evitargli incongruenze e di averlo indotto a non ritrattare le menzogne già
affermate. Bo avrebbe “diretto” le operazioni di condizionamento del pentito.
Mostri a prescindere. Misteri e
depistaggi. Finti pentiti e inchieste sballate. La
strage palermitana di via Mariano D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 morirono
Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta, non è soltanto uno dei peggiori drammi
italiani: è anche uno dei più velenosi ingorghi giudiziari di questo Paese,
scrive Rosalba Di Gregorio su "Panorama". Tre processi, decine d’imputati, 7
persone ingiustamente condannate all’ergastolo e tenute in carcere 18 anni per
le false verità (incassate senza riscontri dai magistrati) del pentito Vincenzo
Scarantino. Poi una nuova inchiesta, partita nel giugno 2008, ha iniziato a
ribaltare tutto grazie alle rivelazioni (stavolta riscontrate) di Gaspare
Spatuzza. Nel marzo 2013, a Caltanissetta, è iniziato un nuovo procedimento,
con nuovi imputati: il "Borsellino quarter". Da oltre 21 anni Rosalba Di
Gregorio, avvocato di Bernardo Provenzano e altri boss di Cosa nostra, contesta
nei tribunali le anomalie di una giustizia che si è mostrata inaffidabile come
alcuni dei suoi peggiori collaboratori. Con Dina Lauricella, giornalista di
Servizio pubblico, la penalista cerca adesso di riannodare i fili di una delle
vicende più sconcertanti della nostra giustizia e lo fa in un libro difficile e
duro, ma spietatamente onesto: Dalla parte sbagliata (Castelvecchi editore, 190
pagine, 16,50 euro). Per capire la portata del disastro d’illegalità di cui si
occupa il libro, bastano poche righe della prefazione scritta da Domenico Gozzo,
procuratore aggiunto a Caltanissetta: "Non ha funzionato la polizia. Non ha
funzionato la magistratura. Non hanno funzionato i controlli, sia disciplinari
sia penali. Non ha funzionato il Csm (...). Solo un avvocato di mafia ha gridato
le sue urla nel vuoto". Urla che non sono bastate a evitare mostruosi errori
giudiziari, per i quali nessun magistrato pagherà, e sofferenze indicibili per
le vittime di tanta malagiustizia. Panorama pubblica ampi stralci del diario di
una visita dell’avvocato Di Gregorio a un cliente sottoposto al "regime duro"
del 41 bis nel carcere di Pianosa, appena un mese dopo via D’Amelio. Piombino,
agosto 1992. Sotto il sole, all’imbarco, fa caldissimo anche se sono le 8 del
mattino. Consegno i documenti e aspetto, ci sono altri due o tre colleghi e
dobbiamo imbarcarci per Pianosa. Passano due ore di attesa e io cerco di capire
perché mi sento ansiosa: in fondo, al carcere, ci vado da tanti anni. Alcuni
colleghi mi hanno detto di vestirmi con abiti che possono essere buttati via,
perché a Pianosa c’è troppa sporcizia, e ho indossato zoccoletti di legno,
pantaloni di cotone e una maglia: tutto rigorosamente senza parti metalliche e
sufficientemente brutto. Aspettiamo ancora, sotto il sole, e non si capisce
perché. Tutte le autorizzazioni per i colloqui sono in regola e, infastidita
dall’attesa, vado al posto di polizia per capire. "È per colpa sua se ancora
non si parte". Non avevano previsto avvocati donne! Stanno convocando il
personale femminile che si occupa dei colloqui dei detenuti con i parenti. Si
parte. Il panorama è unico e spettacolare. Siamo arrivati a Pianosa e ci
accolgono poliziotti e grossi cani che si lanciano ad annusarci appena scesi da
una traballante passerella di legno. Meno male che non soffro di vertigini e non
ho paura dei cani! Benvenuti a Pianosa. Sbarcati sull’isola, ci informano che è
vietato avvicinarsi al mare, che non potremo acquistare né acqua, né altro:
dovremo stare digiuni e assetati fino alle 17 sotto il sole, perché non c’è
"sala avvocati", né luogo riparato ove attendere, né è consentito andare allo
"spaccio delle guardie". (...) La perquisizione per me non è una novità, penso
per rassicurarmi. E sbaglio. Nella stanzetta lurida, spoglia, vengo controllata
col metal detector. Non suona perché non ho nulla di metallico addosso e allora
sto per andarmene. Mi intimano di fermarmi, bisogna perquisire. Ma che
significa? La perquisizione manuale non ha senso visto che non ho oggetti
metallici. Chiedo a una delle due donne addette alla perquisizione perché ha
indossato i guanti di lattice. Le due si guardano e una bisbiglia: "No, forse a
lei no, perché fa l’avvocato". Ma che vuol dire? Ho imparato subito e ho
sperimentato anche in successive visite, che a Pianosa nessuno sorride, tutti
sembrano incazzati, gli avvocati sono i difensori dei mostri e quindi sembra che
l’ordine sia di trattarli male: loro sono lo Stato e noi i fiancheggiatori
dell’antistato. Questa etichetta, nei processi per le stragi del ’92, ce la
sentiremo addosso, ma in modo diverso, forse più subdolo, certamente più
sfumato: a Pianosa, invece, è proprio disprezzo. (...) Finalmente esco da
quella stanzetta, sudata, anche innervosita, e passo nell’altra stanza a
riprendermi il fascicolo di carte processuali, le sigarette e la penna per
prendere appunti. O, almeno, pensavo di riprendere queste cose, ma la mia penna
è "pericolosa" e mi danno una bic trasparente. Le mie sigarette resteranno lì,
perché, per perquisire il pacchetto, sono state tutte tirate fuori e sparse sul
bancone sporchissimo. Le mie carte processuali vengono lette, giusto per la
sacralità del diritto di difesa. Sono di nuovo con i miei colleghi e sono
nervosissima. Ci fanno salire su una jeep, con due del Gom, il Gruppo operativo
mobile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che, seduti davanti
a noi, ci puntano i mitra in faccia, lungo tutto il percorso che va dal punto di
approdo alla "Agrippa". Terra battuta, campetti coltivati dai detenuti: gli
altri detenuti di Pianosa, non quelli del 41 bis. (...) Entriamo nella "sala
colloqui", se così può definirsi quella stanza stretta, divisa in due, per
tutta la sua lunghezza, da un muro di cemento ad altezza di tavolino, sormontato
dal famoso "vetro del 41 bis". Come sedile c’è un blocco di cemento, alle
nostre spalle c’è il "blindato" che viene chiuso rumorosamente. I rumori di
Pianosa sono particolari: non senti parlare nessuno, la consegna pare sia il
silenzio, senti solo rumori metallici, forti, sinistri, nel silenzio dell’isola.
Non parlano nemmeno i 5 detenuti che ci portano dall’altro lato del vetro. I
"boss" – fra loro c’erano anche incensurati, ma questo si scoprirà con 19 anni
di ritardo – hanno lo sguardo terrorizzato, si limitano ad abbassare la testa,
entrano già con la testa bassa e alle loro spalle viene rumorosamente chiuso il
"blindato". Provo a chiedere, per educazione, come stiano, ma nessuno risponde.
Io sono uscita da lì senza aver sentito la voce di nessuno di loro. Ma che
succede? Perché, anziché guardare me o ascoltarmi, questi guardano, verso
l’alto, alle mie spalle? Mi giro di scatto e vedo che lo sportellino del
blindato dietro di me, quello che era stato chiuso al mio ingresso, è stato
aperto e una guardia del Gom li osserva. No, forse è più giusto dire che li
terrorizza con lo sguardo. (...) Torno sulla jeep e sono sconvolta. Per pochi
minuti di non-colloquio, sono stata trattata come un delinquente. (...) Ho
parlato con giornalisti, con colleghi, con magistrati, al mio ritorno da Pianosa
e mi sono sentita dire che, in fondo, non ero obbligata ad andarci e che la
mafia aveva fatto le stragi. Inutile ribattere che alcuni di quelli che erano a
Pianosa erano presunti innocenti, persone in attesa di giudizio: in tempo di
guerra le garanzie costituzionali vengono sospese. (...) "In ogni caso" mi ha
detto un avvocato civilista illuminato "se hanno arrestato loro, vuol dire che,
come minimo, si sono messi nelle condizioni di essere sospettati". E già... Un
vantaggio estetico, però, c’è stato sicuramente. Alla mia seconda visita a
Pianosa ho trovato i miei assistiti in forma fisica migliore: tutti magri,
asciutti, quasi ossuti, direi. Il cibo razionato e immangiabile ha la sua
influenza sulla dieta. (...) Nel ’94 sono stati arrestati, grazie a Vincenzo
Scarantino, anche i futuri condannati (oggi scarcerati) del processo Borsellino
bis: tra questi, Gaetano Murana, Cosimo Vernengo, Giuseppe Urso e Antonino
Gambino erano incensurati e furono accusati da Scarantino di concorso nella
strage di via D’Amelio. Di questi solo Nino Gambino sarà assolto dalla grave
accusa d’aver partecipato al massacro del 19 luglio ’92. Gli altri, assolti in
primo grado dopo la ritrattazione di Scarantino, saranno condannati e poi
riarrestati a seguito dell’ulteriore ritrattazione della ritrattazione del
"pentito a corrente alternata". Oggi, dopo Gaspare Spatuzza, sono scarcerati.
Tutti, comunque, erano stati amorevolmente accolti nelle carceri di Pianosa e
Asinara. Uno di questi, a Pianosa, ha subìto una lesione alla retina, per lo
"schiaffo" di una guardia del Gom. A un altro sono state fratturate le costole.
(...) Racconta, oggi, Tanino Murana: "Appena entrato a Pianosa dopo
l’interrogatorio del gip, mi hanno portato alla “discoteca". La discoteca è il
nome che i detenuti hanno dato alle celle dell’isolamento, perché li si balla
per le percosse e per la paura. "Eppure" dice Tanino "so che dal ’92 al ’94, che
è quando arrivai io, si stava peggio. Alcuni detenuti mi hanno detto, poi,
quando li ho incontrati in altre carceri, che all’inizio il trattamento era
peggiore". E perché non glielo hanno raccontato subito, mentre eravate a
Pianosa? "Lì non si poteva parlare: si doveva stare in silenzio nelle celle a
tre, o quattro posti. Le guardie del Gom non ci volevano sentire neppure
bisbigliare. Ma questo vale da quando ci portavano in sezione. Alla discoteca si
stava in cella singola". Era l’isolamento. L’accoglienza al supercarcere
prevedeva, per iniziare, che il detenuto si spogliasse completamente e, nudo,
iniziasse a fare le flessioni sulle gambe... tante, fino a non avere più fiato
e, nel frattempo, veniva preso a botte dalle guardie, cinque, sei, otto... "Non
lo so quanti erano... a un certo punto non capivi più nulla e trascinandoti di
peso, ti portavano, nudo e stremato, fino alla cella, in discoteca,
scaraventandoti dentro la stanzetta spoglia e sporca". Qui iniziava la seconda
parte del trattamento: perquisizioni, flessioni, acqua e brodaglia razionati,
botte, di giorno e di notte, per non farti dormire. "Appena ti addormentavi
entravano le guardie, alcune pure incappucciate, spesso ubriache e davano pugni,
calci, schiaffi... Dopo un po’ di tempo ho chiesto che mi uccidessero, non ce la
facevo più". (...) Ma cosa vi davano da mangiare? "Una pagnotta al giorno, due
tetrapak di acqua e poi se riuscivi a mangiarlo, il piatto del giorno". Cosa
sarebbe? "Una brodaglia in cui, accanto a qualche pezzetto, o filo di pasta,
galleggiava roba di qualunque genere". E cioè? "Io una volta ho trovato pure un
preservativo". Ecco perché erano tutti magri e asciutti. Ecco perché, quando
Scarantino, nel corso del processo Borsellino, il 15 settembre ’98, ha
raccontato il suo trattamento a Pianosa, i detenuti sono rimasti impassibili e
noi avvocati avevamo voglia di vomitare. All’epoca, non volendo prestare fede a
Scarantino, neppure in ritrattazione, ho cercato di documentarmi. Ho trovato una
sentenza del pretore di Livorno10, a carico di due guardie del Gom, processate a
seguito della denuncia di un ex ospite di Pianosa, per fatti accaduti in
quell’isola "dal luglio ’92 all’08/01/94". (...) La sentenza (...) riporta il
racconto del denunciante, giunto a Pianosa il 20 luglio ’92. "Manganellate,
strattoni, pedate, sputi e schiaffi", sia all’entrata, sia all’uscita per andare
all’aria. E se "all’aria" non ci andavi, il "trattamento" ti veniva fatto in
cella. Il tragitto lungo il corridoio era scivoloso (cera, o detersivo, secondo
altre fonti), così si cadeva a terra, diventando bersaglio del "cordone " di 10
o 20 uomini del Gom, che si schieravano nel corridoio, a dare libero sfogo al
comportamento "animalesco". Racconta il denunciante – ma non è solo lui, oggi,
a riferirlo – che nello shampoo si trovava l’olio, nell’olio si trovava lo
shampoo e la pasta era a volte "condita" con i detersivi. Nessuno all’epoca
denunciava nulla, perché avevano tutti paura di essere uccisi. Preferivano
sopportare le angherie, le botte, gli scherzi, "l’inutile crudeltà" come dice
la sentenza. (...) A cosa serviva tanta violenza? Scarantino, che narra d’averla
subita tutta quella violenza, sostiene d’essersi determinato a fare il "falso"
pentito, perché non era capace più di resistere e non solo alle costrizioni
fisiche. Oggi, e nel tempo, ascoltando i racconti di ex detenuti di Pianosa, ti
accorgi che il ricordo più vivo sembra quello delle torture psicologiche: le
percosse hanno certamente segnato quei corpi, ma te le narrano in modo quasi
distaccato. Le hanno subite e, sembra, ormai quasi metabolizzate.
Un errore da 10 milioni di euro,
da ilSud. Dieci milioni di euro. A tanto, ma anche di più, potrebbe ammontare il
risarcimento che lo Stato italiano potrebbe vedersi costretto a pagare per
risarcire l’eventuale ingiusta condanna subita e patita dai sette imputati per
la strage di via d’Amelio condannati all’ergastolo e per i quali si prospetta la
revisione del processo. La stima è dell’avvocato Marzia Maniscalco, autrice de
L’errore giudiziario e L’ingiusta detenzione nel Trattato dei nuovi danni
pubblicato da Cedam nel 2011. Le risultanze delle nuove indagini codotte dal
Procuratore, Sergio Lari, sulla strage che sconvolgerebbero le verità
processuali fin qui passate in giudicato, sono al vaglio della Procuratore
generale di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, che si appresta a far partire un
processo di revisione, davanti alla Corte d’appello di Catania (o Messina se i
giudici etnei dovessero astenersi), per i sette condannati all’ergastolo per
l’eccidio Borsellino. Si tratterebbe del più grave errore giudiziario della
storia della giustizia italiana considerato il numero di soggetti coinvolti. A
mettere a soqquadro le verità giudiziarie rese definitive dalla Cassazione, sono
stati i nuovi collaboratori di giustizia, Gaspare Spatuzza e Frabio Tranchina
che con i loro racconti hanno consentito di individuare nuovi responsabili
evidenziando l’estraneità di altri già condannati all’ergastolo Le dichiarazioni
dei nuovi pentiti smentiscono – pare anche con riscontri oggettivi – quelle dei
collaboratori di giustizia Salvatore Candura, Francesco Andriotta e Vincenzo
Scarantino (che peraltro hanno ritrattato) e forniscono una chiave di lettura
diversa della fase esecutiva della strage del 19 luglio 1992 rispetto a quella
prospettata in aula alle Corti giudicanti – sulla base delle dichiarazioni dei
pentiti e delle risultanze dell’epoca – dai pm Carmelo Petralia, Annamaria
Palma, Nino Di Matteo, e dai Pg Giovanna Romeo e Dolcino Favi (ma non dal Pg
Roberto Sajeva). In sette adesso sperano di veder cancellata la loro condanna al
carcere a vita per l’uccisione di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della
scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cusina,
Claudio Tarina. Si tratta di Salvatore Profeta, che l’ergastolo se lo è visto
infliggere nel primo processo per la strage di via d’Amelio, e gli altri sei,
Giuseppe La Mattina, Natale Gambino, Gaetano Scotto, Giuseppe Urso, Gaetano
Murana e Cosimo Vernengo, che la condanna l’hanno ricevuta a conclusione del
processo d’appello-bis. Fra i sette per i quali si prospetta la revisione del
processo – il cui esito, ovviamente, non è scontato – tre erano incensurati
prima dell’inizio di questa tormentata vicenda processuale: Murana, Urso e
Vernengo. Il Pg nisseno potrebbe chiedere per loro – e per gli altri quattro –
la cancellazione solo dell’ergastolo per la strage ma non di quella per
associazione mafiosa. In tal caso, gli avvocati Rosalba Di Gregorio, Giuseppe
Dacquì e Pino Scozzola che li assistono, hanno già pronta la richiesta di
revisione anche per quest’ultimo reato. Da “forse innocente”, Gaetano Murana, 53
anni, al primo ottobre scorso ha trascorso in carcere, complessivamente, 4724
giorni. Venne arrestato il 18 luglio del 1994 e poi scarcerato il 13 febbraio
del 1999 (dopo ben 1671 giorni trascorsi al 41bis fra Pianosa e l’Asinara, così
come tutti gli altri im-putati) con la sentenza della Corte d’assise di
Caltanissetta che lo ha assolveva per la strage, ma gli infliggeva 8 anni per
associazione mafiosa.
«Figlio di un pescatore, faceva lo spazzino all’Amia. Per via del processo –
dice l’avvocato Rosalba Di Gregorio che lo assiste – è stato prima sospeso e poi
licenziato. Ricordo che quando venne assolto in primo grado tornò in servizio e
il primo incarico che gli diedero fu quello di andare a spazzare davanti
all’Ucciardone». Murana dopo la sentenza con la quale i giudici d’appello lo
condannarono all’ergastolo, il 18 marzo del 2002, si presentò spontaneamente in
carcere. Con lui, adesso, sperano nel buon esito della revisione la moglie ed il
figlio che quando il padre venne arrestato per la prima volta aveva appena 2
mesi. Giuseppe Franco Urso ha 52 anni ed in carcere, complessivamente, ha
trascorso 4724 giorni (sempre al primo ottobre scorso). È stato arrestato il 18
luglio del 1994 e poi scarcerato il 13 febbraio del 1999 con la sentenza della
Corte d’assise di Caltanissetta che lo assolveva per la strage, ma gli
infliggeva 10 anni per associazione mafiosa. Cugino di Francesco Marino Mannoia,
al maxi processo, Franco Urso era stato peraltro assolto dal reato di
associazione mafiosa. Quando il 18 marzo del 2002 i giudici d’appello lo
condannarono all’ergastolo per via D’Amelio, si rese irreperibile fino al 23
maggio del 2003. Cognato di Cosimo Vernengo, gestiva con la sorella una
rivendita di vini nella zona di ponte dell’Ammiraglio a Palermo che, oggi, non
c’è più. Cosimo Vernengo, 47 anni, ha trascorso in carcere 4346 giorni. È stato
arrestato il 18 luglio del 1994 e poi scarcerato il 13 febbraio del 1999 con la
sentenza della Corte d’assise di Caltanissetta che lo ha assolveva per la strage
ma gli infliggeva 10 anni per associazione mafiosa. Quando il 18 marzo del 2002
i giudici d’appello lo condannarono all’ergastolo si rese irreperibile fino 6
marzo del 2004. Figlio del boss Pietro Vernengo, Cosimo è sposato ed è padre di
tre figli. Prima dell’inizio di questa vicenda aveva una impresa di rimessaggio
barche che ora non c’è più. «Tenendo conto della notevole durata di restrizione
subita, accompagnata dalle incisive modalità di esecuzione, nonché alle
conseguenze personali e familiari che ineriscono alla salute ed ai pregiudizi
lavorativi e affettivi – dice a il Sud l’avvocato Maniscalco a proposito delle
posizioni dei tre incensurati – pur ritenendo che attribuire alla libertà lo
stesso valore per tutti sia solo formalmente ed in apparenza rispettoso del
principio di uguaglianza – portando, invero, ad una inaccettabile omologazione
delle persone, quali individui privi di individualità – non si crede, comunque,
potrà scendersi al di sotto della soglia base di un milione e duecentomila euro
cadauno, prospettandosi importanti aggiustamenti, anche sino al doppio, sulla
scorta delle allegazioni delle parti e senza considerare gli eventuali
pregiudizi di tipo patrimoniale da demandarsi, nel caso di cessione di attività
imprenditoriale, alla stima di un perito». Il record, per così dire, di
detenzione “ingiusta” spetta (calcolando sempre come giorno ultimo il primo
ottobre 2011) a Salvatore Profeta, cognato del pentito Vincenzo Scarantino.
Arrestato il 9 ottobre del 1993 e condannato all’ergastolo nel primo processo
per la strage in tutti i gradi di giudizio, Salvatore Profeta ha già trascorso
in cella 6566 giorni. Profeta, però, così come Gaetano Scotto, Giuseppe La
Mattina e Natale Gambino aveva altre pendenze con la giustizia, anche se, tutte,
abbondantemente scontate. La revisione del processo potrebbe essere chiesta pure
per l’ex pentito Vincenzo Scarantino, il “picciotto” della Guadagna che ha dato
il via ad una vicenda giudiziaria oscura sotto molteplici aspetti, ed ha subito
una condanna a 18 anni di reclusione con una sentenza di primo grado
curiosamente non appellata. (da ilSud)
SONO INNOCENTE. GIUSEPPE SILLITTI.
News, chi è il Maresciallo assolto
accusato di favorire clan mafiosi: il servizio di
Pecoraro (Le Iene Show, oggi 28 aprile 2016). Giuseppe Sillitti, il maresciallo
accusato nel 2012 di favorire i clan mafiosi, assolto perché il fatto non
sussiste. Oggi a Le Iene l’incontro con Gaetano Pecorario e il carabiniere,
scrive il 28.04.2016 "Il Sussidiario". A Le Iene Show si è da poco parlato del
caso di Giuseppe Sillitti Maresciallo accusato di favorire alcuni clan mafiosi
tre anni fa. L’inviato Gaetano Pecoraro si è recato a intervistare proprio
Giuseppe Sillitti andando a cercare di capire quello che è successo a
quest’uomo. Su Twitter proprio la Iena ha pubblicato un tweet legato proprio al
servizio con scritto: “In Italia un carabiniere può finire in carcere sulla base
di accuse strampalate che poi alla fine cadono dopo appena pochi giorni
#LeIene”, clicca qui per la foto e per i tweet dei follower. Questa sera il caso
di Giuseppe Sillitti viene raccontato nella nuova puntata de Le Iene Show: il
maresciallo accusato e poi scagionato tre anni fa per accuse infamanti di
concorso e favoreggiamento di clan mafiosi pugliese, racconta la sua storia alla
Iena Gaetano Pecoraro con i vari dettagli dell’inchiesta incredibile e l’intero
iter del processo che lo ha visto alla sbarra assieme a tre colleghi
carabinieri. Come racconta il Giornale di Sicilia dell’epoca dei fatti, il
processo ha avuto fin da subito molte sorprese: presunte vittime di pizzo hanno
finito per gettare ombre sull’operato degli inquirenti, come se avessero subito
in qualche modo “pressioni” per rivelare alcuni nomi, come quello di Silitti ad
esempio. Sentite il caso di un testimone, un ristoratore Vincenzo De Santis,
sempre sul quotidiano siciliano: «MI hanno chiamato in Procura e mi hanno tenuto
lì sei ore, mi hanno quasi trattato come se fossi un delinquente e mi hanno
detto che se non avessi fatto i nomi mi avrebbero arrestato». Testimonianze come
queste sono state decisive durante il processo per arrivare alla completa
assoluzione del maresciallo che questa sera racconterà nello specifico. Nella
puntata di oggi a Le Iene Show si torna sul caso di Giuseppe Sillitti, un
maresciallo dei carabinieri che nel 2012 fu protagonista di un increscioso fatto
di malagiustizia, o quantomeno di una giustizia che ha funzionato nel uso ultimo
grado di giudizio. Originario di Caltanissetta, nel 20120 fu accusato assieme a
tre colleghi e poi arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione
per delinquere, estorsioni e favoreggiamenti. In sostanza, la procura di Foggia
che ha indagato sul caso, accusava Giuseppe Sillitti e i tre colleghi, di
depistare le indagini sul clan mafioso dei Cenicola Riggi di Lucera, nel
Foggiano. Dopo circa un mese di detenzione, la misura carceraria però è stata
annullata per totale insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Anche i
processi successivi hanno assolto completamente i quattro imputati, con
l’appello che ha assolto tutti gli imputati dell’Arma perché il fatto non
sussiste. Verdetto a suo modo clamoroso dopo che è stato demolito l’impianto
accusatorio della procura che voleva il favoreggiamento mafioso di Giuseppe
Sillitti e dei colleghi carabinieri. Da allora il maresciallo non solo è tornato
a vestire la divisa dell’arma ma attualmente presta servizio come vicecomandante
della Stazione Carabinieri di Foggia: oltre a ribadire la propria innocenza, il
maresciallo oggi racconta alla Iena Gaetano Pecorario come secondo lui si
sarebbero svolti i fatti. La Iena poi si recherà dal pubblico ministero che
sviluppò l’indagine per avere spiegazioni in merito. All’epoca dell’assoluzione
in appello, parlò per conto dI Giuseppe Sillitti il suo avvocato, Giacomo Grasso
che sul Giornale di Sicilia dichiarò «È una sentenza che non ci sorprende,
frutto di un’accusa infamante quanto evanescente sostenuta con prove antefatte
dalla Procura di Lucera. È un riscatto social per il maresciallo Sillitti e i
suoi colleghi che hanno lavorato a Lucera, contrastando duramente il crimine in
questi anni, non favorendolo».
Le Iene ed il pm Marangelli. Il
carabiniere Sillitti replica all’ ANM e conferma: “Il pm mi ordinò una rapina a
mano armata”, scrive il 14 maggio 2016 "Il Corriere
del Giorno". Il pm Alessio Marangelli, stando a quanto riportato durante la
trasmissione Mediaset su Italia Uno, si sarebbe accanito contro alcuni
carabinieri per semplice ripicca. Una vicenda che ha scatenato l’immediata
replica dell’Associazione Nazionale Magistrati che a Foggia è presieduta
da Antonio Buccaro. Dopo l’intervento dell’Anm che ha preso le difese del
pm Marangelli accusando “Le Iene” di cattiva informazione, ecco l’immediata
precisazione e replica all’ ANM di Foggia, da parte del maresciallo Giuseppe
Sillitti dell’Arma dei Carabinieri, accusato dal pm di avere legami con il “clan
lucerino” dei Cenicola-Ricci e persino incaricato dal magistrato di commettere
una rapina. “Ho letto ed appreso, con sommo rammarico ed enorme stupore, la nota
della A.N.M. (Associazione Nazionale Magistrati) – sottosezione di Foggia, del
09.05.2016, a firma del suo sig. Presidente, rilasciato all’indomani del
servizio giornalistico realizzato da “Le Iene” (noto programma Mediaset), ed
avente il seguente titolo: “Magistrati foggiani contro Le Iene, scontro sul caso
del pm Marangelli. Cattiva informazione”; ed ancora: “Buccaro: “‘Le Iene’ su
Marangelli, chiarimenti non riportati nel servizio”. Si esordiva
stigmatizzando le modalità improprie della intervista televisiva realizzata,
nonché “…l’intollerabile denigrazione mediatica a cui è stato sottoposto il
collega (Alessio Marangelli) per l’attività svolta nell’esercizio delle sue
funzioni…”. In buona sostanza, si accusava quella trasmissione televisiva di
aver operato cattiva informazione e, soprattutto, per aver arrecato un “grave
danno alla credibilità della funzione giudiziaria”. Si dichiarava, altresì, di
essere stati autorizzati dall’assemblea a diffondere il testo a tutte le
primarie testate giornalistiche locali, esprimendo solidarietà al collega,
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il testo
così diramato impone una replica, e la farò contestando, punto per punto, le
asserzioni rilasciate in quel comunicato. Vorrei dire (e dico) all’A.N.M. di
Foggia e, per essa, al suo ill.mo sig. Presidente, che prima ancora di esprimere
supina solidarietà al Collega per aver “subito” una intervista (certamente forte
ed imbarazzante, ma decisamente vera e comprovata testualmente da una miriade di
provvedimenti giudiziari), sarebbe forse il caso di leggere meglio, e con
estrema attenzione, tutte le risultanze documentali pervenute alle mani degli
intervistatori, altrimenti si corre davvero il rischio di fornire una “cattiva
informazione”. E sarebbe pure il caso di ricordare – così, solo perché mi viene
in mente in questo momento – che proprio a causa delle “discutibili” modalità
investigative seguite dal dott. Marangelli (definite da un provvedimento
giudiziario “…a dir poco, poco ortodosse”), io ho patito la più terribile ed
umiliante delle misure: la detenzione in carcere, con isolamento diurno e
notturno! So già che Lei avrà risposta facile sul punto: “E allora? …è stato
assolto da ogni accusa e scarcerato. Son felice per lei. Tutto è bene quel che
finisce bene”. Eh no, dott. Buccaro (a Lei mi rivolgo nelle specifiche funzioni
di Presidente ANM di Foggia, e quale firmatario della nota indirizzata ai
giornali), proprio non può licenziarmi in questo modo. Non so per quale
ragione ma “una stretta di mano” finale proprio non mi soddisfa. Non mi
appaga. Non mi ristora. Sono convinto del fatto che anche una sola ora di
libertà, sottratta ad un innocente, rappresenta il più grave, il più incivile,
il più crudele ed il più malvagio dei torti che possa infliggersi a qualunque
essere umano. Qui è il senso generale di Giustizia (e non soltanto il mio, mi
creda) che viene ferito, sfregiato, trafitto a morte, specie quando – ottenuta
la mia sacrosanta libertà – ho constatato quali e quante violazioni (in danno
della Legge, prima ancora che in mio danno diretto) sono state perpetrate dal
suo Collega, dott. Marangelli, verso il quale si riversa così tanta
incondizionata solidarietà. Innanzitutto, è opportuno rilasciare un dato di
fatto storico: io ed i miei colleghi, ingiustamente colpiti da ordinanza di
custodia cautelare in carcere, siamo stati definitivamente assolti con sentenza
passata in giudicato. E se è lecito, ed anzi doveroso, commentare la sentenza
totalmente assolutoria e restitutiva della mia/nostra dignità violata(ricordo
che sono un maresciallo dei Carabinieri, con pluriennale anzianità di servizio
ed innumerevoli encomi), mi pare un inopportuno “fuor d’opera”, mi sia
consentito, parlare al di fuori delle sedi opportune di casi giudiziari ancora
aperti, come quello del sig. De Fantis Vincenzo (al quale egli fa esplicito
riferimento, così rivelando i procedimenti penali contro di lui pendenti presso
il Tribunale di Lecce). E se, per puro amore di giustizia, la inviterei
(contrariamente a quanto scriverò per il dott. Marangelli) ad attendere gli
esiti giudiziali definitivi prima di commentare – a favore o contro qualcuno – i
procedimenti penali in corso di svolgimento, era forse obbligatorio, e
maggiormente consentito, commentare i provvedimenti “definitivi” (vedi sentenza
Corte di Assise di Appello di Bari, passata in giudicato), che proprio in
relazione al sig. De Fantis così testualmente si esprimeva: “…il De Fantis ha
descritto un clima caratterizzato da palpabile tensione e da forti pressioni
che, andate al di là del ragionevolmente ammissibile, erano finalizzate ad
ottenere da lui una conferma di quella che era solo una convinzione degli
inquirenti…una esperienza scioccante…non può ritenersi che la sua audizione
avvenne in un contesto sereno e tale da garantire la genuinità delle
dichiarazioni nell’occasione rese…trovando un oggettivo addentellato
in innegabili anomalie del verbale di dichiarazioni in esame…Va innanzitutto
evidenziato che il verbale di dichiarazioni del De Fantis risulta redatto nella
data del 9 agosto 2011 e che la data così indicata non può essere rispondente
alla realtà…quel che rileva è che si è in presenza di un verbale di
dichiarazioni di cui non è neppure certa la data di formazione e non vi è dubbio
che tale anomalia sia sintomatica di un modo poco ortodosso di conduzione
dell’audizione del teste… – e quanto ai verbalizzanti che si dicono presenti e
non firmarono il verbale si scrive – si è anche in questo caso in presenza di
una anomalia che, di difficile comprensione, è però indicativa di modalità di
conduzione dell’esame poco ortodosse…le evidenti anomalie ravvisabili nel
verbale di dichiarazioni in esame, in uno all’abnorme tempo occorso per la sua
redazione delineano un contesto connotato da innegabile tensione e rendono
tutt’altro che inverosimile la verificazione della situazione descritta in
dibattimento dal De Fantis…”. Ma aspetti dott. Buccaro, perché non ho ancora
terminato. Per dovere di cronaca, che assai poco efficacemente si tenta di
ristabilire con la nota dell’ANM di Foggia, è opportuno che si sappia che pure
il De Fantis ebbe a denunciare il dott. Marangelli, ed il documento posto a base
della sua denuncia (un verbale di sommarie informazioni testimoniali a sua
firma), recava evidenti e visibilissime anomalie (soggetti di cui si attestava
presenza ma non firmatari del verbale, orari e date sicuramente infedeli,
equivoche e “poco ortodosse” modalità di escussione), e tali numerosissime
“anomalie” non mancarono di essere notate dalla Corte di Assise di Appello di
Bari che, sempre per dovere di corretta informazione, commentava testualmente
come sopra riportato. Ed è pure giusto che lei sappia, egr. dott. Buccaro, che
a differenza del sig. De Fantis (che, per quanto scritto sopra, risponderà più
che agevolmente alle contestazioni elevategli in quel di Lecce), vi sono
provvedimenti giudiziali (quelli sì definitivi!) che, invece, hanno interessato
il suo Collega, dott. Marangelli, proprio presso il Tribunale di Lecce, e che di
fatto spietatamente contraddicono la sua nota di solidarietà. Già perché di lui,
il g.i.p. di quel Tribunale (in un tema così caldamente affrontato dalla A.N.M.
di Foggia, ovvero, l’ordine impartito dal dott. Marangelli a fare una rapina a
mano armata in danno di un privato cittadino!), così si esprime testualmente:
“…sulla veridicità della descrizione dei fatti offerta dal m.llo Sillitti e dal
Ten. Pozone non vi sono ragioni per dubitare, atteso che, nonostante l’apparente
negazione dei fatti ad opera del dott. Marangelli…è lo stesso contenuto del
decreto da lui sottoscritto che (sebbene con una formula meno eclatante)
conferma quali fossero le azioni (illecite sia pur in forma simulata) che il
magistrato aveva ordinato verbalmente e, poi, in forma scritta di compiere ai
militari dei carabinieri…è evidente che nel caso di specie l’ordine dato dal
dott. Marangelli esorbitasse dai confini tracciati con le massime della Suprema
Corte sopra riportate. Quanto in concreto è avvenuto e sopra nel dettaglio
descritto (oggetto delle specifiche doglianze del m.llo Sillitti) vale a
dire l’ordine di compiere una (finta) rapina per poter disporre della vettura
dell’indagato al fine di installarvi una microspia, certamente delinea un ordine
non legittimo (e che, quindi, correttamente i militari non eseguivano)…deve
ordinarsi l’archiviazione del procedimento con riferimento alla posizione del
dott. Marangelli Alessio, la cui condotta certamente non conforme ai crismi
della legittimità andrà valutata in altra sede…”. Non solo. Mi si perdoni se
sottolineo il fatto che, oltre allo scrivente, anche un Ufficiale dei
Carabinieri, ascoltato alla pubblica udienza dibattimentale del 07.05.2013, ebbe
a confermare l’ordine altamente ILLEGALE ricevuto da quel p.m.,prima a voce (in
termini esatti di “rapina”) e poi per iscritto, sicchè l’affermazione contenuta
nella nota dell’ANM di Foggia (…la delega ‘incriminata’, a firma di esso
dott. Marangelli, assolutamente non prevedeva alcuna “autorizzazione alla
rapina”…), non solo è palesemente contraddetta dalle risultanze del pubblico
dibattimento penale, oramai caduto in giudicato e sul cui esito non è più lecito
avere riserve, ma è pure smentita dal tenore testuale della delega scritta in
cui si legge testualmente quanto segue: “…dispone l’intercettazione delle
conversazioni o comunicazioni che intercorreranno all’interno dell’autovettura
XXYY con installazione di apparato di rilevazione satellitare di posizione e con
autorizzazione a compiere ogni atto che si renda necessario all’installazione
degli apparati tecnici e, in particolare, a simulare l’illecita sottrazione
dell’auto all’indagato ed il successivo rinvenimento della stessa”. E mi si
perdoni ancora se, sul punto, mi sembra un pò zoppicante la debole osservazione
rilasciata dall’ANM di Foggia che quella delega non conteneva, esattamente, un
ordine alla rapina (come se fosse decisivo il termine utilizzato da quel
p.m.?!), ma una intimazione assai più vasta – e per questo ben più illegale e
pericolosa! – a compiere qualsiasi atto illecito (e dunque, anche una rapina! E
perché non un furto? E perché non una “gambizzazione”? Un’aggressione? Un atto
intimidatorio?). Ma quale differenza può mai fare, secondo lei, sul piano
giuridico, se non esclusivamente etico e morale?!? E su tale circostanza
stimolo una banale considerazione: e se quell’ordine illecito (quello, cioè, che
il dott. Marangelli si ostina a sostenere di non aver mai impartito), fosse
stato effettivamente eseguito? Cosa sarebbe potuto accadere? E se si fosse
scatenato un conflitto a fuoco per reazione? Chi ne avrebbe giudizialmente
risposto? Cosa avremmo potuto dire alla vittima? Me lo ha ordinato il
dott. Marangelli?! E se si fossero manifestate complicanze esecutive? Come
si sarebbe potuto spiegare un tale abominio commesso da Tutori dell’Ordine ai
danni di un privato cittadino?? Non si vorrà davvero sostenere che “il fine
giustifica i mezzi”?!? Veda, dott. Buccaro, io sollecito tali
interrogativi poiché, con lei, condivido la necessità di fornire la più esatta
ed obiettiva informazione ai mezzi di stampa, considerando tutti (ma proprio
tutti) i dati documentali raccolti nella tristissima vicenda che mi ha
direttamente colpito, anche quelli più scomodi ed imbarazzanti per il suo
Collega, ma pur sempre veri, e ben capaci di far percepire ai lettori la realtà
dei fatti narrati, e non soltanto un accorato e “solidale abbraccio” nei
confronti di chi, di tali fatti, si è reso incontrovertibile autore.
Beninteso, probabilmente anche io, al suo posto, avrei espresso la stessa “piena
solidarietà” al Collega raggiunto da arrembanti ed invasivi intervistatori,
ma da qui a scendere in particolari di merito della vicenda di cui,
all’evidenza, conosce la sola versione del dott. Marangelli, ce ne passa. E
molto. Ed è pure giusto che si sappia che la gravità della vicenda
giudiziaria da me patita è salita agli onori dell’attenzione governativa, con
ben due interrogazioni parlamentari all’indirizzo del Ministro di Giustizia e
degli Interni, oltre a numerose segnalazioni al C.S.M. ed alla Procura Generale
presso la Corte di Cassazione, e che il dott. Marangelli è stato più volte
denunciato (dal momento che proprio si deve parlare anche dei procedimenti
penali in corso) per una moltitudine di reati, che vanno dalla istigazione a
delinquere alla calunnia, dalla intercettazione abusiva al falso ideologico e
materiale in atto pubblico, dall’abuso in atti di ufficio al sequestro di
persona, ma debbo constatare, mio malgrado, che solo delle pendenze del De
Fantis si è inteso parlare, ma non anche di quelle (e sono tante) del
dott. Marangelli. E quanto alla “intollerabile denigrazione
mediatica” presuntivamente patita dal suo collega a causa del servizio
televisivo andato in onda su Italia 1, è appena il caso di ricordarle che il
sottoscritto ed i suoi tre colleghi dell’Arma, all’indomani del proprio arresto,
furono mediaticamente esposti alla feroce ed incontrollata “gogna mediatica”
sollecitata, proprio, dal dott. Marangelli e dalle sue non più numerabili
conferenze-stampa (se la memoria non m’inganna ebbi modo di contarne circa 18!),
oltre ai servizi televisivi nazionali, net journal e quotidiani di levatura
nazionale, sicchè – mi perdoni – ma proprio non riesco a provare solidarietà per
chi, proprio col mezzo dei mass media (che oggi, paradossalmente, gli si
ritorcono contro), disintegrò reiteratamente e senza alcuna umana compassione il
mio onore, quello dei miei familiari e quello di tutti i miei amici più sinceri.
Per me ha un valore enorme, mi creda, il doveroso (e decoroso) silenzio degli
inquirenti sull’esito delle proprie indagini – e son sicuro che lei è d’accordo
con me – e trovo che non ci sia alcuna moralità nel divulgare le “spoglie” degli
arrestati al pasto osceno di tv e giornali prima ancora di un giudizio, prima
ancora di una sentenza, e con inviti pubblici, addirittura, a costituirsi parte
civile contro i carabinieri (pensi che il dott. Marangelli invitava a tanto
il Comune di Lucera!). Ma è proprio quello che è accaduto a me, e per dovere
di cronaca e di corretta informazione, dott. Buccaro, è giusto che si sappia.
Quanto alle omissioni informative che, a dire del dott. Marangelli, sono state
realizzate in suo danno dagli intervistatori, vorrei sottolineare che anche le
mie rivelazioni (benchè tutte dettagliatamente documentate), sono state
enormemente “tagliate” e sfoltite dalla originaria intervista dedicatami poiché,
mi dissero i giornalisti, non ci sarebbe stato spazio sufficiente per poter
illustrare tutti i numerosi dettagli che andavo terribilmente dipanando, e che
vi sarebbero state altre occasioni per narrare ogni particolare. Sul punto, dal
momento che sono arcisicuro delle oscure e documentate verità che ho solo in
parte narrato ai giornalisti, e visto che gli stessi (ed altri) han già promesso
di tornare sul grave fatto di cronaca e renderne doverosa informazione,
abdicherò il mio intero spazio televisivo in favore del dott. Marangelli che, in
tal modo, avrà tutto il modo per spiegare dove, come ed in quale punto di quella
intervista de “Le Iene” è stato affermato del falso o si è fornita ai
telespettatori una “cattiva informazione”, ma sono più che persuaso del fatto
che le solide ed incelabili prove documentali in mio possesso (ed in possesso
degli intervistatori), daranno più d’un problema al dott. Marangelli in tema di
oggettiva e semplice sua credibilità. Quanto al momento del mio arresto rispetto
all’ordine illegale di effettuare una rapina, mi preme di evidenziare (giusto
perché anche questo s’è scritto nella nota dell’ANM di Foggia), che io non ho
mai sostenuto nella rilasciata intervista di essere stato raggiunto da ordinanza
cautelare dopo tre mesi dal detto ordine illegale (questa fu una deduzione
dell’intervistatore), ma è un dato oggettivo constatare – e chi mi legge sa bene
la gravità di questo fatto – che la mia utenza cellulare, proprio dopo tre mesi,
venne sottoposta ad intercettazione senza alcun presupposto legale e che, per
tale fatto, il dott. Marangelli è stato pure formalmente denunciato presso la
Procura della Repubblica di Lecce presso cui ancora pendono specifiche indagini.
Esorto, pertanto, ad astenersi per il futuro dal rilasciare commenti o note che
si propongono l’aspettativa di chiarire, ma che nulla chiariscono, o di
criticare le oggettive risultanze documentali al di fuori degli ambiti
giurisdizionali, emerse ed emergende nelle interviste o nei programmi televisivi
nazionali che vogliano prestarne il più lecito interesse. A tale scopo, e nella
solida onestà che mi caratterizza, voglio preannunciare che mi rivolgerò anche
alla A.N.M. Sede Nazionale per chiedere un parere circa l’opportunità della sua
Sottosezione di Foggia di fornire alle stampe un comunicato come quello oggetto
della presente replica o se, invero, sia passibile di reprimenda una tale “presa
di posizione” e “discesa nel merito”. È ovvio che sarà mia cura fornire, a chi
voglia davvero leggerli, tutti i documenti di cui dispongo e ben abili a far
intendere quanto è realmente avvenuto. Nessun intervento, individuale o di
categoria, riuscirà mai nell’obiettivo che mi sono ufficialmente posto: la
discoperta e la divulgazione della verità, per quanto amara ed indigesta possa a
molti sembrare. Null’altro. E non nego che mi aspettavo, francamente, piena
solidarietà alla mia persona ed alla mia angosciosa vicenda (che, dalla sua,
possiede l’incontrovertibile forza dei documenti, delle sentenze e dei
provvedimenti), e non il compatto schieramento dall’altro, più debole ed assai
meno documentato, fronte opposto. Ma non fa nulla. Non mi abbatto, non mi
ammutolisco. Anzi mi rafforzo, e di sicuro mi propongo – magari illudendomi – di
sensibilizzare l’attenzione di tutti dinanzi alle Ingiustizie ed alle Illegalità
che possono spietatamente colpire chiunque. Senza motivo. Senza pietà. Senza
preavviso. D’altronde, prestai giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e
alle sue Leggi, ed oggi sono ancora più convinto che per prestare onore a quel
sacro impegno non posso, non voglio,non debbo desistere, nonostante le avversità
e le atroci delusioni ricevute.
SONO INNOCENTE. PIO DEL GAUDIO.
«Io, ex sindaco finito in carcere da
innocente: la mia vita distrutta», scrive Marilù Musto
Venerdì 27 Gennaio 2017 su Il Mattino. «Io rispondo alla mia coscienza». Inizia
così il lungo sfogo dell'ex sindaco della città di Caserta, Pio Del Gaudio,
eletto nel 2011 e arrestato il 14 luglio del 2015 nell'operazione della Dda di
Napoli «Medea». Ieri, dopo un anno e mezzo di indagini sul suo conto, il gip di
Napoli ha deciso di archiviare il caso. Pesanti le accuse contestate e poi
ritirate dalla Procura: corruzione e finanziamento illecito ai partiti in
campagna elettorale con l'aggravante di aver agevolato il clan dei Casalesi
negli appalti. Accuse cadute prima al Riesame e poi in Cassazione, dove i
giudici hanno demolito la prima ordinanza emessa a luglio del 2015. «Sapevo di
non aver fatto nulla - dice ancora Del Gaudio - mi ha fatto male vedere mio
figlio scegliere di partecipare alla selezione universitaria per Medicina solo
al Nord, che ha poi superato. Ho pianto da solo a casa, senza farmi vedere da
nessuno in questi anni, nemmeno da mia moglie. Ho perso un mio amico e collega
che un giorno mi disse: scusami, ma tu sei seguito dai carabinieri, noi non
possiamo camminare insieme. Alcune deleghe mi sono state ritirate. In carcere
però ho scoperto la solidarietà umana, la vicinanza del mio amico di cella,
Mirko, e degli altri detenuti che mi dicevano: ma tu cosa ci fai qui? Ora
ringrazio i miei avvocati, Dezio Ferraro e Giueppe Stellato». «È finito un
incubo», dice ancora sollevato Del Gaudio. «La mia fortuna - conclude - è che
nel mio caso i magistrati sono stati molto veloci, decidendo in un anno e mezzo,
ma penso alle tante persone accusate ingiustamente, specie a quelle che sono in
carcere, ma che non hanno la possibilità di difendersi. Voglio battermi per
loro. Non ce l’ho con i magistrati, fanno il loro lavoro, ma dico che prima di
arrestare qualcuno bisogna pensarci molto bene. Questa indagine ha rovinato la
mia vita personale e professionale; faccio il commercialista e il mio studio,
dopo il mio arresto, ha avuto un crollo. La cosa positiva è che quasi tutta la
città già mi aveva assolto. Per ora non penso però a tornare in politica, e
soprattutto non in questa politica dove non contano il merito e la competenza».
ASSOLTO PIO DEL GAUDIO …Non È CAMORRISTA!
Scrive il 26 Gennaio 2017 Caserta Keste. Il Gip di Napoli Egle Pilla ha
prosciolto dall’accusa di corruzione e finanziamento illecito ai partiti, con
l’aggravante mafiosa, l’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio (Fi), arrestato nel
luglio del 2015 nell’ambito dell’indagine della Dda partenopea “Medea”, sulle
infiltrazioni e i condizionamenti del clan Zagaria negli appalti concessi da
amministrazioni pubbliche. Pio Del Gaudio, accusato di aver intascato prima
delle elezioni comunali del 2011, poi vinte, 30mila euro dall’imprenditore Pino
Fontana, ritenuto vicino al clan Zagaria, restò in carcere per 14 giorni. Allora
fece scalpore il fatto che per arrestare Del Gaudio, che in quel momento non
occupava più da un mese la carica di sindaco, fosse stato utilizzato dai
carabinieri un elicottero con cui sorvolare la sua abitazione. Nelle scorse
settimane, la Dda di Napoli sostituti Alessandro D’Alessio e Maurizio Giordano,
aveva notificato a Del Gaudio l’avviso di conclusione indagini, ma poi in
seguito agli elementi a discarico presentati dal legale dell’ex sindaco, Dezio
Ferraro, ha deciso di richiedere l’archiviazione, accolta oggi dal Gip. “È
finito un incubo”, dice sollevato Del Gaudio. ” e scrive sulla sua pagina
facebook:
DUE ANNI D’INFERNO. FINALMENTE I GIUDICI HANNO
CAPITO. PENSO AI TANTI CONDANNATI O DETENUTI INGIUSTAMENTE. CHE DIRE. SONO
CONFUSO. NON SONO FELICE. RABBIA? GIOIA? VENDETTA? NON LO SO HO IMPARATO TANTO.
HO SOFFERTO E CON ME LA MIA FAMIGLIA, I MIEI COLLEGHI DI STUDIO, I MIEI AMICI.
NON E’ ACQUA PASSATA. NON DIMENTICO. HO SUBITO MORTIFICAZIONI. HO VISSUTO DA
"CAMORRISTA" SENZA ESSERLO. HO CONOSCIUTO IL CARCERE DIETRO E FUORI LE SBARRE.
QUALCHE PERSONA MI HA ALLONTANATO E GIUDICATO SENZA SAPERE O CONOSCERE. HO PERSO
CLIENTI IN STUDIO.TANTISSIMI. HO SEMPRE CAMMINATO A TESTA ALTA MA SPESSO HO
FINTO. HO PIANTO E LA NOTTE NON DORMO E ALLE 4.00 …HO PAURA DEL CITOFONO….
RICORDO QUEI MOMENTI. UOMINI MASCHERATI. L’ELICOTTERO. MA NON HO SOFFERTO IN
CARCERE HO SOFFERTO FUORI DAL CARCERE IN UN MONDO INFAME E FALSO. MI SONO
AGGRAPPATO AL POPOLO, ALLA MIA CITTA’, AGLI AFFETTI, AI VALORI VERI. CREDO IN
CASERTA. HO CORSO NELLA REGGIA, QUANTO HO CORSO. AMO LA REGGIA. HO CORSO NON PER
DIMENTICARE MA X RIFLETTERE .PENSAVO AL PROCESSO , A COSA DIRE. A COME
DIFENDERMI. BLUFF …ORA TUTTO FINITO. UN MIRACOLO. UNA FORTUNA. LA GIUSTIZIA
ESISTE ED IO CREDO NELLO STATO. SI RIPARTE. CON SLANCIO? NON LO SO. CON LA
COSCIENZA PULITA CERTO. COME SEMPRE. AVEVO QUASI 48 ANNI IL 14 LUGLIO 2015. OGGI
IL 26 GENNAIO 2017 NE HO QUASI 50. HO PERSO DUE ANNI? FORSE. HO GUADAGNATO
SAGGEZZA. MA NON LO AUGURO A NESSUNO. HO IMPARATO A NON GIUDICARE. RICORDO LA
TV, LA RAI , IL TG3, CANALE 5. LE INTERVISTE DI QUALCHE POLITICO IDIOTA E
CATTIVO. IO IN CARCERE. NON SAPEVO PERCHE’. LORO SAPEVANO TUTTO. PIO DEL GAUDIO
= CAMORRISTA. ED ORA. ASSOLTO. INNOCENTE. ARRESTATO SENZA MOTIVO. NON DOVEVO
ESSERE ARRESTATO. MA GRAZIE A TUTTI, AI GIUDICI, ALLE FORZE DELL’ORDINE, AI
GIORNALI, ALLE TV. MA…”GUAI A CHI CI CAPITA”.
«Carcere senz'acqua, detenuti in doccia
coi sacchi dell'immondizia», scrive Marilù Musto
Mercoledì 5 Luglio 2017 su Il Mattino. «Per lavarsi i detenuti facevano il
“canotto”. In sostanza, disponevano una busta di plastica nera a terra sostenuta
da quattro bottiglie piene, il detenuto che doveva fare la doccia si poneva al
centro della busta nudo e gli altri, con le bottiglie, gettavano acqua su di
lui, in modo che questo poteva lavarsi e fare una sorta di doccia». Lo spiega
bene l’ex sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, il piano di sopravvivenza dei
detenuti. Lui, in carcere da innocente per 12 giorni, nel luglio del 2015, ha
raccontato la vita dal di dentro, fra le quattro mura della casa circondariale
di Santa Maria Capua Vetere. La sua posizione è stata archiviata dalla Procura
Antimafia di Napoli nel 2016, ma lui, Del Gaudio, ora parla del modo in cui si
sopravvive. «In condizioni assurde», dice. Senz’acqua sin dalle prime luci
dell’alba. Impossibile resistere. «Non mi piace parlare di ciò che ho subito -
racconta Del Gaudio - ma lo faccio perché lo devo ai miei compagni di cella con
i quali ho condiviso 12 giorni di inferno. Ho promesso che una volta uscito
avrei spiegato all’esterno il mondo del carcere. Se “vivere” può essere un verbo
adatto per definire il trascorrere inesorabile dei giorni in quel luogo
senz’anima, allora vuol dire che fuori, oltre quelle mura, si sta da Dio. I
detenuti chiedono sempre il trasferimento da Santa Maria Capua Vetere a Terni o
ad Avellino perché in quelle case circondariali si vive umanamente, almeno così
mi dicevano. Mentre a Santa Maria la lotta è continua per ottenere il minimo.
Anche perché in carcere non sei nulla. Quando io sono entrato non avevo niente
con me, nemmeno le lenzuola per il letto, ciò che sono riuscito a ottenere
appena entrato in cella lo devo al mio compagno di stanza, un ragazzo che si
chiama Mirko e che mi ha donato persino le federe dei cuscini». Del Gaudio
spiega che l’acqua non arrivava al bagno fin dalle prime ore del giorno: «Alle
ore 9 i rubinetti erano al secco, quindi nessuno poteva lavarsi. C’era l’acqua
delle bottiglie con cui fare il famoso “canotto”, ma nient’altro. È orribile
constatare che da quando sono uscito nulla è realmente cambiato lì. Se si toglie
l’acqua stiamo parlando di una privazione essenziale durante l’arco dell’intera
giornata». Le proteste dei detenuti iniziavano alle ore 20 di ogni sera, quando
davvero non ne potevano più.
SONO INNOCENTE. ANTONIO COLAMONICO.
Estetista uccisa a Mola, assolto compagno
in cella dal 2014. Antonio Colamonico, compagno di
Bruna Bovino, è stato assolto, scrive il 7 Novembre 2018 "La Gazzetta del
Mezzogiorno". Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di assise di
appello di Bari ha assolto «per non aver commesso il fatto» Antonio Colamonico,
accusato dell’omicidio della 29enne italo-brasiliana Bruna Bovino, uccisa il 12
dicembre 2013 nel centro estetico che gestiva a Mola di Bari. Colamonico sarà
scarcerato oggi stesso, dopo oltre quattro anni e mezzo di detenzione in
carcere. Fu arrestato nell’aprile 2014. In primo grado era stato condannato a 25
anni per omicidio volontario e incendio doloso. L’incendio doloso era stato
appiccato dall’assassino - secondo l’accusa - per cancellare le prove del
delitto appena compiuto. Il corpo della vittima, infatti, fu trovato
semicarbonizzato sul pavimento del centro estetico, fra brandelli di indumenti e
sangue, dopo essere stata uccisa con 20 colpi di forbici e strangolata. Alla
lettura della sentenza hanno assistito i familiari della vittima, che hanno
subito lasciato l’aula in silenzio, e i parenti di Colamonico, moglie, genitori,
fratelli e amici, che hanno urlato e applaudito dopo aver appreso
dell’assoluzione. "Adesso è stata fatta davvero giustizia», hanno detto
abbracciandosi uscendo dal Tribunale. «Lo sapevamo dall’inizio che era
innocente, - ha detto il padre Matteo - sono cinque anni che lottiamo e la prima
cosa che farò quando andrò a prenderlo dal carcere, sarà portarlo da suo figlio,
che oggi ha 7 anni». In lacrime la moglie, Rossella, e il gemello Giovanni, che
ha detto di volerlo «portare in Chiesa, nel luogo dove in questi anni ho tanto
pregato». Gli avvocati dell’imputato, Nicola Quaranta e Massimo Roberto
Chiusolo, hanno spiegato di aver «trovato, grazie ad indagini difensive e un
lungo lavoro con consulenti di parte, la prova dell’innocenza di Colamonico.
Secondo la Procura - hanno spiegato - la ragazza era stata uccisa intorno alle
17, ma abbiamo trovato testimoni che l’hanno vista e salutata alle 18.20, quando
Colamonico era in un altro luogo, come dimostrano le celle telefoniche».
Estetista uccisa a Mola, 4 anni in cella
per un tabulato sbagliato: citata Wind3. Avvocati:
errore su cella telefonica determinò accuse e arresto. Stando alle informazioni
sui tabulati inizialmente fornite dalla compagnia telefonica, il testimone a
quell'ora si trovava a 20 chilometri di distanza, scrive l'8 Novembre 2018 "La
Gazzetta del Mezzogiorno". Intenteranno una causa per risarcimento danni nei
confronti della compagnia telefonica 'Wind3' i difensori di Antonio Colamonico,
assolto ieri dalla Corte di Assise di Appello di Bari - dopo quattro anni e
mezzo trascorsi in carcere - dall’accusa di aver ucciso la sua ex compagna,
l’estetista Bruna Bovino, il cui corpo fu trovato semicarbonizzato e con diverse
ferite provocate da forbici, nel dicembre 2013, nel centro estetico che gestiva
a Mola di Bari, a circa 20 chilometri dal capoluogo pugliese. Secondo gli
avvocati Massimo Roberto Chiusolo e Nicola Quaranta, l’errore
nell’individuazione di una cella telefonica sarebbe stato determinante per la
ricostruzione dei tempi dell’omicidio fatta dalla Procura e posta a fondamento
dell’arresto di Colamonico, che in primo grado era stato condannato a 25 anni di
reclusione. I pm ritenevano che la donna fosse stata uccisa alle 17, mentre
invece un testimone, un commerciante amico della vittima, ha sempre sostenuto di
averla vista viva poco dopo le 18, orario in cui Colamonico era ormai a
Polignano, a circa 37 chilometri da Bari. Stando alle informazioni sui tabulati
inizialmente fornite dalla compagnia telefonica, il testimone a quell'ora si
trovava a 20 chilometri di distanza e quindi le sue dichiarazioni erano state
ritenute inattendibili, rafforzando l’ipotesi accusatoria e i sospetti su
Colamonico. In realtà una perizia tecnica disposta nel processo di secondo
grado, su richiesta delle difese, ha accertato l’errore causato dall’omonimia di
due strade, dimostrando che il telefono del testimone, dopo le 18, agganciava
effettivamente una cella telefonica non lontana da Mola. I legali annunciano che
aspetteranno le motivazioni della sentenza per poi procedere alla richiesta di
risarcimento.
ALTRI CENTO, MILLE, MILIONI DI INNOCENTI.
Beatrice Cenci, il fantasma
dell’ingiustizia. Il suo processo fu una farsa, la sua
barbara esecuzione l’11 settembre 1599 venne seguita da migliaia di persone,
scrive Daniele Zaccaria il 13 Ottobre 2018 su "Il Dubbio". Il carro che porta i
Cenci al patibolo si fa largo tra grappoli di folla; e grida, singhiozzi,
ululati provengono dai marciapiedi, dalle carrozze, dai balconi dei palazzi, in
un misto di compassione e ferocia, di eccitazione e paura, nobiltà e popolino a
formare un unico, delirante branco. E mentre la processione attraversa Santa
Maria di Monserrato, i Banchi, Tordinona, e si avvicina al luogo dell’esecuzione
l’aria è satura di calore: quell’ 11 settembre 1599 a Roma fa un caldo torrido,
l’estate sembra non voler finire più. C’è un momento però in cui la schiera si
azzittisce, un istante sospeso, quasi a raccogliere pensieri e spiriti animali
prima del supplizio: la figura sdegnosa di Beatrice appare sul ciglio di San
Celso, neanche uno sguardo rivolto agli astanti, gli occhi dritti su ponte S.
Angelo dove di lì a poco verrà decollata, ceppo e mannaia, l’ombra del boia già
occhieggia sinistra sul palco. Sul carro, dietro di lei, la matrigna Lucrezia
Petroni tremante e inebetita, e il corpo già afflitto ma ancora in vita del
fratello Giacomo: durante il tragitto lo hanno mazzolato sul cranio, divelto con
tenaglie roventi, alla fine morirà per squartamento nel più brutale dei
martirii. Lucrezia non sopporta la scena e perde i sensi, Beatrice, che è già il
suo fantasma, rimane muta e altera. Al fratello Bernardo, che ha appena 15 anni,
viene risparmiato il patibolo ma non lo strazio di assistere alla morte dei suoi
cari, anche lui perde i sensi per l’orrore e rimane svenuto per mezz’ora. La
prima testa a cadere è quella di Lucrezia, tagliata di netto dallo spadone del
boia. Poi tocca a Beatrice, la star, ha 22 anni, ed è di una bellezza rara. Le
cronache raccontano di una preghiera sussurrata, di un bacio lieve al crocifisso
e, anche qui, di un istante di esitazione da parte del carnefice prima che le
vibrasse il colpo fatale: «Intimorito si trovò impacciato a vibrarle la mannaia.
Un grido universale lo imprecava, ma frattanto il capo della vergine fu mostrato
staccato dal busto, ed il corpo s’agitò con violenza. La testa di Beatrice fu
involta in un velo come quella della matrigna, e posta in lato del palco; il
corpo nel calarlo cadde in terra con gran colpo, perché si sciolse dalla corda».
In piazza quel giorno c’erano migliaia di persone, tra di loro anche un giovane
pittore lombardo, Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. In dodici persero la
vita, chi per insolazione, chi schiacciato nella calca, chi affogato nel Tevere.
Una cupa giornata di morte e di delirio, quell’ 11 settembre 1599. Erano stati
condannati alla pena capitale direttamente da Papa Clemente VIII per l’uccisione
del conte Francesco Cenci, padre di Beatrice, Giacomo e Bernardo e marito di
Lucrezia, sua seconda moglie. Un delitto premeditato per porre fine alle
violenze di quell’uomo malvagio di cui tutti dicevano un gran male. Francesco
Cenci, ultimo esponente di una nobile e influente casata che acquistò i titoli
del medioevo, era arrogante, brutale e perverso, coinvolto in risse e diversi
fatti di sangue, finito più volte a processo per violenze sessuali e pedofilia
(aveva violentato il figlio 12enne di un popolano) era sempre riuscito a
comprarsi un’assoluzione, sfruttando la sua posizione e le sue ricchezze. Ma era
con le donne della sua famiglia che riusciva a esprimere al meglio la sua
crudeltà. La figlia maggiore Antonina scrive addirittura a Clemente VIII per
sfuggire agli abusi paterni, il pontefice, che non aveva alcuna simpatia per
Francesco, accoglie la richiesta combinandole un matrimonio con un nobiluomo di
Gubbio. Costretto a pagare una ricca dote si sfoga su Beatrice che fa segregare
assieme a Lucrezia in un castello in provincia di Rieti che appartiene alla
famiglia Colonna, nel territorio del Regno di Napoli. È il 1595 e, fino alla
morte avvenuta nel 1598, il castello sarà teatro di sevizie e percosse, di
continue umiliazioni, accentuati dall’animo sempre più incarognito di Francesco,
malato di gotta e di rogna e assediato dai debiti e dai creditori. Con l’aiuto
dei domestici Olimpio Calvetti e Marzio da Fioran, Lucrezia, Beatrice e Giacomo
tentano di ucciderlo per ben tre volte, provando ad avve- lenarlo, tentando di
pagare dei briganti locali, stordendolo con l’oppio. Alla fine è Olimpio a
ucciderlo nel sonno, a colpi di martello e a chiodate. Ufficialmente Francesco
Cenci è morto per una brutta caduta da una balaustra, ma la messa in scena è
goffa, amatoriale. Fanno ritrovare il corpo in un orto ai piedi del castello.
Non ci vuole molto agli investigatori mandati sia dal viceré del Regno di Napoli
che dal Vaticano per capire che quello non era un incidente, ma un delitto.
Riesumano il cadavere, trovano i segni delle martellate sul cranio e alcuni
buchi nel collo, due chirurghi certificano l’omicidio. Il movente è limpido:
tutti sapevano delle brutalità del conte nei confronti dei familiari che avevano
più di una buona ragione per liberarsi di lui. I Cenci vengono portati a Roma,
in un primo momento ai domiciliari nel loro palazzo sotto la sorveglianza delle
guardie pontificie. Si dichiarano innocenti, sono una famiglia molto in vista,
dei “vip” e il loro processo, che oggi verrebbe definito uno show mediatico,
calamita l’attenzione morbosa dell’opinione pubblica ed è condotto dai più noti
giuristi dell’epoca. Il dibattimento vede affrontarsi infatti due autentici
principi del foro, Pompeo Molella per la pubblica accusa e Prospero Farinacci
per la difesa, il giudice è Ulisse Moscato che due secoli più tardi il francese
Stendhal (grande appassionato della tragedia dei Cenci) descrive nelle
sue Cronache Romane come «uomo dalla profonda sapienza e dalla superiore
sagacità dell’intelletto». Ma Clemente VIII, lo stesso che l’anno successivo
farà ardere vivo Giordano Bruno, non può accettare una sentenza che non si
concluda con la morte per gli accusati. L’avidità, la cupidigia untuosa di Papa
Aldobrandini, beneficiario naturale della confisca dei beni dei Cenci, rende il
processo una farsa, fosse stato per lui non ci sarebbe stato nessun processo, li
avrebbe fatti squartare tutti appena arrivati a Roma. Irritato dalla
ragionevolezza e dalla moderazione di Moscato e preoccupato che possa venire
colpito dalla grazia della giovane, lo fa sostituire dal giudice Cesare Luciani,
noto per la facilità con cui spedisce gli imputati dal boia fin dai cupi tempi
di Sisto V, soprannominato “il Papa della delazione e delle forche”. Ma
soprattutto c’è Beatrice, superba e altezzosa, che rifiuta di ammettere le
violenze e gli stupri del padre, un po’ per scongiurare il movente, un po’ per
orgoglio e vergogna. A nulla servono le suppliche del suo avvocato, che la
invita ad ammettere l’omicidio ma anche a elencare tutti gli abusi subiti da
quell’orrendo genitore, abusi che potranno servire da altrettante attenuanti e a
risparmiarle la vita. Niente da fare, lei rigetta con sdegno ogni accusa.
Molella porta in aula a testimoniare il domestico Marzio che alla vigilia aveva
confessato sotto tortura, ma alla vista di Beatrice, di cui era perdutamente
innamorato, scoppia a piangere e ritratta tutto. Viene ucciso qualche giorno
dopo a colpi di mazza dagli aguzzini del Papa. Olimpio, l’altro domestico che
aveva partecipato alla congiura era invece riuscito a darsi alla macchia prima
degli arresti, ma viene ritrovato da un simpatizzante dei Cenci che lo ammazza
per impedirgli di testimoniare. La sentenza di condanna a morte è scontata,
tanto che viene emessa in assenza di Farinacci, ancor prima che possa
pronunciare l’arringa difensiva. Soltanto al piccolo Bernardo è risparmiato il
supplizio, lo condannano ai “remi perpeutui” nelle galere delle Stato Pontificio
(comprerà la sua libertà qualche anno dopo pagando un’ingente somma).
Immediatamente i Cenci sono portati in prigione, Lucrezia e Beatrice rinchie
nella Corte Savella, Giacomo e Bernardo nel carcere di Tordinona, prima
dell’esecuzione ci sarà la tortura. Clemente VIII vuole infatti che i Cenci
confessino e vuole eliminarli prima che la pietà possa far breccia nei
sentimenti del popolo, incuriosito e appassionato da quella tragica vicenda.
Confesseranno tutti, l’ultima a piegarsi è proprio Beatrice, sottoposta al
trattamento della “corda” che consiste nel sollevare il corpo tramite una
carrucola mentre delle grosse funi ti spezzano giunture e articolazioni. Si
piega per il dolore fisico, insopportabile, ma anche perché capisce che tutto è
ormai perduto, che i suoi familiari hanno confessato, che niente e nessuno potrà
salvarla dallo spadone affilato del boia. Il suo processo e la sua esecuzione,
il barbaro squartamento del fratello Giacomo, simbolo di una giustizia
vendicativa e ancella del potere, ha colpito a fondo l’immaginario collettivo
del popolo e degli artisti e intellettuali. E nei secoli ha ricevuto il tributo
di scrittori come Stendhal, Shelley, Dumas, Artaud, Moravia, di pittori come
Caravaggio, Artemisia Gentileschi (anche lei in piazza il giorno della morte),
Guido Reni, di musicisti come Rota e Goldschmidt, di cineasti come Mario
Camerini e Lucio Fulci. La leggenda vuole che ogni 11 settembre, annunciato da
una gelida brezza, il fantasma di Beatrice Cenci appaia all’imbrunire sui
balconi di Castel S. Angelo. La testa appoggiata sulle mani bianche come la
luna, la camminata leggera e altezzosa, una luce malinconica nello sguardo, e un
sorriso beffardo da regalare ai romani, proprio come quando era in vita.
Assolti dopo 27 anni. “E ora
risarciteli!” Per quattro imputati la Corte d’Appello
ha riconosciuto un indennizzo per l’irragionevole durata del processo, scrive
Simona Musco il 20 Novembre 2018 su "Il Dubbio". Vent’anni per arrivare ad un
processo. E altri sette perché dei giudici stabilissero che il fatto non
sussiste. È una storia paradossale quella della cosiddetta “banda della coca” di
Alghero. Che non esiste, secondo i giudici, che si sono ritrovati a giudicare
presunti trafficanti di cocaina, un affare che dalla Sardegna arrivava alla
Calabria, passando per Roma e per la Colombia. Ma dopo quasi tre decenni, lo
Stato si ritrova ora a dover risarcire i primi quattro imputati per
l’irragionevole durata del processo di primo grado. Una strada che potrebbero
seguire ora anche le altre persone coinvolte, assieme a quella della richiesta
di risarcimento per ingiusta detenzione. Tutto comincia nel 1991, quando 15
persone, dopo la soffiata di una fonte confidenziale e il lavoro di agenti sotto
copertura, vengono coinvolte in un’indagine su un presunto traffico di sostanze
stupefacenti. Per otto di loro l’accusa è di aver promosso, diretto e
organizzato un’associazione per delinquere finalizzata allo smercio della droga
e così finiscono in carcere, rimanendoci per circa un anno. L’udienza
preliminare arriva nel 1995, ma il Gup di Sassari annulla la richiesta di rinvio
a giudizio, rimettendo gli atti al pm, al quale chiede altre prove a carico
delle persone coinvolte. Nel tornare in Procura, però, le carte spariscono. Non
se ne accorge nessuno fino al 2010, quando dopo 19 anni di silenzio viene
notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con una nuova
udienza preliminare fissata ad ottobre. Alcuni faldoni spariscono e per far
iniziare il processo è necessario attingere da più parti: dai carabinieri per le
intercettazioni, mentre altri documenti vengono forniti direttamente dalle
difese. Con quanto ha in mano, l’accusa chiede il rinvio a giudizio e si arriva,
dunque, a luglio del 2011, quando il gup decide di mandare tutti a processo. Ma
dopo sei anni, a novembre del 2017, tutti gli imputati vengono assolti perché il
fatto non sussiste. «Nonostante fossero decorsi i termini della prescrizione –
spiega al Dubbio l’avvocato Paola Milia – i giudici sono entrati nel merito,
spiegando che questa banda non è mai esistita. Si è trattato, invece, di una
sorta di invenzione di alcuni confidenti e di agenti sotto copertura, che però
non hanno mai portato le prove della sua esistenza». Secondo quanto si legge in
sentenza, le testimonianze sono risultate vaghe e insufficienti e «nulla è poi
emerso con riferimento al delitto associativo». Ma non solo: di alcuni dei
soggetti indicati come promotori del traffico «non è emerso neppure il nome nel
corso dell’attività istruttoria». La sentenza è diventata irrevocabile il 31
marzo del 2018, ma l’assoluzione non è bastata ai difensori di Salvatore
Budruni, Giuseppe Ballone, Antonio Martiri e Gervasio Madeddu, gli avvocati
Gabriele Satta, Franco Luigi Satta e Milia, che hanno presentato ricorso alla
Corte d’appello, ottenendo un risarcimento di 600 euro per ogni anno successivo
ai tre anni riconosciuti come periodo ragionevole di durata di un giudizio di
primo grado. Ad ognuno di loro, adesso, andrà una cifra compresa tra i 16mila e
i 18mila euro. «Questo caso sottolinea Milia – rappresenta il classico esempio
di come la sospensione dei termini della prescrizione sia incostituzionale e
illegittima e renderebbe discrezionale la trattazione dei processi in fase
d’appello. Noi avvocati da domani (oggi, ndr saremo in agitazione. Molti degli
imputati di questo processo hanno dovuto rinunciare a tutto, si sono visti
togliere concessioni demaniali e le loro famiglie sono dovute andare via. Si
parla sempre e solo dei colpevoli conclude – ma ci si dimentica che a processo
ci finiscono anche gli innocenti».
«Confessa o resti in cella». Davigo dice
che va bene così. Il consigliere del Csm rivendica
l’uso del carcere come strumento di pressione, scrive Piero Sansonetti il 17
Novembre 2018 su "Il Dubbio". Piercamillo Davigo – l’ex presidente dell’Anm, il
giudice di Cassazione, l’attuale consigliere del Csm, insomma, una delle
autorità della nostra magistratura – ieri, in Tv, intervistato da Goffredo
Buccini del “Corriere della Sera”, ha rivendicato l’uso del carcere come
strumento per far confessare gli indagati. Ha usato un giro di parole e un
sorriso per affermare questo principio, ma lo ha affermato. «Confessa o resti in
cella» Davigo dice che va bene così. Buccini lo ha portato a parlare del
rapporto tra arresti e confessioni, riferendosi soprattutto ai metodi di
indagine usati dal famoso pool mani- pulite negli anni novanta. Davigo, con una
smorfia ironica, ha spiegato che loro non arrestavano per far confessare ma
semplicemente scarceravano dopo la confessione. Dalla smorfia di Davigo si
capiva che il magistrato sa benissimo che non c’è una gran differenza tra le due
cose. Gli piace giocare un po’ sulle parole, con destrezza. I magistrati
milanesi mettevano in prigione le persone e le tenevano lì finché non
confessavano. Spiegando loro, durante gli interrogatori, che non potevano fare
altrimenti, perché solo se confessavano si poteva star tranquilli che non ci
fossero più rischi di reiterazione del reato. E in questo modo i Pm milanesi
ottennero decine di confessioni, nessuno sa quanto spontanee e quanto veritiere
(ma ottennero anche qualche suicidio, che ancora brucia). Non ci vuole molto a
capire che se ti trovi in cella, magari da un mese, o da due, e sei disperato,
impaurito, pieno di angosce – e forse anche innocente – e ti fanno intuire, o ti
dicono esplicitamente, che o confessi qualcosa ( e magari ti fanno capire anche
cosa) o resti dietro le sbarre, beh è abbastanza probabile che prima o poi tu
confessi. Quanto è attendibile una confessione ottenuta in questo modo? Poco,
molto poco. Quanto è rispettoso della Costituzione e dello stato di diritto e
del codice di procedura penale, e dei diritti dell’uomo, questo metodo? Poco,
forse niente. Vorrei fare una breve digressione, che potete pensare fuori luogo,
ma io credo che invece c’entri qualcosa col ragionamento di Davigo. Nel
diciottesimo secolo, in Francia, fu eliminata la tortura dal sistema penale.
Prima la tortura era ammessa, anche se regolata da norme molto precise e
piuttosto rigorose. Che tra l’altro davano al torturato un piccolo vantaggio: se
resisteva alla tortura era definitivamente e incontrovertibilmente assolto e il
magistrato accusatore aveva perso. Fu eliminata – questo è il dettaglio più
interessante – non perché considerata un metodo crudele e inumano. No, per
un’altra ragione, più di dottrina. Perché fu stabilito che non potevano
mescolarsi gli strumenti di indagine e la pena. Dovevano restare assolutamente
distinti e distanti. Mentre la tortura, indubitabilmente, era una pena. Quindi
non poteva valere ai fini dell’indagine. Certo, la tortura fisica era molto
molto dura e sanguinosa, e non è paragonabile alla detenzione in una prigione
italiana del ventunesimo secolo. Quando si dice che la detenzione è una tortura
si usa una metafora (o, almeno, per comodità di ragionamento, ammettiamo che sia
così). Resta il fatto che indiscutibilmente la detenzione è una pena. Pena
addirittura identica a quella che poi si deve scontare se si è riconosciuti
colpevoli dopo il terzo grado di giudizio. La cella è quella, le condizioni
della prigionia son quelle. Possibile che in Italia, nel ventunesimo secolo, non
si sia ancora arrivati a comprendere, o a riconoscere, e ad attuare un principio
che i francesi affermarono più di 250 anni fa? E possibile che una persona colta
e sensibile come Piercamillo Davigo non avverta questo problema come problema
serio e reale? Il problema generale è quello della liceità della detenzione
preventiva, se non in casi estremi. Il diritto e le leggi prevedono che sia
così. Prevedono che l’indagato sia considerato innocente e che il suo arresto
possa avvenire solo per ragioni particolarissime. Però sappiamo che questo non
avviene. La detenzione preventiva è molto, molto usata. Quasi il 40 per cento
degli attuali detenuti non ha subito una condanna definitiva. Le statistiche ci
dicono che più della metà di loro risulterà innocente. Parliamo di decine di
migliaia di persone innocenti in prigione. Possibile che di fronte a questi
problemi e a queste cifre indiscutibili, una personalità come quella di Davigo
possa limitarsi, in una intervista Tv, a lamentarsi – come ha fatto – perché in
Italia troppi pochi condannati scontano effettivamente la pena? Dopodiché devo
ammettere che l’intervista di Buccini e di Formigli (si è svolta nel
programma Piazza Pulita della 7) a Davigo è stata molto divertente. Davigo
sicuramente è l’esponente più radicale dello schieramento giustizialista, ma è
comunque una persona colta e anche spiritosa. Non solo: sicuramente è un uomo
libero (sono quelli che finiscono sotto il suo martello, spesso, a non essere
più liberi…) e infatti su molti argomenti ha picchiato duro sul governo e anche
sul movimento dei 5 Stelle che pure, notoriamente, è un movimento davighista. Ha
liquidato il condono, ha liquidato la “daspo” anticorruzione, ha liquidato la
riforma della prescrizione, ha liquidato soprattutto la proposta di riformare le
norme sulla legittima difesa. Ha fatto notare che se uno spara a qualcuno che
scappa disarmato, e il proiettile entra dalla schiena e uccide il poveretto, non
c’è legge che possa impedire di processare quel tale per omicidio. E ha anche
ricordato che la legge sulla legittima difesa (prima ancora che fosse modificata
e resa più lasca, nel 2006, quando ministro era un leghista) era stata scritta
non da un pericoloso anarchico amico dei ladruncoli, ma da Alfredo Rocco,
ministro della giustizia di Mussolini. Detto tutto questo, il problema del
rapporto tra arresti e confessione resta drammaticamente in piedi. L’idea che un
membro del Csm ritenga legittimo usare le manette per indurre gli indagati a
“cantare”, getta un’ombra cupa, molto chupa, sul nostro stato di diritto.




 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: